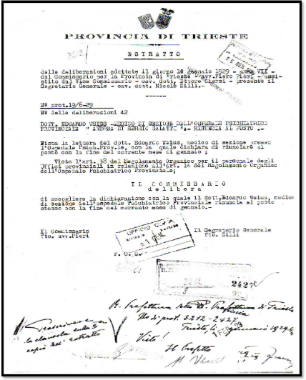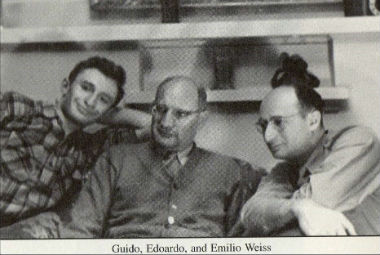La Ricerca
SpiPedia
Adolescenza
Adolescenza
A cura di Anna Maria Nicolò
L’adolescenza non è solo una fase temporale di transizione (come il titolo di un famoso libro di Peter Blos), ma è piuttosto un processo organizzativo, un enzima che attiva la mente verso la trasformazione propria dell’età adulta. Anche gli studi neuro psicoanalitici supportano questa idea mostrando il potente rimodellamento del cervello, della corteccia, delle connessioni sinaptiche che avviene nel corso dell’ adolescenza. Il vecchio aforisma di Evelyne Kestemberg (1980) era molto acuto a questo proposito quando affermava che tutto si prepara nell’infanzia, ma tutto si gioca in adolescenza. Questa posizione non è senza conseguenze e sullo sfondo di queste proposizione vi è il dibattito tra continuisti e discontinuisti e cioè coloro che vedono la crescita dell’individuo in una continua progressione ma soprattutto ritengono l’adolescenza una ricapitolazione dell’infanzia e altri che invece segnalano l’emergere in adolescenza di processi trasformativi nuovi che determinano nuovi percorsi. Specifici sono i compiti evolutivi che questa età della vita comporta ed essi sono l’integrazione della sessualità, l’individuazione/separazione dal passato infantile, dal corpo infantile e dagli oggetti parentali infantili con il lutto evolutivo conseguente, l’integrazione dell’aggressività e quella trasformazione dall’azione al pensare-sognare che è anche uno degli obiettivi dell’analisi. Nuove sensazioni mai sperimentate prima emergono in adolescenza e riguardano l’avvento delle trasformazioni puberali: la tempesta ormonale, il cambiamento corporeo, la nuova statura fisica, la maturazione sessuale e le nuove esperienze legate al menarca, al pubarca e all’iniziazione sessuale. Quest’ultima permette l’emergere, in particolar modo nella ragazza, di sensazioni nuove connesse con lo sperimentare gli organi interni (Laufer, 2002; Nicolò, 2011). In adolescenza, esistono sia una sensorialità che una sensualità nuove che emergono e si innestano sulle antiche esperienze. Gutton (2003), ad esempio, descrive come i vissuti arcaici siano l’effetto immediato della “sensorialità sensuale” e di come i nuovi vissuti (adolescenziali) “rivisitino” quelli antecedenti, in particolare i più originari. Nuove sensazioni sono anche offerte in questa età dalla masturbazione. La masturbazione e la fantasia masturbatoria centrale (Laufer, 1984) che la accompagna costituiscono un atto di prova che permette di sperimentare “pensieri, sensazioni o soddisfacimenti” indagando quali “sono accettati dal Super-io o quali non possono far parte dell’immagine che l’individuo ha di sé come sessualmente maturo” (Laufer, 1984).
In adolescenza la valutazione si presenta molto difficile (Anna Freud, 1957) dato che la presenza di meccanismi primitivi in superficie e in continua trasformazione rende difficile l’orientamento. Funzionamenti come l’agire per sperimentare e sperimentarsi al di fuori di questa età sarebbero disfunzionali. In adolescenza invece possono assumere anche una valenza protosimbolica. La fantasie e le fantasticherie spesso riempiono angosciosamente lo spazio mentale e talora si organizzano in romanzi familiari. La FMC (fantasia masturbatoria centrale) si rivela molto utile per l’analista perché ci dà indicazioni sulle fissazioni attuali del paziente e sulla sua evoluzione. Ci sono situazioni in cui la fantasia masturbatoria contiene desideri regressivi e vergognosi che l’adolescente odia e che gli impediranno di sperimentarsi e sperimentare il suo corpo e le sensazioni connesse (Laufer, 1984).
In adolescenza, come ci dice Florence Guignard (1996), il preconscio, area tampone che regola gli scambi tra il mondo interno e la realtà esterna diventa “più trasparente e più fragile” fin quando l’adolescente non sarà cresciuto ed è proprio questa trasparenza che ci consente di vedere, senza infingimenti, quanto avviene nel mondo interno in ristrutturazione dell’adolescente. Vediamo con maggior chiarezza le potenzialità psicotiche della personalità, altrimenti inaccessibili, ma sappiamo anche che talora l’adolescenza le simula. Questo è sostenuto e complicato da un fenomeno per altro normale in adolescenza: il riattivarsi di disposizioni polimorfo perverse, che sono anche in relazione al riattivarsi dell’Edipo e che sono caratterizzate anche da confusioni bisessuali. Quelle che Donald Meltzer (1973) chiama le confusioni zonali (combinazione bocca-vagina-ano e poi capezzolo-lingua-feci), che il bambino aveva già imparato a distinguere, erompono alla pubertà a volte accompagnate da una idealizzazione della confusione. Alla base di molti problemi e di molte incertezze nell’identità di questo periodo della vita possiamo ritrovare proprio questi fenomeni, espressione di una difficoltà del processo di soggettivazione (termine introdotto da analisti francesi tra cui Cahn, Richard, Wainrib, Kaës et al., con il quale si designa un processo di appropriazione del funzionamento psichico che l’Io opera in un rapporto intersoggettivo grazie alla sua progressiva capacità di rappresentazione).
Una certa ansia intorno alla definizione dell’identità di genere in questo periodo non sarà particolarmente rilevante. Più che essere espressione di una scelta oggettuale o di problematiche connesse con l’identità di genere, le ansie omosessuali nascono dalle vicissitudini delle identificazioni, dalla passività che l’adolescente teme e lo perseguita. Esse si iscrivono nell’“evoluzione dall’omoerotismo infantile alla pubertà” (Gutton, 2002) ma possono essere anche espressione di un’incipiente e più vasta regressione.
In adolescenza ancora una volta, come all’inizio della vita, l’adolescente dovrà reinvestire narcisisticamente il suo corpo e riappropriarsene simbolicamente (Ruggiero, 2011). Tale investimento reso obbligato dalla realtà puberale impone “la perdita dell’illusione di perfezione, illusione della bisessualità” (Ladame, Perret-Catipovic, 1998, p. 59). L’equilibrio tra queste nuove esperienze, la loro quota di eccitazione e la capacità di contenerla e/o di rappresentare tali esperienze, è importantissimo dato che un surplus di eccitazione può generare difese contro lo sperimentare questi nuovi aspetti. Un eccesso di eccitazione fa assumere a queste esperienze una valenza traumatica. La crisi dell’adolescente di cui molti parlano è correlata con le profonde trasformazioni del suo corpo, del suo funzionamento mentale e delle relazioni sociali di questa età della vita, oltre che con la crisi dei genitori e della famiglia intera dove l’adolescente vive.
Queste specifiche trasformazioni sono la vera sfida che impegna l’adolescente: integrare i cambiamenti del suo corpo indotti dalla pubertà, trasformare i suoi legami con i genitori e accettare il lutto della separazione dal mondo infantile e dalla onnipotenza ad esso correlata, rifondare la sicurezza di sé, processo che alcuni psicoanalisti connettono con la ripresa dei processi di ri-narcissizzazione in adolescenza.
La condizione dell’adolescenza proprio per le sue caratteristiche specifiche correlate con le vicissitudini dei processi di identificazione, è un indicatore straordinario delle trasformazioni socio culturali della nostra società oltre che del disagio della nostra civiltà. Se l’adolescente di oggi ha certamente guadagnato una maggiore libertà, ha purtroppo anche perso molti riferimenti che prima gli assicuravano sicurezza e stabilità. Assistiamo ad esempio all’emergenza di nuove patologie del corpo e sul corpo, ad una violenza prima inattesa, a disagi diversi, imprevedibili e inspiegabili o anche a nuove manifestazioni della sessualità più precoce e variamente articolata.
Di certo lo psicoanalista di adolescenti dovrà avere una competenza specifica rispetto a questa età della vita (Novelletto, 1986; Nicolò, 1998; de Vito, 1998) e al suo modo multiforme di presentarsi, dovrà essere capace di muoversi tra le manifestazioni abbastanza diversificate della prima, media e tarda adolescenza (Blos, 1979) e di essere mobile adattandosi al suo paziente, associando, disegnando, parlando, narrando o usando metafore o talora in silenzio, accettando perciò le variazioni e la flessibilità del setting (Pellizzari, 2010; Senise, 1990) e anche del contratto analitico, proprie del lavoro in adolescenza. Il particolare funzionamento mentale dell’adolescente imporrà poi di non sfidare troppo la paura dell’adolescente nei confronti della dipendenza, cosa che egli mal tollera a causa della lotta incessante in questo periodo tra attività e passività.
L’adolescenza sfida la psicoanalisi e dobbiamo riconoscere che il lavoro in questi setting come quello con gli adulti più gravi ha contribuito a determinare mutamenti profondi nella nostra tecnica e nella valutazione (Nicolò, 2012) e perfino nella visione degli obiettivi del nostro stesso lavoro clinico.
Bibliografia
Aliprandi M.T., Pelanda E., Senise T. (1990). Psicoterapia breve di individuazione. La metodologia di Tommaso Senise nella consultazione con l’adolescente. Milano: Feltrinelli.
Blos P. (1979). L’adolescenza come fase di transizione. Aspetti e problemi del suo sviluppo. Roma: Armando Editore, 1988.
De Vito E. (1998). Alcune caratteristiche specifiche del setting con l’adolescente. Richard e Piggle, 6 (1): 89-92.
Freud A. (1957). Adolescenza. In: Anna Freud. Opere 1945-1964, vol. 2. Torino: Boringhieri, 1979.
Guignard F. (1996). Au vif de l’infantil. Lausanne: Delachaux et Niestlé. [trad. it. Nel vivo dell’infatile. Milano: Franco Angeli, 1999]
Gutton Ph. (2002). Psicoterapia e Adolescenza. Roma: Borla, 2002, p. 61.
Gutton Ph. (200). Esquisse d’une théorie de la génitalité, Adolescence, 21, 2, 217-248.
Kestemberg E. (1980). Notule sur la crise de l’adolescence. De la déception à la conquête, Revue Française de Psychanalyse, 44 : 523-530.
Ladame F., Perret-Catipovic M. (1998). Jeu, fantasmes et réalité. Le psychodrame psychanalytique à l’adolescence. Paris: Masson [trad. it. Gioco, fantasmi e realtà. Lo psicodramma psicoanalitico nell’adolescenza. Milano: Franco Angeli, 2000. Capitolo 3: L’adolescenza. La posta in gioco dello sviluppo e le difficoltà di valutazione].
Laufer E. (2002). Il corpo come oggetto interno. Relazione presentata al Centro di Psicoanalisi Romano nel novembre 2002. [Le corps comme objet interne. Adolescence, 2005, 23, 2, 363-379]
Laufer M., Laufer E. (1984). Adolescenza e breakdown evolutivo. Torino: Boringhieri, 1986.
Meltzer D. (1973). Stati sessuali della mente. Roma: Armando, 1975.
Nicolò A.M. (1998). Dibattito a cura di A. Nicolò “Esiste una specificità della formazione al lavoro psicoanalitico con gli adolescenti?”, Richard e Piggle, 6, 1, pp. 86-101.
Nicolò A.M (2011). Sexual initiation and romantic love during adolescence. Relazione presentata al panel Current Day Sexuality and Psychoanalysis. More than a Hundred Years on from the “Three Essays” del 47th IPA Congress, Città del Messico 2011) [trad it. Iniziazione sessuale e illusione amorosa in adolescenza, Richard e Piggle, 2012, 20, 4, pp. 354-366].
Nicolò A.M. (2012). L’adolescenza, una sfida per lo psicoanalista. Come il lavoro con gli adolescenti ci ha costretto a ripensare i nostri modelli. Relazione presentata al Convegno Nazionale di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza AGIPPsA “Adolescenza e psicoanalisi oggi”. (In corso di stampa)
Novelletto A. (1986). Psichiatria psicoanalitica dell’adolescenza. Roma: Borla.
Pellizzari G. (2010). La seconda nascita. Fenomenologia dell’adolescenza. Milano: FrancoAngeli.
Ruggiero I. (2011). Corpo strano, corpo estraneo, corpo nemico: itinerari adolescenziali tra corpo, psiche e relazione, Rivista di Psicoanalisi, anno LVII, n. 4, pp. 825-847.
Richard F., Wainrib S. (a cura di) (2006). La soggetivazione. Roma: Borla, 2008.
Luglio 2014
Approfondimenti:
A. Nicolò: Pelle da comunicare pelle da danneggiare, CpdR
Adolescenza (Terapia)

Keith Haring
A cura di Giuseppe Pellizzari
L’adolescenza per lungo tempo è rimasta ai margini dell’attenzione degli psicoanalisti. Anna Freud la definiva “la Cenerentola della psicoanalisi”. Questo era dovuto al fatto che gli adolescenti sono per loro natura dei soggetti instabili, difficilmente inquadrabili nella patologia tradizionale delle nevrosi. Del resto anche i bambini erano entrati nel campo d’azione della psicoanalisi quasi clandestinamente. Occorrerà aspettare Melania Klein e Donald Winnicott perché alla psicoanalisi infantile venga riconosciuta la legittima cittadinanza analitica.
Nei tempi recenti l’adolescenza è assurta invece ad oggetto privilegiato, capace di convogliare interessi sempre più complessi e articolati. Da “Cenerentola” a “prima donna” dunque?
Il fatto è che l’adolescenza, proprio per la sua natura caratterizzata da incertezze, fragilità, smarrimenti, si presta bene a incarnare lo spirito dell’epoca attuale. Sappiamo che la stessa patologia nevrotica si è profondamente modificata: se un tempo il disagio psichico si concentrava sulla colpa e sulla trasgressione, oggi sembra incentrato quasi esclusivamente su problematiche narcisistiche, che, guarda caso, sono le problematiche tipiche dell’adolescenza.
Vediamo in breve in cosa consistono. Come è noto il processo di crescita dell’individuo trova nel periodo adolescenziale una fase particolarmente critica, poiché tale processo consiste nel passaggio piuttosto repentino dall’infanzia all’età adulta. Il soggetto adolescente incontra tre fondamentali trasformazioni: acquista una massa corporea che modifica i rapporti di forza con i genitori e il mondo adulto in generale (non è più un bambino che possa essere fisicamente costretto a ubbidire, con le buone o con le cattive), diviene sessuato come un adulto ed è in grado di generare a sua volta dei figli, sviluppa una capacità di pensiero ormai matura se non altro nelle potenzialità cognitive. Queste trasformazioni da un lato lo portano ad allontanarsi dalla dipendenza infantile e ad accedere ad un potere adulto, ma contemporaneamente lo destabilizzano rendendolo spesso confuso, instabile nell’umore, a volte incapace di concentrarsi. In una parola lo mettono in una fisiologica crisi d’identità, che può esitare in un conseguimento di un’identità matura, ma anche in fenomeni regressivi più o meno preoccupanti.
Mentre è normale una oscillazione tra momenti di sviluppo e momenti di stasi e di regressione, diventa seria la preoccupazione se vi è un blocco evolutivo o il prodursi di sintomi e di comportamenti che denotino un disagio grave e costante. Si possono considerare tra questi i disturbi alimentari continuativi, le varie forme di ritiro dalla vita sociale, i gravi disturbi psicosomatici, le molteplici forme di dipendenza da sostanze, le condotte autolesive e lo strutturarsi di sintomi ossessivi o psicotici.
I genitori sono chiamati dall’adolescenza dei figli ad un compito spesso assai impegnativo. Hanno ormai perduto l’autorità che possedevano durante l’infanzia dei figli; adesso questi, come spesso si sente dire, “fanno quello che vogliono senza ascoltare”, e sono confrontati su un piano personale con la loro contemporanea “crisi di mezza età”. Forse si può dire che siano costretti a passare attraverso una seconda adolescenza che a volte li spinge ad assumere atteggiamenti altrettanto rigidi e velleitari di quelli dei figli che sembrano sfidarli.
Tutto questo però è anche una grande occasione di trasformazioni positive e di maturazione, sia per i ragazzi che possono riaffrontare nodi irrisolti della loro trascorsa infanzia in un nuovo contesto evolutivo (quella che viene chiamata la “seconda chance”), sia per i genitori che possono, a loro volta, rivisitare il ricordo dell’adolescenza e, per così dire, “completarla”. Il conflitto tra generazioni può diventare una forma feconda, anche se spesso dolorosa, di complementarità. Una complementarità capace di consentire una separazione. L’adolescenza, infatti, è anche un processo di lutto della propria infanzia, che viene perduta senza che ci si possa fare niente, e di distacco dalla dipendenza dai genitori, fastidiosa fin che si vuole, ma anche rassicurante e comoda.
Il trattamento psicoanalitico degli adolescenti, come del resto era avvenuto per quello dei bambini, comporta delle variazioni della cosiddetta tecnica classica dell’analisi. Come è noto i ragazzi mal sopportano le rigidità delle regole e degli atteggiamenti. Pur avendo bisogno di un contenimento che dia loro un senso di solidità e di continuità, occorre una certa elasticità, un ascolto “su misura”, che venga sentito non come applicazione di una regola anonima, ma come la creazione di uno spazio condiviso, del quale l’adolescente si senta non solo partecipe ma corresponsabile. Non deve sentirsi come soggetto passivo di un’indagine mirante a mostrargli le sue debolezze e la sua patologia, ma come una persona in difficoltà che ha l’occasione di trasformare tale difficoltà nel vantaggio di un’esplorazione di sé molto impegnativa ma affascinante. E’ indispensabile che il terapeuta più che “curare” un giovane malato, intenda stimolarne la creatività, insita in ogni disagio affettivo come una potenzialità nascosta.
Certe caratteristiche tecniche del trattamento analitico (il Setting, il numero delle sedute, il tipo di interpretazioni, l’uso del lettino) devono quindi essere sottoposte ad un’elasticità particolare, frutto dell’inventiva e della capacità di improvvisazione che sono gli aspetti specifici di questo tipo di intervento terapeutico.
Un’ultima osservazione riguarda il particolare interesse che lo studio dell’adolescenza riveste nell’attualità. Comprendere la ricchezza e la complessità della “mente adolescente” vuol dire avvicinarsi ai processi che caratterizzano nel bene e nel male le grandi trasformazioni che rendono così inquieta la nostra epoca.
Ottobre 2013
Adolescenza / disturbi somatici funzionali
Disturbi somatici funzionali in adolescenza
A cura di Franco D’Alberton
Si tratta di una categoria di disturbi che si esprimono attraverso manifestazioni somatiche, che non hanno spiegazioni da un punto di vista medico e che, in età evolutiva, si presentano soprattutto nella prima adolescenza, sostanzialmente nell’età della scuola media, fra i 10 e i 14 anni (D’Alberton, 2004).
Sono quadri che prevalentemente afferiscono agli studi dei pediatri o ai reparti ospedalieri perché dolori muscolari e forme di astenia impediscono la locomozione e fanno temere forme complesse di patologie neurodegenerative; oppure perché dolori addominali, disturbi respiratori, episodi di tosse parossistica e persistente hanno effetti invalidanti di giorno mentre di notte misteriosamente scompaiono.
I pediatri hanno imparato a collegare questi sintomi a difficoltà emotive proprie di questo momento delicato dello sviluppo anche se a volte può essere sottovalutata la varietà sintomatologica con cui gli adolescenti, a fronte di una crescente pressione istintuale, usano il corpo come via d’ espressione della tensione (Blos 1962).
Ciò può accadere soprattutto in una prima fase del periodo adolescenziale durante il quale, in modo quasi impercettibile ad un osservatore esterno, si preparano le trasformazioni più marcate della pubertà, con un disequilibrio fra la qualità e l’intensità dei nuovi impulsi e le capacità di tenerli integrati in un sistema coerente di funzionamento mentale.
Non è facile infatti riconoscere l’impatto sulla mente in evoluzione del giovane adolescente dei cambiamenti dovuti allo sviluppo endocrino, somatico, cognitivo e psicosessuale. Tale complesse progressioni evolutive mettono sotto pressione gli equilibri delle istanze dell’Io, del Super Io e dell’ Ideale dell’ Io, influiscono sul processo di autonomia e di soggettivazione e sulla quantità di adattamenti che si richiedono alla mente (al fine di una loro integrazione nella rappresentazione di sé).
In questo periodo della vita l’evoluzione dell’Io e delle sue funzioni e lo sviluppo somatico psicosessuale sembrano prendere strade, ritmi e velocità differenti che, solo alla conclusione del percorso adolescenziale, potranno arrivare ad una nuova sintesi e ad una nuova sincronia nell’integrazione psichica del corpo sessuato.
Inoltre, la contrapposizione fra investimenti narcisistici e investimenti oggettuali (Jeammet, 1992), nodo cruciale dell’adolescenza, può portare alcuni soggetti ad avvertire l’investimento pulsionale come un rischio per la fragilità della base narcisistica e minare i processi di soggettivazione (Cahn, 1998).
Oltre ad episodi reattivi transitori, legati a condizioni specifiche dell’età, a particolari situazioni familiari e/o sociali di simulazione o di mitomania, le due principali categorie nosografiche che fanno da confine e sponda alle condizioni che stiamo affrontando sono la conversione nevrotica e i disturbi psicofunzionali della patologia psicosomatica.
In altre parole, torna attuale la differenza fra nevrosi attuali e psiconevrosi, trattata da Freud nei suoi primi lavori, che getta una luce chiarificatrice sul delicato passaggio dal corpo alla mente. Questa distinzione rappresenta un ideale punto di partenza per avvicinarci a tale sintomatologia dove la mente, con le sue nuove acquisizioni e alcuni suoi vecchi limiti, cerca di aprirsi faticosamente la strada nel mondo sconosciuto di un corpo attraversato da rapide modificazioni.
Secondo il modello di Freud del trauma in due tempi descritto nel “Progetto di una psicologia” lo sviluppo somatopsichico renderebbe traumatiche esperienze avvenute precedentemente nell’infanzia. Ogni adolescente ha tracce mnestiche che possono venir comprese solo con la comparsa delle proprie emozioni sessuali; ogni adolescente, di conseguenza, porterebbe con sé il germe dell’isteria” (Freud S., 1895, pag.256).
Vi sono pareri diversi sull’opportunità di utilizzare il termine di nevrosi e soprattutto di isteria in età evolutiva quantunque Semi e Campanile (2010) sottolineino l’incidenza delle le manifestazioni isteriche nella prima adolescenza e Campanile (2000) usi il nome di “isteria di transizione” per descrivere queste forme caratterizzate da un deficit delle capacità rappresentative.
Anche De Ajuraguerra (1974) sostiene la legittimità della diagnosi di nevrosi in età evolutiva circoscrivendola al quadro preciso dell’’isteria di conversione.
Lebovici, dopo un’ accurata disamina dell’evoluzione del concetto nosografico, individua una predisposizione alla nevrosi isterica come espressione di un anticipo libidico sulla maturazione dei meccanismi dell’Io. (Lebovici et al.,1985).
Cramer (1977) considera la conversione come espressione del tormentato percorso dell’investimento del corpo da parte dell’adolescente quando l’intensità della pressione istintuale avvertita a livello somatico fa percepire il corpo come estraneo.
Se la nevrosi fa riferimento alla possibilità di una rappresentazione psichica di conflitti o condizioni traumatiche e all’utilizzo di meccanismi psichici di difesa, l’espressione psicosomatica è dovuta a un sovraccarico o una carenza di eccitazione che, bypassando lo psichico, si manifesta nel corpo. Il problema si pone sulla qualità, sulla carenza o su una eccessiva quantità di stimoli, e sul modo in cui questa prenda direttamente la strada del corpo. La caratteristica dei disturbi psicosomatici colloca la loro origine ad uno stadio più precoce dello sviluppo all’interno di una relazione madre bambino nella quale è stata carente la gestione degli scambi sensoriali.
Kreisler sostiene che il sintomo di conversione, secondo una formulazione classica, si contrappone al disordine psicosomatico. Secondo una sua felice espressione In queste forme nevrotiche con un insufficiente livello di mentalizzazione “l’isterico parla attraverso il corpo, il paziente psicosomatico soffre nel corpo. Il corpo è, per l’isterico, uno strumento; per il paziente psicosomatico una vittima” (1981, pag. XII).
Bibliografia
Blos P. (1962) L’Adolescenza. Franco Angeli, Milano 1980.
Chan R. (1998) L’adolescente nella psicoanalisi. Borla, Roma 2000
Campanile P. (2000) Hystérie de transition – Le fait de l’analyse, 8
Campanile P., Semi A.A. (2010) Teoria dell’isteria e isteria della teoria. In Albarella C., Racalbuto A. Isteria, Borla, Roma.
Cramer F. (1977) Vicissitues de l’investissment du corps, symptômes de conversion en période pubertaire, Psichiatrie de l’enfant, 1977, XX, 1.
D’Alberton F. (2004) Disturbi emotivi ad espressione somatica in preadolescenza. Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza Vol. 71:127-142
De Ajuraguerra J (1974) Manuale di psichiatria del bambino. Masson, Milano 1979.
Freud S. (1894) Le neuropsicosi da difesa. In OSF 2, Bollati Boringhieri, Torino, 1968.
Freud S. (1895) Progetto di una psicologia. In OSF 2, Bollati Boringhieri, Torino, 1968.
Jeammet P. (1992) Psicopatologia dell’adolescenza. Borla, Roma
Kreisler L. (1981) Clinica psicosomatica del bambino. Raffaello Cortina Editore, 1993.
Lebovicì S. (1985), L’Isteria nel bambino e nell’adolescente In Lebovici S.,Diatkine R.,Soulè M. Trattato di psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Edizioni Borla, Roma 1990.
Dicembre 2014
Adolescenza / lavoro coi genitori
A cura di Paola Catarci
Come si trasforma la relazione tra genitori e figli quando questi entrano in adolescenza?
Possiamo guardare all’adolescenza come una fase della vita che implica un certo specifico funzionamento mentale, che risponde alle esigenze separative e di individuazione degli individui. E’ dunque un processo che confronta i suoi protagonisti – gli adolescenti, ma anche i loro genitori- con i temi della crescita e del distacco. La funzione genitoriale che aveva funzionato fino a quel momento si basava su una basilare asimmetria e sul bisogno di supporto del bambino da parte dell’adulto. L’adolescente, invece, propone nuovi bisogni e nuove distanze. I genitori sono confrontati con un cambiamento di rotta totale: dove, fino ad allora, si trattava di condividere, ora si tratta di dividersi, mantenendo però ugualmente presenza e funzione genitoriale. E’ un compito quasi paradossale: si tratta, per gli adulti, di modificare l’identità di genitori di un bambino, ed assumerne invece una – mediamente – più scomoda. Un genitore di adolescente è confrontato, in genere, col tema del limite, del rischio, della questione dell’apprendere attraverso agiti più o meno violenti o lesivi, del dover rispondere a richieste talvolta incongrue, spesso poco negoziabili.
I genitori che si rivolgono agli psicoanalisti sono offesi, doppiamente traumatizzati: dalla incomprensibilità dei comportamenti, dei vissuti dei figli, che li espongono socialmente al biasimo ed alle critiche, ma anche offesi dalla rottura del legame coi figli stessi. Rotture esterne, per quelli che prendono le distanze restituendo al figlio l’intera responsabilità del conflitto, e rotture interne, per quelli che sentono di non poter sostenere la collusione, e sentono slegato, rotto, il patto etico che aveva sostenuto la relazione col ragazzo fino a quel momento. In che modo questo insieme, intreccio di sentimenti, può essere utilizzato perché si crei una motivazione personale del genitore a ricercare il senso degli agiti, dei sintomi del figlio, e, a seguire, il senso più ampio della relazione coll’adolescente? Credo si possa ritrovare spesso, negli agiti e nei sintomi degli adolescenti che i genitori portano alla nostra attenzione, il precipitato di fantasie inconsce connesse al mito di fondazione della coppia, ovvero al concepimento del figlio stesso – assunte dal figlio nella propria organizzazione psichica, ma che erano rimaste incastonate, sorta di traumi, che attengono alle relazioni primarie, che non avevano potuto essere simbolizzati e significati, e che l’adolescenza prepotentemente rimette in circolo, chiedendo, esigendo una qualche forma di riconoscimento e soddisfacimento, sia pure in termini di agiti, sintomi, conflittualità a tutto tondo.
Che tipo di lavoro psicoanalitico è quello coi genitori?
Ho descritto poco fa l’adolescenza come un processo attivatore della crescita. Credo che il compito-complesso ma non impossibile – che spetta a noi, psicoanalisti che lavorano coi genitori degli adolescenti, sia quello di poter trasformare richieste di aiuto, di sostegno, di guida, in una scoperta di risorse personali per la propria crescita. Nel momento in cui la terapia coi genitori si configura nei suoi aspetti transferali, ovvero come spazio di trasferimento delle fantasie inconsce, ciò che si avvia è un processo di elaborazione interno alla coppia così come un processo che può generare nuovi spazi di libertà per l’adolescente. Con la crisi adolescenziale del loro figlio, i genitori si trovano confrontati a qualcosa che attiene alla loro stessa crescita. Si tratta di elaborare il loro proprio lutto per quella fase della vita – l’adolescenza – della quale è ora il figlio il protagonista. Ciò che conta allora, ciò a cui l’intervento dovrebbe mirare, è l’attivarsi, grazie al lavoro psicoanalitico coi genitori, di una catena di eventi la cui natura è intersoggettiva ed allo stesso tempo intrapsichica.
La ritrovata soggettività della coppia genitoriale, o del singolo, alimenterà un processo di differenziazione, di utilizzo di energie disponibili per lo sviluppo.
Quando è consigliata una terapia coi genitori di adolescenti?
Si potrebbe rispondere, un po’ provocatoriamente: sempre.
Sappiamo invece quanto sia difficile, allestire un intervento che li riguardi.
Parliamo di interventi, perché ci sono davvero molti modi di accogliere ed elaborare le richieste di aiuto che ci arrivano dai genitori di adolescenti. La psicoterapia con la coppia genitoriale, o con un singolo genitore, è solo una delle possibili risposte.
Sappiamo però che, tutte le volte che riusciremo a far emergere un bisogno di riflessione su se stessi, sul come si è genitori in quel momento, di quel ragazzo, con le sue specifiche difficoltà, questo innescherà un circuito virtuoso, un allargamento della pensabilità, di cui sarà l’adolescente stesso a valersi.
Ottobre 2013
Adolescenza e gruppo

Dal film L'attimo fuggente di Peter Weir
A cura di Simonetta Bonfiglio
Il gruppo, in adolescenza, assume forma e valenze nuove e centrali per il percorso di crescita e la costruzione dell’identità .
Quando pensiamo ad un adolescente, in effetti, lo immaginiamo insieme ad altri adolescenti, immerso in un gruppo, come in un habitat naturale. Le trasformazioni somatiche che avviano, con la pubertà, il turbolento e creativo percorso adolescenziale, si accompagnano ad un progressivo orientamento dei preadolescenti nella ricerca di investimenti esterni alla famiglia. I ragazzi appaiono impegnati nella ricerca di nuovi oggetti ed affetti, con movimenti di allontanamento dalle figure che sono state fino ad allora punto di riferimento e rifornimento affettivo e di sicurezza narcisistica.
Ha così inizio la profonda trasformazione che coinvolge l’adolescente nelle sue relazioni con il mondo esterno, a partire da quella con i genitori, con se stesso, con il proprio corpo. Dopo la pubertà nulla sarà più come prima: il passaggio attraverso questa fase porta destabilizzazione, improvvisa perdita di certezze. La forza della crescita si accompagna quindi ad uno stato di fisiologica fragilità, per il lavoro di separazione, trasformazione e individuazione che l’adolescente compie, nella tensione creativa di costruzione della propria identità, in oscillazione tra bisogni di ritiro nel sé e bisogni di appartenenza.
In questo quadro, per la specificità del funzionamento mentale dell’adolescente, caratterizzato da estrema fluidità, bisogni fusionali, tendenza all’esteriorizzazione, uno degli indicatori forti della spinta evolutiva è la “scelta” degli amici : fino alla pubertà gli spazi di socializzazione sono quelli “offerti” dai genitori, che sorvegliano e selezionano, indirizzano e controllano la qualità degli incontri e delle esperienze. A partire dalla pubertà, spesso, l’apprensione da parte dei genitori per la perdita del controllo e per l’influenza negativa dei compagni, vanno di pari passo con la potente rivendicazione da parte dei figli della loro libertà di scelta, talvolta venata da sfumature di ribellione come espressione forte di bisogni di differenziazione.
Il vero gruppo “creato” dall’adolescente è il gruppo spontaneo, che si organizza sulla base della cooptazione reciproca, secondo scelte che delineano un campo, nello stesso tempo definito e mobile , dove chiusure e aperture al nuovo e ai nuovi componenti si alternano; è un gruppo diverso dai gruppi strutturati(come la classe o gruppi sportivi) anche se può nascere da incontri che avvengono in quegli ambiti.
Il gruppo quindi assume un significato di rottura o superamento dalle dipendenze infantili, diventa luogo di sicurezza affettiva, di intense esperienze emotive, di elaborazione dell’identità, attraverso il dispiegarsi di movimenti proiettivi e introiettivi. Far parte del gruppo significa riconoscersi in altri e con altri, condividere motivazioni e paure, trovare sicurezza nell’accettazione degli altri e nella identificazione con gli altri. Alla domanda “chi sono”, il preadolescente risponde con il “noi siamo”; il sentimento di “Io sono”, l’identificazione profonda di sé come soggetto, è vicariata dal gruppo : conosco chi sono perché mi riconosco negli altri e attraverso gli altri. Al gruppo è affidato il senso di continuità e di coerenza, insieme all’elaborazione di un nuovo ideale dell’Io, aspetto centrale del lavoro dell’adolescente, dopo la perdita dell’idealizzazione delle figure genitoriali.
Il gruppo dei pari assume necessariamente caratteristiche diverse nelle diverse fasi dell’adolescenza : nella preadolescenza è tendenzialmente composto da ragazzi dello stesso sesso, spesso in opposizione ai gruppi di sesso opposto. Questa dinamica è sostenuta da aspetti difensivi legati in particolare al bisogno di rassicurazione intorno all’identità sessuale. L’evoluzione naturale di questo gruppo “chiuso” è, con la crescita psicologica e con il costituirsi di più mature capacità relazionali, l’aprirsi alla formazione di coppie e quindi al gruppo misto della piena adolescenza. La fluidità dei passaggi e la mobilità del gruppo sono garanzia di un sano funzionamento che permette e sostiene il processo di crescita, attraverso l’appartenenza.
. La costruzione dell’identità si nutre anche delle offerte culturali e identitarie che la società presenta . L’adolescenza porta fortemente le impronte dell’ambiente culturale e del tempo in cui si svolge; dovrà, a sua volta, lasciare la propria impronta generazionale ed è proprio attraverso il gruppo dei pari che gli adolescenti contribuiscono alla formazione di una identità generazionale, con la costruzione di valori comuni e l’uso di “oggetti generazionali” condivisi. Da questo punto di vista, le nuove tecnologie e i nuovi mezzi di comunicazione offrono oggi specifiche e condivise modalità agli scambi tra gli adolescenti.I luoghi virtuali degli incontri, o la modalità di essere continuamente in contatto, caratterizzano le nuove generazioni e quindi le qualità dei gruppi, che in linea con le caratteristiche della società postmoderna, hanno oggi un carattere più fluido e confini meno definiti. Si può velocemente e facilmente transitare da un gruppo all’altro nel reale e nel network. Tutto questo pone specifici interrogativi e sfida alla comprensione di nuove dimensioni relazionali, al loro significato in termini evolutivi, in particolare intorno ai bisogni di dipendenza e la loro patologia.
Sul piano clinico, la modalità e la qualità di partecipazione al gruppo evidenziano, per il singolo adolescente, difficoltà specifiche nella crescita. Oltre agli aspetti costruttivi, vanno quindi ricordati gli usi difensivi e le derive patologiche : il gruppo può diventare banda e branco, agendo, in una dimensione onnipotente, meccanismi proiettivi primitivi e modalità violente intra e intergruppali, come difesa dal limite e dalla quota di dolore che la crescita impone.
Insieme all’uso patologico del gruppo, uno degli indicatori di disagio in adolescenza è l’isolamento o la difficoltà ad accedere al gruppo: : quando il sè è a rischio rottura e la fragilità narcisistica è tale che l’incontro con gli altri alimenta, insieme a un sentimento di estraneità, l’angoscia di frammentazione , potenti meccanismi di difesa possono interferire fino a rendere inagibile l’uso del gruppo per la costruzione dell’identità .
La psicoanalisi, a partire da Freud, si è sempre interessata delle dinamiche tra l’individuo e il gruppo e dei cambiamenti che si producono nel soggetto dentro il gruppo. Bion ha approfondito i significati e le dinamiche profonde, gli aspetti regressivi e quelli trasformativi che caratterizzano la mentalità di gruppo, dove si esprime “la funzione spontanea ed inconscia delle qualità sociali della personalità dell’uomo” . Da questi presupposti nasce l’uso del gruppo terapeutico, che trova anche in adolescenza specifiche indicazioni e la cui finalità, per l’adolescente sofferente, è offrire uno spazio relazionale di contenimento, per superare confusione e ritrovare coerenza, uscendo da stati di grave frammentazione del sé.
Bion W.R.(1961),Esperienze nei gruppi, Armando, Roma, 1971
Bollas C., (1992),Essere un carattere,Borla, Roma, 1995
Kenberg O.F.(1998),Le relazioni nei gruppi,Raffaello Cortina, Milano,1999
Meltzer D., Teoria psicoanalitica dell’adolescenza in Quaderni di Psicoterapia infantile n°1, Borla, Roma,1978
Novelletto A., L’Adolescente, Astrolabio,Roma, 2009
Winnicott D.W. (1965), La famiglia e lo sviluppo dell’individuo,Armando,Roma,1968
Luglio 2014
Adolescenza/comportamenti trasgressivi e antisociali
A cura di Cristina Saottini
I comportamenti trasgressivi e antisociali degli adolescenti sono una grande fonte di preoccupazione per gli adulti (genitori, insegnanti, educatori). La risposta del mondo adulto a questi comportamenti è spesso allarmata, condizionata da pregiudizi e tentata da reazioni repressive che non solo sono inefficaci, ma spesso controproducenti. Sulla base delle conoscenze derivanti dagli ultimi decenni di ricerca sulla trasgressività adolescenziale è invece possibile impostare un intervento efficace, in grado di sconfiggere il pessimismo degli scorsi anni.
Gli adolescenti sono naturalmente trasgressivi e l’equazione tra adolescenza e trasgressività è stata da sempre riconosciuta. Può pertanto essere particolarmente difficile distinguere le situazioni in cui la trasgressività e l’aggressività sono al servizio della crescita e dell’acquisizione di un’identità sociale e quelle in cui all’opposto sono l’espressione di una tendenza antisociale o l’inizio di una vera e propria carriera delinquenziale.
L’opacità delle motivazioni, la percezione di una mancanza di alternative decisionali, l’agire d’impulso, l’effetto di contagio deresponsabilizzante del gruppo, la scarsa empatia, la minimizzazione del significato trasgressivo o aggressivo del comportamento, sono tutti tratti che spesso si ritrovano nei ragazzi che commettono reati e nella valutazione iniziale può essere difficile dire quanto siano l’espressione di tratti di personalità stabili, a specifiche condizioni del momento o siano piuttosto da attribuire ad una dinamica evolutiva.
Le trasgressioni tipicamente adolescenziali riguardano le fughe da casa, il consumo di sostanze, l’appropriazione di oggetti, i furti, le risse o gli atti vandalici; azioni spesso compiute in un clima concitato ed eccitato, in coppia o in un piccolo gruppo, in un contesto ludico e di evasione.
Nella prima parte dell’adolescenza, intorno ai 12-14 anni, sono più frequenti gli atti di vandalismo e le aggressioni, mentre dai 15-16 anni aumentano il furto e le rapine e le trasgressioni che hanno a che fare con il consumo o lo spaccio di droga.
Anche il contesto sociale è determinante nell’emergere della trasgressività, in quanto contribuisce, attraverso la definizione di valori sociali condivisi, a stabilire ciò che è permesso o proibito, ponendo di fatto i limiti il cui superamento costituisce appunto una trasgressione, il cui valore può variare molto in base alla cultura o alla subcultura di riferimento.
Intervenire in modo efficace con gli adolescenti trasgressivi ha una valenza anche dalla prospettiva delle politiche sociale e del welfare.
La commissione di un reato è un gesto a forte rilevanza simbolica a cui va riservata una corretta lettura per poter comprendere le ragioni del disagio dell’adolescente ed evitare così che si trasformi in un punto di non ritorno verso la delinquenza minorile.
Una prospettiva psicologica e più specificamente, psicoanalitica è fondamentale per interpretare per riconoscere l’appello che il comportamento antisociale rivolge agli adulti. L’individuazione del senso comunicativo del comportamento trasgressivo è, infatti, la premessa indispensabile per una risposta efficace da parte del mondo adulto. Una risposta che deve superare la dicotomia tra la “cura” di un disturbo e la “punizione” di un gesto deviante e che deve porsi piuttosto al servizio di un percorso di crescita che altrimenti rischia di vedere nel gesto trasgressivo un muro invalicabile.
Novelletto (1986) racconta come abbia sempre cercato di sottrarsi ad una spiegazione sociologica dell’antisocialità in adolescenza, concependo il reato come espressione di una fantasia di recupero maturativo, equivalente ad una sorta di “delirio maturativo”, una concezione evidentemente molto lontana da una visione sociologica. In questa prospettiva vicina alla concezione di Winnicott della tendenza antisociale, un reato è un’azione simbolica, che ha lo scopo di superare un blocco maturativi, la manifestazione di un aspetto del Sé che non riesce ad esprimersi in altro modo.
Questa concezione è sintonica con quella di Senise (1990). In entrambi i casi l’accento è posto sul concetto di Sé come un particolare oggetto interno, che si costruisce progressivamente e che in adolescenza si rende progressivamente consapevole. Il concetto di individuazione, avvicinabile a quello di soggettivazione (Cahn, 1998) descrive il processo che consente la costituzione soggettiva dell’identità. E’ difficile capire bene le distinzioni tra i diversi concetti che descrivono questo processo. Da una parte, infatti, si può ritenere che sia l’Io a costruire rappresentazioni di Sé come oggetto, in modo quindi sostanzialmente riflessivo e consapevole. Dall’altra tuttavia è possibile pensare che vi sia anche un modo preriflessivo di costruzione del Sé in adolescenza, come mostrano tra l’altro le trasformazioni dei riti iniziatici. Vi sarebbe quindi una coscienza primaria, o coscienza affettiva, prima di una coscienza riflessiva.
In queste concezioni, l’accento non è posto quindi su un problema di controllo pulsionale e nemmeno su un problema relazionale, ma sulla mancanza di un senso di Sé in quanto adolescente, che si costituisca come contenitore di senso per il comportamento (Giaconia, 2005). L’antisocialità in questa prospettiva è un blocco nell’acquisizione di un’identità sociale, che da un punto di vista psicologico può essere intesa come acquisizione di un senso di Sé dotato di valore. Molti romanzi per adolescenti descrivono questo passaggio, per esempio attraverso la scoperta di un tesoro, che dà un nuovo valore al soggetto, che molte volte è legato ad un ritrovamento di un’eredità familiare, un processo che Blos ha descritto attraverso un’analisi della dinamica identificatoria dell’adolescente con il genitore dello stesso sesso.
Il problema è come sia possibile aiutare l’adolescente a superare questo blocco evolutivo. In un modo che può apparire paradossale, nella prospettiva di Senise e Novelletto, il processo di soggettivazione che supera il blocco evolutivo sarebbe attivato non tanto attraverso lo sviluppo di una funzione riflessiva volta ad aumentare l’autoconsapevolezza, ma attraverso un intervento che assegna un ruolo centrale al rapporto con l’ambiente. Questa prospettiva implica che la costruzione del Sé in adolescenza è in primo luogo una funzione della relazione dell’adolescente con l’ambiente di sviluppo, come se il Sé si costruisse nella relazione di rispecchiamento con il contesto e non solo attraverso una riflessione o rispecchiamento nel mondo interno dell’adolescente, un processo che Jeammet (1992) descrive attraverso il concetto di uso soggettivo dell’ambiente.
Il cambiamento avviene attraverso nuovi investimenti di senso nelle relazioni tra il soggetto e i suoi oggetti, Le indicazioni di intervento possono essere molteplici proprio perché all’adolescente la realtà esterna offre opportunità di nuovi investimenti: trattamenti psicoterapeutici, pedagogici, psicopedagogici, farmacologici, scelta o cambiamento di scuola, attività extrascolastiche, attività sportive, ridefinizione degli spazi familiari, allontanamento dal nucleo familiare.
L’importanza dell’ambiente terapeutico è sottolineata anche da Novelletto, Biondo e Monniello (2000), per i quali nel comportamento antisociale l’adolescente si rende conto di non avere qualcosa che gli serve per lo sviluppo e cerca un ambiente di soccorso alternativo a quello naturale, anche attraverso un comportamento di sfida. In una prospettiva psicoanalitica questa funzione ambientale non si riduce ad un intervento educativo comportamentale perché l’ambiente non svolge solo con funzioni, ma fornisce rappresentazioni, è un luogo che l’adolescente può riempire di significati (Maggiolini, 2006; Novelletto, Biondo e Monniello, 2000).
Il sistema penale minorile in Italia è molto centrato sulla valutazione della personalità degli adolescenti che commettono reati e sulla valutazione delle risorse delle famiglie nel sostenere il loro cambiamento. Attraverso la misura della Messa alla Prova viene proposto un sistema di prescrizioni atte a favorire la ripresa del loro percorso evolutivo e la valorizzazione della capacità di assumere responsabilità rispetto al proprio comportamento. L’impegno e la capacità nel portare bene a termine un percorso che comprende interventi di riparazione attraverso attività socialmente utili, la ripresa dell’attività scolastica o lavorativa, il monitoraggio sull’uso delle sostanze stupefacenti e percorsi psicoterapeutici ed educativi, consente non solo l’estinzione del reato ma soprattutto la ripresa di uno sviluppo adolescenziale maturo.
Gli adolescenti e i giovani delinquenti cronici, quelli cioè che tendono a commettere ripetutamente reati, vanno dal 3 al 6% di coloro che commettono reati, una percentuale particolarmente bassa. La maggior parte dei denunciati, infatti, ha pochi arresti, ma i pochi che sono recidivi sono responsabili di un’alta percentuale di reati.
Fino agli inizi degli anni Settanta era diffuso il pessimismo sulla possibilità che la delinquenza potesse essere trattata in modo efficace (Martison, 1974). Questa convinzione si è modificata negli ultimi decenni, poiché le ricerche meta-analitiche hanno stimato un’efficacia complessiva nell’ordine del 10-30%, con un risparmio di circa sette volte tanto per ogni euro investito nel trattamento di un adolescente autore di reato, se paragonato al costo per la comunità di una carriera delinquenziale (Losel, 2010; Koehler et al. 2011).
Nel contesto italiano, le ricerche sull’applicazione della messa alla prova confermano la possibilità di modificare il precedente pessimismo rispetto all’efficacia dell’intervento penale: i dati disponibili sulla messa alla prova indicano che l’81.9% dei progetti trattamentali si concludono con un esito positivo (Mordeglia, Piras2011), dato che risulta abbastanza stabile nell’ultimo decennio con un lieve aumento nella tendenza storica per quanto riguarda le pronunce favorevoli (+1.2%; Bartolini, 2011) e che mostra l’efficacia di questo tipo di misura, nonostante la discutibilità giuridica della sua formulazione, che in qualche modo rischia di ridurre le garanzie del minore, che per certi aspetti rinuncia al diritto di difesa (Cesari, 2011). Vi è inoltre una riduzione del numero di condanne a esito di messa alla prova non favorevolmente concluse, che passano dall’8.9% del 2008 al 6%. Sebbene non siano presenti ancora studi longitudinali di follow-up che consentirebbero di stimare in modo preciso quanti ragazzi a seguito di una messa alla prova favorevole commettono altri reati, un dato incoraggiante da questo punto di vista è relativo al fatto che gli studi sulla recidiva (sugli adulti così come sui minori) sono concordi nel ritenere infondata la tesi secondo la quale l’incremento di progetti alternativi alla detenzione porterebbe ad un aumento di soggetti in libertà in grado di delinquere; al contrario, le misure alternative conducono ad un tasso di recidiva statisticamente e significativamente più basso di quello riscontrabile a seguito di condanne o di pene detentive (20% vs 68%).
Bibliografia
Aichorn A. (1951) Gioventù disadattata. Roma: Città nuova, 1978. Seconda conferenza: Analisi di un sintomo, pp. 23-45.
Aliprandi M., Pelanda E., Senise T., (1990), Psicoterapia breve di individuazione. La metodologia di Tommaso Senise nella consultazione con l’adolescente. Feltrinelli, Milano.
Alvarez A. (1997) Chi esercita quali violenze, tecniche diverse per diversi tipi di violenza. Atti del convegno Le vittime e gli autori della violenza, Torino.
Bartolini B. (2011), La messa alla prova del minore. Art. 28 d.P.R. 448/88. Exeo Editore
Bleiberg E. (2001) Il trattamento dei disturbi di personalità nei bambini e negli adolescenti. Roma: Fioriti, 2004.
Blos P. (1979), L’adolescenza come fase di transizione, Armando, Roma 1988.
Blos P. (1991) Il ruolo del padre originario nello sviluppo adolescenziale maschile. In Greenspan S. I., Pollock G. H. (1991) (a cura di) Adolescenza. Roma: Borla, 1997, pp. 11-27.
Cahn R. (1998) L’adolescente nella psicoanalisi. L’avventura della soggettivazione Borla, Roma, 2000.
Cahn R. (2002) La fine del divano? Roma, Borla, 2004.
Cesari C. (2011). “Trasferire la messa alla prova nel processo penale per adulti: condizioni e limiti di una riforma possibile”. In MORDEGLIA, S., MASTROPASQUA I., (a cura di), Esperienze di probation in Italia e in Europa (pp. 151-156). Quaderni dell’osservatorio sulle devianza minorile in Europa. Dipartimento per la giustizia minorile, Centro Europeo di studi di Nisida. Gangemi Editore.
Eissler K.R. (1953) The effect of the structure of the Ego on psychoanalytic technique. J. Amer.
Psychoanal. Assn, 1, 104-143. tr it. in Genovese C. (1988) (a cura di) Setting e processo psicoanalitico. Milano: Raffaello Cortina.
Eissler K.R. (1958) Notes on problems of technique in the psychoanalytic treatement of adolescent. With some remarks on perversion. Psychoanal. St. Child, 13, 223-254.
Giaconia G. (2005) Criminalità e adolescenza. In Giaconia G. (a cura di) Adolescenza e etica.
Monografie della Rivista di Psicoanalisi. Borla, Roma
Jeammet P. (1992) Psicopatologia dell’adolescenza. Borla, Roma.
Jeammet P. (1997) Violence à l’adolescence, Adolescence, 30.
Kernberg O. (1997) La diagnosi delle patologie narcisistiche in adolescenza. In Pissacroia M. (1997) Trattato di psicopatologia dell’adolescenza Piccin, Padova.
Kernberg O. (1999) Psicodinamica e gestione psicoterapeutica dei transfert paranoide, psicopatico e narcisistico. Adolescenza, 10.
Koelher J.A., et al (2011) “The Effectiveness of Treatment Programmes to Reduce Juvenile Reoffending in Europe: A Systematic Review and Meta-Analysis” Paper presented at the annual meeting of the ASC Annual Meeting, Washington Hilton, Washington, DC
Loesel F. (2010) What Works in Reducing Reoffending: A Global Perspective. First European Seminar of the STARR Project, Cambridge, UK
Maggiolini A. (2014) (a cura di) Senza paura senza pietà Raffaello Cortina Milano
Maggiolini A., Pietropolli Charmet G. (2004) (a cura di) Manuale di psicologia dell’adolescenza: compiti e conflitti. F. Angeli, Milano
Maggiolini A. Saottini C. (2009) L’intervento psicoanalitico con gli adolescenti antisociali nel contesto istituzionale. In Essere adolescenti oggi (a cura di) S. Bonfiglio, R. Goisis Quaderni del Centro Milanese di Psicoanalisi
Martinson R. (1974) What works? Questions and answers about prison reform. The public interest, 10, 22-54.
McGuire J. (ed.) (1995) What works: reducing reoffending. Guidelines from research and practice. John Wiley and Sons. Chichester.
Meltzer D., Harris M. (1981) Psicopatologia dell’adolescenza, Borla, Roma.
Moffitt A. (2003), Life-course persistent and adolescent-limited antisocial behavior: a 10-year research review and a research agenda, in Lahey B.B., Moffitt T.E., Caspi A. (2003) cit.
Mordeglia S., Piras, M.L. (2011), “La messa alla prova: elementi di forza, criticità e ipotesi di sviluppo. Rielaborazione critica di contributi di casi e buone prassi”. In Mordeglia S., Mastropasqua I. (a cura di). Esperienze di Probation in Italia e in Europa. Quaderni dell’osservatorio sulla devianza minorile in Europa. Dipartimento per la Giustizia Minorile. Centro Europeo di Studi di Nisida. Gangemi, Roma.
Novelletto A. (1986) Psichiatria psicoanalitica dell’adolescenza. Roma: Borla.
Novelletto A., Biondo D., Monniello G. (2000) L’adolescente violento. Riconoscere e prevenire l’evoluzione criminale. F. Angeli, Milano.
Person E.S., Cooper A., Gabbard G.O. (2005) Psicoanalisi. Teoria, clinica, ricerca. Raffaello Cortina: Milano
Redl F. (1966), Il trattamento psicologico del bambino. Boringhieri, Torino 1977.
Richard F., Wainrib S. (2006) La subjectivation. Paris: Dunod.
Rutter M., Giller H., Hagell A. (1998) Antisocial behavior by young people. Cambridge University Press.
Saottini C. (1999) Molestie sessuali e adolescenza. Adolescenza, 10, 1, 40-52.
Saottini C. (2002) – Sostegno alla ripresa evolutiva in un gruppo di adolescenti. La funzione del gruppo omogeneo a tempo limitato nel contesto istituzionale penale Gruppi 1, 85-99.
Senise T. (1990) La rappresentazione del Sé e i processi dei separazione/individuazione nell’adolescente. In Aliprandi M., Pelanda, E., Senise T. Psicoterapia breve di individuazione. Milano: Feltrinelli, pp. 31-45.
Winnicott D.W. () La delinquenza come sintomo di speranza. In Feinstein S.C., Giovacchini P.L., Psichiatria dell’adolescente. Roma, Armando, 1989, pp. 137-144.
Marzo 2015
Vedi anche:
Dibattito su: “L’Adolescente e il suo Corpo” a cura di F. Carnaroli e A. Nicolò
Adolescenza/diagnosi

hold_me__by_Rooze Mirjan
La diagnosi in adolescenza
A cura di Giovanna Montinari
L’adolescente nella diagnosi
L’adolescenza segna l’inizio di un’attività autodiagnostica del soggetto, a differenza del fatto che durante l’infanzia la diagnosi del bambino è fatta da altri: genitori, educatori, operatori delle istituzioni ecc.. L’ottica di osservazione si dovrà perciò muovere in un continuum fra l’ascolto del soggetto adolescente e la valutazione diretta o indiretta del contesto relazionale e affettivo in cui l’adolescente è inserito. La diagnosi in adolescenza, non va intesa soltanto come riconoscimento obiettivo di uno stato, né come individuazione della causa dei sintomi, ma come un tentativo di scoperta del Sé segreto dell’adolescente (Novelletto 1986), nei suoi vari aspetti, sia funzionanti che disturbati.
Nel periodo dello sviluppo psichico normale che si definisce adolescenza, il soggetto va incontro ad un insieme di trasformazioni intrapsichiche intimamente correlate, che lo porteranno ad integrare nel proprio Sé il corpo sessuato, capace di generare, l’appartenenza all’uno o all’altro dei due sessi, che sono complementari.
Questi processi sono intimamente correlati con lo sviluppo dell’esame di realtà, nei suoi aspetti cognitivi e di pensiero.
Il bagaglio di identificazioni che il bambino porta con sé e che si era formato sulla base di idealizzazioni degli oggetto primari (i genitori) va incontro ad un’adeguamento alla realtà, che mette in gioco il problema della perdita, che porta con sé il lavoro del lutto. Ciò richiede che l’attenzione dell’osservatore si rivolga agli aspetti economici del funzionamento mentale dell’adolescente; cioè al disinvestimento della cariche istintive che egli fa rispetto agli oggetti del passato e all’investimento su altrettanti oggetti nuovi.
Durante tutto il suddetto processo di rimaneggiamento e di perdita, il sistema Io-Sé diviene particolarmente bisognoso di sostegno. Quest’ultimo avviene dapprima sul modello della dinamica di doppio, cioè privilegiando oggetti affini (per sesso, età, somiglianza ecc.). Però se da un lato l’amore per “lo stesso” rinforza il narcisismo, dall’altro esso va a detrimento dell’amore per “l’altro”, il diverso da sé per le stesse caratteristiche (sesso, età e altre differenze). Le amicizie particolari della prima adolescenza svolgono questo ruolo, e così pure il dialogo con lo specchio. Si definiscono oggetti-Sé quelli che vengono scelti per salvaguardare la coesione del Sé, cioè che consentono l’uso narcisistico di oggetti esterni.
Un aspetto importante di questa evoluzione dell’esame di realtà è la possibilità di distinguere tra realtà esterna e realtà interna. L’oggetto reale esterno deve poter essere percepito come tale e non come ricettacolo dei desideri e delle aspettative che il soggetto proietta su di lui come pura espressione del desiderio.
L’azione come mezzo per influire costruttivamente sulle condizioni reali esterne (ad esempio per mettersi in contatto con l’oggetto dei desideri) deve potersi liberare dal primato del principio del piacere ed essere modulata in base ai dati dell’esame di realtà.
L’energia istintuale aggressiva, indispensabile alla conquista e alla creazione del legame con l’oggetto, deve poter perdere le connotazioni di onnipotenza, distruttività ed urgenza che possedeva nelle fasi di sviluppo precedenti.
Lo sviluppo dell’attività, introspettiva dovuta ai rimaneggiamenti sopra detti, induce l’adolescente a formulare una sua diagnosi autonoma . Spesso le definizioni che costruisce di sé sono affrettate, esagerate, autolesionistiche, alcune ben note: la dismorfofobia, l’anoressia, il destino fallimentare, le distorsioni dell’identità, l’isolamento ecc. Negli adolescenti meno disturbati questa attività è invece circondata dal riserbo, tutt’al più possono condividerla con i pari scelti elettivamente (Novelletto1986). Il lavoro terapeutico consiste spesso sostanzialmente nell’aiuto a rendere compatibili e confrontabili queste due diagnosi. Tale lavoro si pone come il primo tentativo del terapeuta di mostrare al paziente aspetti nuovi della propria diagnosi.
Il processo diagnostico con l’adolescente si pone fin dalle prime battute come lo spazio per un possibile passaggio che fa evolvere l’immagine di Sé da diagnosi segreta a diagnosi condivisa, passo essenziale verso l’assunzione di un’identità pubblica, complementare a quella di altri e pre-condizione per la creazione di nuove reazioni.
Fin dal primo colloquio con l’adolescente queste dinamiche sono parte integrante del processo diagnostico. Il bisogno difensivo di differenza e di ambiguità rende impossibile all’adolescente accedere sollecitamente ad una negoziazione. La valutazione che il terapeuta fa dentro di sé deve spesso essere immediata, perché può essere urgente trovare l’equidistanza tra l’interesse dell’adolescente per una maggiore conoscenza di sé, che però lo allarma, e la banalità dell’incontro, che lo delude (Donnet1983). Da parte sua il terapeuta deve trovare l’ascolto interno del proprio controtransfert, che è la matrice dell’interpretazione diagnostica.
Dunque l’incontro tra terapeuta e adolescente possiede da entrambi i lati una dimensione creativa importante, che però richiede il superamento di tutte le operazioni difensive con cui l’adolescente cerca di occultare il proprio mondo interno e, da parte dell’osservatore, il superamento della preoccupazione di trovare la distanza giusta tra l’intrusione o l’eccessivo riserbo.
Diversi autori hanno nel tempo proposto modelli di valutazione nel tentativo di inquadrare sia il processo che l’organizzazione, della personalità in divenire dell’adolescente. Fra questi Kernberg (1984) con l’uso dell’intervista per la diagnosi dell’adolescente, centrata sulla valutazione dell’interazione esistente fra l’intervistatore e l’adolescente in un procedimento circolare che correla la storia dei sintomi con la relazione terapeutica. Molto utili sono le categorie di valutazione di massima, come quelle proposte da Laufer (1984) che distingue tre categorie: 1) il funzionamento difensivo; 2) la situazione di stallo; 3) la conclusione prematura dello sviluppo. Altri autori proposto un atteggiamento diagnostico più integrato (Novelletto 1986, Monniello 2005,2014, Nicolò 1992, 2014) con il pensiero psicoanalitico, come Jammet (1980) nella importante chiarificazione sulla specificità del funzionamento mentale dell’adolescente che si muove in un continuum fra il mondo interno e il mondo esterno, tale per cui l’uso che egli fa delle relazioni e dell’altro è funzionale non solo alla sua economia narcisistica ma al trattamento delle sue istanze interiori. Il contributo radicale e prezioso proposto da R. Cahn (1998) con il concetto di soggettivazione, considera l’adolescenza un tempo organizzatore l’identità del soggetto, un tempo deputato allo sviluppo della soggettivazione e al conseguimento dei compiti evolutivi propri di quella fase. Processo di soggettivazione che perdura nel corso di tutta la vita a seconda di come si è concluso e risolti nella fase dell’adolescenza.
Novelletto (1986) in questa direzione ha sviluppato il concetto di “diagnosi prolungata”, una sorta di trattamento di prova in cui l’operatore può rendersi conto dello stato dell’arte dello sviluppo dell’adolescente, dei suoi rimaneggiamenti difensivi, può valutare il rapporto fra investimenti narcisistici e investimenti oggettuali e in sostanza saggiare la propensione alla terapia dell’adolescente. Anche T. Senise proponeva un processo di valutazione differenziato fra genitori e adolescenti definendo il proseguo della valutazioni una “psicoterapia breve di individuazione”.
Si evince che la letteratura psicoanalitica declina in diversi modi sia il punto dello sviluppo sia il tema relativo al quadro psicopatologico emergente in adolescenza. Le caratteristiche provvisorie e mobili delle patologie adolescenziali indicono ad una prudenza nelle generalizzazioni i invitano alla valutazione caso per caso, seguendo una linea generale dell’intreccio fra asse narcisistico e asse oggettuale.
L’osservazione diagnostica basata sulla tecnica dell’osservazione dinamica, valorizza in modo particolare il racconto della propria storia da parte dell’adolescente, ritenuta da quest’ultimo un patrimonio narcisistico ( Novelletto 2006). L’osservatore si trova spesso di fronte a tre storie: quella raccontata dai genitori, quella che il figliotenta di costruirsi dentro di sé (condividendo brani di quella dei genitori, rifiutandone altri e
aggiungendone altri ancora) e infine quella che egli è in grado di comunicare, seguendo i propri bisogni di causalità e le necessità della propria economia narcisistica
Molto importanti sono anche i sentimenti che accompagnano invariabilmente il racconto della propria storia , essi sono ispirati dall’assetto narcisistico del passato.
E’ insomma evidente, oltre al valore diagnostico, anche quello prognostico della storia come indicatore delle possibili scelte terapeutiche utili a quel soggetto adolescente.
Si può dire che l’osservatore funge da animatore della storia del paziente, ma lo fa indirettamente, attraverso l’effetto provocatorio che il transfert produce nel paziente. L’imprevedibilità dell’incontro con un oggetto nuovo, che è propria delle consultazioni iniziali, può spesso offrire spunti di transfert rivelatori delle capacità dell’adolescente di fare nuovi legami, e del come la relazione con altro viene percepita e usata.
In ogni caso il transfert organizza nuove aggregazioni, spesso inattese e sorprendenti per lo stesso paziente, degli eventi e dei ricordi del passato che egli credeva talvolta di avere già archiviati in una propria storia.
Data l’importanza del transfert nel corso della raccolta della storia, è opportuno ricordare,
oltre al transfert oggettuale, anche i vari tipi di transfert narcisistico che l’adolescente può presentare, ( Kohut1971).Trattandosi di una relazione a due, è ovvio che si prendano in considerazione anche le risposte emotive del terapeuta di fronte al transfert dell’adolescente. Non di meno è necessario conoscere le risposte ai transfert narcisisti che l’adolescente può fare su di noi, e cioè il controtransfert speculare e quello idealizzante.
Nella maggiore parte dei manuali di psicopatologia dell’adolescenza ( Marcelli e Braconier, Ammaniti) si trovano di solito schemi di osservazione che hanno lo scopo di elencare ordinatamente i dati da raccogliere nel corso dei colloqui e di altre eventuali indagini sull’adolescente, eventualmente anche sui suoi famigliari.
Ciò contribuisce ad aiutare l’operatore ad orientarsi verso una valutazione diagnostica del caso.
Naturalmente questa diagnosi potrà essere intesa in modo diverso a seconda dell’orientamento teorico-tecnico di ciascun osservatore o del servizio istituzionale del quale egli fa parte (Monniello 2005,) , qualunque sia il destinatario della valutazione diagnostica, e qualunque sia il metodo di raccolta e di descrizione dei dati forniti dal paziente, l’osservatore dovrà tenere nel massimo conto tutto quello che si origina nella propria mente, perché è proprio da quella zona, definita “preconscio” (proprio perché è intermedia fra inconscio e coscienza e strettamente legata al Sé) che provengono spontaneamente le intuizioni da cui potrà formarsi un giudizio relativamente partecipe sull’osservato. Questo processo, che fa parte del cosiddetto “controtransfert” prende inizio sotto forma di elementi psichici rozzi, prevalentemente emotivo-affettivi che, se non prematuramente repressi dall’osservatore come interferenze indebite, nel loro transito verso una coscienza più piena, si integreranno con percezioni, apporti di pensiero, ricordi, operazioni intellettive, fino a raggiungere lo stato di veri e propri giudizi. E’ grazie a questo lavoro spontaneo, non intenzionale, che il resoconto diagnostico dell’osservatore, anziché limitarsi ad una operazione esclusivamente razionale di collegamento fra dati psichici singoli, funzioni sane o deviate e presunte cause, potrà assumere le caratteristiche di un incontro umano vissuto e perciò suscettibile di fungere da modello per ogni altra relazione possibile (Montinari-Natali 2005).
La tecnica dell’osservazione psicodinamica permette di arrivare alla formulazione dei quesiti diagnostici in merito a quali delle tappe di sviluppo sono state raggiunte oppure no e quale rapporto causale può esservi tra gli eventuali arresti e ritardi di sviluppo, da un lato, e i disturbi dall’adolescente osservato dall’altro.
Lo scopo di questa valutazione dello sviluppo psichico del soggetto sta nel definire il grado della sua vulnerabilità psichica, innanzi tutto ai fini del rischio più grave che l’adolescente può correre, cioè quello del breakdown (rottura psicotica o come lo definiscono i Laufer) sempre che il breakdown non si sia già verificato e che sia proprio quello il motivo della consultazione.
Le decisioni in merito a qualsiasi forma d’intervento devono tener conto del danno che si è verificato, che continua a sussistere o che può verificarsi nel processo evolutivo dell’adolescente.
Il traguardo diagnostico ideale è quello di raggiungere un giusto equilibrio tra valutazione dei dati obiettivi (tra cui i sintomi) e quelli soggettivi (in particolare le nostre risonanze controtransferali di osservatori partecipi) di fronte all’interazione che l’adolescente che abbiamo davanti stabilisce con noi, alle sfumature transferali che possiamo cogliere fin dal primo incontro. Non di meno saranno rilevanti le valutazioni riguardo alle dinamiche familiari e della coppia genitoriale (Carbone 2005)
Tra i fattori che possono aiutare di più l’analista a definire la possibilità per l’adolescente di accedere ad una psicoterapia, vi è la capacità della coppia analitica di costituire un’alleanza terapeutica, la capacità di sfruttare l’analisi del transfert, la possibilità di collocare il lavoro analitico (raccolta del materiale, interpretazione, elaborazione) in un’area non troppo conflittuale dell’Io.
Tornando alla fase di valutazione iniziale, è importante che nel corso di essa l’osservatore non assuma prematuramente un atteggiamento analitico rigoroso (silenzio, neutralità dell’atteggiamento, assenza di domande, ecc…). Quello che conta è che la risposta al paziente sia totale, cioè comprenda i dati oggettivi e quelli soggettivi, il presente e il passato, i sintomi e l’organizzazione di base, la risonanza controtransferale immediata e la riflessione meditata.
Bibliografia
Ammaniti M., a cura di, Manuale di Psicopatologia dell’adolescenza, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2002
Cahn R. (1998) L’adolescente nella psicoanalisi. L’avventura della soggettivazione, Roma, Borla 2000
Carbone P., Genitori e figli, in a cura di Carbone P., Adolescenze, Roma Magi edizioni, 2005
Donnet J.L.(1983), Sur la rencontre avec l’adolescent, “Adolescence”,1,1, 1083, pp.45-61
Freud S. (1989), “Ricordi di copertura”, in Opere, vol 2, Torino, Boringhieri,1968, pp.435-453
Jammet P., Psicopatologia dell’adolescenza, Roma Borla, 1992
Kernberg O. ( 1984) Disturbi gravi della personalità, Torino, Bollati-Boringhieri, 1987
Kohut H. (1971), Narcisismo e analisi del Sé, Torino, Boringhieri, 1976, pp.80-143
F. Ladame,M Perret-Catipovicc (1998), Gioco ,fantasmi e realtà, cap.3.” L’adolescenza.La posta in gioco dello sviluppo e le difficoltà di valutazione pag., Milano, Franco Angeli,2000
Laplance J., Pontalis J.B., (1967), Enciclopedia della psicoanalisi, Bari, Laterza, 1968
Laufer M.,Laufer M.E. (1985) , Adolescenza e breakdown evolutivo, Torino, Boringhieri, 1986, pp.195-214
Marcelli D., Braconier A., (1983), Adolescenza e psicopatologia, V°edizione italiana a cura di Ammaniti M.,Novelletto A., Milano, Masson 1999
Monniello G., a cura di, Luoghi istituzionali e Adolescenza, Quaderni di Psicoterapia Infantile n.51, Roma, Borla, 2005
Monniello G., Un giorno questa adolescenza ti sarà utile, in Adolescenza e psicoanalisi oggi nel pensiero italiano, a cura di G.Montinari, Milano Franco Angeli editore, 2014
G. Monniello,L.Quadrana, Neuroscienze e mente adolescente, cap.X pag.85, Roma Edizioni Magi 2010
Montinari G.,Natali M.F., Una lettura psicoanalitica dell’aiuto psicologico agli adolescenti. L’esperienza della Cooperativa Rifornimento in volo, in Luoghi istituzionali e adolescenza, a cura di Monniello G., Quaderni di Psicoterapia Infantile,n.51, Roma Borla , , 2005
Nicolò A.M.,Zavattini G.C., l’adolescente e il suo mondo relazionale, Roma , NIS 1992
Nicolò A.M., L’adolescenza, una sfida per lo psicoanalista. Come il lavoro con gli adolescenti ci ha costretto a ripensare i nostri modelli, in “Adolescenza e psicoanalisi oggi nel pensiero italiano”, a cura di, G. Montinari, Roma,Franco Angeli 2014
Novelletto A. (1985), nascita e sviluppo della diagnosi, dalla mente del terapeuta a quella dell’adolescente, in Psichiatria psicoanalitica dell’adolescenza, Roma, Borla, 1991, pp.97-101
Novelletto A., Psichiatria Psicoanalitica dell’adolescenza, Roma, Borla, 1986
Novelletto A., (2005), La valutazione diagnostica, in Carbone P. (a cura di). Adolescenze. Roma. Magi 2005
Novelletto A., L’adolescente. Una prospettiva psicoanalitica, Roma Astrolabio 2009
Febbraio 2015
Vedi anche:
Anna Maria Nicolò – Organizzazione difensive nei breakdown
Affido familiare
A cura di Benedetta Guerrini Degl’Innocenti
Cos’è l’Affido Familiare?
L’affido familiare è un provvedimento disciplinato da una legge dello Stato che si fonda sul riconoscimento del diritto del minore ad avere una famiglia. Quello che la legge n. 184 del 1983, poi modificata dalla Legge n. 149 del 2001, stabilisce è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno ad un minore proveniente da una famiglia che al momento non è in grado di occuparsi delle sue necessità. Attraverso l’affidamento, il bambino incontra una famiglia che, accogliendolo nella propria casa e nella propria vita, si impegna ad assicurare un’adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi, educativi, di mantenimento ed istruzione nel rispetto della sua storia individuale e familiare. Alla base quindi di questa legge ci sta il fondamentale riconoscimento dell’importanza vitale che rappresenta, per l’avvenire della salute mentale, la qualità delle cure prodigate al bambino dalle figure genitoriali nei primi anni dell’infanzia.
Accudimento e funzione genitoriale
La funzione genitoriale è un compito che ha a che fare con l’allevamento dei bambini, un compito che prevede la messa in atto di un ambiente favorevole allo sviluppo cognitivo e sociale, un compito che riguarda la capacità genitoriale di rispondere alle situazioni di disagio del bambino, ai suoi approcci sociali, alle sue necessità così come ai suoi comportamenti negativi; un compito che ha a che fare con la risoluzione dei conflitti e delle difficoltà interpersonali.
Per queste ragioni la realizzazione di un’adeguata funzione genitoriale richiede delle “capacità” di vario genere che si possono sintetizzare nello sviluppo di una sensibilità ai segnali che vengono dal bambino e nella capacità di rispondere adeguatamente ai differenti bisogni che caratterizzano le diverse fasi del suo sviluppo; nella capacità di gestire le interazioni sociali, le situazioni difficili e gli eventi vitali perturbanti; nel sapere come giocare e parlare con il bambino e in un uso della disciplina tale da ottenere la messa in atto del comportamento desiderato da parte del bambino in un modo che risulti armonico ed adeguato a favorire l’incremento del suo auto-controllo (Rutter, 1989).
Dati emersi da ricerche effettuate in popolazioni di diverse culture sembrano suggerire che madri socialmente isolate che portano da sole l’intero carico della responsabilità diventano più frequentemente rifiutanti verso i propri figli. Questo suggerisce la necessità di una prospettiva che potremmo definire “ecologica”, che riconosca che la famiglia è un sistema funzionale la cui operatività può essere alterata dalla sua composizione interna così come da situazioni esterne (Bronfenbrenner, 1979). Una tale prospettiva implica che si debba rivolgere un’attenzione speciale alla genitorialità intesa in termini di risorse emozionali disponibili per il genitore.
Anche le risorse pratiche, intese come fonti di supporto quotidiano nella gestione dei figli, hanno una loro importanza e un peso, anche se, naturalmente, la mancanza di supporto materiale non può essere considerata come una variabile completamente indipendente rispetto a quelle che spesso sono le difficoltà interpersonali della famiglia. In altre parole si può pensare che la povertà di risorse esterne di certe famiglie rifletta abbastanza fedelmente quelle che sono le insoddisfacenti relazioni sociali primarie della famiglia stessa, un profondo bisogno di supporto pratico ed emotivo e probabilmente anche la conseguenza di frequenti cambiamenti di casa e di ambiente sociale che rende assai difficile sviluppare buone relazioni di aiuto e di vicinato.
Il supporto sociale non è qualcosa che è di per sé disponibile o meno nell’ambiente circostante, ma riflette abbastanza chiaramente la forza o la debolezza sviluppata da ciascuno nell’elicitare o attrarre il sostegno da parte degli altri.
Poiché i figli tendono a identificarsi inconsapevolmente con i genitori sotto vari aspetti, e pertanto ad adottare, quando siano diventati a loro volta genitori, verso i propri figli gli stessi modelli comportamentali che hanno essi stessi sperimentato durante la propria infanzia, modelli di interazione sia adattivi che disadattivi si trasmettono più o meno fedelmente da una generazione all’altra. Pertanto l’eredità della salute mentale e della malattia mentale tramite la microcultura familiare è certamente non meno importante di quanto sia l’eredità tramite i geni e forse anche più importante.
Le cause del disfunzionamento genitoriale sono indubbiamente complesse, ma sia la violenza fisica che sessuale, che la trascuratezza, riconoscono al fondo dei sentimenti negativi verso i bambini.
Se una società vuole davvero aiutare i bambini in difficoltà – scriveva John Bowlby – deve trovare un modo per aiutare i loro genitori e l’importanza della teoria dell’attaccamento sta nel fatto che ha dato consistenza scientifica allo studio del legame che i bambini e i loro genitori (o le persone più importanti che si prendono cura di loro) stabiliscono fin dagli stadi precoci dello sviluppo (Bowlby, 1958; 1969).
Attaccarsi, separarsi e affidarsi
In un noto libro Myriam David (1989) suggerisce che le situazioni che conducono all’affidamento scaturiscono prevalentemente da una sorta di “intolleranza madre- bambino” che sarebbe da ricondurre ad un precoce disturbo del processo di costruzione delle strategie di attaccamento. Tale intolleranza potrebbe essere sufficientemente consapevole da motivare la richiesta di affidamento da parte degli stessi genitori, caso a dire il vero non molto frequente, o, più facilmente, essere più o meno occulta, inconscia, e manifestarsi o attraverso la comparsa di sintomi di disagio o di sofferenza psichica nel bambino, o attraverso un improvviso e spesso violento passaggio all’atto da parte del genitore.
Anche altri autori hanno sottolineato come l’elemento strutturale comune di molte famiglie multiproblematiche sia riconducibile ad una distribuzione patologica di stili relazionali assimilabili a categorie di attaccamento quali l’“invischiamento” e il “disimpegno”, e come mostrino al loro interno oscillazioni continue fra un totale coinvolgimento e invischiamento fra i membri da un lato, ed il disinteresse, il disimpegno reciproco, in particolare dei genitori per i figli dall’altro. All’oscillazione tra coinvolgimento e disimpegno corrisponderebbe poi quella tra attitudini fusionali e brusche separazioni che, nella loro forma più estrema, si possono manifestare come veri e propri abbandoni, sia fisici che psicologici (Stierlin, 1978).
Da questi contributi sembra emergere una sostanziale convergenza riguardo alla centralità dei processi di separazione-individuazione e dei loro aspetti problematici raffigurantesi nei comportamenti ambivalenti e ambitendenti dei genitori problematici e di come questi possano innescare quei meccanismi di espulsione che inducono l’affidamento familiare. Del resto è ormai ampiamente documentata in letteratura la frequenza di “cicli dell’abuso”, intendendo il termine di abuso nel suo significato più estensivo che include accanto alle forme estreme e conclamate di grave maltrattamento fisico e di abuso sessuale, tutte quelle situazioni ben più subdole di abuso emotivo e di trascuratezza fisica e psicologica. Il bambino emotivamente deprivato di oggi diventa il genitore trascurato di domani: le esperienze avverse vengono internalizzate dal bambino che cresce in modo tale da condurre ad altre esperienze avverse, perpetuando così il circolo negativo della patologia.
D’altra parte, la ricerca sull’attaccamento ci mostra come per il bambino nel primo anno di vita sia condizione indispensabile per lo sviluppo psicologico, la presenza di una figura di accudimento stabile, capace di assicurare un’interazione affettiva e per mezzo della quale costruire una strategia di attaccamento il più possibile “sicura”, strategia che rappresenterà nel futuro lo schema di riferimento per i rapporti con se stesso e con il mondo. È per questo motivo che, soprattutto nelle situazioni in cui la relazione familiare disfunzionale coinvolge un bambino nei primi due anni di vita, la scelta dell’affido familiare può rappresentare una nuova occasione per il bambino e per i genitori naturali di far ripartire il percorso evolutivo su un binario più sicuro.
E’ abbastanza inevitabile pensare che l’affido di un bambino molto piccolo, ad eccezione di quelle situazioni in cui si possa ipotizzare subito una probabile evoluzione verso l’adottabilità, deve necessariamente essere pensato come una forma di presa in carico di tutto il nucleo familiare (Guerrini Degl’Innocenti, 2015). Infatti la famiglia affidataria può rappresentare non solo un’occasione per quel bambino di riabilitare la propria capacità interattiva precocemente interrotta o disturbata dalle distorsioni delle relazioni genitoriali e familiari, ma anche una nuova occasione per i genitori naturali di sperimentare loro stessi una forma di sostegno e di aiuto. Molto spesso le difficoltà relazionali precoci sono leggibili come una forma di riattualizzazione da parte dell’adulto divenuto genitore, di un’immagine del sé bambino trascurato, fisicamente e/o psicologicamente, talvolta abusato o, al contrario, iperinvestito fino a complete inversioni di ruolo in cui il bambino viene trasformato nel genitore del proprio genitore. Queste dinamiche, nella maggior parte dei casi non elaborate e quindi inconsce, fanno sì che quel genitore trascurato, abusato o negletto possa inconsapevolmente proiettare sul proprio figlio quella parte così danneggiata del sé infantile allo scopo, sempre inconscio, di liberarsene. Al tempo stesso quello che viene messo in atto è un modello operativo interno patologico della relazione di attaccamento, modello che quel genitore ha strutturato nei primissimi anni dell’infanzia nella interazione quotidiana con i propri genitori.
L’affido, che interviene a regolamentare sia la separazione fra il bambino e i suoi genitori che a stabilire le modalità di incontro e scambio, può così aiutare questo nucleo disfunzionante a compiere il percorso verso l’elaborazione dei processi di separazione e individuazione, laddove la separazione fisica di fatto stabilita serva a promuovere quella separazione psichica che può contribuire alla ristrutturazione del sistema familiare.
Bibliografia nel testo
Bronfenbrenner U. (1979), The ecology of human development: experiments by nature and design. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Bowlby J. (1958), The nature of the child’s tie to his mother. International Journal of Psychoanalysis, 39, 350-373.
Bowlby J. (1969), Attaccamento e perdita. 1: L’attaccamento alla madre, Boringhieri, Torino, 1983.
David M. (1989), Le placement familial. De la pratique à la théorie. ESF Paris.
Guerrini Degl’Innocenti B. (2015) I legami di cura: attaccarsi, separarsi, affidarsi. Famiglia e Diritto. Mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2: 199-204.
Rutter M. (1989), Intergenerational continuities and discontinuities in serious parenting difficulties, in D. Cicchetti & V. Carlson (Ed.), Child Maltreatment, Cambridge University Press.
Stierlin H. (1978), La famiglia e i disturbi psicosociali, Boringhieri, Torino, 1983.
Voci bibliografiche di riferimento generale
AAVV (1997), Un bambino per mano. L’affido familiare, una realtà complessa. Franco Angeli, Milano.
Barbagli M., Saraceno C. (1997) Lo stato delle famiglie in Italia. Il Mulino, Bologna.
Mazzucchelli F. (1993) (a cura di) Percorsi assistenziali e affido familiare. Franco Angeli, Milano.
Nunziante Cesaro A., Ferraro F. (1992) (a cura di) La doppia famiglia. Discontinuità affettive e rotture traumatiche. Franco Angeli, Milano.
Vedi anche :
In Dibattiti: Dibattiti IPA: le nuove famiglie
Allucinatorio/ Allucinazioni
A cura di Antonello Correale
L’allucinazione, che in psichiatria viene classicamente definita come una percezione senza oggetto, è considerata in psicoanalisi come la punta estrema di un fenomeno percettivo molto più ampio, che può essere definito allucinatorio.
Per allucinatorio, si intende un pensiero, un’immagine, una traccia mnestica, un particolare percettivo, che assumono una iperchiarezza, una vivacità sensoriale, una coloritura così intensa, da occupare lo spazio mentale, rallentare o addirittura impedire il flusso associativo e determinare sul soggetto che lo prova una sorta di ipnosi, di incantamento, di catturamento quasi totale dell’attenzione.
Le caratteristiche dell’allucinatorio, oltre alla iperchiarezza e alla vivacità sensoriale, sono una perdita della terza dimensione, un allentamento del rapporto figura – sfondo, una perdita di un punto di vista particolare. L’immagine viene insomma in larga misura decontestualizzata e rimane come sospesa nella mente, potente e isolata in una sorta di fissità.
Freud ha fatto dell’allucinatorio uno dei pilastri del suo pensiero, al punto di arrivare a dire che la percezione è sempre in prima istanza allucinatoria.
Per comprendere questa affermazione, bisogna considerare che Freud pensa che il soggetto- bambino è sempre dominato da un desiderio violento di oggetto e delle soddisfazioni che l’oggetto può offrigli o offrirle.
Quando l’oggetto è assente e quindi non in grado di offrire le soddisfazioni richieste, il bambino allucina cioè presentifica l’oggetto alla mente, in forma particolarmente intensa e eccitante, per compensare la delusione dell’assenza. Solo gradualmente, attraverso il ritmo assenza- presenza, la madre permette al bambino di riconoscere una presenza reale fuori di sé e di rinunciare alla gratificazione allucinatoria in nome dell’oggetto reale.
Nel lavoro La negazione, Freud riprende questa tema e arriva a dire, che solo il ritrovare l’oggetto ne permette il riconoscimento di realtà. Se l’oggetto non viene ritrovato, ma solo trovato, la percezione rimane in prima istanza allucinatoria.
Insomma, Freud ritiene che il principio del piacere influenzi profondamente il principio di realtà, al punto che solo un’insistenza dell’oggetto sul soggetto permette che al principio del piacere – è buono, è cattivo – si aggiunga il principio di realtà – è vero, non è vero.
Freud distingue poi i ricordi di copertura e l’allucinatorio vero e proprio.
Nei ricordi di copertura, un desiderio verso un oggetto proibito si sposta su un oggetto contiguo, incapace in se stesso di procurare desiderio, ma investito perché vicino all’oggetto desiderato. Questo meccanismo è presente nelle nevrosi e in particolare nell’isteria.
Nell’allucinatorio vero e proprio, il desiderio e i meccanismi di divieto e di difesa che mette in atto, la fa da padrone e l’oggetto allucinatorio prende il posto addirittura dell’oggetto reale. Questo meccanismo è tipico, secondo Freud, della psicosi.
La Klein pone l’allucinatorio sotto il segno della scissione. L’aggressività rabbiosa che domina il bambino lo spinge o la spinge a scindere addirittura la percezione, che viene attaccata e frammentata. L’allucinatorio e il suo polo estremizzato, l’allucinazione, sono frammenti di una percezione sotto attacco.
Il tema verrà ancora più fatto avanzare da Bion, che pone tutto l’allucinatorio sotto l’egida dei meccanismi della identificazione proiettiva maligna, un attacco evacuativo non solo al pensiero, ma anche alla percezione, in obbedienza a intensi bisogni espulsivi dell’attività di pensiero.
Winnicott modifica questo approccio e individua un percorso che potremmo chiamare dall’allucinazione alla illusione. La madre-oggetto transizionale raccoglie tracce dell’allucinatorio, per inserirle nella attività condivisa dell’illusione.
Più recentemente, nell’ottica di una ripresa attenta del pensiero freudiano, i Botella affermano che l’allucinatorio è l’effetto del trauma. La scomparsa improvvisa di un oggetto investito potentemente non lascia un vuoto, ma un pieno di frammenti sensoriali allucinatori, che hanno il fine di mantenere, trattenere qualcosa dell’oggetto, per non sprofondare in un vuoto affettivo e rappresentativo.
I Botella chiama lavoro della raffigurabilità psichica questo operare sull’allucinatorio, che diviene così, nella loro ottica, non più un elemento di scarto, ma addirittura la via maestra per recuperare una certa possibilità di rappresentazione dell’oggetto perduto.
Possiamo riassumere dicendo che l’allucinatorio è un attività fondamentale della mente, al servizio della pulsione, ma che assume una rilevanza del tutto particolare in alcune condizioni, come il trauma, l’isteria, la psicosi.
Può essere considerato come frutto di un espellere o come frutto di un trattenere. E’ questo un dibattito fondamentale nella psicoanalisi contemporanea, i cui risultati possono determinare una modifica profonda nelle modalità di trattamento della psicosi cronicizzata e dei disturbi gravi di personalità, nonché nei casi sempre più frequenti di isteria grave.
In ogni caso è fondamentale un’attenzione assoluta al fenomeno nell’attività clinica.
Febbraio 2014
Allucinazioni uditive
A cura di Gabriella Giustino
Anche se le allucinazioni possono interessare tutti i sensi (la vista, l’udito, il tatto, l’olfatto, il gusto), quelle più studiate e frequenti sono quelle acustiche.
Un punto importante nello studio delle allucinazioni è quello che riguarda il giudizio di realtà.
In che modo il paziente conferisce un carattere di realtà a stimoli che, fuori di ogni ragionevole dubbio, nascono dalla sua mente?
Un elemento caratteristico dello stato allucinatorio consiste nel fatto che il paziente perde la differenziazione tra realtà interna ed esterna e smarrisce il giudizio di realtà. Nell’allucinazione lo stimolo, che nasce dall’interno, viene proiettato all’esterno e, senza che esista una corrispondenza con un oggetto esterno, acquisisce il carattere della realtà.
Come può la nostra mente essere ingannata dal fenomeno allucinatorio e quali sono le condizioni che permettono di formulare un giudizio di realtà?
Come il giudizio di realtà sia aleatorio e come la sua alterazione dipenda da strutture cerebrali che ingannano la mente è dimostrato da un elegante esperimento neuroscientifico (Schacter et al.,1996). A una serie di soggetti un intervistatore comunicava a voce una lista di nomi che corrispondevano a degli oggetti. In un momento successivo gli stessi soggetti leggevano un’altra lista in cui erano presenti alcuni nomi elencati nella prima lista ( e quindi uditi) e altri in cui gli stessi oggetti della prima lista venivano nominati con una parola diversa ma dotata dello stesso significato (ad esempio “dolce” invece di “torta”). Alla fine si chiedeva se un determinato vocabolo era presente nella prima lista o meno. Alcune volte i soggetti confondevano i nomi della seconda lista con quelli della prima, mentre altre volte ricordavano benissimo i nomi della prima lista. Attraverso tecniche di neuroimagining i ricercatori hanno visto che l’ippocampo si attiva sia quando il soggetto ricorda correttamente sia quando sbaglia.
La differenza è che quando il ricordo è vero si attiva anche la corteccia uditiva, sede della memorizzazione uditiva (la prima lista è stata letta); quando invece il ricordo non ha riscontro nella realtà, al di là della convinzione del soggetto, si attiva l’ippocampo mentre la corteccia uditiva rimane inattiva.
La conclusione dei ricercatori è che l’attivazione dell’ippocampo fornisce il convincimento di realtà al ricordo, indipendentemente che questo sia veramente accaduto o meno.
Alcune ipotesi psicoanalitiche
Freud ha affrontato il tema delle allucinazioni da molti punti di vista, a volte difficili da integrare fra loro. All’inizio considera l’allucinazione secondo il modello della rimozione, della regressione e del ritorno del rimosso.
Per Freud l’Io, allontanandosi dalla rappresentazione incompatibile, si stacca anche dalla realtà poiché alla rappresentazione incompatibile sono connessi pezzi di realtà.
Descrivendo il caso del Presidente Schreber (1911), affermerà che le allucinazioni sono il prodotto del conflitto inconscio derivante dagli impulsi omosessuali inconsci del Presidente.
Inoltre Freud (1924) prospetta l’interessante ipotesi che la realtà psicotica deriva dalle sensazioni del proprio corpo in quanto il paziente riconosce come esterocettiva una realtà propriocettiva. L’ingresso nella psicosi, per Freud, si svolge in due stadi. Prima L’Io nega (rigetta) la realtà e si svincola da essa, poi crea una nuova realtà tramite un delirio o un’ allucinazione. Questa neocreazione avviene per risarcire l’Io del danno subito. L’angoscia non è dovuta al ritorno del rimosso (come nella nevrosi) ma al riemergere di quella parte di realtà che è stata rigettata.
In modo abbastanza sorprendente e nel periodo maturo della sua produzione, Freud (1937) riprende il tema dell’allucinazione legandolo alla memoria. Egli sostiene che le allucinazioni non psicotiche contengono i ricordi di avvenimenti remoti, qualcosa che il bambino ha udito quando non sapeva ancora parlare. Ma anche le allucinazioni psicotiche, inserite nei sistemi deliranti, avrebbero lo stesso significato di memorie del passato, sia pur estremamente deformate, che aspirano a emergere dall’oblio.
L’allucinazione, per Bion, è frutto di un’operazione mentale che distrugge gli elementi alfa (simboli), li riduce in frantumi che non possono essere pensati ma solo evacuati. Tale evacuazione avviene attraverso gli organi di senso, il cui funzionamento s’inverte espellendo nel mondo esterno elementi beta indigeriti insieme a tracce di Io e Super-Io, dando luogo agli oggetti bizzarri ( Bion 1958).
Alcuni pazienti usano l’onnipotenza implicita nell’allucinazione come un metodo per acquisire indipendenza da qualsiasi oggetto o situazione mediante la capacità di usare i propri organi di senso come organi di evacuazione in un mondo creato da loro stessi.
Un’ intuizione originale infine sul tema delle allucinazioni ci viene da Lacan (1981). Com’è noto egli distingue tre ordini di funzioni: l’ immaginario, il simbolico e il reale che vede collegati insieme dalla funzione del linguaggio. Quando interviene la forclusione, come nel caso della psicosi, il linguaggio non può più esercitare la funzione di legame e si realizza una confusione tra il reale e il simbolico come nel caso delle allucinazioni acustiche. Per Lacan l’allucinazione è il ritorno di ciò che non è stato elaborato a livello simbolico ma che è stato forcluso, ovvero dissociato dalla coscienza. Il contenuto dissociato dalla personalità del soggetto verrà quindi ad imporsi come esperienza proveniente dalla realtà esterna, pertanto nell’allucinazione la parola dell’inconscio appare come puro Es.
Bibliografia
Bion W.R. (1958). On Hallucination. Int. J. Psycho-Anal., 39:341-349
Freud S. (1911) Psycho-analitic notes on an autobiographical account of a case of paranoia (Dementia paranoides). SE 12:3-84
Freud S. (1915) A Metapsychological Supplement to the Theory of Dreams. SE 14:217-36
Freud S. (1924) The loss of reality in neurosis and psychosis. SE 19 183-90
Freud S. (1937) Constructions in Analysis SE 23:256-270
Hugdall K. (2009) Hearing voices: hallucinations as failure of top-down control of bottom-up perceptual. Scandinavian Journal of Psychology 50: 553-560
Lacan J., (1981), Les Psychoses, Séminaire III 1955-56, Seul, Paris.
Schachter, D. L. et al. (1996). Neuroanatomical correlates of veridical and illusory recognition memory: evidence from positron emission tomography. Neuron, 17:1-20.
Approfondimenti
Amore primario

Andrea Segantini, Le Due Madri - 1889 -
A cura di Simonetta Diena
Balint e la teorizzazione dell’amore primario
Che cos’è l’amore primario passivo, o relazione oggettuale primaria, per Balint?
E’ una pulsione originaria, fonte di ogni successiva evoluzione normale o patologica. Le prime relazioni madre/bambino per Balint si posizionerebbero in una felice ed estatica attesa d’amore e di soddisfazione, che va dal bambino alla madre, senza percezioni di obblighi di reciprocità: una sconfinata ed onnipotente possibilità di ricevere da parte del bambino, una infinita e illimitata capacità di dare nella madre. La tenerezza, in Balint, non è più, come in Freud, una libido inibita nella meta, (vedi oltre) ma è una pulsione autonoma, che non deve più essere individuata rispetto alla genitalità. E anche la genitalità, in Balint, si configura come una pulsione autonoma, legata alla riproduzione del singolo e della specie. Il destino dell’uomo è per Balint legato appunto alla relazione oggettuale primaria: solo la tenera e puntuale gratificazione del bisogno d’amore passivo consentirà al bambino una progressiva crescita nell’esame di realtà fino ad affrontare da adulto l’avventura della genialità. L’assenza di questo amore primario invece lo obbligherà ad affrontare le strade della nevrosi, della perversione o della psicosi.
Primary Love and Psychoanalytic Thecnique, è un insieme di saggi apparsi nel 1952, e scritti da Balint tra il 1930 e appunto il 1952, su tre argomenti strettamente collegati tra loro: la sessualità umana, le relazioni oggettuali e la tecnica psicoanalitica. Non tutti gli scritti, come sottolinea giustamente Zucchini nella prefazione italiana, sono ugualmente interessanti. Ad una lettura attuale sembrano a tratti noiosi e decisamente superati, ciononostante contengono elementi a mio avviso di grande interesse.
Nel saggio Note critiche alla teoria dell’organizzazione genitale della libido (1935) Balint si propone di studiare “lo sviluppo delle relazioni oggettuali, e cioè lo sviluppo dell’amore”
E’ difficile tradurre in linguaggio moderno questo saggio di Balint, che troppo appare impastato di concetti biologici e pulsionali. In parte rimando ai paragrafi successivi dedicati al lavoro di Freud, la comprensione del suo lavoro, ma in parte devo confessare che sono rimasta colpita da quanto, in un insieme di concetti appunto ora desueti, compaiano invece intuizioni fondamentali di clinica e di teoria psicoanalitica. Per esempio quando descrive quei pazienti che “non amano, ma vogliono essere amati.” La richiesta di gratificazione di tale necessità è assolutamente problematica, e viene spesso manifestata in modo violento e con grande dispendio di energia, come se fosse una questione di vita o di morte. Da questa tendenza deriva la paura di essere abbandonati. Balint sottolinea il fraintendimento cui questa richiesta va incontro, perché viene letta come una forma di aggressività e di innato sadismo (In seguito nella Klein questo fraintendimento verrà legato alla teorizzazione del predominio della distruttività nei primi anni di vita.) Ma, dice Balint, e secondo me è geniale: “E’ la sofferenza che rende cattivi, tutto ha un suo precedente che può essere rimosso”. L’altro fraintendimento riguarda la passione. La modalità di manifestazione della pulsione vien confusa con la sua meta: si pensa che i desideri il cui appagamento venga richiesto in modo così appassionato appartengono ad una vita pulsionale sana; mentre sono le mete pulsionali appassionate che conducono ad uno sviluppo disturbato, al fraintendimento delle lingue di cui parla Ferenczi.
In questo modo Balint intende mettere in discussione il bambino polimorfo perverso di Freud, il bambino autoerotico e narcisistico. Ma, dice Balint, la tendenza primaria del bambino a pensare “Io sarò sempre amato, dovunque, in qualunque modo, senza il minimo sforzo da parte mia” che poi è la meta finale dell’amore oggettuale passivo, appartiene appunto al mondo dell’Io del bambino, che non ha ancora operato la differenziazione tra Io e mondo esterno, un mondo che è ancora completamente narcisistico, non ad una perversa ostinazione del bambino, ad una sua innata cattiveria.
In realtà Balint suggerisce, più o meno implicitamente, di sostituire il concetto di narcisismo primario con quello di amore primario passivo. Il narcisismo del bambino deriva, per Balint da questo pensiero: “Se il mondo non mi ama abbastanza, sono io che devo amare e gratificare me stesso”. Di conseguenza vediamo come per Balint il narcisismo sia sempre di natura secondaria. Di fatto insiste sulla differenza tra narcisismo come investimento libidico, cioè quello in cui la persona ama se stessa e quello in cui la persona non prende in considerazione, o in modo insufficiente, la realtà esterna.
Ma per Balint se c’è l’amore oggettuale passivo, che è, ripetiamo, la meta primaria dell’erotismo, l’amore libidico di sé, c’è anche l’amore oggettuale attivo, nel quale invece amiamo e gratifichiamo il nostro partner perché ci ricambi con amore e gratificazione. Entrambi sono strettamente collegati. Commentando la domanda di Freud su “da dove origina il nostro bisogno di applicare la libido agli oggetti” (in Introduzione al narcisismo), Balint dichiara che solo la concezione dell’amore passivo per l’oggetto fornisce una spiegazione di questa descrizione clinica. L’amore narcisistico non può mai raggiungere la meta di tutti gli impulsi sessuali: per essere amati, bisogna entrare in contatto con il mondo e con i suoi oggetti.
Prima di introdurre quello che è a mio avviso il saggio più bello, Amore e odio, (1951) sento che è necessaria una piccola premessa storica.
Non si può affrontare il lavoro di Balint sull’amore primario passivo, dicevo prima, senza fare infatti un breve riferimento all’opera di Freud cui si riferisce costantemente, e cioè ai Tre saggi sulla teoria sessuale. Inoltre credo che ogni riflessione di Balint sulle preoccupazione freudiane sulla relazione tra sessualità e amore, tenerezza e sessualità scelta d’oggetto e scelta narcisistica, non possa non prescindere da questo lavoro iniziale.
I Tre saggi sulla teoria sessuale (1905) sono, insieme all’Interpretazione dei sogni (1899) l’opera che Freud ha arricchito e precisato maggiormente nel corso delle edizioni successive, pur mantenendone intatta la struttura.
E’ nel terzo saggio, Le trasformazioni della pubertà che affronta il compito più arduo, quello di collegare l’esperienza della sessualità infantile all’organizzazione complessiva dello psichismo. La teoria del primato genitale risulta poco soddisfacente: “ L’inizio e la meta finale della successione evolutiva descritta stanno chiaramente davanti ai nostri occhi. I passaggi intermedi ci sono ancora oscuri da molti punti vista; dovremo lasciare in essi più di un enigma non risolto.” La teoria del primato genitale viene prima proposta e poi contrastata continuamente, a favore di un’implicita consapevolezza della necessità di continue ristrutturazioni del funzionamento psichico in relazione alle esperienze di incontro con gli oggetti.
L’enigma di una tensione libidica che non si estingue con il suo soddisfacimento, come avviene invece per la fame, resta aperto, come strada verso sviluppi che valorizzano gli aspetti relazionali: “Ci è rimasto assolutamente non chiaro donde derivi la tensione sessuale che, nel soddisfacimento delle zone erogene, nasce contemporaneamente al piacere, e quale sia l’essenza di essa.”
Come possiamo vedere, Balint parte da questo saggio, ma poi se ne discosta, e non di poco.
Prendiamo per esempio, come inizio di discussione, il punto in cui, in Amore e odio, discute il concetto di onnipotenza infantile:
“Onnipotenza- dice- non significa mai propriamente una situazione di potenza: al contrario, indica un tentativo disperato e molto incerto di vincere una sensazione di inferiorità e impotenza.” Balint inizia a discutere il concetto di onnipotenza per meglio capire quella che chiama la differenza tra amore maturo, o adulto e amore primitivo, nel quale appare di fondamentale importanza un tempestivo e opportuno appagamento di tutti i bisogni, a causa della assoluta dipendenza dall’oggetto. O secondo un altro punto di vista, non è tanto il bambino, o l’adulto, ad essere avido, ma sono le loro gratificazioni ed il loro oggetto ad avere un’importanza assoluta.
Tutte le situazioni oggettuali pregenitali o primitive, come le definiremo meglio adesso, contengono in varia misura questi tre elementi: disperata dipendenza, rifiuto di questa dipendenza per mezzo dell’onnipotenza, il dare l’oggetto per scontato trattandolo come un vero oggetto, una cosa. Alla base di tutte queste relazioni primitive risiede una verifica di realtà falsa e ancora poco sviluppata, o difettosa. Ecco perché l’amore onnipotente, o avido è instabile, e condannato a subire infinite frustrazioni e trasformazioni in odio. L’odio, è per Balint, l’ultimo residuo, il rifiuto e la difesa contro l’amore oggettuale primitivo. Ciò significa che odiamo le persone che non ci amano e si rifiutano di collaborare malgrado i nostri sforzi di guadagnarci il loro affetto. Ci difendiamo innalzando le barriere dell’odio. Ma l’odio ha bisogno del rifiuto della dipendenza, e della disuguaglianza tra oggetto e soggetto.
Gli scritti di Balint si collocano sempre all’interno di un dibattito creativo. In questo contesto dobbiamo leggere i suoi scritti, estremamente attuali nel dibattito moderno sull’esperienza relazionale. Per Balint questa è sempre collocata in una vicenda di costante ambivalenza, di amore e odio, attrazione e rifiuto, fiducia e sfiducia al tempo stesso. Per tali ragioni Balint sottolinea più volte la necessità di una base sicura nella fase pre-verbale. Ecco quindi l’origine e la necessità dell’amore primario.
Ottobre 2015
Angoscia di separazione

Dal film E.T. l'extra-terrestre di Steven Spielberg
A cura di Giorgio Mattana
L’angoscia di separazione, introdotta per primo da Otto Rank (1924) con il concetto di trauma della nascita, fa riferimento a un evento centrale e caratteristico di ogni relazione,a partire da quella primaria fra madre e bambino. Immerso in una situazione di dipendenza totale dalla madre, il neonato può vivere la separazione da essa come un evento estremamente drammatico, capace di ripercuotersi negativamente sulle future separazioni adulte, e prima ancora sul vissuto di quei processi fondamentali di separazione che sono lo svezzamento, la crescita, l’adolescenza e la maturità. Nel caso di un poco felice superamento delle prime angosce infantili di separazione, anche il vissuto della morte come separazione definitiva sarà difficilmente elaborabile e integrabile nella prospettiva di vita del soggetto. Nell’ambito della revisione della sua prima teoria dell’angoscia, Freud (1926) chiaramente antepone all’angoscia di castrazione legata alla fase fallica e al dramma edipico un’angoscia di separazione che rimanda a fasi evolutive precedenti, e tuttavia in qualche modo già prefigura quelle successive, nella fedeltà a un modello energetico-pulsionale della mente che individuava il vero pericolo e motivo del “segnale d’angoscia” nella scomparsa dell’oggetto in quanto fonte di soddisfacimento pulsionale. In linea con le ultime formulazioni freudiane, la Klein (1935) sottolinea come nel corso dello sviluppo il bambino vada inevitabilmente incontro a situazioni di separazione o di perdita, le prime e più significative delle quali riguardano la nascita e lo svezzamento. Quest’ultimo in particolare, nella sua connessione con la separazione dalla madre e l’ingresso nella posizione depressiva, rappresenterebbe il modello di tutte le perdite successive. Benché espresse in un linguaggio pulsionale, le formulazioni kleiniane sembrano inscriversi più organicamente di quelle freudiane in un contesto relazionale, come risulterebbe dal rifiuto del concetto freudiano di narcisismo primario e dalla tesi della originarietà della relazione con oggetti esterni e interni.
Fra gli autori postkleiniani, Bion (1962) sottolinea la capacità innata del bambino di far fronte alle frustrazioni che inevitabilmente la madre, come rappresentante della realtà, provoca in lui. Si tratta di frustrazioni orali collegate anche alla separazione, come nel caso dello svezzamento, o di frustrazioni edipiche precoci legate alla presenza della figura del padre. Grazie alla sua capacità di rêverie, la madre potrà accogliere l’angoscia di morte che si accompagna nell’infante alla frustrazione dei bisogni più elementari, aiutandolo a trasformarla e tollerarla, oppure fallire in questo compito creando le premesse della sua patologia relazionale adulta. In sintonia con l’ultima Klein (1963), Winnicott (1965) definisce la capacità di essere solo come una delle conquiste evolutive più difficili, ma al tempo stesso essenziali al raggiungimento della maturità affettiva. Il bambino sviluppa la capacità di essere solo in maniera progressiva: dapprima in presenza della madre e successivamente, in maniera graduale, attraverso l’interiorizzazione di questa, fino alla possibilità di essere veramente solo, inconsciamente sostenuto dalla sua rappresentazione interna.
Notevole supporto empirico alle formulazioni postfreudiane dell’angoscia di separazione proviene dalle osservazioni effettuate da Bowlby (1960, 1988) nell’ambito dei suoi studi sull’attaccamento. Questo autore concepisce l’angoscia di separazione come qualcosa di primario e biologicamente determinato, espressione della tendenza innata del bambino a stabilire un intimo contatto emotivo con l’oggetto, e conseguenza diretta della rottura di tale legame. Come evidenziano Emde (1981) e Stern (1985), fin dalla nascita il bambino mostra uno spiccato interesse per l’ambiente umano e ricerca selettivamente l’interazione con esso, contrariamente all’interpretazione prevalente del narcisismo primario freudiano come fase iniziale caratterizzata dall’assoluta chiusura relazionale del soggetto.
Come conseguenza della sua centralità nello sviluppo, numerosi autori postfreudiani pongono particolare enfasi sulla separazione in analisi, suscettibile di far emergere nel transfert gli antichi vissuti separativi del soggetto, fino a farne in alcuni casi l’aspetto centrale del trattamento e delle sue finalità trasformative. Notevole è l’attenzione riservata dagli autori kleiniani alle difese dall’angoscia di separazione, dalla negazione alla scissione e all’identificazione proiettiva, all’identificazione adesiva, alla masturbazione anale e a diversi tipi di agito. Significativa la posizione di Meltzer (1967), che si sofferma sulla ciclicità del processo analitico, sottolineando come l’esperienza della separazione tenda a dominare l’inizio e la fine di tali cicli (seduta, settimana, segmento, anno di analisi): l’analisi è “dominata” da questo aspetto dinamico “fino a quando le ansie con esso connesse non siano state chiarite, di modo che la loro elaborazione possa avviarsi” (p. 46). Ancora più radicalmente, Quinodoz (1991) colloca la separazione e le connesse ansie e difese al centro dell’attenzione fin dalla prima seduta, di fatto facendone l’asse portante del trattamento fino alla sua conclusione.
Con Bion (1963), è possibile replicare a tale accentuazione considerando la separazione un “elemento” della psicoanalisi, centrale e imprescindibile ma da non confondere con il tutto, bensì da esplorare di volta in volta nelle sue declinazioni peculiari, nella sua variabile incidenza nelle diverse manifestazioni psicopatologiche. Appresa dall’esperienza, la categoria psicoanalitica della separazione a quest’ultima deve rimanere collegata, testimoniando caso per caso la propria rilevanza e dinamica, onde evitare di costituirsi in categoria metafisica inconfutabile, essendo in linea di principio tutto quanto avviene fuori della stanza dell’analisi interpretabile nel suo nome. Ciò introduce a un’ultima considerazione, che muove dalla consapevolezza che intense angosce di separazione e relative difese possono del pari attivarsi all’interno della situazione analitica: a condizione di ancorarsi a indici clinici significativi, l’esperienza della separazione e dell’identità separata nelle sue diverse e multiformi modalità, appare qualcosa di più complesso e interiore rispetto alla separazione spazio-temporale legata ai “cicli” analitici. Come suggeriscono Winnicott (1965) e la Klein (1963), l’esperienza della separazione è un vissuto profondo e difficilmente obiettivabile, a partire dall’essenziale possibilità di sperimentarla in presenza dell’oggetto. Per converso, non sempre e non necessariamente sensazioni di vuoto, solitudine e distacco con le relative ansie e difese corrispondono in maniera lineare a situazioni di separazione in senso spazio-temporale.
Bibliografia
Bion W.R. (1962). Apprendere dall’esperienza. Roma, Armando, 1972.
Bion W.R. (1963). Gli elementi della psicoanalisi. Roma, Armando, 1973.
Bowlby J. (1960). Separation anxiety. Int. J. Psycho-Anal, 41, 89-113.
Bowlby J. (1988). Una base sicura. Milano, Cortina, 1989.
Emde R.N. (1981). Changing models of infancy and the nature of early development. Remodeling the foundation. J. Am. Psychoanal. Ass., 29, pp. 179-219.
Freud S. (1926). Inibizione, sintomo e angoscia. O.S.F., 10.
Klein M. (1935). Contributo alla psicogenesi degli stati maniaco-depressivi. In Scritti 1921-1958, Torino, Boringhieri, 1978.
Klein M. (1963). Sul senso di solitudine. In Il nostro mondo adulto ed altri saggi. Firenze, Martinelli, 1972.
Meltzer D. (1967). Il processo psicoanalitico. Roma, Armando, 1971.
Quinodoz J.M. (1991). La solitudine addomesticata. Roma, Borla, 1992.
Rank O. (1924). Il trauma della nascita. Guaraldi, Firenze, 1972.
Stern D.N. (1985). Il mondo interpersonale del bambino. Torino, Bollati Boringhieri, 1987.
Winnicott D.W. (1965). La capacità di essere solo. In Sviluppo affettivo e ambiente. Roma, Armando, 1974.
Luglio 2014
Anoressia

Rooze Mirijan
A cura di Maria Teresa Palladino
L’anoressia è un disturbo del comportamento alimentare che comporta un rifiuto più o meno grave ad alimentarsi. L’obiettivo è quello di mantenere uno stretto controllo sul peso per evitare di ingrassare come parte di un bisogno di controllo totale del corpo e delle sue funzioni. Implica anche una distorsione dell’immagine corporea per cui viene negata l’effettiva condizione di debilitazione fisica. Inoltre esiste una negazione di stimoli come la fame o la stanchezza spesso connessa alle attività di fitness messe ossessivamente in atto al fine di mantenere sotto controllo il peso. Questo insieme di comportamenti implica quasi sempre una situazione di amenorrea e può arrivare nelle forme estreme a provocare conseguenze permanenti sul piano corporeo fino a mettere in pericolo la vita stessa.
E’ un disturbo che spesso si presenta alternato al suo opposto, la bulimia, caratterizzata da abbuffate compulsive di quantità e qualità di cibo notevoli con una sensazione, durante l’episodio, di perdita di controllo. Nella bulimia il tentativo di controllare il peso viene spesso messo in campo attraverso il vomito autoindotto o con l’abuso di farmaci lassativi e/o diuretici. L’aspetto in comune è il desiderio di assoluto controllo sul corpo.
L’anoressia riguarda prevalentemente giovani donne nella fase adolescenziale benchè sempre più spesso abbiamo esperienza del permanere di questa sintomatologia anche in età adulta magari in forme meno gravi di fobia alimentare e come esito di anoressie conclamate in adolescenza. Inoltre, negli ultimi anni, è aumentato il numero di adolescent maschi coinvolti seppure in percentuale minore rispetto alle ragazze. (10 a1). Per questi ultimi parliamo però di anoressia inversa o vigoressia, solo in parte sovrapponibile ai disturbi alimentari femminili ed espressione di problematiche legate all’identità di genere.
I primi a parlare di anoressia furono alla fine dell’ 800 Lasegue e Gull che la descrivono con termini molto simili a quelli con cui viene ancora identificata nel DSM .
Freud parla di rifiuto del cibo in collegamento con la melanconia (1895) e come espressione della rimozione dell’erotismo orale (1905).
In ambito Kleiniano si sottolineano le paure paranoiche di essere avvelenati o la paura di attaccare e mettere in pericolo gli oggetti interni buoni.
Dalla seconda metà del secolo scorso la problematica anoressica ha subito un incremento notevole, diffondendosi prima tra le giovani donne della borghesia e poi allargandosi a tutte le fasce sociali tanto che si può parlare con Di Chiara di sindrome psicosociale (Di Chiara 1999) o con Devereux(1951) di disturbo etnico. Le forme in cui si presenta sono variegate e, se rappresentano senz’altro l’espressione più diffusa di sofferenza psichica del nostro tempo in ambito adolescenziale femminile, si pongono, per altro, in una zona di confine con la “normalità” del perseguimento di un ideale ascetico di bellezza che sembra essere il mito della femminilità contemporanea.
Parlare di disturbo del comportamento alimentare significa in ogni caso mettere l’accento sul comportamento come canale privilegiato di comunicazione della sofferenza psichica senza entrare nel merito di eventuali quadri psicopatologici sottostanti.(Riva 2009).
Infatti sul fatto che esista una corrispondenza tra un quadro psicopatologico specifico e l’anoressia ci sono opinioni controverse.
Su questo punto Anna Nicolò (2010) evidenza come si debba distinguere tra situazioni in cui l’anoressia è sindrome da quelle in cui è sintomo di strutture di personalità sottostanti celate da questo. In questo senso l’Autrice distingue I casi in cui l’anoressia sembra riallacciarsi a disturbi evolutivi adolescenziali più o meno incisivi e che opportunamente affrontati e decodificati hanno spesso una risoluzione abbastanza veloce, da situazioni, più gravi, in cui sembra strutturarsi invece una sorta di conversione isterica. In questi casi più gravi si può definire con Bollas (2000) e Young-Bruehl Cummins(1993) l’anoressia come la forma moderna di isteria. Ancora più impegnative, per Nicolò sembrano essere invece quelle situazioni in cui l’anoressia si presenta come una sindrome complessa vera e propria collegata con amenorrea, iperattività e con una intensità e perseveranza della sintomatologia che possono portare ad un rischio di morte.
L’Autrice evidenzia come questa possa essere invece un sintomo che rappresenta una difesa da un breakdown evolutivo perché, attraverso l’insieme dei comportamenti anoressici che permettono un controllo della realtà e del corpo, si ottiene l’effetto di tenere a bada il conflitto tanto nel mondo interno quanto in quello esterno, il che è particolarmente importante soprattutto nella fase adolescenziale.
I vari autori sono comunque concordi nel non ritenere questa patologia come esclusivamente intrapsichica, ma come luogo di incontro di problematiche intrapsichiche, relazionali e sociali.
Sul piano intrapsichico il tema centrale che impegna l’anoressica e su cui il suo sviluppo sembra incagliarsi è quello della separazione –individuazione proprio nel momento in cui la spinta ormonale indirizza verso una definita costruzione dell’identità di genere.
In questo processo l’anoressica sembra essere in conflitto con il modello femminile e soprattutto con quello materno in uno sforzo di acquisire una separatezza dalla madre che evidentemente non è stata conquistata in una fase precedente e che fa fatica a delinearsi essendo in conflitto con un desiderio contemporaneo di fusione (Breen 1989). Il terreno del conflitto è appunto il corpo attaccato nelle sue forme femminili e nelle sue funzioni procreative quasi che possedere un corpo diverso sia l’unico modo per differenziarsi ed evitare l’equazione tra diventare adulta e diventare la madre (Hughes 1985). Avere un corpo diverso da quello della madre sembra realizzare questa istanza L’attacco al corpo è concreto e testimonia la difficoltà delle pazienti alla mentalizzazione e la preferenza per l’agire piuttosto che per il pensare. Questa è una tendenza tipica dell’adolescenza e che racconta la fatica di questo momento evolutivo a rappresentare i conflitti traducendoli in pensieri e raccontandoli con le parole. La tendenza è ad esprimerli con comportamenti e l’attacco al corpo sessuato ne è un esempio. Certamente anche se si inscrive in un problema specifico della adolescenza, questa difficoltà a mentalizzare il corpo si deve probabilmente fare risalire ad ancora più precoci difficoltà di rispecchiamento che la bambina ha incontrato nel rapporto con la propria madre probabilmente più pronta a proiettare contenuti personali che ad accogliere e rispecchiare gli stati d’animo della figlia.
In questo sforzo di distacco dal modello materno l’adolescente si rivolge cosi ad un modello paterno vissuto come più potente, più indipendente, più vincente.
L’obiettivo diventa far perdere o meglio non fare acquistare le caratteristiche femminili che sarebbero fisiologiche nel processo di sviluppo per acquisire un corpo fallico che, quando non del tutto emaciato e quindi scheletrico, diventa corpo efebico ed asessuato.
Corpo infantile però, testimone del conflitto tra il desiderio di separazione dalla madre e di unione con lei in una infanzia senza fine. Il rischio che si delinea e’ quello di portare al limite lo sforzo di indipendenza e di strutturare piuttosto un modello di funzionamento autarchico in cui ogni relazione di scambio è annullata e in cui ci si rifugia in una rigida corazza narcisistica di negazione totale dei propri bisogni. Quello che viene così’ a strutturarsi è un modello in cui sono prevalenti su vari livelli di funzionamento le difficoltà ad introiettare e a simbolizzare.
La Breen in particolare sottolinea come le difficoltà di simbolizzazione siano da collegare ad una assenza di spazio transizionale connessa alla impossibilita’ ad accedere ad una posizione triadica che costringe la anoressica dentro ad un conflitto tra il desiderio di essere confusa con la madre e la spinta a separarsene.
Queste considerazioni rimandano a modelli teorici che individuano situazioni di deficit nelle relazioni precoci, nodi che vengono al pettine in adolescenza.
Posizione diversa ha invece Jeammet che fa riferimento a problematiche dell’Io e che definisce l’anoressia un disturbo da dipendenza il cui nucleo è rappresentato sostituzione della dipendenza dall’oggetto con una dipendenza da ciò che ha sostituito l’oggetto e cioè il corpo e il cibo con tutte le pratiche che intorno a questo ruotano.
Il nucleo del problema è il conflitto tra l’estremo bisogno di vicinanza, di fusione, e la paura di essere intrusi e occupati dall’altro che caratterizza ognuno di noi ma che certo è esasperato al massimo in adolescenza diventando esplosivo.
La coppia anoressia / bulimia rappresenta così una concretizzazione di questo paradosso in cui : “ciò di cui ho bisogno mi minaccia”( Nicolò 2010). Per questo Jeammet pensa che l’anoressia e più in generale i DCA rappresentano solo una variante delle condotte di dipendenza che celano un grande bisogno di riconoscimento legato ad una grande insicurezza interna. Ed è in ragione di questa insicurezza che gli inevitabili incidenti che si possono incontrare in adolescenza rischiano di innescare la paura di essere sopraffatti e/o di perdere il controllo. Cio’ si traduce in una chiusura che diventa concreta e impedisce il nutrirsi per il timore di essere invasi dal troppo bisogno dell’altro, di cibo.
Certo anche Jeammet sottolinea come in questo si possa essere aiutati o meno dall’ambiente circostante.
Passando dunque dalla dimensione intrapsichica a quella più prettamente relazionale vediamo come, in effetti, la famiglia della anoressica sia stata oggetto di studio da parte di tutti coloro che si sono occupati di anoressia e come esista un generale accordo sul fatto che si tratta di una famiglia a vari livelli disfunzionale.
Già Kestemberge e Decobert nel 1972 parlavano di un legame madre-figlia cosi stretto che era molto difficile per la figlia disincagliarsi e procedere verso la costruzione di una identità autonoma senza rimanere incagliata in modelli imitativi materni.
La difficoltà principale sembra quella ad accedere ad una dimensione triadica. La famiglia sembra strutturarsi in un asse di due uniti spesso contro o almeno ad escludere un terzo.
Più spesso il terzo escluso è il padre e quello che vediamo è una alleanza simbiotica tra madre e figlia che riproduce talvolta quella che ha legato in precedenza la mamma alla nonna materna. Questo contribuisce alla costituzione di una immagine interna di madre fagocitante da cui bisogna difendersi perché non c’è un padre capace di costituire una barriera difensiva. Il padre infatti spesso si autoelimina anche dalla relazione coniugale lasciando madre e figlia unite in un abbraccio mortifero e rinunciando alla sua funzione di agente separante.
C’è dunque alla base una disfunzionalità della coppia che non riesce a proporsi come sufficientemente coesa ed in grado di definire con chiarezza gli spazi e le differenze generazionali.
Questo tipo di funzionamento fondato sulla alleanza di madre e figlia con un padre escluso sembra funzionale sicuramente ad evitare i conflitti, altra caratteristica centrale di queste famiglie, per lo meno fino a quando non si affacciano le prime istanze di separazione adolescenziali. Sotto la spinta della necessità di definirsi e di confrontarsi con la dimensione di una nascente sessualità l’equilibrio precedente si rompe e spesso l’anoressia sembra l’unico modo per impedire un processo di crescita altrimenti ineludibile e tuttavia terrorizzante.
A volte il padre tenta di rientrare in gioco a questo punto, ma spesso riproponendo un legame a due in cui la madre appare svalutata e screditata, nella speranza di avere dalla figlia quel supporto narcisistico che la moglie non gli ha fornito. Ancora una volta la dimensione triadica viene bypassata e non si delinea una funzione ordinatrice paterna. Sono perciò tentativi di ridefinire il quadro destinati al fallimento e che comportano spesso un nuovo ritiro del padre dalla dinamica familiare.
Infine per quanto riguarda l’intervento terapeutico c’è ormai un certo accordo sulla necessità di un approccio multidisciplinare. Il coordinamento tra gli operatori che si occupano del corpo e quelli che lavorano a livello della psiche è fondamentale anche per non supportare una scissione tra corpo e mente che caratterizza questi pazienti.
Altrettanto importante è che l’intervento coinvolga anche il contesto relazionale familiare all’interno del quale il disturbo si è manifestato. Molta esperienza sul piano dell’intervento familiare è stata elaborata dalla scuola sistemica che fin dagli anni 60 lavora a livello del gruppo famiglia (Selvini 1963). Tuttavia anche in ambito psicoanalitico interventi sul gruppo famiglia sono in questi casi abbastanza diffusi (Nicolò 2010, Riva 2009).
Spesso si ricorre ad interventi integrati di affiancamento a terapie familiari con terapie individuali. E’ un fatto che stringere una alleanza terapeutica con una paziente anoressica non è cosa facile dal momento che le pazienti non vedono l’anoressia come un problema e quindi spesso oppongono un netto rifiuto ad ogni intervento di cura. Nelle situazioni piu gravi c’è inoltre una persecutorietà che fa si che ogni intervento sia vissuto come una introduzione di elementi pericolosi da cui bisogna difendersi. D’altra parte si tratta di adolescenti e, se è vero che spesso c’è un rifiuto ad essere “curati” da parte dei ragazzi, è altrettanto vero che spesso c’è una maggiore apertura ad essere aiutati nell’indagare quali sono le difficoltà ad affrontare i compiti evolutivi di cui anche il sintomo anoressia e i disturbi alimentari in genere possono essere testimonianza. Si tratta allora di individuare un setting stabile ma flessibile che tenga conto della ambivalenza e dell’oscillazione tra il desiderio e la paura di dipendere. E’ fondamentale così conformarsi al regime dietetico (psicoterapeutico) che sembra possibile in relazione alla paura di essere invase ed intruse e contemporaneamente al bisogno di avere vicinanza.
In questo contesto flessibile sembra possibile arrivare ad investigare sia le paure più profonde che rendono indispensabile la chiusura ad ogni introiezione, sia operare attraverso il rapporto terapeutico quel processo di rinarcisizzazione di cui parla Jeammet (2004) che può consentire di riavviare il processo di crescita bloccato.
Bibliografia
Birot E. Chabert C. Jeammet P. (2006) Curare l’anoressia e la bulimia. trad it Borla Roma 2009.
Birksted- Breen D. (1989) Working with an anorexic patient, Int. J. Psychoanal.,70:29-40.
Birksted- Breen D. (1996) Phallus, penis and metal space, Int. J. Psychoanal,77:649-656.
Bruch H.(1988) Anoressia. Casi clinici trad it Cortina Milano 1988
Brusset B. (1998)Psicopatologia dell’anoressia mentaleTr it Borla Roma 2002
Camassa P.”(1998) “Anoressia”Rivista di Psicoanalisi, XLIV,3,pp 461-490
Cotrufo P.((2005) Anoressia del sessuale femminile. F. Angeli Milano
Devereux G. (1951) Saggi di etnopsichiatria generale. Tr. It. Armando, Roma 1978.
Di Chiara G. (1999) Sindromi psicosociali. La psicoanalisi e le patologie sociali.Cortina, Milano.
Hughes A., Furgiuele P., Bianco M. (1985) Aspects of anorexia nervosa in the therapy of two adolescents J. Child. Psychother.,111,1,pp17-32
Jeammet P. (2004) Anoressia , bulimia. I paradossi dell’adolescenza interpretati da un grande psichiatra francese. Tr. It Franco Angeli, Milano 2006.
Kestemberg E., Kestemberg J. Decobert S. (1972) La fame e il corpo. Trad. it Astrolabio, Roma 1974
Klein M. (1932 “Le conseguenze delle prine situazioni dia ngoscia sullo sviluppo sessuale della bambina” in Klein M.(1932) La psicoanalisi dei bambini, Martinelli, Firenze (1988)
Nicolò A.M. Russo L. (2010). Una o più anoressie. Borla, Roma
Polacco Williams G. (1994)” La sindrome “vietato l’accesso” in Alvarez A. e al.(a cura di) Un buon incontro, Astrolabio Roma
Polacco Williams G.(1997) Paesaggi interni e corpi estranei trad. it. Mondadori, Milano 1999.
Riva E. (2004) “I disturbi della condotta alimentare. La costruzione dell’identità di genere”in Maggiolini A. Pietropolli Charmet G.( a cura di ) Manuale di psicologia dell’adolescenza:compiti e conflitti. Franco Angeli, Milano.
Riva E. (2009) Adolescenza e anoressia. Cortina, Milano.
Selvini Palazzoli M. (1963)L’anoressia mentale. Cortina Milano.2006
Vedi anche:
Interruzione dello sviluppo in adolescenza di M. Eglé Laufer
Ansia/Angoscia

L'urlo, Edvard Munch
A cura di Gabriella Giustino
Definizione
L’ansia è una condizione psichica, prevalentemente consapevole, caratterizzata da sensazioni di paura. Queste possono derivare da stimoli soggettivi od oggettivi. L’ansia è spesso associata a sintomi corporei ( palpitazioni, senso di oppressione al petto, affanno, tremori).
In ambito psicoanalitico più che di ansia si parla di angoscia.
L’angoscia si distingue dalla paura (ansia) per il fatto di essere meno specifica o legata ad un oggetto che la genera. Può derivare da un conflitto interiore e non è una paura immediatamente individuabile. E’ un terrore senza nome che deriva dall’immaginazione catastrofica dell’individuo. Il tema dell’angoscia in psicoanalisi è molto complesso ma l’evoluzione teorica di questo concetto ha dato un grande contributo alla comprensione clinica di alcune situazioni psicopatologiche. Mi soffermo in particolare sull’approccio a quelle condizioni cliniche in cui determinati stati d’angoscia esprimono sottostanti problematiche strutturali e funzionali del Sé.
Si tratta di situazioni in cui l’ambiente sembra essere stato inadeguato a fornire le condizioni necessarie allo sviluppo di un senso identità stabile e allo sviluppo della capacità di contenimento e di elaborazione dell’angoscia.
Storia del concetto
Il tentativo di Freud, non privo d’indeterminatezza, nel definire l’angoscia, un concetto molto complesso, sembra oscillare dalla concezione economico – biologica della pulsione e della scarica (l’angoscia come “libido convertita”), a quella simbolica dell’angoscia-segnale basata sulla visione strutturale e genetica dell’apparato psichico.
Nel primo periodo ( 1915-1917) prevale il punto di vista economico: l’angoscia é definita come un eccesso di libido che si accumula e non può essere trasformata mediante il legame con la rappresentazione; un’eccitazione eccessiva che deriva da tensioni somatiche mancanti di rappresentazione e di legame e che comporta una reazione di “scarica” attraverso canali neuro vegetativi.
Successivamente Freud introduce i concetti di rimozione e di sintomo psiconevrotico: la rimozione trasforma in angoscia l’affetto legato alla rappresentazione rimossa.
Con l’introduzione della teoria strutturale diviene possibile concepire l’esistenza di un’istanza che può rispondere con l’ansia a situazioni di pericolo sia interne che esterne.
In “Inibizione sintomo e angoscia” (1925) Freud effettua, infatti, una revisione del concetto di angoscia ed indica come ancora valido in senso fenomenologico il concetto di “libido convertita” ma aggiunge una rappresentazione metapsicologica del termine. In questo lavoro emerge la distinzione tra angoscia come “segnale di pericolo” e angoscia come “reazione al pericolo” e l’Io viene definito come l’istanza psichica che percepisce l’angoscia in quanto simbolo “mnestico” o “affettivo” di una situazione di pericolo.
Appena conosciuto il pericolo l’Io dà il segnale d’angoscia e inibisce il minaccioso investimento dell’Es in modo da evitare di essere sopraffatto dall’afflusso di eccitazioni e permettendo di far scattare così le operazioni di difesa.
L’angoscia nevrotica é una reazione ad un pericolo pulsionale interno, l’angoscia “reale” ad un pericolo esterno.
In questo lavoro Freud rivolge la sua attenzione anche ai contenuti psicologici dell’angoscia: affrontando il rapporto tra angoscia e trauma della nascita l’autore scrive: “…Sia come fenomeno automatico, sia quale segnale di salvataggio, l’angoscia appare il prodotto dello stato di impotenza psichica del poppante…”; l’angoscia viene quindi considerata come una risposta spontanea dell’organismo a una situazione traumatica (o a una sua riproduzione). Affermando che le situazioni infantili di pericolo e angoscia mutano nei diversi stadi della vita, e criticando la tesi di Rank secondo la quale il trauma della nascita costituisce l’angoscia unica e ubiquitaria, Freud sottolinea come il trauma della nascita venga invece man mano sostituito dal trauma della perdita dell’oggetto, dalla paura di perderne l’amore, dall’angoscia di castrazione e dalla paura della perdita di amore del Super-Io.
Per Freud l’angoscia di castrazione é comunque centrale e sembra rappresentare il prototipo di tutte le angosce, risignificando, nella situazione edipica, lo stato affettivo originario dell’impotenza e della paura della perdita (separazione).
Anche l’angoscia di morte é, in un certo senso, equiparata all’angoscia di castrazione: nell’inconscio freudiano, la pulsione di morte é silente e non ha collegamenti con l’angoscia di morte. L’inconscio, per Freud, é soprattutto il luogo dei desideri e degli appagamenti libidici e non prevede una rappresentabilità della morte.
Nella teorizzazione kleiniana il problema dell’angoscia appare centrale. Le ipotesi teoriche di Melanie Klein sullo sviluppo mentale si basano sul concetto di “posizione” schizoparanoide e depressiva e su una visione del funzionamento mentale fondata sulle corrispondenti angosce e relazioni oggettuali.
L’autrice nei suoi primi lavori (1928) teorizza che vi sono nell’infante fantasie sadiche e aggressive contro il corpo materno con l’angoscia che deriva dall’attesa di una successiva rappresaglia. Successivamente, introducendo la nozione di posizione depressiva, individua come angoscia fondamentale dell’individuo quella della perdita dell’oggetto interno amato (1935) e infine si concentra (1946) sull’angoscia di annichilimento dell’Io.
Concettualizzando l’angoscia in relazione al dolore mentale ed ai fenomeni legati alla teorizzazione delle “posizioni”, l’autrice distingue l’angoscia persecutoria dall’angoscia depressiva. Il significato dell’angoscia per il soggetto può essere legato prevalentemente a vissuti di minaccia per l’Io (angoscia persecutoria o paranoide) o a vissuti di perdita e minaccia per l’oggetto d’amore ( angosce depressive); queste ultime sono, in un certo senso, comparabili all’angoscia di separazione di Freud, ma la Klein va oltre introducendo i sentimenti di colpa per gli impulsi distruttivi diretti all’oggetto e il desiderio di riparazione che ne deriva.
Per l’autrice le vicissitudini dell’Io e dell’oggetto esistono e si intrecciano sin dall’inizio della vita mentale: il presupposto di base é l’esistenza di un Io precoce capace di difendersi e di percepire l’angoscia (1932). Si potrebbe in questo senso dire che, nella teorizzazione kleiniana, l’angoscia si definisce sin dal principio come “segnale” in quanto ha sempre ( dall’inizio della vita) un significato psicologico per il soggetto. Peraltro, la tesi generale dell’autrice é che l’angoscia, purché non sia eccessiva, agisce da stimolo allo sviluppo.
Nel 1946 la Klein accoglie l’ipotesi della centralità della paura di annichilimento nelle primissime esperienze della vita: queste angosce rappresentano il modo in cui viene sperimentato l’istinto di morte che opera all’interno della personalità.
A questo proposito l’autrice scrive: “…se assumiamo l’esistenza dell’istinto di morte dobbiamo anche assumere che negli strati più profondi della mente c’é una risposta a questo istinto in termini di paura di essere annientati […] questo a mio avviso é la prima causa di angoscia” (1946). Il primo generatore dell’angoscia deriva dalla percezione da parte dell’Io della minaccia di annichilimento operata dall’istinto di morte. Per l’autrice, l’angoscia dell’infante origina proprio dalla paura di morire e, nell’inconscio, la rappresentazione della morte corrisponde a quella degli oggetti cattivi e persecutori. La proiezione all’esterno aiuta inizialmente l’Io a superare l’angoscia liberandolo da ciò che é pericoloso e minaccioso.
Anche Winnicott sposta l’attenzione della sua ricerca dall’angoscia di castrazione ad angosce più precoci e primitive, ma la sua teorizzazione pone l’accento sul ruolo cruciale della risposta dell’ambiente e si declina all’interno di un modello evolutivo che riguarda la strutturazione del Sé e lo sviluppo dell’identità.
Winnicott pensa che l’ambiente può esercitare un’influenza tale da distruggere la “continuità dell’essere del bambino”.
Se la madre non conferma l’ipotesi del bambino di essere in grado di soddisfare anche da sé i propri bisogni, cioè non sostiene e facilita il senso di “onnipotenza” infantile, allora l’infante soffre dell’esperienza della “pressione ambientale” e sperimenta la sensazione di annichilimento. Questo causa gravi interferenze nello sviluppo della personalità con la costituzione difensiva di un falso Sé (teorizzazione che qui tralascio).
Complessivamente, comunque, le osservazioni cliniche di Winnicott sullo sviluppo affettivo infantile condurranno all’interesse verso i processi che promuovono oppure interferiscono con l’integrazione del Sé. L’individuo, per potersi costituire come persona intera, parte dal suo Sé originario che necessita di sviluppo: l’immaginazione del soggetto é il “luogo” di questo sviluppo potenziale che dipenderà da una felice relazione dinamica tra la funzione creativa dell’individuo e quella ambientale.
Le vicissitudini pulsionali si intrecciano quindi con le vicende legate alle relazioni oggettuali: l’individuo cresce e sviluppa il suo Sé attraverso esperienze relazionali e, per poter costruire un proprio senso di identità personale, necessita di una “matrice relazionale” adeguata a dargli un senso di significatività e valore.
A questo proposito l’autore scrive: “[…] Il Sé si trova naturalmente posto nel corpo ma, in certe circostanze, può dissociarsi dal corpo nello sguardo e nell’espressione della madre e nello specchio che può giungere a rappresentare il viso della madre… Infine il Sé arriva a un rapporto significativo tra il bambino e la somma di identificazioni che (dopo una sufficiente incorporazione ed introiezione di rappresentazioni mentali) si organizzano nella forma di una viva realtà psichica interna” (1971). La relazione tra la madre e il bambino diventa fondante per lo sviluppo dell’identità e del senso di sé vitale: attraverso il rapporto reciprocamente creativo con la madre, il bambino ri-conosce le sue doti innate e sperimenta il suo senso di esistere come persona.
La naturale funzione materna di cure empatiche fornisce un ambiente “che sostiene” (holding) e attraverso cui il figlio si sente contenuto e può sperimentare il proprio senso di esistere come individuo. Il processo evolutivo si compie attraverso la progressione da stati di non integrazione ad esperienze di sempre maggiore senso di “unità” ed integrità della continuità dell’essere, dove I confini del corpo e della psiche divengono sempre più definiti.
La patologia del Sé si configura allora, in questa teorizzazione, come un’interferenza nel senso di continuità dell’esistenza dovuta a fallimenti nella responsività materna, con il conseguente sviluppo di angosce specifiche. Winnicott definirà queste angosce come “andare in pezzi”, “cadere per sempre”, non avere rapporto con il proprio corpo, non avere orientamento, essere annientato, e descriverà gli insuccessi della madre-ambiente (in termini di holding, handling e object-presenting) e i tentativi del Sé nell’organizzare difese specifiche.
Il disturbo psicosomatico diventa allora un sintomo che segnala un’angoscia a livello del Sé corporeo (disturbo dell’indwelling, patologia del Sé somato-mentale); l’angoscia di “crollare” viene invece messa in connessione con fenomeni terrificanti di disintegrazione del Sé (depersonalizzazione da fallimento dell’holding), dissociazione dell’unità psico-somatica (fallimento dell’handling), cattiva relazione con gli oggetti (fallimento dell’object presenting).
L’angoscia di morte si configura quindi in Winnicott come terrore di annientamento, di perdita irreparabile del Sé potenziale, angoscia di non esistenza.
Vi sono alcune analogie tra il concetto di “holding” di Winnicott e il concetto di “madre contenitore” di Bion. Questo autore sviluppa, infatti, l’idea che l’identificazione proiettiva del bambino possa ricevere un primo grado di significato dalla madre tramite la capacità di quest’ultima di rendere “pensabili” e “nominabili” le angosce senza nome del bambino. Nel 1967 scrive: “… Se vuole capire quello di cui ha bisogno il bambino la madre non può limitarsi a considerare il suo pianto semplicemente con la presenza di lei…la madre dovrebbe prenderlo in grembo e accogliere la paura che ha dentro di Sé, la paura di morire, perché é questa che il bambino non é in grado di tenersi dentro…una madre comprensiva é in grado di sperimentare questa angoscia che il figlio tenta di introdurre in lei attraverso l’identificazione proiettiva e di mantenere un sufficiente equilibrio…”.
Bion e Winnicott, seppure attraverso differenti intuizioni e riferendosi a modelli teorici diversi, sembrano concordare su un punto fondamentale: le madri che non possono accogliere, comprendere e rendere tollerabili (restituendole trasformate) le angosce primitive dei propri figli, fanno mancare loro una struttura psichica di base di cui hanno bisogno per costituire un senso di sé vitale. La cura analitica si configura allora come un’opportunità di contenimento e trasformazione di intollerabili angosce di morte ed annientamento del Sé ( che possono diventare pensabili) e può fornire un ambiente adeguato, uno spazio potenziale dove è possibile il cambiamento.
BIBLIOGRAFIA
Bion, W.R. “Attacchi al legame” in Analisi degli schizofrenici e metodo psicoalnalitico. Armando Roma 1970 p. 159
De Bianchedi, E.T. et al. Theories on anxiety in Freud and Melanie Klein. Their metapsychological status. International Journal of Psychoanalysis, London 1986.
Freud, S. (1915 ) La rimozione. O.S.F., 8
Freud, S. (1915-1917). Introduzione alla psicoanalisi: “Angoscia”. O.S.F., 8
Freud, S. (1925). Inibizione, sintomo e angoscia. O.S.F., 10 Hinshelwood, R.D. Dizionario di psicoanalisi kleiniana.Raffaello Cortina Editore Milano 1989.
Klein, M.(1928). I primi stadi del conflitto edipico. In “Scritti 1921 1958”) Bollati Boringhieri Torino 1978
Klein, M.(1935). Contributo alla psicogenesi degli stati maniacodepressivi. In “Scritti 1921 1958”) Bollati Boringhieri Torino 1978.
Klein, M.( 1946). Note su alcuni meccanismi schizoidi. In “Scritti 1921 1958”) Bollati Boringhieri Torino 1978.
Winnicott, D.W. Dalla pediatria alla psicoanalisi. Martinelli Firenze 1975.
Winnicott, D.W. Sviluppo affettivo e ambiente. Editore Armando Roma 1970.
Winnicott, D.W. (1971) Lettera a Mme Jeannine Kalmanovitch. Nouvelle Revue de Psychanalyse, 3.
Attaccamento/Teoria
A cura di Maria Rosa De Zordo
Che rapporto c’è tra psicoanalisi infantile e teoria dell’attaccamento? Perché occuparsi di questa teoria?
La psicoanalisi si è da sempre interessata allo sviluppo umano dalla nascita all’età adulta, la psicoanalisi infantile in particolare si è occupata dei primi anni di vita. La teoria dell’attaccamento va intesa come la primaria relazione affettiva tra infante e genitore, che si sviluppa nel primo anno di vita, risposta del genitore all’assoluta dipendenza dell’infante e ricerca precoce di relazioni del neonato. Influisce sullo sviluppo della personalità come stima di sé, atteggiamento verso la realtà esterna, aspettative nelle relazioni. Comprensibilmente quindi interessa una parte considerevole di analisti che si occupano di età evolutiva, prima infanzia, ma anche dell’età adulta, e cercheremo di capire perché. Al tempo stesso tuttavia è una teoria che incontra alcune critiche, poiché sembra orientata piuttosto al cognitivismo e non tenere nel debito conto alcuni concetti fondamentali della psicoanalisi classica: inconscio, pulsioni… Ma la critica non regge: che i processi mentali siano per la maggior parte inconsci è assodato anche dalle neuroscienze (anche se il termine “inconscio” è usato con accezioni diverse da discipline diverse dalla psicoanalisi); quanto alle pulsioni, la teoria dell’attaccamento non contraddice a mio avviso tale assunto. Comunque il dibattito è aperto, così come la discussione tra orientamenti ed evoluzioni diverse della psicoanalisi sollecitati dall’esperienza clinica e dal confronto con discipline dei territori di confine.
Il pregio forse maggiore di questa teoria (e il motivo per cui vale la pena di accennarvi) è l’affinità e l’intreccio con la ricerca nell’area dell’infanzia, cioè con quegli studi che si occupano di conoscere lo sviluppo infantile attraverso l’osservazione diretta accurata delle interazioni precoci tra l’infante e chi se ne prende cura.
L’infant research ipotizza la presenza nel neonato di una tendenza sociale innata a interagire e a comunicare con l’altro, usualmente la madre, i genitori biologici (talvolta, per vari motivi, altre figure, da cui la preferenza per il termine inglese caregiver: chi offre la cura, chi si prende cura). Questa tendenza innata, presente attraverso l’orientamento preferenziale che il lattante manifesta verso la madre (il caregiver) a livello di attenzione olfattiva, uditiva e visiva, diventa più marcata dopo poche settimane, con movimenti di orientamento verso la madre e con scambi vocali e mimici, dialogo che diventa più coerente quando il neonato incontra una madre responsiva, cioè che risponde essa stessa con un orientamento nei confronti del lattante, guardandolo intensamente, toccandogli il capo e le mani, utilizzando un particolare tono di voce, incoraggiando in questo modo l’infante ad aprirsi e a ricercare il contatto: potremmo dire che questo incontro felice favorisce nel bambino l’innamoramento per la vita. Una recente ricerca (Nadia Bruschweiler Stern, 2013) approfondisce i momenti precoci di incontro tra madre e neonato in cui entrambi appaiono felicemente in grado di sintonizzarsi, la madre confortandosi di poter essere un buon genitore (sufficientemente buon genitore), sentendo che può proteggere e amare il nuovo nato e dando un senso ai segnali comunicativi del piccolo attraverso la sua interiorità. Quando questo sembra difficile da realizzarsi, i momenti di incontro della madre (di cui son frequenti e comprensibili incertezze e timori) con il neonato richiederebbero un sostegno alla diade per favorire lo sviluppo dell’attaccamento. A questo riguardo è comunque importante sottolineare che le difficoltà di interazione, il mancato coordinamento tra infante e caregiver hanno molteplici cause, che si possono genericamente ascrivere non solo all’ambiente, ma anche alle particolarità costituzionali dell’infante.
La teoria dell’attaccamento si è sviluppata in tre fasi principali.
Nella prima fase il londinese John Bowlby (1907-1990), psichiatra e psicoanalista, richiamò l’attenzione sul sistema comportamentale di attaccamento, come garante dell’incolumità e della sopravvivenza del bambino nel suo ambiente. Da questo punto di vista l’attaccamento è un sistema altrettanto importante di quello che regola l’assunzione del cibo. Esso orienta il bambino verso la/le figura/figure di protezione, le figure appunto di attaccamento, e ricerca queste figure come rifugio sicuro in caso di pericolo.
La psicoanalisi classica parla di pulsione (che è un concetto psicologico distinto dall’istinto, che è un concetto biologico), che ha la sua fonte in un organo del soggetto e cerca il soddisfacimento in una meta oggettuale. Da questo punto di vista l’attaccamento sembra piuttosto riduttivo, solo processo istintuale, comune agli altri mammiferi, che non tiene nel debito conto la specificità somato psichica della pulsione. Ma è anche vero che i teorici dell’attaccamento non ignorano tutta la complessità emotiva della relazione e la sua importanza per lo sviluppo psichico: la base sicura per affrontare la vita, come abbiamo accennato sopra.
I primi legami di attaccamento in genere si formano nei primi mesi e si costruiscono con poche persone; la selezione delle figure di attaccamento avviene attraverso le interazioni sociali: il bambino tenderà a piangere quando tali figure si allontanano e mostrerà piacere quando ricompaiono. E’ così forte il bisogno di attaccamento per la sopravvivenza che i bambini sviluppano un legame di attaccamento anche verso genitori insensibili o maltrattanti. E’ comunque importante sottolineare che le difficoltà di interazione, il mancato coordinamento tra infante e caregiver hanno molteplici cause, che si possono genericamente ascrivere non solo all’ambiente, ma anche alle particolarità costituzionali dell’infante.
La tendenza a controllare la disponibilità delle figure di attaccamento e a cercarle nei momenti difficili permane, secondo Bowlby, per tutta la vita (negli adulti di solito è un amico o il partner).
Tuttavia è utile tenere presente che la formazione dei primi legami di attaccamento è un campo di indagine aperto, così come i processi che portano gli individui a cambiare le proprie figure di attaccamento.
La seconda fase si può far coincidere con gli studi della psicologa clinica canadese Mary Ainsworth (1913-1999). Essa individuò nei bambini di dodici mesi tre modelli organizzati di risposta a due brevi separazioni da un genitore e successivamente in sua presenza in una situazione sperimentale (Strange Situation). Parallelamente fu condotta a Baltimora una ricerca osservativa longitudinale della durata di un anno nell’ambiente familiare.
I bambini che mostravano segni di disagio durante l’assenza della madre, che la salutavano attivamente e tornavano a giocare al suo rientro, erano considerati capaci di utilizzare la madre come “base sicura” nell’esplorazione dell’ambiente di casa, raramente irritati o ansiosi dopo brevi separazioni. Questo modello di risposta sicura compariva nella maggioranza dei casi ed era associato ad un comportamento amorevole e attento da parte della madre (attaccamento sicuro). Pochi bambini apparivano preoccupati durante tutta la procedura, arrabbiati o passivi, non riprendevano a giocare al ritorno della madre; apparivano ansiosi nel loro ambiente familiare, non perché le madri fossero rifiutanti, ma incapaci di contenimento, di coordinare le loro risposte nelle interazioni con il bambino (attaccamento insicuro-resistente, insicuro-ansioso).
L’attaccamento insicuro-evitante sarebbe caratteristico dei bambini che non piangevano durante le separazioni, ignoravano o evitavano attivamente la madre al suo ritorno. In casa questi bambini tendevano a manifestare una certa rabbia verso la madre per i suoi spostamenti, ma tali comportamenti non apparivano nella Strange Situation. Le madri di questi bambini sembravano restie al comportamento di attaccamento del bambino e mostravano una certa avversione al contatto fisico. Bowlby aveva osservato lo stesso comportamento evitante dopo una lunga separazione.
Queste ricerche e scoperte della Ainsworth furono seguite da numerosi altri studi e sono tuttora ricerca di indagine. Ci si è chiesti quale sia il contributo dei genitori allo stile di attaccamento, quale l’impatto dello stile di attaccamento nello sviluppo emotivo. Come osservato in nota, vivace è il dibattito sul ruolo ricoperto dal temperamento del bambino.
Ci limitiamo a segnalare che lo stile di attaccamento disorganizzato-disorientato (conseguente a situazioni ambientali e diadiche particolarmente catastrofiche) sembra quello a più alto rischio di futuro disturbo mentale.
La terza fase che si può far iniziare con Mary Main (che insegna presso il Department of Psychology dell’Università di Berkeley in California) è la prevalente fase attuale degli studi. I ricercatori hanno osservato relazioni sistematiche tra l’organizzazione dei primi legami di attaccamento e le capacità rappresentazionali in età scolare, in adolescenza, nell’età adulta. Se si intervistano gli adulti sulle esperienze, sulle relazioni di attaccamento vissute nell’infanzia, le separazioni, la perdita delle figure di attaccamento e gli effetti di queste esperienze sulla loro crescita e persona, si ottengono delle risultanze molto significative che descrivono lo stato mentale dell’adulto (ma le ricerche si sono rivolte anche agli adolescenti) relativamente ai legami di attaccamento.
E’ stata elaborata dalla Main e dai suoi collaboratori un’intervista clinica semistrutturata (Adult Attachment Interview), che individua quattro categorie relative alle rappresentazioni interne degli originari legami di attaccamento e il conseguente stato mentale: sicuro-autonomo, distanziante, preoccupato, disorganizzato a seguito di traumi e lutti irrisolti.
Ci sarebbe una certa relazione tra la risposta dell’adulto caregiver a questa intervista e il legame di attaccamento dell’infante.
La sintesi presentata della teoria dell’attaccamento è ovviamente una presentazione breve, che rischia di apparire generica. Vuole solo evidenziare un’importante area di ricerca e congruenza tra la psicoanalisi clinica e la ricerca nell’area infantile. Le domande aperte sono certamente maggiori delle risposte che si possono dare, ma continuano gli studi e i contributi sul tema.
Bibliografia
Cristina Ria Crugnola (2007). Il bambino e le sue relazioni. Raffaello Cortina Editore, Milano.
Nadia Bruschweiler Stern (2013). Il momento di incontro del neonato,costruzione del dialogo e rafforzamento del legame. infanzia e adolescenza, 3, 161,173.
Widlöcher et al. ( 2000). Sessualità Infantile e Attaccamento. Franco Angeli, Milano, 2002
Attacco di panico

Rissa in galleria_ Umberto Boccioni
A cura di Franco De Masi
L’attacco di panico è caratterizzato dall’insorgere improvviso di episodi di angoscia intensa che sopravvengono senza alcuna prevedibilità e senza la possibilità di essere bloccati. Si accompagna a forti manifestazioni neurovegetative, quali palpitazioni, tachicardia, vertigine, tremori corporei, diarrea o sudorazione eccessiva e soprattutto sensazione di soffocamento.
L’opinione che avanzo é che la crisi di panico abbia un’origine squisitamente psichica capace di scatenare una risposta neurobiologica specifica e automatica.
E’ possibile, infatti, isolare due momenti progressivi dell’attacco: il primo, in cui l’angoscia è ancora avvertita psichicamente, e il secondo, in cui la partecipazione corporea è prevalente e il terrore diventa angoscia somatica incontrollata.
La sequenza
Nell’attacco di panico è il corpo a parlare della propria morte o, meglio, della propria agonia. Nelle persone che soffrono di attacchi di panico i circuiti neurovegetativi, che connettono la coscienza ai segnali del pericolo, sembrano talmente esaltati da diventare indipendenti da ogni controllo razionale. Il paziente ad un certo livello “sa” che non morirà, ma, nello stesso tempo, perde la capacità di arginare la paura e “crede” di morire.
Una volta comparso, l’attacco di panico tende inesorabilmente a ripetersi.
Chi lo ha subito, lungi dall’essere rassicurato dal fatto di essere sopravvissuto o dal convincersi dall’inconsistenza dei suoi terrori, sembra sempre più incline a farsene catturare. Un elemento molto importante nella preparazione e nello scatenamento dell’attacco è il ruolo giocato dall’immaginazione.
Una delle ragioni del suo ripetersi e aggravarsi è il condizionamento che si stabilisce nella mente tra stimolo, immaginazione e risposta emotiva. La risposta emotiva e neuro-vegetativa è un prodotto dell’immaginazione che concretizza la percezione e la realtà del pericolo di morte. Lo scampato pericolo rafforza paradossalmente il successivo allarme.
Un contributo neuroscientifico
Il neuroscienziato Joseph LeDoux (1990) ha identificato i percorsi inconsapevoli della paura e ne ha proposto una suddivisione in più semplici e più sofisticati. I primi sono più veloci e meno discriminanti, i secondi più precisi ma più lenti.
E’ possibile identificare tre percorsi o meglio tre livelli del percorso della paura:
1) Il circuito primitivo della paura governa il repertorio di emergenza che consente di mettere in atto reazioni immediate quali la lotta e la fuga. Scatena le reazioni ormonali e neurovegetative connesse alla difesa. E’ la risposta attacco-fuga.
La caratteristica del circuito principale della paura sta non tanto nella precisione della risposta quanto nella rapidità e nella globalità della sua azione.
Solo successivamente, sulla base delle informazioni che provengono dalla corteccia cerebrale, il circuito primitivo della paura può riesaminare le decisioni iniziali e adeguare le reazioni alla situazione di pericolo.
2) Il circuito razionale della paura è quello che va dalla corteccia prefrontale al sistema limbico. Questo sistema è più lento ed elaborato, ma permette di valutare con maggiore attenzione e realismo la situazione generale, prendere decisioni e valutare la risposta.
3) Un ultimo circuito è quello riflessivo che è caratterizzato dalla autoconsapevolezza, dalla coscienza di provare paura e dalle ragioni di questa.
Prendiamo come esempio un uomo che cammina di notte in un bosco. Un rumore qualsiasi può suscitare in lui una reazione di allarme, con lo scatenamento dei segnali neurovegetativi legati alla paura. Solo in un secondo tempo gli è possibile capire che l’allarme era ingiustificato, era un innocuo stormire di fronde. In questo caso il segnale di allarme è stato attivato attraverso la via più breve, quella che fa capo all’amigdala.
Il circuito primitivo della paura, che si sottrae al controllo della coscienza, comporta l’inconveniente che il riconoscimento del pericolo può essere falso; in questo caso la discriminazione avviene solo a posteriori cioè dopo che è stato scatenato il corteo neurovegetativo della paura.
Può esserci dunque un falso allarme che viene riconosciuto come tale solo dopo che lo stimolo è stato scrutinato dalla coscienza. E’ interessante che il primo riconoscimento dell’oggetto capace di produrre angoscia avviene in primo luogo per vie completamente inconsapevoli e che sfuggono al controllo razionale.
Da quanto finora prospettato risulta suggestivo immaginare che l’angoscia dell’attacco di panico risulta imprigionata nel circuito primitivo della paura, il che spiegherebbe l’immediatezza e la non discriminazione tra pericolo reale o immaginato.
Pericolo immaginato che equivale a quello reale per chi subisce l’attacco di panico anche se, agli occhi di un osservatore esterno, il pericolo non esiste.
Il punto di vista psicoanalitico
L’attacco di panico in analisi viene considerato un sintomo di una complessa ma aspecifica sofferenza del sé, espressione del venir meno di alcuni parametri necessari al suo funzionamento.
L’angosciosa sensazione di non comprendersi porta all’accumulo dell’ansia che, nel corso della crisi, si travasa nel corpo e si esprime in un linguaggio viscerale, sottraendosi sempre di più alla possibilità di essere raffigurata psichicamente.
Gli psicoanalisti sanno tuttavia che le fobie e gli attacchi di panico sono solo un sintomo di una situazione molto più complessa: sono l’espressione di un difetto di costituzione della personalità.
Alcune volte gli attacchi di panico compaiono nel corso di crisi di identità, nei momenti di trasformazione (entrata nell’età adulta, crisi della mezza età) o come reazioni psicosomatiche alla separazione, ma indicano sempre una mancata strutturazione del sé.
Nei casi più semplici l’attacco di panico segue alla caduta di assetti narcisistici. Per questo motivo sono particolarmente frequenti nelle crisi di mezza età (dove il mito della propria efficienza, bellezza o successo non è in grado di sostenere l’angoscia per il limite della propria esistenza) o nelle reazioni all’abbandono dove la separazione dal partner viene sentita come un crollo del sè e delle proprie sicurezze.
Conclusioni
Il mio punto di vista è che i sintomi somatici, che riconoscono un’origine neurobiologica, non sono direttamente legati a un particolare conflitto inconscio, ma piuttosto a una costellazione psicologica ed emotiva di base in cui la funzione di contenimento dell’angoscia è andata perduta.
Penso, infatti, che l’attacco di panico sia l’espressione del fallimento di quelle funzioni inconsce che modulano e monitorizzano lo stato emotivo.
Nelle condizioni di stress non è possibile utilizzare quell’insieme di operazioni inconsapevoli necessarie a trasformare i contenuti emotivi per renderli idonei al funzionamento della vita psichica
In altre parole si viene a configurare una rottura simile a quella del disturbo post-traumatico da stress in cui la persona, in uno stato di ipervigilanza, cade improvvisamente preda di attacchi di terrore legati associativamente all’episodio traumatico.
L’attacco di panico, ricorrente espressione di sofferenza del sè, ci dice che la membrana protettiva della mente (Freud, 1920) si è lacerata.
Lo scatenamento dei sintomi, che è sostenuto da un continuo rimando dalla psiche al soma e viceversa, si collega a un micro-delirio, limitato nel tempo e nello spazio e legato ad alcuni oggetti, luoghi o pensieri, che origina nell’isolamento e nell’angoscia.
La risposta neurovegetativa, biologicamente predeterminata, potenzia a sua volta le costruzioni traumatiche nell’immaginazione attraverso il ruolo determinante dell’angoscia proveniente dal corpo (terrore somatico).
E’ possibile isolare tre livelli, da quello più a valle a quello più a monte, che sono strettamente interconnessi nel configurare l’attacco di panico.
Il livello inferiore, quello più a valle, è sotto il controllo dell’amigdala ( l’organo cerebrale che regola tutte le reazioni neurovegetative della paura) ed è in grado di scatenare le reazioni somatiche.
Il livello intermedio, è quello della memoria traumatica che costruisce i nessi associativi e le immagini visive o mnestiche che entrano nell’immaginazione catastrofica.
Il terzo livello, quello superiore, è connesso alla struttura della personalità, alle esperienze infantili o alle difese psichiche, cioè a quella complessa configurazione dinamica che non solo dà origine al sintomo ma che condiziona l’intero mondo interno e relazionale del paziente.
Le differenti terapie, che partono da ipotesi etiopatogenetiche divergenti, si differenziano in realtà per i diversi livelli in cui cercano di agire.
Agendo al livello inferiore, quello più a valle, gli psicofarmaci cercano di ridurre l’intensità delle reazioni neurovegetative scatenate dal sistema limbico e di combattere lo stato depressivo di base.
La terapia cognitiva, agendo a un livello intermedio, cerca di correggere la distorsione percettiva, che genera la paura, mediante strategie di decondizionamento e graduale esposizione del paziente allo stimolo che induce il terrore.
Entrambi questi due approcci hanno lo scopo di liberare il paziente dal sintomo del panico.
La terapia psicoanalitica, che considera l’attacco di panico conseguenza di un disturbo dell’identità personale e della crisi di assetti difensivi, ha come scopo quello di agire a livello strutturale e non puramente sintomatico.
L’esperienza clinica mi ha convinto che è indispensabile in ogni caso lavorare in seduta sull’attacco di panico, focalizzandolo ogni volta che si manifesta e invitando il paziente a descrivere le sensazioni, percezioni o pensieri che l’hanno preceduto e accompagnato.
In questo modo è possibile cominciare a riconoscere come si formano i sintomi, in quali situazioni più facilmente compaiono e quale é il ruolo dell’immaginazione catastrofica.
Il paziente ha così la possibilità di rivivere in seduta la vicenda traumatica che viene analizzata, condivisa con l’analista e sperimentata in una sequenza potenzialmente pensabile.
Questo tipo di lavoro analitico permette al paziente di prendere atto del proprio contributo al costituirsi dell’attacco e ha il vantaggioso effetto di liberare nuovi spazi ed energie per lo sviluppo del processo analitico.
BIBLIOGRAFIA
De Masi, F. (2004), The Psychodynamic of Panic Attack: a Useful Integration of Psychoanalysis and Neuroscience. Int. J. Psychoanal. 85, pp. 311-336.
Freud, S. (1920) Al di là del principio del piacere OSF, vol 9, Boringhieri Torino. 1977.
LeDoux, J. (1996) Il cervello emotivo Alle origini delle emozioni. Tr. It. Baldini e Castoldi 1998.
Autolesionismo

ORLAN self hybridation africaine
A cura di Mario Rossi Monti e Alessandra D’Agostino
Definizione
Quali condotte sono comprese sotto il termine “autolesionismo”? Riprendendo la definizione di Armando Favazza, l’autolesionismo è “un comportamento ripetitivo, solitamente non letale per severità né intento, diretto volontariamente a ledere parti del proprio corpo, come avviene in attività quali tagliarsi o bruciarsi” (1989, p. 137). Dunque, non possono essere considerate autolesionistiche in senso stretto le condotte che determinano solo indirettamente danni fisici (abbuffate, anoressia, assunzione di sostanze, etc.). Mentre possono essere considerate autolesionistiche le condotte che portano comunque a un ferimento volontario, anche se non inquadrabile all’interno di un chiaro contesto di patologia. Entrando maggiormente nello specifico, Favazza (1996) suddivide essenzialmente le condotte autolesive in due grandi gruppi: autolesionismo “deviante” e autolesionismo “culturalmente approvato”.
Due tipi di autolesionismo.
Del primo tipo (per intenderci, quello che si ritrova nel nuovo DSM-5 sotto il nome di “Non-Suicidal Self-Injury”, NSSI) fanno parte tutte quelle condotte ascrivibili a precisi disturbi psichiatrici e che l’autore suddivide a sua volta in tre sottogruppi:
-un autolesionismo “maggiore” che comprende gesti poco frequenti ma molto gravi (come l’enucleazione di un occhio, l’evirazione, l’auto-amputazione di un orecchio) e che si manifestano spesso nel contesto di intossicazioni acute da sostanze o di esperienze psicotiche.
-un autolesionismo “stereotipato” che comprende azioni ripetitive e occasionalmente ritmiche (come battere la testa, percuotersi, mordersi, graffiarsi la bocca o gli occhi, strapparsi i capelli, lesionare la pelle, etc.) che si riscontrano in genere in soggetti con ritardo mentale (specie se istituzionalizzati), psicotici in fase acuta, sindromi autistiche o altre sindromi di carattere neurologico (come la sindrome di Tourette, quella di Cornelia de Lange o quella di Lesch-Nyhan).
– un autolesionismo “superficiale/moderato”, che comprende forme autolesive lievi suddivisibili, a loro volta, in tre tipologie: condotte compulsive (come la tricotillomania, il mangiarsi le unghie fino alla carne viva, lo strapparsi e scorticarsi la pelle), condotte episodiche e condotte ripetitive (come tagliare, incidere e bruciare la pelle, conficcarsi aghi, rompersi le ossa, interferire con la guarigione delle ferite, etc.). Tra queste le condotte più comuni sono tagliarsi e bruciarsi, presenti in numerose patologie: nei disturbi di personalità (soprattutto borderline), nel disturbo post-traumatico da stress, nei disturbi dissociativi e nei disturbi dell’alimentazione. Tali atti sono in genere occasionali, ma possono diventare ripetitivi quando il soggetto li assume come modello di condotta per far fronte a determinate situazioni emotive o per rispondere a bisogni di identificazione con il gruppo di appartenenza. In questi casi il gesto autolesivo può configurarsi come un tratto stabile del modo di essere attorno a cui si sviluppa l’intera identità (si parla allora di cutters o burners) o come una vera e propria “sindrome di autoferimento intenzionale”, che inizia in adolescenza e si protrae per dieci o quindici anni, alternando periodi caratterizzati da gesti autolesivi a periodi di quiete e ad altri comportamenti impulsivi (disordini alimentari, abusi di sostanze, cleptomania).
Del secondo tipo di autolesionismo, invece, quello “culturalmente approvato”, fanno parte “rituali” e “pratiche” autolesionistiche accettate da un gruppo. I “rituali” sono attività portate avanti per generazioni, che riflettono tradizioni e credenze della particolare società che li perpetua; molte di queste cerimonie hanno l’obiettivo di prevenire o scongiurare fenomeni che potrebbero destabilizzare la comunità (come catastrofi, rabbia degli dei, degli spiriti o degli avi, conflitti fra tribù, scontri uomo/donna, perdita dell’identità di gruppo). Le “pratiche”, invece, sono forme di modificazione o manipolazione corporea approvate dalla società di appartenenza (come tatuaggi, piercing, incisioni sulla pelle, impianti sotto pelle, scritture direttamente nella carne con ferri arroventati, etc.). Sono tutte condotte molto in voga nella società moderna: basti pensare ai ragazzi “Emo” che, sulla scia di una cultura post-punk/gotica, ricorrono a condotte autolesionistiche quasi fossero, queste, un rito da assolvere obbligatoriamente per affermare la propria identità e la propria appartenenza al gruppo, oppure ancora a quelle persone che si sottopongono a numerosi interventi di chirurgia estetica senza essere mai soddisfatte dei risultati, o persino a quegli artisti contemporanei (come Marina Abramovic, Gina Pane, Stelarc o Orlan) il cui lavoro è tutto incentrato sull’attacco al proprio corpo, un attacco violento, brutale, ma soprattutto reale, per quanto prodotto di un vero e proprio progetto artistico e di una strategia comunicativa pensata nei dettagli.
Autolesionismo nelle società contemporanee.
Oggi l’autolesionismo è un fenomeno talmente diffuso nei paesi industriali avanzati da costituire una vera e propria emergenza sociale, che riguarda tutta la popolazione, non soltanto quella psichiatrica e, in special modo, la fascia di età giovanile. Giusto per citare qualche dato: circa il 4% di adulti privi di disturbi clinici riporta una storia di autolesionismo (Klonsky, Oltmanns & Turkheimer, 2003); negli Stati Uniti e in Canada il 14-15% degli adolescenti riferisce di aver compiuto almeno un atto autolesivo nell’ultimo anno (Laye-Gindhu & Schonert-Reichl, 2005); in Svezia gli adolescenti di 14 anni che riferiscono almeno un episodio di autolesionismo oscillano tra il 36 e il 40% (Bjärehed, Lundh, 2008); tra i pazienti psichiatrici adulti, gesti autolesivi sono presenti nel 20% dei casi (Briere & Gil, 1998) e, tra i pazienti psichiatrici adolescenti, le cifre salgono fino al 40-80% (Nock & Prinstein, 2004). Una situazione decisamente drammatica, dunque. Quasi un’epidemia.
Perché questa diffusione trasversale dell’autolesionismo nelle società odierne?
E, soprattutto, cosa spinge le persone a ferirsi (e nei modi più disparati)?
Dal panorama complesso mostrato finora, le cose non sembrano per nulla chiare. Certo è che chi si ferisce lo fa per un motivo che a poco o niente a che fare con l’idea di darsi la morte. Su quali motivi sottendono queste condotte il dibattito è aperto ormai da anni. Friedman et al. (1972), ad esempio, pensano che l’autolesionismo serve a tenere sotto controllo pulsioni sessuali o di morte; Simpson e Porter (1981) ritengono che esso sia utile nel definire i confini tra il Sé e l’altro; Suyemoto (1998) ipotizza che tale comportamento protegga gli altri dalla propria aggressività e rabbia.
In particolare Lemma (2010) sostiene che l’autolesionismo assolve una serie di compiti inconsci, tra cui:
-negare la separazione o la perdita (con la fantasia inconscia di essere fusi con l’oggetto, rifiutando di elaborare il lutto per il corpo dell’oggetto perduto)
– tentare la separazione (con la fantasia inconscia di sovrascrivere, tagliare via in modo violento o strappare l’altro, sentito risiedere dentro il proprio corpo)
– coprire un corpo vissuto con vergogna (con la fantasia inconscia di distrarre, e quindi controllare, lo sguardo dell’altro)
– porre rimedio a un senso interno di frammentazione (con fantasia inconscia di identificazione con l’immagine che l’altro vede e che ristabilirà un senso di coesione interna)
– attaccare l’oggetto (con la fantasia inconscia di infliggere un dolore, e quindi punire l’oggetto, esponendolo al luogo del crimine).
Organizzatori di senso.
Per muoversi nel contesto di un insieme di comportamenti altamente indifferenziati ed opachi ci è sembrato utile proporre una serie di “organizzatori di senso” (Rossi Monti & D’Agostino, 2009) non certamente esaustivi né mutuamente esclusivi, ma che possano funzionare un po’ come boe durante la navigazione clinica:
-il primo organizzatore lo abbiamo chiamato “concretizzare”, là dove il gesto autolesivo viene usato come modo per trasformare uno stato psichico in uno fisico, per controllare nel corpo sentimenti intollerabili, come un angoscioso vuoto interiore;
-il secondo organizzatore è “punire-estirpare-purificare”, dove ferirsi è un mezzo per punire/estirpare la parte cattiva di sé (il sé alieno di cui parla Fonagy) al fine di disintossicarsi/purificarsi e attaccare pensieri, sentimenti, ricordi, o anche per ripetere inconsciamente una sequenza emotiva che rimanda ad una storia di abuso infantile;
-il terzo è “regolare la disforia”, dove l’atto di auto-ferimento aiuta a controllare sentimenti di tensione angosciosa, quale può essere ad esempio lo stato disforico cronico che fa da sfondo all’esperienza borderline (un misto di tensione, irritazione, sordo malumore, confusione, rabbia), ma anche ad interrompere il ciclo di depersonalizzazione/derealizzazione, ricercando esperienze vive e stimolanti nel dolore;
-il quarto è “comunicare senza parole”, dove il gesto autolesivo funge da linguaggio per trasmettere qualcosa che a parole non si riesce a dire, o anche per controllare i comportamenti e le emozioni dell’altro, o pure per suscitare nell’altro risposte di accudimento (in questo contesto si parla spesso in modo inesatto di “manipolazione”, una modalità di pensiero e azione che richiede funzioni mentali complesse e sofisticate, in genere sostanzialmente compromesse nel disturbo borderline grave);
-il quinto è “costruire una memoria di sé”, dove ferirsi diventa un modo per fissare una memoria di se stessi, incidendo sul proprio corpo marchi che segnano sulla pelle momenti, vicende ed emozioni, corrispondenti a significativi punti di passaggio;
-il sesto ed ultimo organizzatore è “volgere in attivo/cambiare pelle”, dove l’auto-ferimento agisce come uno strumento per trasformare in attive esperienze che vengono vissute passivamente, subite o imposte, un modo per ribaltare un senso di impotenza di per se stesso traumatico in un “trauma” auto-provocato, del quale ci si può sentire autori.
Tanti, dunque, sembrano essere i percorsi di senso, consapevoli o meno, che sottendono un gesto per altri versi sempre uguale. Ogni gesto autolesivo racconta in qualche misura una storia diversa. Ma ognuna di queste storie mostra in definitiva che l’autolesionismo, in qualunque forma si declini, svolge una precisa funzione all’interno dell’economia psichica della persona (Lemma, 2010): una funzione per certi versi “vitale”, volta alla salvaguardia dell’ identità.
Bibliografia
Bjärehed, J., & Lundh, L. G. (2008). Deliberate self-harm in 14-year-old adolescents: How frequent is it, and how is it associated with psychopathology, relationship variables, and styles of emotional regulation? Cognitive Behavior Therapy, 37, 26-37.
Briere, J., & Gil, E. (1998). Self-mutilation in clinical and general population samples: Prevalence, correlates, and functions. American Journal of Orthopsychiatry, 68, 609– 620.
D’Agostino, A. (2012). Corpi alla deriva. Autolesionismo e oltre. in M. Rossi Monti (a cura di). Psicopatologia del presente. Crisi della nosografia e nuove forme della clinica, Milano: FrancoAngeli, pp. 64-110.
Favazza, A. R. (1989). Why patients mutilate themselves. Hospital & Community Psychiatry, 2, 137-45.
Favazza, A. R. (1996). Bodies under siege: Self-mutilation and body modification in culture and psychiatry. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
Friedman, M., et al. (1972). Attempted suicide and self-mutilation in adolescence: Some observations from a psychoanalytic research project. The International Journal of Psychoanalysis, 53, 2: 179-83.
Klonsky, E. D., & Muehlenkamp, J. J. (2007). Self-injury: A research review for the practitioner. Journal of Clinical Psychology, 63(11), 1045-1056.
Klonsky, E. D., Oltmanns, T. F., & Turkheimer, E. (2003). Deliberate self-harm in a nonclinical population: Prevalence and psychological correlates. American Journal of Psychiatry, 160, 1501–1508.
Laye-Gindhu, A., & Schonert-Reichl, K. A. (2005). Nonsuicidal self-harm among community adolescents: Understanding the “whats” and “whys” of self-harm. Journal of Youth and Adolescence, 34, 447– 457.
Lemma, A. (2010). Sotto la pelle. Psicoanalisi delle modificazioni corporee. Milano: Raffaello Cortina, 2011.
Nock, M. K., & Prinstein, M. J. (2004). A functional approach to the assessment of self-mutilative behavior. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72, 885–890.
Rossi Monti, M. & D’Agostino, A. (2009). L’autolesionismo. Roma: Carocci.
Simpson, C. A., & Porter, G. L. (1981). Self-mutilation in children and adolescents. Bulletin of the Menninger Clinic, 45, 5: 428-438.
Suyemoto, K. L. (1998). The functions of self-mutilation. Clinical Psychology Review, 18, 5: 531-554.
Balbuzie
A cura di Irenea Olivotto
(Inglese: stuttering, stammering – Francese : bégaiement – Tedesco : stottern – Spagnolo: tartamudeo)
La balbuzie è un fenomeno relativo al comportamento verbale che si manifesta frequentemente nell’età evolutiva e che in molti casi scompare spontaneamente. Lieve o intensa che sia la sua manifestazione, essa è una caratteristica generalmente assai disturbante per la persona che ne è affetta ed anche per coloro che con chi balbetta vengono a contatto. Può, infatti, incidere pesantemente sulla possibilità di comunicare e creare un disagio nella relazione che non è facilmente superabile.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha proposto la seguente definizione: “La balbuzie è un disordine nel ritmo della parola, nel quale il paziente sa con precisione quello che vorrebbe dire, ma nello stesso tempo non è in grado di dirlo a causa di involontari arresti, ripetizioni e/o prolungamenti di un suono”. E’ da considerarsi pertanto una disfemia, cioè uno dei disturbi di fluenza del linguaggio, distinguibile sia da altri disturbi di disfluenza (come per esempio il tumultus sermonis o tartagliamento, dove è stata riscontrata una più netta base organica), sia dai disturbi che riguardano più specificamente la pronuncia delle parole (come per es. la dislalia), sia dai disturbi relativi alla organizzazione del pensiero e del linguaggio verbale.
E’ un fenomeno universale, testimoniato fin dall’antichità; è presente in tutti i popoli della terra, anche nelle culture primitive; si riscontra in tutti i livelli sociali. La storia ricorda illustri personaggi affetti da balbuzie; solo per citarne qualcuno: Mosè, Aristotele, Demostene l’oratore greco, Esopo, Virgilio, Newton, Napoleone, Washington, Darwin, Wittgenstein, il re inglese Giorgio VI, Churchill, Lenin, Manzoni, Somerset Maugham… ed anche Marilyn Monroe.
Da tutte le discipline che si interessano di questo fenomeno (in campo medico, psichiatrico, psicologico) viene riconosciuta l’importanza degli aspetti psicologici e relazionali implicati nel disturbo, tanto che secondo O. Schindler, audiofoniatra di Torino e uno dei maggiori studiosi della balbuzie in Italia, si può dire che un individuo nasce o diventa disfluente e la società lo trasforma in balbuziente.
Una persona affetta da balbuzie non balbetta quando pensa, quando sogna, quando parla da sola o con gli animali, o parla una lingua straniera, quando canta o recita…
Ci sono età della vita in cui la balbuzie si manifesta più facilmente: nella prima infanzia, all’inizio della scuola elementare e all’inizio della pubertà; l’insorgenza nell’età adulta è rara e generalmente è legata a problematiche di tipo organico quali traumi o malattie neurologiche. Viene anche generalmente riconosciuto che il primo manifestarsi della balbuzie è spesso correlato con episodi traumatici o di intenso significato emotivo sgradevole per il soggetto che poi ne resta affetto. La fascia di età di maggiore frequenza della balbuzie è fra i 3 e i 6 anni (oltre il 30%) ed è considerata fisiologica; poi la frequenza diminuisce e oltre i 18 anni scende al di sotto dell’1% anche per il fatto che il balbuziente ha trovato dei sistemi per controllare l’emissione del linguaggio e riesce a tenere il disturbo, qualora persista, in forma latente appena rilevabile da leggera disfluenza del ritmo della parola.
Si osserva una maggiore incidenza nei maschi, con rapporto generalmente accettato di 3-6 a 1 rispetto alle femmine.
Solitamente si distinguono tre forme di balbuzie: la tonica, la clonica e una forma mista delle due. La balbuzie tonica è caratterizzata da blocchi improvvisi e parossistici di emissione del linguaggio per cui la persona non può cominciare un dato fonema o non riesce a superarlo per passare ad un altro. La forma clonica si presenta con una ripetizione convulsiva di un fono, di una sillaba o di una parola soprattutto all’inizio della produzione verbale o durante l’enunciazione della frase. Emil Fröschels, illustre foniatra austriaco del secolo scorso, descriveva sei livelli di intensità nella manifestazione della balbuzie. A partire da un primo livello (in cui è presente solo la semplice ripetizione di suoni, sillabe o parole) via via il disturbo si intensifica accompagnandosi con incoordinazione respiratoria, sincinesie mimico-facciali, movimenti ticcosi del volto, della testa, del busto, degli arti e delle mani che hanno lo scopo di superare il blocco spastico. Si arriva ad un ultimo stadio, detto del mascheramento, in cui il balbuziente tenta di adattarsi all’ambiente sociale mettendo in atto una serie di meccanismi che lo aiutano a nascondere il proprio difetto, come per esempio evitare le parole che ingenerano balbuzie usando al loro posto altre parole o frasi sostitutive. Il tutto rende la produzione linguistica del soggetto difficile e alterata nella qualità e nella quantità di emissione delle parole e la comunicazione estremamente penosa per chi parla e per chi ascolta.
Gli autori americani distinguono una balbuzie primaria da una secondaria. La balbuzie primaria viene riferita ai primi anni di età, quando il bambino non ne è consapevole, è limitata ad esitazioni, prolungamenti o ripetizioni di suono, non interessa la parola e la frase e non vi sono tentativi di evitarla. La balbuzie secondaria si instaura più tardi, in età scolare, con coscienza del disturbo e può accompagnarsi alle sincinesie, ai movimenti ticcosi, alla incoordinazione respiratoria. La balbuzie che insorge nella prima infanzia viene detta anche evolutiva, in quanto in condizioni ambientali favorevoli scompare spontaneamente e nella maggioranza dei casi non si ripresenta.
Per quanto riguarda la terapia, il problema della balbuzie viene affrontato con metodi e tecniche diverse e differenziate a seconda dell’età. Sempre più frequentemente è considerato elettivo il trattamento psicoterapeutico, nella visione della balbuzie come disturbo della relazione interpersonale, accompagnato o no che sia da tecniche di rieducazione logopedica.
Nella prima infanzia è sconsigliato generalmente un trattamento specifico con tecniche logopediche e si preferisce tenere sotto controllo l’evolversi del disturbo, seguendo i genitori e dando consigli sul modo più opportuno di rivolgersi al figlio quando balbetta, in modo da evitare al massimo il fissarsi del sintomo. Perché la rieducazione logopedica abbia buoni effetti, è necessario, infatti, che vi sia nel balbuziente la coscienza del disturbo e che la sua disfluenza venga sentita come disturbante.
Le tecniche logopediche attuate sono svariate, e si basano soprattutto in pratiche di rilassamento, di controllo della respirazione e della emissione delle parole, nello sviluppare le abilità verbali e non verbali del linguaggio e nell’incoraggiare l’interazione comunicativa. Ma non sempre la rieducazione logopedica ha successo: dopo cicli di rieducazione che hanno avuto buon esito la balbuzie spesso si ripresenta…e magari succede che il paziente riesca a non balbettare più durante le sedute con la logopedista, per poi riprendere a balbettare appena esce dalla stanza.
Sulla eziologia della balbuzie, vengono chiamati in causa numerosi fattori sia organici che funzionali, la predisposizione ereditaria, la psicologia del soggetto e le influenze ambientali. Le teorie organicistiche, foniatriche e psicogenetiche dibattono i loro punti di vista. Gli psicoanalisti Renato Sigurtà e Mariangela Barbieri in un loro libro del 1955 nel quale hanno trattato ampliamente l’argomento, hanno affermato che esistono casi nei quali l’organicità almeno parziale del disturbo appare troppo evidente per poter essere negata; ma che l’origine organica nulla toglie al fatto che nelle manifestazioni di balbuzie i fattori emozionali esercitino un ruolo particolare. Essi escludono la univocità psicogenetica del disturbo e affermano che anche nelle sindromi nelle quali la componente psichica è più evidente esiste una componente organica la quale è la causa effettiva perché il disturbo fisico si manifesti sotto forma di balbuzie e non di altri aspetti.
Nel versante organico, si nota un’alta correlazione con incoordinazione e ritardi motori, alterazione o disturbi della lateralizzazione (frequente il mancinismo), della strutturazione spazio percettiva, ritardo nel feedback uditivo, nonché un’elevata familiarità, la quale però può trovare ragione anche nel comportamento appreso e nel fatto che i genitori particolarmente sensibilizzati da esperienze di balbuzie, possono con la loro ansia contribuire a fissare il sintomo nel figlio. Non è stata trovata correlazione alcuna della balbuzie con il livello intellettivo.
Gli studi sulle dinamiche affettive hanno evidenziato nei balbuzienti delle caratteristiche assai peculiari sia per quanto riguarda la personalità di questi soggetti che per quanto riguarda il loro ambiente e le relazioni familiari. Nella nostra cultura occidentale, il rapporto genitori/figlio balbuziente pare caratterizzato da una forte richiesta da parte dei genitori che il figlio risponda alle loro aspettative narcisistiche di successo, da un’educazione rigida e formale, da tensioni e contrasti soprattutto con la figura paterna. Nei balbuzienti e nelle loro famiglie si trova spesso una ipervalutazione della parola: essa appare eccessivamente privilegiata come veicolo della comunicazione e come indice di evoluzione culturale, in un contesto dove sono più importanti gli aspetti formali della parola che non il suo contenuto affettivo. Questa caratteristica appare più facilmente quando la personalità dei genitori, al di là del bagaglio culturale e del livello socioeconomico, si presenta a sua volta disturbata. Invece che essere usata nel suo valore simbolico come segno verbale del pensare, la parola sembra restare fissata a significati concreti, non affettivamente neutralizzati; il che rende assai problematico l’uso del linguaggio come mezzo di comunicazione.
Fra il balbuziente e il contesto ambientale si instaura un clima di tensione e di aspettative continuamente deluse. I balbuzienti possono assumere un atteggiamento passivo e dipendente, con inibizione delle loro potenzialità espressive ed interattive in famiglia e nell’ambiente sociale; oppure possono reagire in modo eccessivo con disinibizione verbale (il cosiddetto Complesso di Demostene), manifestazioni di prepotenza o di instabilità emotiva. Le indagini psicologiche effettuate hanno evidenziato che l’espressione e l’uso dell’aggressività è uno degli aspetti principali della problematica dei balbuzienti.
APPROFONDIMENTI
La balbuzie nella psicoanalisi
Viene esposta qui di seguito una breve panoramica degli autori che si sono interessati di questo disturbo del linguaggio, focalizzando l’attenzione sul fatto che essi mettono strettamente in relazione la balbuzie con le problematiche inerenti ai vari livelli e stadi dell’evoluzione della personalità.
Secondo alcuni autori (Blanton, Fröschels – vedi Bloom 1978) Freud non avrebbe mai condotto analisi su balbuzienti e avrebbe dichiarato la sua poca esperienza a proposito. Negli “Studi sull’Isteria” (1895) egli espone il caso di Frau Emmy von N., che aveva trattato col metodo dell’ipnosi. Fra i vari disturbi di Emmy vi era anche la balbuzie, insorta in seguito ad un paio di incidenti traumatici: mentre era in carrozza con le figlie piccole i cavalli si erano imbizzarriti e lei si era imposta di stare quieta per non spaventare maggiormente i cavalli. Freud era riuscito con la suggestione ad eliminare il sintomo, ma il disturbo era ricomparso sia durante la frequentazione di Freud, sia dopo il trattamento. Freud lo spiega per il fatto che era stata cancellata con l’imposizione ipnotica la balbuzie legata all’angoscia del fatto traumatico in sé, ma non quella relativa alla lunga catena di ricordi associati. Freud considera la balbuzie di Emmy “una sorta di conversione isterica”, “un simbolo mnestico corporeo”, “un sintomo motorio formatosi per semplice conversione dell’eccitamento psichico in fatto motorio”. (Per una visione critica di questo caso in relazione alla balbuzie, vedi B. Barrau 1980).
Anche se non vi sono lavori specifici di Freud sulla balbuzie, accenni ad essa si trovano in vari punti della sua opera e sono riportati da autori a lui contemporanei suoi interventi a proposito. In “Psicopatologia della vita quotidiana” (1901) ne fa cenno come indice di conflitto interiore. Nel 1907, discutendo il caso di un balbuziente presentato da Adler, non concorda con lui che si tratti di un difetto innato derivante da una inferiorità dell’organo del linguaggio, ma pensa piuttosto ad una soppressione dell’esibizionismo, accennando indirettamente alla connessione fra la balbuzie e la nevrosi ossessiva. Nel 1910 dichiara a Federn che la balbuzie, come l’asma ed i tic, è “un disordine che assomiglia all’isteria… ma che dobbiamo classificare a parte come nevrosi di fissazione” (ad un organo). Nel 1915, in una lettera a Ferenczi, gli chiede “se gli constasse che la balbuzie poteva essere causata da uno spostamento verso l’alto di conflitti a carico delle funzioni escretorie” (Jones 1953). Pare si riferisse ad un paziente balbuziente su cui non era riuscito a condurre l’analisi.
Fra i seguaci di Freud, molti si interessarono della balbuzie, o per avere incontrato il disturbo nei loro pazienti o perché specificamente interessati alla patologia del linguaggio: Putman, Jones, Adler, Jung, Seashore, Travis, Appelt e Johnson che erano balbuzienti, Van Riper, Blanton, Fröschels… Le loro teorizzazioni furono svariate, le cause e meccanismi riportati furono molteplici. E’ interessante notare che le loro idee si possono ritrovare nelle interpretazioni della balbuzie che furono date da autori successivi.
La prima esposizione clinico-scientifica psicoanalitica completa si deve a Stekel (1908) che dedicò alla balbuzie un capitolo del suo trattato sulle nevrosi d’angoscia, ma la sua idea (balbuzie come impotenza psichica, inibizione al parlare derivante dalla fobia di non poter parlare senza interruzioni) non fu condivisa da Freud.
Scripture (1912) affermò che la balbuzie inizia da un trauma che porta ad uno stato generale di ansia; il balbettare inizia come un’abitudine, che la disapprovazione dell’ambiente fa diventare psiconevrosi.
Dorsey (1934) considerava il balbuziente difettoso nella libido genitale, come risultato di difetto nella libido orale anale e uretrale.
Melanie Klein in un saggio del 1923 parla della sublimazione delle fissazioni orali, cannibalesche e sadico-anali che si ha nel linguaggio e cita una bambina balbuziente di 9 anni, Grete, come esempio di non felice esito del processo di maturazione. Per Grete il parlare e il cantare rappresentavano l’attività mascolina e il movimento della lingua quello del pene. “Nel corso dell’analisi – dice la Klein – si dimostrò che l’occasionale balbuzie di cui soffriva la bambina era determinata dall’investimento libidico del parlare e del cantare. Il salire e il calare della voce, e i movimenti della lingua, rappresentavano il coito”.
Coriat (1927, 1933, 1942-43) vede la balbuzie non come una difesa ma piuttosto come una perversione. Alla base di essa vi sarebbe un eccessivo erotismo orale (succhiare, masticare, mordere). La parola sarebbe trattenuta per avere una più intensa gratificazione, senza quindi sensi di colpa e inibizione. Questo autore descrive la personalità del balbuziente come passiva-dipendente e interpreta la balbuzie come una ripetizione compulsiva dei primi atti relativi all’allattamento, un tentativo di tenere legata a sé la madre come oggetto d’amore. A sostegno delle sue opinioni, sottolinea la relazione fra svezzamento ritardato ed assenza di balbuzie nelle tribù primitive della Nuova Guinea, dove manca anche il termine “balbuzie”.
Fenichel (1945) pone la balbuzie (come il tic psicogeno e l’asma bronchiale) fra le conversioni pregenitali, un terzo tipo di nevrosi i cui sintomi rientrano in quelli della conversione, ma gli impulsi inconsci espressi nei sintomi sono pregenitali. Pur evidenziando anche l’importanza di pulsioni orali, falliche ed esibizionistiche nella strutturazione del disturbo, egli considera la balbuzie principalmente un sintomo di fissazione allo stadio sadico-anale e avvicina la struttura di personalità del balbuziente a quella del nevrotico coatto. La parola detta e non detta, espulsa e trattenuta, viene rifiutata dall’Io perché rappresenta desideri relativi al livello sadico-anale del bambino. Il significato inconscio del parlare, o della cosa che sta per essere detta, o dell’attività del parlare in genere, rende impossibile esprimere quello che sta per essere detto. Come è proprio del pensiero magico concreto che caratterizza questa fase evolutiva, le parole non “rappresentano le cose” ma “sono” le cose e quindi sono sentite pericolose di sporcare e di uccidere.
Secondo Wassef (1955) sono altamente implicate nella personalità del balbuziente problematiche specifiche del livello edipico, che non trovano soluzione a causa del permanere di conflitti irrisolti dei livelli precedenti (orale e anale). Il sintomo della balbuzie esprime simbolicamente le modalità con cui sono state strutturate, negli stadi successivi dello sviluppo psicosessuale, le relazioni oggettuali e libidiche degli stadi precedenti.
Johnson (1959), pubblicando i risultati di una più che ventennale ricerca sui balbuzienti dello Iowa, arrivò a concludere che, come conseguenza della reazione del bambino ai suoi genitori, egli sviluppa una visione negativa del suo linguaggio che “inibisce” il suo parlare, e che nel dire “il mio fiato si è fermato” il balbuziente vuole significare che ci sono entità e forze sulle quali egli non ha controllo. Questo autore dà cruciale importanza all’influenza della “proiezione inconscia” dei genitori sullo sviluppo della balbuzie. Afferma: “la balbuzie inizia nell’orecchio di chi ascolta piuttosto che nella bocca del balbuziente”.
Più tardi, nel 1963 Augusta Bonnard ipotizzerà che la balbuzie, equiparata in questo senso a tutti gli altri disturbi del linguaggio, sia un’espressione psicosomatica di stati affettivi arcaici che si manifestano attraverso i meccanismi muscolari della lingua ma che vengono contrastati da azioni dirette ad annullare l’impulso.
Glauber, autore statunitense appartenente alla corrente della Psicologia dell’Io, a partire da 1935 ha pubblicato una quindicina di articoli sulla balbuzie e sul pensiero di Freud a riguardo. Egli afferma che la balbuzie ha le sue origini nel rapporto primitivo diadico madre-bambino e nel gioco fantasmatico di proiezioni-introiezioni che si crea tra di loro. In questo caso si presume una fissazione a livello orale-narcisistico che si traduce nella personalità dipendente e passiva che, secondo questo autore, è tipica del balbuziente. Nell’ultimo articolo pubblicato nel 1968, dopo la sua morte, parla della balbuzie come disautomatizzazione, cioè come un disordine del funzionamento preconscio dell’Io. Egli afferma che il parlare è una delle funzioni dell’Io che opera preconsciamente. Nella formazione del linguaggio, il bambino passa dall’imitazione conscia all’identificazione inconscia; il parlare diventa un automatismo. In talune circostanze può accadere che avvenga un investimento conscio delle funzioni preconscie, le quali quindi non avvengono più automaticamente ma passano sotto i meccanismi di controllo dell’Io. Se nel processo di separazione dall’identificazione primaria con la madre avviene un trauma, l’aggressività che si sviluppa in conseguenza della defusione delle pulsioni va a colpire la funzione del linguaggio negli aspetti dell’automatismo e della fluenza che ad esso è legata. La balbuzie viene considerata il prototipo della disautomatizzazione. Essa di solito consiste soltanto in un sintomo transitorio; se persiste nella latenza e nella adolescenza, diventa una sindrome cronica che ha due aspetti principali: 1) il disturbo primario, balbuzie come sintomo, una fissazione derivante dal trauma precoce; 2) secondariamente un conflitto nevrotico posteriore che viene innestato sopra e utilizza la fissazione primaria. Inoltre, la fissazione determina lo sviluppo di un disordine del carattere che in generale tende a riflettere la struttura della fissazione. Secondo Glauber la tecnica analitica raramente produce una completa risoluzione del sintomo, che ha radici così profonde. Può essere trattato con l’analisi solo ciò che appartiene alla struttura nevrotica; il funzionamento balbuziente, a sua volta libidinizzato e automatizzato, diventa egosintonico e vengono instaurate ambivalenze e grosse resistenze alla terapia.
La teoria di Glauber sulla balbuzie si inserisce e si accorda con il pensiero di Anna Freud per ciò che riguarda lo sviluppo delle funzioni dell’Io e le sue problematiche. La linea di sviluppo di una funzione (in questo caso il linguaggio, la comunicazione) non è stabile e continuativa ma può essere alterata da pressioni disturbanti provenienti sia dal mondo esterno che da quello interno. Anna Freud riferisce del piccolo Martin di tre anni, il quale veniva preso da collera violenta e da crisi di rabbia quando non poteva restare con la bambinaia alla quale era affidato all’asilo e alla quale era legatissimo. Dopo le sue scenate, diventava malamente balbuziente per parecchie ore, a volte anche per l’intera giornata. Il livello di funzionamento raggiunto dal bambino nel linguaggio veniva turbato dall’angoscia di perdere l’amatissima bambinaia. Un commento di Anna Freud è che “i balbettamenti infantili hanno diritto di esistere nella vita del bambino, accanto ai discorsi razionali e in alternanza con essi” (1943, 1965).
Annie Anzieu (1964, 1969, 1980, 1982) ipotizza nel bambino che diventerà balbuziente un’estrema precocità della rimozione, dovuta all’intensità delle pulsioni libidiche. Il sintomo della balbuzie non esprime la regressione o la fissazione dell’affettività soltanto ad un determinato stadio di sviluppo, ma si manifesta contemporaneamente su tre registri: paranoico, ossessivo e isterico, i quali si riferiscono agli stadi successivi orale, anale e fallico dello sviluppo psicosessuale ed alle relazioni oggettuali elaborate o non completamente elaborate all’interno di essi. Questa interpretazione permette di spiegare il carattere sfaccettato e la presenza di atteggiamenti contraddittori, come attività e passività, nel balbuziente. Annie Anzieu osserva nei balbuzienti una struttura psichica estremamente fragile sotto le difese apparenti, pur avendo riscontrato molto raramente balbuzienti psicotici o psicotici balbuzienti, come se la balbuzie fosse un segno o un mezzo per superare e controllare la parte psicotica della personalità. Nel pensiero di questa autrice, il linguaggio come conquista del simbolico è il segno della accettazione delle differenze generazionali e del divieto dell’incesto. La balbuzie quindi è il sintomo che esprime la lotta fra il desiderio inconscio e la non ammissione di esso. Per questa autrice (come per Glauber) la balbuzie si manifesta spesso in un contesto familiare caratterizzato da una relazione madre-figlio fusionale, altamente sessualizzata, in cui le tematiche edipiche del figlio si incontrano con i desideri edipici inconsci della madre, colludendo con essi. Nel balbuziente la posizione edipica sembra restare la stessa, non superata, per tutta la vita; la sessualità genitale mai pienamente raggiunta e goduta. L’eliminazione della balbuzie viene ritenuta quasi impossibile per le radici arcaiche di essa e per l’utilizzazione difensiva del sintomo.
Anche Sigurtà (1955, 1970) dà della balbuzie una visione più allargata, che non lega più il disturbo ad una regressione-fissazione ad un unico e determinato stadio dello sviluppo psicosessuale, ma la interpreta come un sintomo che può presentarsi in diverse forme nevrotiche, le quali esprimono problematiche a livelli diversi. La balbuzie si manifesta in quei casi in cui gli organi del linguaggio vengono investiti di significato tale da diventare il luogo più adatto per l’espressione del conflitto.
Per W. Bion (1967, 1970) il balbettare è un attacco al linguaggio in quanto legame fra paziente e analista. La formulazione verbale con la quale le esperienze vengono espresse viene mandata in frantumi dalle emozioni sottostanti che non riescono più ad essere contenute dal contenitore linguaggio, cosicché il significato che chi parla vuole esprimere viene spogliato di significato. Come per M. Klein, Bion riferisce, nella situazione clinica di balbuzie che riporta, l’investimento libidico masturbatorio della bocca.
E. Gaddini (1980) avvicina la balbuzie all’asma bronchiale, affermando che là dove la sindrome dell’asma non si è instaurata (fine del primo anno di vita), nel secondo anno di vita si può instaurare la balbuzie. La balbuzie quindi viene collegata alle sindromi psicofisiche datate che, secondo questo autore, si riferiscono ad una patologia della mente relativa al distacco e alla separatezza dall’oggetto primario materno. Esse esprimono in una sorta di linguaggio preverbale, concreto e presimbolico, quale è quello di un alterato funzionamento corporeo, un contenuto mentale difensivo. La connessione funzionale del parlare con il respirare viene usata dalla mente infantile per riattivare una delle prime esperienze della mente, quella del succhiare e del deglutire al seno in concomitanza con il respirare.
Renata Gaddini a sua volta (1980) sottolinea come nell’età in cui insorge la prima balbuzie, 2/3 anni, il mondo interno del bambino è pieno di contenuti sadici: tensioni dirompenti e fantasie distruttive. Secondo questa autrice, le tensioni che sono alla base dei sintomi che insorgono a questa età, come la balbuzie, sono di natura istintuale e quindi non tendono a risolversi da sole ma “urgono senza pietà” nel corso del crescere in relazione al rapporto oggettuale.
Anche Giannitelli, che aveva avuto a che fare come pedopsichiatra con questa patologia, in un articolo del 1976 aveva parlato di attivazione nella balbuzie di pulsioni pregenitali prevalentemente aggressive e distruttive sulla base di angosce traumatiche di separazione.La localizzazione somatica sulle prime vie aeree viene collegata all’iperinvestimento dell’aria sulla base della fissazione anale. Rifacendosi a Fenichel, questo autore suppone che “a livello del pensiero primitivo l’apparato respiratorio sembra diventare la sede dell’incorporazione degli oggetti alla stessa guisa di quello intestinale: alla stessa guisa si prendono e si ricevono sostanze dal mondo esterno, o si restituiscono, si ridanno ad esso”. Giannitelli sottolinea l’alternanza (nei casi da lui studiati) della balbuzie con le malattie respiratorie, entrambi come comunicazione di richiamo al rapporto per via somatica secondo modalità espressive non verbali.
R. Diatkine (1985) sottolinea che la balbuzie nel bambino non è un sintomo nevrotico nel senso stretto del termine, ma piuttosto una inibizione in una situazione di parola. Egli afferma che nei piccoli balbuzienti si ritrova con innegabile frequenza l’importanza delle fissazioni sadico-orali e delle relazioni pregenitali, in particolare dell’invidia, nel senso kleiniano del termine. Secondo questo autore, la balbuzie costituisce una debolezza nella relazione con l’altro, dove la disorganizzazione del linguaggio rappresenta il fallimento dell’identificazione primaria coi genitori. Quando nel bambino le organizzazioni preedipiche ed edipiche – che hanno partecipato alla labilità strutturale nel corso della quale si organizza la balbuzie – non evolvono positivamente, allora la balbuzie può fissarsi come sintomo nevrotico di varie forme psicopatologiche.
Nel 1999 Tomas Plänkers, nel discutere il materiale dell’analisi di un paziente balbuziente, formula una nuova ipotesi sulla psicodinamica della balbuzie facendo riferimento alla teoria del claustrum di Meltzer. Sostiene che il balbuziente si trova a far fronte ad esperienze intollerabili di separazione dall’oggetto primario e all’esperienza catastrofica della situazione edipica attraverso una fantasia inconscia nella quale l’odio predominante conferisce all’oggetto materno interno delle qualità anali. Lo spazio dell’oggetto sadico-anale di questo “claustrum” è proiettata sullo spazio dell’oggetto esterno, in modo specifico sulla bocca in quanto cavità involucro dei suoni che, secondo le teorie di D. Anzieu, viene considerata il vero primo spazio psichico; ne consegue la rottura delle parole. In parallelo, nelle relazioni d’oggetto ne consegue l’attacco al legame e il ritiro psichico, come Plänkers testimonia nelle vicende del transfert e controtransfert con il suo paziente.
Dal punto di vista psicoanalitico, dunque, la balbuzie è considerata un sintomo, indice di un disagio psicologico che ha addentellati nelle fasi più precoci dello sviluppo affettivo e che trova espressione a livello organico con una conversione dal conflitto psicologico alla funzionalità dell’organo (sistema respiratorio, articolatorio-fonatorio). E’ implicita l’idea di base di una stretta connessione fra l’espressione psichica e il substrato organico nell’individuo dove (citando A. Anzieu) il linguaggio costituisce l’adempimento dei processi di mentalizzazione che a poco a poco portano sulla via simbolica attraverso i labirinti somato-psichici e la dialettica Io/altro. L’origine del disturbo è dunque collocabile nelle fasi precoci dello sviluppo psichico, là dove l’aggressività è componente fondamentale dei processi di separazione e differenziazione di sé dall’altro e dove i processi di simbolizzazione ancora non sono completati.
All’aggressività è stata attribuita una grande importanza come fattore caratterizzante sia la manifestazione della balbuzie, sia la personalità del balbuziente. Il padre di un bambino portato a consultazione perché balbettava, spiegava che capiva benissimo il problema e la sofferenza del figlio, perché anche lui era stato balbuziente da ragazzo. Disse che non gli riusciva di pronunciare le parole specialmente quando era arrabbiato, perché gli pareva che una spada di fuoco gli uscisse dalla gola e andasse a colpire la persona alla quale parlava. Le parole di questo padre sarebbero molto piaciute a Fenichel, il quale scrisse che, nella situazione affettiva da cui si origina la balbuzie, le parole possono uccidere e i balbuzienti sono persone che inconsciamente ritengono necessario usare con cura un’arma così pericolosa.
L’aggressività è necessaria per mettere spazio fra sé e l’altro e stabilire i confini. Da un confine all’altro, quello spazio può essere percorso dalla parola quale espressione del pensiero e degli affetti, come un ponte segno di separazione e di relazione. Ma se l’aggressività invece che creare spazio produce distruzione, la parola non potrà mai essere espressa e il pensiero non potrà trovare evoluzione.
Bibliografia
Anzieu A. (1964), Reflexions critiques à propos de le bégaiment, Révue de Neuropsychiatrie Infantile, 1-2, 101.
Anzieu A. (1969), Sur quelques traits de la personnalité du bègue,Bull. Psychol., 21, 1022-1028.
Anzieu A. (1980), Dalla carne al verbo: mutismo e balbuzie, in: Anzieu D. e Altri “Psicoanalisi e linguaggio”, ed. Borla, Roma, 1980.
Anzieu A. (1982), Essai sur le corps fantasmatique du bègue, Pratiques des mots, 1982, 40, 14-18.
Anzieu D. (1985), L’Io-pelle, ed. Borla, Roma, 1987.
Barrau B. (1980), Balbuzie e violenza orale, in: Anzieu D. e Altri “Psicoanalisi e linguaggio”, ed. Borla, Roma, 1980.
Bion W.R. (1967), Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico (cap. 7), ed. Armando, Roma, 1970.
Bion W.R. (1970), Attenzione e interpretazione (cap. 10), ed. Armando, Roma, 1973.
Bloom L. (1978), Notes for a History of Speech Pathology,The Psychoanalytic Review, 1978, 65, 3.
Bonnard A. (1963), Impediments of speech: a special psychosomatic instance , International Journal of Psycho-Analysis, 1963, 151-162.
Coriat J.H. (1927), The oral erotic component of stammering, International Journal of Psycho-Analysis, 8, 56-62.
Coriat J.H. (1933), The Dynamics of Stammering, Psychoanalytic Quarterly, 2, 250-252.
Coriat J.H. (1942-43), The Psychoanalytic Concept of Stammering,The Nerv. Child, 2, 167-171.
Diatkine R. (1985), I disturbi della parola e del linguaggio, in: Lebovici e Altri, Trattato di Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ed. Borla, Roma, 1990 (2º volume).
Dorsey J.M. (1934), The Treatment of the Person Who Stutters, Mental hygiene, 1934, 18.
Fenichel O. (1945), Trattato di Psicoanalisi, ed. Astrolabio, Roma, 1951.
Freud A. (1943), Bambini senza famiglia, in: Anna Freud Opere, vol. 1°, ed. Boringhieri, Torino, 1978.
Freud A. (1965), Normalità e patologia del bambino, in: Anna Freud Opere, vol. 3°, ed. Boringhieri, Torino, 1979.
Freud S. (1892-95), Studi sull’isteria, in: Freud Opere, vol. 1º,ed. Boringhieri, Torino, 1967.
Freud S. (1901), Psicopatologia della vita quotidiana, in: Freud Opere, vol. 4º, ed. Boringhieri, Torino, 1973.
Gaddini E. (1980), Note sul problema mente-corpo,Rivista di Psicoanalisi, 1981/1.
Gaddini De benedetti R. (1980), Patologia psicosomatica come difetto maturativo, Rivista di Psicoanalisi, 1980/3 .
Giannitelli S. (1976), Sé ed espressione: condizioni, sviluppo della regolazione energetica e partecipazione somatica, Rivista di Psicoanalisi, 1976/3.
Glauber I.P. (1943), Psychoanalytic Concepts of the Stutterer,Nerv. Child, 2, 172.
Glauber I.P. (1950), Ego Development and the Character of the Stutterer, Psychoanalytic Quarterly, 19, 142.
Glauber I.P. (1951), The Mother and the Etiology of Stuttering, Psychoanalytic Quarterly, 20, 160.
Glauber I.P. (1954), Dynamic Therapy for the Stutterer, in Specialized Techniques in Psychotherapy, Basic Books, New York, 1954.
Glauber I.P. (1958), Freud’s Contribution on Stuttering: Their Relation to Some Current Insights, J. Amer. Psychoanal. Assoc., 6, 326-347.
Glauber I.P. (1968), Dysautomatization: a Disorder of Preconscious Ego Functioning, International Journal of Psycho-Analysis, 1968, 49, I,
89-99.
Johnson W. (1959), The Onset of Stuttering, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1959.
Jones E. (1953), Vita e opere di Freud, vol. 2º, Garzanti, Milano, 1977.
Klein M. (1923), Analisi Infantile, in: Melanie Klein Scritti 1921-1958,ed. Boringhieri, Torino, 1978.
Meltzer D. ( 1992) , Claustrum, uno studio sui fenomeni claustrofobici, ed. Cortina, Milano, 1993.
Numberg H. e Federn E. (a cura di), Dibattiti della società psicoanalitica di Vienna 1906-1908, ed. Boringhieri, Torino, 1973.
Piänkers T. (1999), Speaking in the Claustrum: the Psychodynamics of Stuttering, (Int. Jour. Psycho-Anal., 1999, 80, 239-256.
Schindler O. e AL. (1994), Etiopatogenesi , in: La Balbuzie, XXVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Foniatria e Logopedia, Acta Phoniatrica Latina, vol 16 fasc. 1-2, 1994, a cura di M. Maurizi.
Scripture E.W. (1912), Stuttering and Lisping, New York, Macmillan, 1912.
Sigurtà R. (1970), Balbuzie e psicoanalisi, Articolo non pubblicato, Istituto di Psicoanalisi, Milano, 1970.
Sigurtà R., De Benedetti Barbieri M. (1955), La balbuzie, Milano, Minerva Medica, 1956.
Stekel W. (1908), Nervose Angstzustande und Ihre Behandlung, Berlino, Urban und Schwarzenburg, 1908.
Wassef H.W. (1955), Etude clinique de différentes modalités structurales au cours de psychanalyses de bègues, Revue Francaise de Psychanalyse, 19, 440-472.
Maggio 2014
Balconi Marcella

Marcella Balconi
A cura di Raffaela Pagano
Marcella Balconi è stata, con Maria Elvira Berrini e Giovanni Bollea, uno dei principali fondatori della psicoanalisi infantile in Italia. Dal 1949 al 1980 ha diretto dapprima un servizio pilota di neuropsichiatria infantile, poi il reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Maggiore di Novara. Nel suo centro si sono formati centinaia di psicoterapeuti ad indirizzo psicoanalitico che, a loro volta, hanno poi fondato e diretto altri centri con caratteristiche affini. Si può dire che molti dei reparti di neuropsichiatria infantile nati in Piemonte (ma non solo) siano sorti quasi per gemmazione dal reparto novarese diretto da Marcella Balconi.
Molti tra gli psicologi e i medici che hanno effettuato il tirocinio a Novara o che hanno lavorato in quel reparto di neuropsichiatria infantile, sono in seguito entrati nella Società Psicoanalitica Italiana. Anche Marcella Balconi era un membro della SPI.
Si era formata nell’immediato dopoguerra, dapprima attraverso uno stage nell’ospedale parigino di Sant’Anna, dove iniziò a collaborare con Serge Lebovici, poi lavorando nel centro medico-pedagogico di Lucien Bovet a Losanna, infine presso il Service médico-pédagogique di André Repond, nella località svizzera di Malévoz.
Il centro istituito da Repond era, in quegli anni, all’avanguardia in Europa e venne frequentato, tra gli altri, anche da Lebovici, Berrini e Bollea. Era un centro nel quale veniva richiesta una formazione psicoanalitica e Marcella Balconi intraprese un’analisi con N. Beno che si concluse nel 1953.
Ai tirocinanti che lavorarono nel suo reparto di Neuropsichiatria infantile, Marcella Balconi non richiese però mai di fare un’analisi personale, anche se appoggiò e sostenne la scelta di coloro che decisero di intraprenderla. Il suo obiettivo era quello di creare una struttura diffusa capillarmente nel territorio, gestita da operatori ai quali erano affidate mansioni diverse, con un processo di formazione permanente, sempre condotto, però, all’interno di un’ottica psicoanalitica.
Il ruolo e il peso di Marcella Balconi nello sviluppo della psicoanalisi non solo infantile in Piemonte e in altri contesti geografici è stato di assoluto rilievo, come testimoniano coloro che hanno avuto modo di formarsi e di collaborare con lei.(1) Di questa sua attività, condotta per quarant’anni nel centro di Novara, e poi attraverso un numero rilevantissimo di supervisioni negli anni successivi, restano però testimonianze scritte relativamente esigue. C’è infatti una assoluta sproporzione tra la mole di lavoro che Marcella Balconi svolse e i libri che ha scritto.(2)
Per spiegare questa discrepanza, si è detto di lei che fosse soprattutto una clinica e non una teorica. Il che, in parte, forse è vero. Ma è anche vero che non esiste una clinica senza una teoria. E viceversa.
E allora qual era la teoria alla quale Marcella Balconi faceva riferimento? I seminari che Marta Harris e Donald Meltzer tennero per molti anni nel centro di Novara, indussero alcuni a qualificarla come kleiniana. Il che, però, non è corretto.
“Non definirei Marcella Balconi una psicoanalista ortodossa – scrive Carla Gallo Barbisio – Non poteva essere collocata facilmente come kleiniana, annafreudiana, winnicottiana o altro: era se stessa”.(3)
 In cosa consistesse questa sua singolarità analitica può essere dedotto, anche se solo a grandi linee, soprattutto da un breve testo pubblicato dai Quaderni di Psicoterapia Infantile nel 1984.(4) Era un numero della rivista dedicato proprio alla fondatrice del reparto di Neuropsichiatria infantile di Novara e al tema per lei cruciale dell’osservazione. Raccoglieva i contributi di molti collaboratori del centro novarese e si apriva, letteralmente, con la voce di Marcella Balconi. Il testo raccolto sotto il titolo di “Autobiografia scientifica”, infatti, non era stato scritto da lei, ma consisteva nella trascrizione di una intervista che Marcella Balconi aveva concesso nel 1980 a Francesco Scotti.(5)
In cosa consistesse questa sua singolarità analitica può essere dedotto, anche se solo a grandi linee, soprattutto da un breve testo pubblicato dai Quaderni di Psicoterapia Infantile nel 1984.(4) Era un numero della rivista dedicato proprio alla fondatrice del reparto di Neuropsichiatria infantile di Novara e al tema per lei cruciale dell’osservazione. Raccoglieva i contributi di molti collaboratori del centro novarese e si apriva, letteralmente, con la voce di Marcella Balconi. Il testo raccolto sotto il titolo di “Autobiografia scientifica”, infatti, non era stato scritto da lei, ma consisteva nella trascrizione di una intervista che Marcella Balconi aveva concesso nel 1980 a Francesco Scotti.(5)
In quell’intervista sono contenuti, pur se in estrema sintesi, i principali concetti teorici ai quali Marcella Balconi ha fatto riferimento per tutta la vita. Sono espressi in modo semplice e piano, con un linguaggio che non ha quasi nulla di tecnico, e ciò nonostante essi contengono spunti che sono di grande attualità e interesse nell’odierno dibattito teoretico in ambito psicoanalitico.
Sono concetti che riguardano il ruolo e la figura del terapeuta, i suoi rapporti con i pazienti, la trasmissione del sapere psicoanalitico, il metro di valutazione riguardo a normalità e patologia, gli strumenti e gli obiettivi della cura, il peso e l’incidenza della realtà esterna nel costituirsi del mondo interno.
Partirò proprio da quest’ultimo punto per descrivere in modo un po’ più approfondito il pensiero di Marcella Balconi. Lo farò ricorrendo a un aneddoto riportato da quasi tutti i suoi collaboratori. Quando un medico o uno psicologo veniva accolto nel reparto di neuropsichiatria di Novara, il primo approccio lavorativo consisteva in un “viaggio nella realtà”. Marcella Balconi portava i nuovi arrivati nei quartieri, nei paesi, nelle scuole e negli asili dove vivevano coloro che sarebbero stati i loro pazienti.(6) Il perché, lo spiegava in questo modo: “Non è solo il mondo interno l’oggetto del nostro lavoro, ma vi è, come elemento costitutivo, anche lo scontro con la realtà”.(7)
La necessità che la muoveva era quella di avere una visione globale: del contesto sociale e del territorio, del contesto famigliare e transgenerazionale e poi del singolo paziente nella sua totalità. Il punto di arrivo era quello di creare “una medicina di territorio di tipo longitudinale”(8).
Lo strumento primario di questo percorso, ovviamente, era l’osservazione: “Quando ho iniziato ad insegnare, tra le prime cose insegnavo proprio come osservare il bambino. Dicevo, fino a diventare noiosa: osservate bene il bambino che entra. Cominciate ad osservarlo fin dalla porta. Guardate come è vestito, guardate come è pettinato, come vi guarda, come muove le mani. Guardate tutto, perché solo così potrete avere una visione di insieme del bambino. L’osservazione vi dice se in famiglia è curato o non è curato, quali sono le condizioni economiche. Il suo sguardo vi rivela se vi vede come un amico o come un nemico. I movimenti hanno il profondo valore di esprimere quelle tensioni che ancora non si esprimono con la parola”.(9)
Era l’osservazione lo strumento che consentiva di cogliere l’essenza della relazione tra madre e bambino e quindi capire aspetti fondamentali della realtà interna del paziente. ” Se osservi una situazione a due, evidenzi tutti i rapporti che esistono tra quei due ed anche i fantasmi che quando il bambino è piccolo sono nella madre e quando il bambino è più grande sono nel bambino”.(10)
Ma, soprattutto, era importante, anzi, essenziale, il modo in cui si conduceva l’osservazione e lo spirito che animava l’atteggiamento del terapeuta.
“Nel nostro lavoro, osservare significa osservare la vita …. Quando osservi, vai incontro a dei rischi. Il primo è quello di devitalizzare l’oggetto di osservazione; poi di vedere solo una parte o un settore di realtà. Osservare vuol dire acquisire la capacità di vedere un insieme, un tutto unitario….tu devi avere sempre la carica umana che ti fa ricercare l’intero e non la parte: l’interesse per una persona viva, non per i pezzi di una persona. Quando incominci ad osservare in questo modo ti rendi conto di avere delle emozioni, di vivere il rapporto in un certo modo. Prendi coscienza che l’individuo che osservi è pieno di vita come te. Qui la psicoanalisi dà un serio contributo nel far vedere che le problematiche del tuo malato sono anche le tue. Incominci ad avere verso il malato quell’atteggiamento che è l’unico possibile se vogliamo portare avanti un discorso nuovo che è di rispetto dell’altro. Si instaura un dialogo per cui impari da lui e lui da quello che tu sai. Si stabilisce cioè un rapporto di parità. Io ho il compito di guarire il malato; il malato insegna a me a guarirne un altro o a migliorare me stessa”.(11)
La visione di Marcella Balconi sul rapporto con il paziente, e quindi sul ruolo e sull’atteggiamento del terapeuta, precorreva dunque alcuni degli spunti teorici che oggi sono oggetto di intenso dibattito.
Non stupisce che Marcella Balconi, pur essendo membro associato della SPI, non abbia mai voluto partecipare in modo più attivo alle vicende societarie. “A me bastava essere psicoanalista …. Il non essere membro ordinario mi lasciava un ampio margine di movimento”.(12)
Questo “margine di movimento” comprendeva anche la libertà di provare delle emozioni, di mettersi sullo stesso piano del paziente pur non cadendo nell’errore di una falsa simmetria, di ammettere che il paziente poteva insegnarci qualcosa anche riguardo al nostro stesso mondo interno. Non erano esattamente questi, i canoni ufficiali della psicoanalisi negli Anni Sessanta e Settanta.
Ma Marcella Balconi andava ancora oltre: “Quando ho iniziato a preparare persone per la psicoterapia, andavo contro corrente. Allora si parlava solo di analisi classica e si diceva che la psicoterapia deve essere fatta solo da persone analizzate. Io, al contrario, preparavo i giovani del servizio a fare la psicoterapia anche se non erano analizzati”.(13)
Ciò che la infastidiva era un concetto per molti versi élitario di psicoanalisi, che contrastava fortemente con il suo impegno politico e sociale.(14) Asseriva che la psicoanalisi doveva essere a carico di una istituzione e che non doveva comportare esborsi ingenti di denaro da parte dei pazienti. La speranza che la muoveva (e per la quale operava attivamente in prima persona) era quella di consentire a tutti, anche ai meno privilegiati, di poter usufruire di cure fino a quel momento riservate solo alle classi più abbienti.
Era la speranza di coloro che, come lei, avevano fatto la Resistenza e che volevano trasformare un Paese arretrato e classista in una democrazia moderna con un sistema di assistenza sanitario efficiente e diffuso capillarmente nel territorio. La scelta di formare psicoterapeuti anche non analizzati andava proprio in questa direzione: c’era molto lavoro da fare, e bisognava farlo in fretta. C’era bisogno di personale qualificato a svolgere funzioni psicoterapiche di base per le quali un’analisi personale non era da lei ritenuta indispensabile. Certo, chi, tra i suoi tirocinanti, poteva e sceglieva di intraprendere un’analisi personale, aveva tutto il suo appoggio. La sua immagine ideale dello psicoterapeuta non era affatto un’immagine riduttiva e sminuente. Al contrario. Nella sua ottica, non solo il terapeuta doveva avere il più alto livello possibile di conoscenze psicoanalitiche, ma doveva averne anche altre di carattere più generale: “Non credo sia possibile fare il nostro lavoro senza avere basi umanistiche: la conoscenza della storia, il piacere dell’arte. L’individuo non è mai avulso dalla società in cui vive, dalla storia del pensiero. Anche per la patologia vale questo legame con la cultura, con il costume”.(15)
In altri termini, non solo il terapeuta doveva operare in modo da avere una visione globale del paziente e del territorio in cui risiedeva, ma anche della società nella quale tutti, pazienti e terapeuti, vivevano.
La società nella quale Marcella Balconi incominciò a lavorare agli inizi degli Anni Cinquanta era una società nella quale non era neppure ben definito il concetto più elementare di patologia. Il bambino che “recava disturbo”, soprattutto se apparteneva ad una classe sociale bassa, aveva buone probabilità di vedersi rinchiuso in una istituzione che certamente avrebbe aggravato i suoi problemi. Il primo impegno di Marcella Balconi fu quello di organizzare uno screening capillare nella scuola primaria e negli asili: “Mi sono posta il problema di quali parametri di riferimento usavo quando dicevo che un bambino era normale o no. Mi sono detta: se vediamo tutti i bambini della nostra città, di una certa età, ci rendiamo conto delle problematiche di questa età. A partire dall’insieme della popolazione potremo dire chi è malato e chi è sano”.(16)
Poi, ovviamente, si trattava di curare chi ne aveva la necessità.
Il fatto che noi, oggi, consideriamo tutto questo quasi come scontato, significa che il lavoro svolto da Marcella Balconi è stato proficuo.
Credo che Marcella Balconi si sia dedicata quasi esclusivamente alla psicoanalisi infantile e non a quella degli adulti perché era convinta, e con ragione, che i bambini fossero i soggetti più deboli e che quindi abbisognassero maggiormente delle sue cure. Curare i bambini significava aiutarli a diventare adulti sani. Cioè a rendere la società, nel suo complesso, migliore.
Io credo però (ma questa è solo una mia ipotesi) che ci fossero anche altre ragioni alla base di questa sua scelta. Ragioni che forse hanno a che fare proprio con il tipo di rapporto che lei tendeva ad instaurare con i suoi piccoli pazienti, e cioè un rapporto, anche, emozionale.
Oggi questo non ci stupisce affatto, ma negli anni nei quali operava Marcella Balconi, il ruolo dello psicoanalista, e in particolar modo nel setting con gli adulti, le emozioni erano ufficialmente bandite. Una psicoanalisi classica, con il paziente sul lettino, non le avrebbe inoltre consentito di instaurare una relazione attraverso uno strumento che lei considerava fondamentale nella terapia con i bambini: lo sguardo.
Il “vedersi” era per Marcella Balconi il mezzo fondamentale attraverso il quale avveniva la comunicazione più profonda tra terapeuta e paziente: “Lo stare di fronte al terapeuta, seduti al tavolo, il poter volgere costantemente lo sguardo a lui e trattenere a loro volta i suoi occhi permette ai bambini una comunicazione che si fa man mano più intensa, dove si intrecciano lo sguardo, l’agire disegnando, il lasciarsi andare, il parlare, l’intendersi e il difendersi in un periodo evolutivo in cui l’espressione puramente verbale non può ancora essere mezzo privilegiato per comunicare sentimenti complessi”.(17)
Oggi noi sappiamo che il verbo non è affatto l’unico strumento di cui disponiamo anche nelle terapie con gli adulti. Anzi, ci siamo resi conto che la parola è spesso insufficiente e inadeguata per raggiungere traumi che sono avvenuti in ambiti psichici così arcaici da precedere la capacità di parola. Ampi filoni della psicoanalisi contemporanea si stanno muovendo in questa direzione. Credo che la psicoanalisi infantile, e con essa Marcella Balconi, ci abbia fornito indicazioni preziose sulla strada da percorrere.
E’ una strada nella quale non è più in gioco solo l’inconscio del paziente, ma, nell’ambito della relazione, anche quello dell’analista, a cui è richiesta una capacità di comprensione che va oltre la cosiddetta razionalità del livello conscio.
Per definire questa capacità di comprendere attingendo a risorse profonde che sfuggono a tutte le teorie codificate, noi a volte usiamo il termine di “intuizione”. Lo usava anche Marcella Balconi, ma senza attribuirgli alcunché di misterioso. “In realtà – diceva – l’intuizione si costruisce acquistando la capacità di osservare e poi di sintetizzare. Ad un certo punto, questo processo avviene con estrema rapidità. Esso viene chiamato intuizione solo da coloro che non si rendono conto della natura del processo. Tutti possono imparare ad avere intuizione”.(18)
E’ una affermazione rassicurante, ma niente affatto scontata. Chi ha avuto l’opportunità, ad esempio, di osservare la capacità quasi magica che Marcella Balconi aveva di “leggere” i disegni dei bambini, individuandone particolari e significati apparentemente invisibili, non può far altro che dubitare che questa attitudine possa essere in qualche modo insegnata e appresa.
Uno dei pochi testi firmati da Marcella Balconi è contenuto nel libro “Il disegno e la psicoanalisi del bambino”. (19) Ha come titolo “Il ciccione e il tetaccio” e riguarda i disegni di un bambino di quattro anni e mezzo, portato al servizio di neuropsichiatria infantile perché presentava problemi di linguaggio. Marcella Balconi ne analizza, commenta e interpreta i disegni. Lo fa servendosi della sua esperienza e delle sue capacità, ma, soprattutto, facendosi aiutare da quanto Paul Klee scrisse nei suoi diari e nel suo testo sulla teoria della forma e della figurazione.
La psicoanalisi, a partire da Freud, ha spesso interpretato il lavoro degli artisti. Ma è assolutamente inconsueto che uno psicoanalista assegni a un artista il compito dell’interpretazione.
Marcella Balconi lo ha fatto.
Nella sua autobiografia scientifica afferma: “Ho sempre insegnato tutto quello che sapevo”.(20)
Peccato che non tutto si possa imparare.
1) Vedi “Grazie Marcella”, Quaderni ArsDiapason 2009, che raccoglie, a dieci anni dalla sua morte, le testimonianze di molti di coloro che hanno lavorato con lei.
2) In “Grazie Marcella”, op. cit., Germana De Leo racconta che “nelle sue ultime settimane di vita Marcella Balconi si chiedeva se fosse il caso di rammaricarsi per non aver scritto e pubblicato con compiutezza il suo pensiero teorico e le sue esperienze di analista-neuropsichiatra infantile, avendolo affidato quasi esclusivamente alla trasmissione orale”. Pag. 12.
3) Ibidem, pag. 74.
4) “Quaderni di Psicoterapia infantile n. 4”, Borla Editore 1984, pagg. 8-20.
5) Ibidem, pag. 8.
6) “Mi disse che non avrei potuto fare bene il mio lavoro con i bambini in ospedale senza conoscere il contesto, senza rendermi conto delle diverse realtà da cui essi provenivano e in cui vivevano” . Carla Gallo Barbisio in “Grazie Marcella”, op. cit. pag. 70.
7)Quaderni di Psicoterapia Infantile n. 4, op. cit. pagg. 15-16.
8) Ibidem, pag. 11.
9) Ibidem, pag. 14.
10) Ibidem, pag. 14.
11) Ibidem, pagg. 18-19.
12 ) Ibidem, pag. 15.
13) Ibidem, pag. 15.
14) Marcella Balconi ricoprì in varie riprese e in più epoche il ruolo di assessore, di sindaco e anche di deputato al Parlamento nelle fila del Pci.
15) Ibidem, pag. 20.
16) Ibidem, pag. 10.
17) Marcella Balconi – G. Del Carlo Giannini, “Il disegno e la psicoanalisi infantile”, Raffaello Cortina Editore 1987, pag. 5.
18) “Quaderni di Psicoterapia infantile n. 4”, op. cit. pag. 19.
19) Op. cit.
20) “Quaderni di Psicoterapia Infantile n. 4”, op. cit. pag. 16
Balint. Il metodo

Stella Olivier, William Kentridge - 2017
A cura di Mario Perini
I Gruppi Balint – così chiamati dal nome del loro ideatore, Michael Balint – sono un metodo di lavoro di gruppo destinato ai medici e alle altre professioni di cura e d’aiuto, che ha come scopi la formazione psicologica alla relazione con il paziente, la “manutenzione del ruolo curante” e la promozione del benessere lavorativo.
Chi è Michael Balint?
Nato a Budapest nel 1896, figlio di un medico di famiglia, dopo la laurea in medicina lavorò per qualche anno nel campo della biochimica. Si interessò alla psicoanalisi dopo aver assistito a una conferenza di Freud nel 1918 e grazie al fatto che la sua prima moglie, Alice, era una psicoanalista. Formatosi al metodo analitico con Sandor Ferenczi, un allievo di Freud, lavorò a Budapest come analista fino al 1939 e poi si trasferì in Inghilterra come rifugiato. Alla fine della guerra entrò a far parte dello staff della Tavistock Clinic di Londra, dove a partire dai primi anni ’50 iniziò, insieme con la terza moglie, Enid, ad occuparsi della formazione dei General Practitioner: nacquero così i gruppi di training che presero il suo nome, i Gruppi Balint. Nel 1957 uscì il suo libro più importante, Medico Paziente e Malattia, e da allora la formazione dei medici di famiglia inglesi venne profondamente influenzata dal suo metodo, che era noto anche come “medicina centrata sul paziente”.
I Gruppi Balint rappresentano una metodologia collaudata di formazione di gruppo, creata originariamente per l’addestramento psicologico dei medici di famiglia e adattata successivamente ad altre figure professionali. Nata all’interno di un modello delle cure fondato sul rapporto a due curante/paziente, è venuta nel tempo ampiamente trasformandosi e rimodellandosi per rispondere ai profondi mutamenti che nel corso degli ultimi decenni hanno cambiato il volto della medicina, delle cure primarie e del welfare, e che nel lavoro del medico di famiglia hanno gradualmente trasformato la relazione di cura in un insieme di relazioni di coppia, di gruppo e di rete, più complesse e più impegnative sia in termini professionali che per il loro costo emotivo.
Quali sono le premesse del metodo Balint?
Le premesse concettuali del metodo sono le seguenti:
1) il “farmaco” più frequentemente prescritto è il medico, ma la sua farmacologia (l’azione terapeutica, la posologia, la tossicità, gli effetti collaterali, ecc.) è sostanzialmente sconosciuta;
2) sebbene un’ampia quota del lavoro del medico di famiglia sia assorbita da casi “psicologici” la formazione medica non prevede nessun tipo di preparazione specifica;
3) la medicina presta molta attenzione alla malattia e ai sintomi, molto meno alla persona malata, poco o nulla alla relazione medico-paziente, per quanto le vicissitudini di tale relazione siano così spesso causa di insoddisfazione e di ansietà per entrambi i partecipanti, oltre che fonte di frequenti errori diagnostici e terapeutici;
4)l’esperienza, il buon senso e la buona volontà non bastano a fare un buon medico;
5)il moderno sistema delle cure richiede al medico nuove competenze emotive e relazionali, senza le quali il suo lavoro corre il pericolo di diventare inefficace, rischioso e molto logorante
A chi è rivolto e come opera il metodo Balint?
Rivolto in origine essenzialmente ai medici di famiglia, per la specificità del loro lavoro, che si basa su relazioni di cura di lunga durata e spesso di particolare intimità e intensità emozionale, questo approccio è stato esteso e proficuamente adattato anche a medici ospedalieri, infermieri, tecnici e professionisti sanitari, studenti in medicina, psicologi, assistenti sociali, educatori, magistrati, insegnanti, dirigenti di servizi e istituzioni sanitarie, socio-educative e di accoglienza residenziale. In termini generali il metodo si è rivelato utile per tutte le professioni che implicano una relazione d’aiuto (le c.d helping professions) essendo centrato
– sull’indagine della relazione tra professionista e cliente;
– sull’azione del gruppo come strumento facilitatore del pensiero;
– su un apprendimento basato sull’esperienza e non solo sulla conoscenza intellettuale.
Quali sono gli obiettivi primari del metodo Balint?
Gli obiettivi che il metodo Balint si propone possono essere riassunti in quattro punti
a)Miglioramento della relazione di cura
b)Protezione del benessere lavorativo del professionista
c)Addestramento al lavoro di gruppo
d)Manutenzione del ruolo curante
Questi obiettivi sono tra loro strettamente interconnessi.
Infatti l’acquisizione da parte del medico di maggiori competenze emotivo-relazionali gli permette
a)un approccio al paziente più soddisfacente perché fondato più sulla relazione, sull’ascolto e sull’attenzione ai bisogni che sull’intervento e sulla prescrizione;
b)lo sviluppo di una speciale sensibilità che, aiutando il medico a comprendere meglio il paziente, le sue emozioni, il suo comportamento e il suo punto di vista sulla malattia e sul trattamento, riducono le tensioni nel rapporto e facilitano l’alleanza di lavoro;
c)una maggiore consapevolezza delle proprie reazioni emozionali in risposta ai comportamenti del paziente, con aumento della capacità di affrontare le ansie, evitando il ricorso ad atteggiamenti difensivi controproducenti, e lo sviluppo di relazioni di cura più efficaci, efficienti, governabili e gratificanti per entrambe le parti.
d)una più chiara comprensione dei processi di gruppo, delle dinamiche organizzative e delle relazioni di rete che influenzano il lavoro del medico e il suo benessere lavorativo.
Che risultati persegue una formazione col metodo Balint?
I risultati attesi sono i seguenti:
1.individuazione dei fattori emozionali operanti nella relazione e riconoscimento del loro ruolo nei processi di diagnosi e cura (elementi di solito poco affrontati nei corsi di formazione);
2.miglioramento della capacità di lavorare in gruppo, ovvero a crescere professionalmente imparando dalle proprie esperienze e da quelle degli altri, e a cooperare attraverso la gestione delle differenze e il governo dei conflitti;
3.miglioramento della qualità della comunicazione, particolarmente cruciale in un’epoca caratterizzata dal sovraccarico delle informazioni e dal trionfo delle tecnologie, a spese del “sistema umano di erogazione delle cure” e con una crescente disumanizzazione della medicina.
Il metodo Balint non si propone come uno strumento di management sanitario o di ottimizzazione delle risorse e nemmeno mira a trasformare i medici di famiglia in psichiatri o psicoterapeuti; tuttavia tra le ricadute positive che sono state osservate figurano anche vari miglioramenti nel sistema delle cure:
– nel riconoscimento e gestione dell’errore e del rischio (per effetto della riduzione dell’ansia e del miglioramento delle relazioni collaborative)
– nell’utilizzo delle risorse economiche (poiché una buona alleanza medico-paziente riduce la domanda e il ricorso a terapie farmacologiche e indagini diagnostiche inappropriate)
– nell’aiutare i medici a prendersi cura con più soddisfazione dei loro abituali pazienti, riducendo così i fattori di stress e di burn-out.
Che cosa sono i Gruppi Balint ?
Sono lo strumento basilare della formazione secondo il metodo che abbiamo descritto.
Sono piccoli gruppi, mediamente di 6-12 partecipanti, centrati non tanto sulle dinamiche gruppali ma essenzialmente sul compito, cioè sulla discussione collettiva di un caso clinico “problematico” presentato da un partecipante con l’aiuto di uno o due conduttori. La discussione non verte primariamente sugli aspetti tecnici del trattamento come nelle clinical conference, ma sull’esperienza emotiva della relazione di cura da parte dei suoi protagonisti.
I gruppi hanno cadenze prefissate, di solito settimanali o quindicinali, durano circa un’ora e mezza e si protraggono nel tempo in media per un paio d’anni. La partecipazione, preferibilmente su base volontaria, può essere subordinata a una qualche forma di preselezione. Il materiale di discussione è costituito dal libero resoconto (non occorre una relazione scritta o la cartella clinica) su un caso clinico recente che abbia presentato delle difficoltà o abbia creato disagio al medico. La continuità del gruppo permette di seguire l’evoluzione dei casi presentati e di verificare nel tempo le ipotesi diagnostiche e le scelte terapeutiche. Particolare importanza è attribuita alla creazione di un clima di gruppo aperto e solidale, capace di promuovere una libera comunicazione tra pari, assicurando ai membri sostegno e sicurezza, ma anche permettendo la franchezza e la critica. Il metodo di conduzione del gruppo e quello di elaborazione del materiale clinico derivano in larga misura dalla psicoanalisi.
In origine a composizione omogenea (ad es. solo medici di medicina generale), sempre più spesso gli odierni GB sono di tipo disomogeneo, rispecchiando i recenti modelli di lavoro basati su team e su interazioni di tipo interprofessionale.
Chi sono i conduttori dei Gruppi Balint?
Di solito sono due, uno psichiatra o psicologo con formazione psicoanalitica affiancato da un medico di famiglia o altro professionista sperimentato in questo metodo. Il ruolo del conduttore del Gruppo Balint è quello di un promotore del pensiero collettivo, tutore della coesione del gruppo ma anche della sua libertà di parola e di critica, regolatore delle crisi, interprete dei processi psicologici che si rendono visibili nella discussione dei casi. L’accento è messo sul suo ruolo facilitatore, ben diverso da quello di un docente che fa lezione o comunque dell’esperto che trasmette a dei non-iniziati un sapere precostituito. Il gruppo viene così addestrato ad apprendere dalla propria esperienza, a rinunciare alle spiegazioni rassicuranti e a tollerare il dispiacere di non riuscire a capire e di non sapere che cosa fare, almeno fino al momento in cui diventi possibile avere una più chiara comprensione della situazione. Questo è ciò che Balint ha chiamato “il coraggio della propria stupidità”.
Che cosa NON può fare un Gruppo Balint
- Non prescrive ai curanti “come fare” il proprio lavoro
- Non fornisce ricette o facili risposte
- Non è in grado di risolvere tutti i problemi che i curanti hanno con i loro pazienti
- Non è una terapia di gruppo per operatori sanitari
Che cosa può fare un Gruppo Balint
- Offrire ai curanti l’opportunità di riflettere sulla propria attività
- Fornire uno sfogo e un contenimento alle ansie e alle frustrazioni generate dal lavoro
- Risvegliare l’interesse di un curante per un paziente fino ad allora sentito come “difficile”, disturbante o insopportabile
- Aprire la mente ad altre possibilità, sia nella diagnosi sia nella gestione quotidiana
- Fornire supporto al ruolo curante e migliorare il dialogo con i pazienti, con le altre figure professionali e con le istituzioni implicate nel processo di cura
- Aumentare nei curanti la soddisfazione lavorativa (job satisfaction) e nei pazienti la qualità percepita delle cure (customer satisfaction)
- Promuovere benessere organizzativo e contribuire alla prevenzione del burn-out.
Bellanova Piero

Piero Bellavova
Maestri della psicoanalisi
A cura di Luisa Corda
Bellanova, Piero (Sant’Agata di Efeso, 1917 – Roma, 1987)
La vita
Piero Bellanova, personalità ricca e poliedrica, ha vissuto e rappresentato in pieno le principali correnti culturali della prima metà del Novecento ed è stato uno dei padri della psicoanalisi italiana. Attento studioso della relazione paziente-analista, si è dedicato con impegno alla divulgazione della psicoanalisi e ai rapporti con i mass-media. Ha ricoperto la carica di segretario della SPI dal 1966 al 1986 e quella di presidente dal 1986 al 1987, anno della sua morte.
Piero Bellanova nasce nel febbraio del 1917 a Sant’Agata d’Esaro, un paesino della Calabria. La madre, insegnante, muore subito dopo aver dato alla luce quel figlio tanto desiderato; il padre, direttore didattico dell’unica scuola del paese, dopo un anno dalla morte della prima moglie, si sposa in seconde nozze con un’altra donna, anch’essa insegnante e dalla quale non ha avuto figli, che Bellanova ha amato molto e dalla quale è stato sempre sollecitato all’amore per lo studio e per la musica. La notizia della morte precoce della giovane madre mobilita il senso materno di molte madri del paese, che si offrono come balie del neonato; grazie a questa generosità generale il piccolo riesce a sopravvivere e a crescere sano e forte. Le figlie, Monica e Patrizia, raccontano che mentre visitavano il paese di S’Agata, dove tra l’altro Bellenova ha voluto essere tumulato, sono state fermate da tante donne che con orgoglio si presentavano come le “mamme di latte di don Pierino”. Il legame con il paese di Sant’Agata è sempre stato molto forte e significativo per lui: “.. la nostra casa è sempre stata aperta alle persone di Sant’Agata (…)” (ricordano Patrizia e Monica). Dopo aver concluso la scuola elementare nel paese, Bellanova ha vissuto sempre in collegio, lontano da casa, prima presso l’istituto dei Padri Scolopi a Villa Sora – Frascati -, dove ha frequentato le scuole medie, poi a Cava dei Tirreni, presso l’Abbazia dei Benedettini, per studiare al liceo classico. Nel 1932, per una complicazione renale, muore suo padre, uomo molto severo; Piero aveva quindici anni. Due anni dopo si iscrive alla facoltà di Medicina a Roma, dove si trasferisce con la sua amata “mammetta”, che morirà poco dopo la sua laurea, nel 1941. Prese la sua prima specializzazione in chirurgia estetica, in un periodo ancora molto precoce per questa branca della medicina. Accanto ai suoi interessi nel campo della medicina, ha sempre coltivato passioni in campo letterario e artistico; amava la pittura ed era pianista, attento esploratore del suono e abile accompagnatore di readings poetico-musicali. E’ stato sposato con la nipote del pittore Mario Sironi (1885 – 1961), Anna Madami, sua compagna di vita per quarantadue anni, dalla quale ha avuto tre figli, Patrizia, Marco e Monica.
Durante gli studi di medicina, a Roma, Bellanova ha conosciuto Filippo Tommaso Marinetti (Alessandria d’Egitto, 1876 – Bellagio, 1944) poeta, scrittore e drammaturgo italiano, fondatore del movimento futurista, prima avanguardia culturale italiana del Novecento. All’artista è stato legato da una lunga amicizia, diventandone anche medico personale, condividendone le idee letterarie e partecipando attivamente al gruppo dei futuristi romani, fino a divenire uno degli esponenti più qualificati del movimento stesso.
Nel 1939, con Marinetti e Luigi Scrivo, Bellanova ha firmato il “Manifesto futurista del romanzo sintetico”, pubblicato su II Giornale d’Italia. Nel 1940, oltre a partecipare alla stesura del futurista “Manifesto dell’arte tipografica”, pubblica il primo romanzo sintetico italiano, Picchiata nell’amore, dedicato a uno dei suoi più cari amici, il pittore Enzo Caglianone.
Ecco alcune recensioni del romanzo:
“Piero Bellanova ha creato con il suo mirabile e divertentissimo romanzo sintetico futurista Picchiata nell’amore qualcosa di inaspettato e di sorprendente” F.T. Marinetti (dal Giornale d’Italia)
“Opera viva ed originale degna di essere conosciuta da tutti coloro che si interessano all’arte italiana e all’evoluzione del futurismo” Marco Cugiani (da L’Italia Giovane)
“Il primo romanzo sintetico futurista di P. Bellanova, il quale ha certamente una sensibilità finissima e ricca d’imprevisti, non può non mancare di incuriosire quanti credono nell’avvenire delle lettere con sicura fede”. Ettore Settanni (da Meridiano di Roma)
“Il romanzo Picchiata nell’Amore la cui sintesi è indiscutibile rivela in Piero Bellanova uno scrittore immediato, vivace e divertente nel senso ottimo della parola” Marco Ramperti (da L’Illustrazione Italiana)
“.. è il romanzo della gioventù moderna futurista, abituata alla guerra lampo, al vivere dinamico, all’immediatezza e al susseguirsi veloce dei fatti” Gio Ponti (da Domus)
Nel 1943, collabora alla stesura del Canzoniere futurista amoroso guerriero, Edizioni Futuriste, pubblicando, inoltre, un volume di poesie, l’”aeropoema” Bombardata Napoli canta, ultima prova estetica prima della fine della guerra, preceduto da un Aeropoema collaudo di Marinetti, con 4 tavole fuori testo di Prampolini, Benedetta, Dottori e Crali.
 Nel dopoguerra, dal 1945 al 1946, Bellanova ha fatto parte del Ministero per la Costituente, come segretario della Commissione Sanitaria. Accanto alla professione medica, ha sempre coltivato l’interesse per la psicologia: fu lui a istituire i primi Centri Psicotecnici per la selezione del personale nella Marina Militare, nell’Esercito, nell’Aeronautica e nella Polizia. Ha diretto il Centro Psicotecnico della Polizia dal 1952 al 1968.
Nel dopoguerra, dal 1945 al 1946, Bellanova ha fatto parte del Ministero per la Costituente, come segretario della Commissione Sanitaria. Accanto alla professione medica, ha sempre coltivato l’interesse per la psicologia: fu lui a istituire i primi Centri Psicotecnici per la selezione del personale nella Marina Militare, nell’Esercito, nell’Aeronautica e nella Polizia. Ha diretto il Centro Psicotecnico della Polizia dal 1952 al 1968.
L’amicizia con Fabio Metelli (Trieste, 1907 – Padova, 1987) psicologoitaliano, considerato uno dei principali studiosi italiani di psicologia della Gestalt, insieme a Gaetano Kanizsa e Paolo Bozzi, lo ha avvicinato alla Psicoanalisi; è dietro suo consiglio che farà domanda alla Società Psicoanalitica Italiana e inizierà la formazione. Nel 1956, terminato il training psicoanalitico con Emilio Servadio, entra a far parte della SPI per divenirne, dal 1966 all1986, segretario e poi, fino alla morte, avvenuta il 19 maggio del 1987, vicepresidente. Attento divulgatore della cultura psicologica e psicoanalitica, per molto tempo è stato capo redattore della Rivista di Psicoanalisi; molti i suoi interventi pubblici in RAI, sia in televisione sia in Radio. Nel 1958, entra a far parte dell’équipe socio-medico-psicologica dell’Istituto di Osservazione di Rebibbia che esaminava detenuti giovani–adulti (18-28 anni) condannati al terzo grado di giudizio, per studiarne il possibile inserimento lavorativo e ambientale dopo la scarcerazione. All’università di Padova e in Roma ha tenuto dei corsi sul “Primo colloquio clinico”. L’impegno solerte di trovare un appartamento unico che riunisse i due Istituti di training (costituiti nel 1962), quello di via di Villa Emiliani 4, di cui faceva parte Emilio Servadio, e quello di via Salaria 237b, di cui faceva parte Nicola Perrotti, lo rende il precursore di un’esigenza di integrazione sentita ancora oggi nei due Istituti di Roma. Grazie al suo prezioso lavoro di relazioni, cucito con l’allora Assessore alla Cultura (Nicolini), riesce ad ottenere in affitto l’appartamento di via Panama 48 dal Comune di Roma, tutt’ora sede e proprietà della Società Psicoanalitica Italiana.
Nel 1982, insieme alla moglie Anna, redige il libro “Le due Gradive”, dove raccoglie una serie di documenti che testimoniano l’inizio della psicoanalisi in Italia e l’attività della Società Psicoanalitica Italiana dal 1932 al 1982.
Il contributo alla psicoanalisi
 “Psicoanalisipertuttalavita”, scrisse nella presentazione dell’omaggio di Sante Monachesi – pittore, scultore, tra i fondatori del movimento futurista – al VI congresso della SPI nel 1984, come a rimarcare la sua profonda passione e dedizione alla psicoanalisi; freudiano convinto, Piero Bellanova ha contribuito attivamente, grazie al suo lavoro appassionato e intelligente, al diffondersi della cultura psicoanalitica in Italia. Di lui non abbiamo tantissimi scritti, ma le sue idee e il suo “fare analitico” hanno avuto un ruolo sicuramente importante per la nascita di pensieri e modi di lavorare innovativi. La teoria, per Bellanova, è stata sempre strettamente legata alla clinica, la sua capacità di sintesi e l’integrazione tra esperienze vissute e interessi teorici restano tra le sue qualità maggiori, come ha detto Amalia Giuffrida. Sosteneva fermamente che la relazione analista-analizzato fosse uno dei punti più importanti della terapia. La sua indagine si è focalizzata sulla particolarità del mestiere dell’analista e sulla “coppia analitica” al lavoro.
“Psicoanalisipertuttalavita”, scrisse nella presentazione dell’omaggio di Sante Monachesi – pittore, scultore, tra i fondatori del movimento futurista – al VI congresso della SPI nel 1984, come a rimarcare la sua profonda passione e dedizione alla psicoanalisi; freudiano convinto, Piero Bellanova ha contribuito attivamente, grazie al suo lavoro appassionato e intelligente, al diffondersi della cultura psicoanalitica in Italia. Di lui non abbiamo tantissimi scritti, ma le sue idee e il suo “fare analitico” hanno avuto un ruolo sicuramente importante per la nascita di pensieri e modi di lavorare innovativi. La teoria, per Bellanova, è stata sempre strettamente legata alla clinica, la sua capacità di sintesi e l’integrazione tra esperienze vissute e interessi teorici restano tra le sue qualità maggiori, come ha detto Amalia Giuffrida. Sosteneva fermamente che la relazione analista-analizzato fosse uno dei punti più importanti della terapia. La sua indagine si è focalizzata sulla particolarità del mestiere dell’analista e sulla “coppia analitica” al lavoro.
“Quando parliamo della realtà psichica dei nostri pazienti non possiamo prescindere dal rapporto della coppia paziente-analista e da quanto questo rapporto trasformi la realtà psichica del paziente.Ne viene di conseguenza che l’unica realtà psichica che può costituire oggetto d’indagine dello psicoanalista mediante l’uso dello strumento psicoanalitico costituito dall’esplorazione dell’inconscio, è la realtà che viene a determinarsi e ad emergere dal rapporto della coppia terapeutica” (Bellanova et al., 1976).
La lunga pratica istituzionale si è intrecciata con i suoi interessi teorici, stimolando le sue riflessioni sul rapporto tra istituzione e setting; citando l’Autore “(…) l’Istituzione (…) viene sentita da entrambi i componenti la coppia analitica a volte come protettiva, a volte come svalutante, sempre come un elemento costitutivo del rapporto, tanto da far pensare a ciò che abbiamo ipotizzato come a una specie di doppio contenitore: cioè come un contenitore che contiene il setting che è già di per sé un contenitore” (ibid.).
Bellanova teorizzò sia gli aspetti cristallizzati che gli aspetti libidici tipici del rapporto istituzionale e capì, in linea con Bleger, quanto gli aspetti istituzionali possano in alcuni casi favorire l’insorgere di rigide “istituzioni interne”, ma quanto, nello stesso tempo, siano fondanti l’identità professionale.Il setting emana e si configura a partire dagli aspetti istituzionali, condensa la polisemia simbolica contenuta in essi.
Con Emilio Servadio e Cesare Musatti è considerato uno dei padri della psicoanalisi.
Bibliografia
- 1940 Piero Bellanova, Picchiata nell’amore, primo romanzo sintetico italiano futurista
- 1943
- 1965 Piero Bellanova, , Rivista di Psicoanalisi, Rapporti tra terapia ed espressione pittorica nell’analisi di un omosessuale;
- 1976, Bellanova, P., Amati, J., Argentieri, S., Batini, M., Cargnelutti, E., Giordanelli, L., Paulin, P., Vergine, A., Zerbino, E. .Panel su “Realtà istituzionale e setting”: Gruppo di lavoro dell’Istituto Romano di Psicoanalisi. Rivista di Psicoanal
- 1980, Gianna Giuliani, Le strisce interiori: cinema italiano e psicoanalisi, prefazione di Piero Bellanova, Bulzoni, Roma
- 1982, a cura di Piero e Anna Bellanova, , Le due Gradive, notizie sull’attività psicoanalitica Italiana 1932-1982, edizioni CEPI Roma
- Piero Bellanova, Ascoltare le stelle, raccolta di poesie pubblicate postume nel 2010, Biblioteca- Fonoteca,CJC Editore
Poesia da “Ascoltare le stelle” (vedi bibliografia)
Notte Spazio
NOTTE SPAZIO
mare felpato di velluto nero
con spiagge squillanti
di fanfare d’argento
IL TUO AMORE
un palpito d’atomi leggeri
sulle tue ciglia bagnate di viola
IL MIO AMORE
colorare la vita
con le sfumature rosate della tua pelle
LE TUE LABBRA
due coralli in una goccia di luce
I MIEI SOGNI
ali incandescenti agganciati alle stelle
IL MIO DESIDERIO
Berrini Maria Elvira ( Mariolina)
A cura di Pietro Roberto Goisis
Maria Elvira (Mariolina) Berrini fa parte del gruppo di giovani medici che iniziano un’analisi con Cesare Musatti verso la fine degli anni quaranta. Lei sola però, nel gruppo, con l’intenzione già maturata di formarsi come psicoanalista di bambini. Come è arrivata alla psicoanalisi? quali le motivazioni che l’hanno portata poi a farsi organizzatrice di servizi di psichiatria di psicoterapia infantile?
Laureatasi a Milano in Medicina nel luglio 1943, aveva acquisito una solida preparazione clinica, ma i suoi interessi e progetti per il futuro erano andati orientandosi verso lo studio della psichiatria. Capiva che preferiva prendersi cura della “persona” con difficoltà e disagi psicologici. Lo studio del funzionamento della mente, della sofferenza e dei conflitti psicologici la affascinava. E d’altra parte aveva riconosciuto in sé una particolare facilità e disponibilità all’ascolto e al sostegno di persone in difficoltà. La colpiva la frequenza con cui veniva scelta dagli amici come confidente e come riferimento per la soluzione dei propri problemi e dei propri patemi sentimentali.
Subito dopo la laurea però il progetto di specializzarsi in psichiatria doveva venire accantonato. Cresciuta in ambiente antifascista e di sinistra si trovava subito attivamente impegnata nel movimento della resistenza. E’ partigiana e dal Comando Lombardo delle Brigate Garibaldi le vengono affidati compiti ispettivi per verificare in loco e sul campo i bisogni sanitari delle varie formazioni e le possibilità di farvi fronte, provvedendo all’invio di materiale sanitario e di medici ed infermieri. Sarà in Valtellina, in Valcamonica, nell’Oltre Pò Pavese e soprattutto in un Val Sesia e nel Cusio vivendo di volta in volta, sia pure per brevi periodi, l’esperienza di partigiana di montagna.
È stato per lei un periodo indimenticabile e importante, un’esperienza fonte di arricchimento e di maturazione. Come un uscire da una fase di tarda, spensierata adolescenza e prima gioventù per ritrovarsi più matura e responsabile, scoprendo anche in sé capacità organizzative prima insospettate che avrebbe poi messo a frutto nel suo lavoro. Si era iscritta al PCI di cui sarà soltanto un’attiva militante di base. Il suo desiderio di ritornare allo studio, agli interessi scientifici, al lavoro di medico si accompagnano ora ad una forte motivazione per l’impegno sociale.
Prenderà la specializzazione in pediatria e come pediatra incomincerà a lavorare nei consultori dell’OMNI. Ma soprattutto avrà la fortuna di trovare presto indicazioni precise per un’attività che le darà modo di integrare i suoi diversi interessi.
Nell’estate del 1946, appena entrata come volontaria del servizio di neuropsichiatria infantile dell’Istituto Neurologico di Milano, le verrà offerta l’opportunità di partecipare, con tanti giovani pedopsichiatri e psicologi di diversi paesi europei provati dalla guerra, alle prime settimane di aggiornamento organizzate a Losanna per la formazione di equipes medico-psicologiche per l’assistenza all’infanzia disadattata. A Losanna il corso è articolato in lezioni teoriche e in visite a istituzioni psichiatriche e a servizi per l’infanzia. Le lezioni sono tenute da psicologi allievi di Piaget, da pedopsichiatri illustri venuti da Parigi (Heuyer), ma anche da psicoanaliste che lavorano con i bambini nell’Office Medico Pedagogique della città. Mariolina Berrini viene così scoprendo un modo nuovo e affascinante di affrontare lo studio e la cura del bambino affettivamente disturbato o psichicamente sofferente: un modo nuovo in cui rigore clinico, fantasia e gioco, rapporto con la realtà sociale, si intrecciano e si integrano in un occuparsi psicoterapeuticamente non solo del bambino, ma anche del suo ambiente.
A Losanna è con lei Giovanni Bollea con il quale instaura un rapporto di amicizia basato anche sul comune impegno a realizzare in Italia servizi di psichiatria infantile quali sono venuti conoscendo in Svizzera, servizi che si chiameranno centri medicopsicopedagogici (CMPP) in analogia coi servizi svizzeri e francesi. E’ un progetto che coinvolgerà altri giovani medici e psicologi che saranno poi tutti i membri della SPI. A Novara Marcella Balconi, cugina di Mariolina con cui ha condiviso i giochi dell’infanzia, gli anni di università e l’esperienza partigiana. A Roma Adda Corti e Bartoleschi, allievi di Bollea. Sono questi gli amici con cui si stabilisce un rapporto di scambi e di solidarietà che è di aiuto nel difficile inizio della propria attività.
Perché non era davvero facile, specie a Milano, realizzare il progetto a cui ci si era impegnati a Losanna. Ci si doveva preparare e formare professionalmente nel vuoto di centri di formazione specifica e insieme farsi promotori e organizzatori di quei servizi del tutto nuovi in cui il lavoro in equipe e gli interventi psicoterapici e psicosociali erano centrali.
Erano proposte che allora, alla fine degli anni quaranta, non potevano non urtare contro resistenze da parte di una psichiatria accademica fortemente organicista e di un’assistenza neuropsichiatrica infantile incentrata sulle cure del bambino definito “anormale” e visto soprattutto come portatore di deficit intellettuali e di danni cerebrali che finiva per essere isolato in scuole speciali o in istituti. D’altra parte lo stesso clima politico e culturale che si era instaurato dopo il 1948 non era certo tale da favorire le iniziative di giovani psicoanalisti e per di più di sinistra.
Per la sua formazione Mariolina Berrini tornerà a Losanna, anche per un tirocinio pratico che la vedrà impegnata per alcuni mesi presso l’Office Medico Pédagogique. Altro punto di riferimento importante sarà Parigi. Vi si recherà una prima volta per un corso di aggiornamento nel 1947 e poi successivamente per uno stage presso il servizio del Professor Heuyer dove sarà seguita da Serge Lebovici con cui già si erano incontrati, lei e Marcella Balconi, nel 47. Da lui avevano ricevuto le prime indicazioni bibliografiche e soprattutto consigli e suggerimenti preziosi fra cui anche quello di entrare al più presto in analisi. In anni successivi, i seminari di analisi infantile che Lebovici organizzerà ogni anno a Parigi saranno l’occasione per incontri e scambi anche con i colleghi italiani che lavorano con bambini. Importante d’altra parte era stato entrare nel gruppo degli analizzati o analizzandi di Musatti: un gruppo che si ritrova in un clima di cordialità e di amicizia, che si aggiornava, che si formava. Compagni di studio saranno soprattutto Franco Fornari e Giancarlo Zapparoli che come lei si stavano specializzando in psichiatria.
Dopo gli anni ’40 e ’50, diventerà poi tutto più facile. A parte l’apertura di scuole di psichiatria infantile, di psicologia e di psicoterapia, non mancheranno occasioni di supervisioni e di seminari. Adda Corti, e dopo di lei Lussana, torneranno da Londra formati da un lungo training anche come psicoanalisti di bambini. E’ il periodo in cui più che alla psicoanalisi di lingua francese si fa riferimento alla scuola inglese e in particolare agli allievi di M. Klein (Winnicott, Bion, Rosenfeld, Meltzer, ecc.) e si sarà aiutati da E. Bick e da M. Harris ad “osservare” il lattante in famiglia. Gli inglesi scenderanno in Italia per seminari tenuti non solo all’interno della S.P.I. (si pensi ai primi seminari di Meltzer a Novara e a Perugia, ai seminari a Roma di F. Tustin, a Irma Pick, ecc).
A Milano, per l’avvio del primo C.M.P.P. (nel 1948 nell’ambito dei servizi dell’ONMI) le sarà di sostegno Virginio Porta, un illuminato psichiatra di adulti aperto a ogni proposta nuova in campo psicosociale. Con lui M. Berrini pubblicherà il suo primo lavoro sulla “Funzione dei test proiettivi nell’infanzia”.
Dopo questa prima esperienza otterrà dal Comune di Milano il nullaosta per l’apertura di un centro che si affiancherà ai servizi di NPI delle scuole speciali, ma con un taglio completamente diverso. Le condizioni logistiche non erano certamente delle migliori, sistemati in un seminterrato di una scuola di via Sondrio; ma lì, in quelle strutture che evidentemente erano collocate nel sottosuolo non solo per un significato metaforico di ricerca nel profondo, vennero iniziate le prime psicoterapie ed i primi trattamenti psicoanalitici per bambini. Il fatto di nascere come servizio specialistico della medicina scolastica crea però dei problemi. All’inizio, infatti, il centro tende a essere utilizzato dalla scuola, più che per una consulenza per meglio capire i bambini, come strumento diagnostico per la selezione di alunni ritenuti insufficienti e anormali, ma che si riveleranno il più spesso “disadattati” a una scuola che non sa rispondere ai bisogni dei bambini che vivono nelle condizioni sociali più sfavorevoli.
M. Balconi a Novara vive la stessa esperienza. Insieme decidono, negli anni ’50, di avviare un’indagine clinico-statistica sulla casistica dei due centri da loro diretti su di un campione di 1000 alunni segnalati già in prima elementare. Ricercano la correlazione tra il disadattamento ed i fattori ambientali, educativi e psichici ponendo al centro dell’indagine, che riveste un indubbio valore anche sociologico, lo studio delle diverse “strutture” psicologiche del bambino di 6/7 anni. Lo scritto “Diagnosi di struttura in psichiatria infantile” appare in quel momento altamente innovativo in Italia e tale da mutare profondamente, in senso psicodinamico, l’approccio nosografico, diagnostico e clinico.
Sono di quegli anni anche due lavori (Balconi, Berrini e Fornari) sui disturbi nelle “prime relazioni oggettuali”. In uno di essi viene presentato per esteso il primo caso di autismo infantile descritto in Italia, osservato e seguito in psicoterapia da M. Berrini proprio all’interno del C.M.P.P. Così la psicoanalisi era entrata in un servizio pubblico e con lei naturalmente le psicoanaliste. (Numerose sono le psicoanaliste della S.P.I. che, dai tempi pioneristici sino ad anni recenti, hanno lavorato nei servizi di M. Berrini. Impossibile citarle tutte. Va certo ricordata per prima M. Carati, poi Luciana Nissim e Anna Maria Pandolfi, e poi ancora Laura Schwarz e Adriana Pagnoni. Infine, le più “giovani” tuttora attive nell’Osservatorio di Psicoanalisi del bambino e dell’adolescente del Centro Milanese di Psicoanalisi. Numerose sono anche le psichiatre e le psicoterapeute, non S.P.I., formatesi come psicoterapeute anche attraverso un’analisi personale rimaste a tempo pieno nel servizio. Grande importanza verrà data anche alla formazione che non deve essere solo trasmissione di conoscenze, ma di uno stile, di un metodo di lavoro in cui devono congiungersi rigore, fantasia, curiosità intellettuale e culturale. Non vengono fatte mancare supervisioni individuali per chi ha casi in trattamento e per la formazione dei nuovi assunti. Ma acquista importanza soprattutto la settimanale riunione di “sintesi”, in cui in gruppo si impara a riflettere, affinando le proprie capacità diagnostiche e anche di osservazione e di ascolto, sul materiale che viene dalla “consultazione”. Dall’incontro con il bambino e da quanto egli comunica con le parole, col gioco, col disegno e con i test e dall’incontro con i genitori e dalla storia che si saprà ricostruire con loro intorno al figlio e a loro stessi e al gioco di interazioni che li lega. La consultazione, in fondo, ancor più degli interventi sociali, di consulenza e delle psicoterapie, potrà essere considerato l’intervento centrale e di elezione e finirà in molti casi per trasformarsi da momento diagnostico in rapporto psicoterapico vero e proprio anche con i genitori e soprattutto con la madre.
Sul piano organizzativo maturava intanto la consapevolezza, anche dopo l’apertura nel 1960 di un secondo centro, che per poter assolvere i propri compiti consultoriali e preventivi ogni C.M.P.P. doveva poter operare come “servizio di territorio”, in un contesto ambientale ristretto e definito e su tutto l’arco dell’età evolutiva dal periodo perinatale alla prima adolescenza. Venivano quindi avanzate proposte per un decentramento che anticipavano lo stesso decentramento amministrativo, ma che avrebbero potuto realizzarsi proprio con la suddivisione in “zone” della città. Quando lascerà il suo impegno organizzativo e di direzione, le grandi e affollate Scuole Speciali che all’inizio avevano schiacciato il piccolo e diverso C.M.P.P. saranno ormai chiuse e ridimensionate.
Nella prima metà degli anni ’70 M. Berrini sarà riuscita a organizzare e coordinare quattro C.M.P.P., operanti in maniera autonoma in altrettante zone della città e solo in esse. I Centri si chiameranno successivamente SIMEE, ma manterranno le loro finalità e caratteristiche, collaborando in senso preventivo anche con i nidi e con quella rete di servizi consultoriali di zona, pediatrici e familiari che la riforma sanitaria aiuterà a far nascere.
Sulle problematiche relative ai bisogni primari di contenimento e di contatto del neonato e alle angosce che possono accompagnare in casi limite la nascita ed i primi rapporti madre-figlio, M. Berrini, anche dopo aver lasciato la direzione dei suoi centri nel 1978, ritornerà, chiamata da F. Fornari, a seguire il lavoro delle sue allieve, all’interno dell’Ospedale Buzzi.
Vi è un filo, dunque, che dai primi inizi fino alla fine dell’impegno di lavoro di M. Berrini passa dalla Pediatria alla Psicoanalisi e viceversa, dall’attenzione al mondo interno, anche agli albori della vita, alla realtà sociale e alla “preoccupazione” perché si offrano cure e sostegno affinché la vita di un individuo possa iniziare, evolversi e compiersi nel modo più favorevole.
Con l’andata in pensione M. Berrini ha potuto dedicarsi con maggiore respiro al suo lavoro di psicoanalista di bambini e, negli ultimi anni, solo di adulti. Le piaceva ancora, alla soglia degli ottanta anni, lavorare intorno alla “consultazione psicoterapica con genitori e bambino” con un gruppo di giovani psichiatre e psicoterapeute di bambini impegnate nei servizi pubblici.
testo raccolto da Pietro Roberto Goisis nel 1998
Bi-logica

Giuseppe Pulvirenti, 2017
A cura di Alessandra Ginzburg
Inconscio, emozioni e strutture bi-logiche nel pensiero di Matte Blanco
Nella sua opera meno conosciuta, Pensare, sentire, essere, uscita postuma in italiano nel 1995, Matte Blanco propone due nuovi concetti rispetto a quelli presentati in precedenza ne L’inconscio come insiemi infiniti, veri e propri strumenti che si rivelano di grande attualità nell’esperienza clinica: l’antinomia fondamentale e le strutture bi-logiche.
Per quanto riguarda l’antinomia fondamentale, Matte Blanco ritiene che vi sia nella struttura dell’essere umano un’antinomia che deriva dalla co-presenza di due modi di essere fra loro incompatibili, l’uno emanazione del pensiero, in quanto istanza per eccellenza dividente, e l’altro emanazione dell’emozione, che tende invece all’unificazione e alla indivisibilità. Questi modi sono mutuamente anaclitici, vale a dire che svolgono la loro azione soltanto appoggiandosi l’uno sull’altro. Tenere conto di questa ipotesi aiuta l’analista a mantenere una costante attenzione al sostrato emotivo di tutte le affermazioni dell’analizzato e alla loro influenza nella formulazione di tutti i pensieri.
Le strutture bi-logiche sono il risultato più evidente di questa singolare co-presenza. Matte Blanco propone che ci troviamo di fronte ad una struttura bi-logica ( che afferisce contemporaneamente al modo asimmetrico e a quello simmetrico dell’uomo), quando scopriamo che la stessa realtà viene trattata simultaneamente da un lato come divisibile e formata da parti, dall’altro come se fosse una e indivisibile.
Inconscio e in buona parte anche l’emozione sono entrambi strutture bi-logiche, con il risultato che nella maggior parte dei casi ci esprimiamo utilizzando un intreccio più o meno rilevante della logica simmetrica con quella classica, un intreccio che Matte Blanco ha denominato bi-logica. Fa eccezione il pensiero matematico che, ad eccezione dell’infinito (anch’esso considerato da lui una struttura bi-logica), attinge unicamente alla logica basata sul principio di non contraddizione.
É necessario considerare che l’aspetto simmetrico, presente nelle strutture bi-logiche, opera, in virtù delle sue peculiari caratteristiche, in uno spazio di dimensioni maggiori rispetto a quello accessibile alla coscienza, che deve fare i conti con la propria tridimensionalità. Da questa limitazione deriva la necessità del linguaggio onirico di utilizzare i più svariati stratagemmi per evocare la multidimensionalità e l’infinito. Un infinito, da questo punto di vista, concepito come l’espressione del tentativo della modalità asimmetrica e dividente di trattare con l’indivisibile, rendendolo infinitamente divisibile.
Matte Blanco elenca diverse tipologie di strutture bi-logiche, fra cui la Alassi, in cui vi è un’alternanza di simmetria e di asimmetria, o la Simassi, in cui vi è simultaneità di simmetria e di asimmetria, entrambe rintracciabili soprattutto nei funzionamenti psicotici della mente. Ma le due strutture più significative ed immediate dal punto di vista dell’applicazione clinica e che quindi verranno qui trattate in maniera più estesa sono la struttura bi-logica stratificata e la struttura bi-logica tridimensionalizzata.
- La struttura bi-logica stratificata costitutiva
Tenendo presente una mente concepita come una sorta di cilindro composto di infinite stratificazioni che vanno da un massimo di asimmetria ad un grado crescente di simmetria, si può comunque, per semplificazione, limitare a cinque livelli il suo funzionamento.
Nel primo livello ogni oggetto, cosa o situazione è ben distinto da ogni altro. A questo livello esistono le più svariate relazioni di somiglianza e di differenza rispetto ad un gran numero di oggetti.
Nel secondo livello sono presenti emozioni più o meno coscienti, e quindi compaiono forme incipienti di simmetrizzazione, che possono avere le caratteristiche di una similitudine. Se dico che un tale è come una tigre, non intendo che lo sia concretamente.
Nel terzo livello abbondano le simmetrizzazioni che sostituiscono le classi di equivalenza: ogni individuo diventa a tutti gli effetti identico alla classe di appartenenza e ne acquisisce le potenzialità al massimo grado. Qui l’intensità dell’odio, ad esempio, tende a valori infiniti, e la temporalità viene meno. È questo il livello descritto ampiamente dalla Klein, che lo considerava il più profondo in assoluto. In genere è a quest’area che corrispondono i funzionamenti patologici più diffusi.
Nel quarto livello le classi diventano sempre più ampie ed onnicomprensive (ad esempio essere uomo diventa identico all’essere donna o bambino) e si attuano perciò simmetrizzazioni estese che comportano assenza di contraddizione e identità fra realtà psichica e realtà esterna. L’aggressività viene meno, il livello di patologia è considerevole.
Nel quinto livello il limite é l’indivisibilità, e la simmetrizzazione assoluta rende impossibile il pensiero che richiede perlomeno alcune relazioni asimmetriche. Ogni cosa diventa identica a qualunque altra, fino a divenire una sola cosa indivisibile.
Anche se i livelli sono ben differenziati fra loro, ogni strato è tuttavia presente in tutti gli altri che si avvicinano alla superficie. In particolare l’indivisibilità è sempre attiva anche se non sempre riconoscibile. Vale la pena di ricordare che sono sufficienti pochi anelli di simmetria in un ragionamento normale per determinare pericolosi pregiudizi. Negli stati confusionali, invece, ogni cosa tende ad identificarsi con un’altra fino ad impedire ogni forma di pensiero ordinato.
Ogni individuo ha le proprie simmetrizzazioni, determinate dalla storia delle proprie emozioni, che finiscono con l’essere un aspetto delle strutture mentali individuali. In un ragionamento o addirittura a livello percettivo, è possibile constatare che gli stessi anelli simmetrici sono funzione della storia dell’individuo, e che, sia a livello inconscio che nelle emozioni più intense, ognuno riferisce a sé stesso qualunque evento.
- La struttura bi-logica tridimensionalizzata
Questa struttura possiede un funzionamento visibile nei sogni o anche nella veglia, là dove predominano la condensazione e lo spostamento. Lo spostamento, infatti, implica la scissione di un individuo in due in cui l’aspetto spostato è contemporaneamente dentro e fuori della persona. In questo caso l’individuo è isomorfo ad uno spazio di più dimensioni che però deve essere tradotto in uno spazio di dimensioni inferiori, attraverso un’operazione di tridimensionalizzazione. Accade nei sogni, ad esempio che il soggetto sia rappresentato, di conseguenza, da più individui, che tutti si riferiscono a lui. Vi è simmetrizzazione perché più persone ne rappresentano una sola, ma non c’è identificazione apparente fra i diversi rappresentanti. Si tratta di una struttura bi-logica dissimulata, in cui attraverso la scissione-spostamento si ha una moltiplicazione dei soggetti. Nella condensazione accade l’opposto: quella che appare come una singola persona possiede in realtà le caratteristiche di più individui. Ancora una volta un essere isomorfo a più dimensioni viene trattato come se ne avesse soltanto tre.
Di fatto, osserva Matte Blanco, «emozione ed inconscio presentano le stesse violazioni della logica classica. Nessuno dei due è una pura espressione del modo indivisibile, ma entrambi ne sono altamente saturi». Ambedue, inconscio ed emozione, costituiscono la base generatrice della creatività e del pensiero.
Bibliografia
Matte Blanco(1988) Pensare, sentire, essere, Einaudi Torino 1995.
Bon De Matte Luciana

Luciana Bon De Matte
Maestri della psicoanalisi
A cura di Alessandro Grignolio
Foto d’archivio
Bon De Matte, Luciana ( Santiago del Cile 25. 5. 1931 – Roma, 02.5.2012 )
Luciana Bon De Matte, Psicoanalista con funzioni di training, trasferitasi dal Cile in Italia negli anni ‘60 insieme al marito, Professor Ignacio Matte Blanco ed alla sua famiglia, si era dedicata al lavoro con pazienti adulti, con bambini e con adolescenti mostrando notevole sensibilità e capacità di ascolto, tema quest’ ultimo su cui ha formato intere generazioni di allievi ed analisti.
Donna di grande cultura, appassionata di musica e capace di lasciare un segno in chi la frequentava, ha lavorato molto sia per la Società Psicoanalitica Italiana sia al Centro Di Psicoanalisi Romano (CdPR), dove è stata Segretario Scientifico dall’82 all’86.
La contraddistingueva la passione autentica per la psicoanalisi nelle sue varie declinazioni: i pazienti, l’insegnamento, le supervisioni.

La vita
Luciana Bon De Matte si laurea in Medicina e Chirurgia nel 1956 presso l’Università del Cile, si specializza in Psichiatria nel 1961 e nel 1965 entra nella Società Cilena di Psicoanalisi. Giunta in Italia, è Membro Associato della SPI dal 1967 e Membro Ordinario dal 1979, Analista con Funzioni di Training dal 1984. Svolge la sua attività in istituzioni pubbliche e private, è professore a contratto di Psicoterapia dal 1995 presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del “Sacro Cuore” di Roma. E’ stata didatta e Membro Onorario dell’ Associazione Psicoanalitica Infantile (AIPPI).
Il contributo alla Psicoanalisi
Luciana Bon De Matte propone un vivace ripensamento personale dell’impianto psicoanalitico, lungo la direttiva Freud, Klein, Bion, alla luce di una vasta esperienza clinica e della propria sensibilità personale, con una costante apertura al nuovo e una profonda fedeltà agli stimoli, ai dati, alle intuizioni e alle riflessioni emergenti dal contatto con pazienti, allievi, colleghi. I frutti di questa elaborazione si sono riversati in intuizioni originali e stimolanti nel campo della tecnica con bambini, adolescenti e adulti.
Fare lo psicoanalista, essere psicoanalista: questa è una distinzione significativa che Luciana Bon De Matte propone in una delle sue conversazioni e che sembra condensare molto del suo pensiero – più che mai attuale – sulla tecnica analitica. Una spiccata peculiarità di fare sentire l’altro unico, capace di alimentare e sostenere il piacere dello stare insieme e della relazione. La personalità è pensata come complessa e a livelli multipli, compresenti e simultaneamente funzionanti e più o meno integrati tra loro.
La cosa che più colpiva, si può leggere nell’intervista a cura di Carla Busato Barbaglio , era il suo andare sempre in modo originale al cuore del problema senza perdersi in aspetti non essenziali. Puntuale, mai scontata. In profondo ascolto emozionale e intuitivo, libera da paludamenti teorici vincolanti pur avendo una solida fondazione. Tutto era studiato, pensato, teorizzato e ripensato nuovamente divenendo così un gesto. La sua fonte permanente di studio e riflessione era la vita. Per Luciana Bon de Matte ogni evento che si produce fuori o dentro la stanza di analisi viene inevitabilmente attribuito al significato o agli effetti della relazione analitica. Il passato viene utilizzato per comprendere il presente ed il transfert viene perciò vissuto intensamente dall’analista e non necessariamente interpretato. La funzione analitica si esprime nell’accompagnamento della persona verso la comprensione progressiva del proprio funzionamento mentale operando con ritmi che il paziente è disposto a darsi, lavorando nel transfert attraverso un collegamento emozionale con l’altro teso a salvaguardare gli aspetti del paziente che funzionano per non aggravare ulteriormente la persona sofferente.
La persona è vista nella sua totalità con un’attenzione particolare alla valorizzazione di una corporeità fatta di sensazioni e di emozioni prima ancora che di pensieri. Una spiccata attenzione alle potenzialità ed alle risorse psicologiche che restano inespresse che la colloca a pieno titolo nel panorama clinico-teorico contemporaneo senza per questo tralasciare quegli aspetti della personalità rimasti inesplorati che attraverso l’indagine psicoanalitica potranno essere portati alla luce aprendo un dialogo ricco e fruttuoso all’interno di sé.
Il suo pensiero suggerisce il passaggio da una tecnica basata su una teoria del conflitto, che prevedeva un osservatore il più possibile neutrale, a una pratica clinica di valorizzazione delle esperienze vissute dalla coppia analitica, modello questo che ha comportato un ampliamento degli orizzonti clinicio-teorici in molte direzioni.
Bibliografia
1)Bon De Matte L. 1970. Introduzione allo studio della identificazione proiettiva. Psiche 7, I: 37-48.
2)Bon De Matte L. 1988. An account of Melanie Klein’s conception of projective identification. In Matte Blanco I. Thinking Feeling and Being. Routledge, London. Traduzione in Italiano: Einaudi Editore, Torino 1995.
3)Bon De Matte L. 1989. Una forma di scissione nella situazioni arcaiche della psicoanalisi clinica. In Bazzi C., Belletti F., Panzini V. Editors: Alla ricerca del bambino perduto. Come , dove, perché . Edizioni Unicopoli.
4)Bon De Matte L., Durst M. 1991. Melanie Klein. In Novecento filosofico e Scientifico, volume quarto, Marzorati Editore, Milano.
5)Bon De Matte L. 1994 pp. 9-15. In Ferrari A.B. Adolescenza la seconda sfida. Borla, Roma. Traduzione in Portoghese.
6)Bon De Matte l. 1996. Considerazioni sull’analista al lavoro. In Candelori C., Dolore mentale e conoscenza. Edizioni Cosmopoli, Roma.
7)Bon De Matte L. 1998. Anorexia Syndrome in Adolescence and Anorexia. In Bria P., Ciocca A., De Risio S. Editors, Psychotherapeutic Issues on Eading Disorders. Società Editrice Universo, Roma.
8)Bon De Matte L. 1998. Felicità, una difficile conquista. In Psyche 2,6: 89-95, Borla, Roma.
9)Bon De Matte 1998. L’idea dell’inquietudine. In Cent’anni di Psicoanalisi. Micromega, 3 pp. 209-217.
10)Bon De Matte L. 1999. Elementi di bi-logica nel lavoro clinico con bambini e adolescenti. In Bria P., Oneroso F. Editors, L’inconscio Antinomico, Sviluppi e prospettive dell’opera di Matte Blanco. Franco Angeli, Milano.
11)Bon De Matte L. 2004. Mito e gioco nella psicoanalisi infantile, in: Bria P., Oneroso F.
Collegamenti in rete:
Intervista a Luciana Bon de Matte (di Carla Busato Barbaglio – 2009)

Bon De Matte, Luciana
Psychoanalyst with training function, Luciana Bon de Matte moved to Italy in the 60s from Chile with her husband, professor Ignacio Matte Blanco and his family. She worked with adult patients, children and adolescents showing high feeling and ability to listen, the latter being a subject on which she trained generations of students and analysts.
A woman of great culture, with a strong passion for music and able to leave a mark in audience’s mind. She has worked extensively for the Italian Psychoanalytical Society and the Center for Psychoanalysis Romano (CDPR), where she was Scientific Secretary from ’82 to’86. She was characterized by a genuine passion for psychoanalysis in its various forms, towards patients, teaching, and supervision.
Life
She graduated in Medicine and Surgery in 1956 at the University of Chile before specializing in Psychiatry in 1961, becoming member of the Chilean Society of Psychoanalysis in 1965. In Italy she was Associate Member of the SPI since 1967 and Ordinary Member from 1979, obtaining the Training functions in 1984. She currently carries out her activities in public and private institutions being Visiting Professor of Psychotherapy (1995) at the School of Specialization in Psychiatry – Faculty of Medicine, Catholic University “Sacro Cuore” of Rome. She has been both Teaching and Honorary Member of the Child Psychoanalytic Association (AIPPI).
The contribution to psychoanalysis.
Luciana Bon de Matte offers a helpful rethinking psychoanalytic theory, along the tradition of Freud, Klein and Bion. A woman of great clinical experience and personal sensitivity, with a constant openness to new and emerging insights from contact with patients, students, colleagues. Her elaboration has produced original and stimulating insights in the field of practice with children, adolescents and adults. Making the psychoanalyst, being a psychoanalyst: this is a significant distinction that Luciana Bon de Matte offers in one of her conversations and that seems to condense much of her thought – more relevant than ever – on the analytical technique.
She always shows a remarkable peculiarity to make feel the other relevant, able to feed and sustain the pleasure of being together and of the relationship itself. Personality is thought as complex and of multiple levels, coexisting and simultaneously functioning, more or less integrated. The most striking thing, you can read in the interview by Carla Busato Barbaglio (link to the interview: From the center of Psychoanalysis Romano an interview to Luciana Bon de Matte), it was her strong attempt to find an original way to reach the heart of the problem, without getting lost in non-essential details.
Creative but at the same time with a solid theoretical and clinical training, everything was studied, thought, and theorized, thus becoming a gesture.
Her permanent source of study and reflection was life. For Bon de Matte each event that occurs inside or outside the room of analysis is inevitably attributed to the meaning or effect of the analytic relationship. The past is used to understand the present and the transference is then intensely experienced by the analyst, without being necessarily interpreted.
The analytic function is expressed in the accompaniment of the person towards the progressive understanding of its mental functioning, working with rhythms that patient is ready to give himself, working in the transference and looking for an emotional connection with the patient’s mind.
The person is seen in its totality and in its potential and the aspects of personality that remained unexplored by the psychoanalytic investigation can be brought to light by opening up a rich and fruitful dialogue within himself.
Her thinking suggests the shifting from a technique based on a theory of conflict, which included an observer as neutral as possible, to a practice of enhancing the experiences lived by the analytic pair, a model that favoured an extension of the clinical and theoretical horizons in many directions.
Borderline
A cura di Gabriella Giustino
Il disturbo borderline è il più comune tra i disturbi di personalità ed è caratterizzato da un notevole impoverimento del funzionamento psicosociale e da un ampio utilizzo di trattamenti psichiatrici e/o psicoterapeutici. Il termine borderline inizialmente indicava una patologia che si colloca “al confine” tra nevrosi e psicosi. Più recentemente tale termine è apparso meno adeguato per la descrizione di questa complessa psicopatologia. A tale proposito A. Correale (2012) ha proposto il termine “borderless” per sottolineare maggiormente “ l’assenza di confine” che si esprime con la ben nota disforia ed impulsività dei soggetti affetti da questo disturbo.
Secondo la diagnosi del DSM-IV il disturbo borderline è caratterizzato da una pervasiva instabilità delle relazioni interpersonali, dell’immagine di sé e dell’umore, da sentimenti cronici di vuoto e di abbandono, sintomi dissociativi e rabbia immotivata ed intensa.
Altri criteri importanti per la diagnosi sono: la facilità agli agiti (spesso secondaria ad impulsività ed umore disforico), l’intolleranza alle frustrazioni, lo scarso controllo e consapevolezza delle emozioni, la difficoltà a percepire emotivamente l’altro e l’incapacità di identificarsi con esso, la tendenza a sviluppare manifestazioni transferali burrascose.
Oltre alle configurazioni sopra menzionate va aggiunta la propensione, in forme e gradi diversi, dell’uso della sofferenza in senso vittimistico e vendicativo/rivendicativo in vista di un ipotetico risarcimento.
E’ utile affiancare a questi parametri l’individuazione di specifici aspetti di carattere processuale che, a partire da situazioni traumatiche intese come fattori dinamico-etiologici fondamentali, strutturano la personalità del paziente colonizzando la sua mente con specifiche organizzazioni psicopatologiche (così come descritte da vari autori tra cui Rosenfeld, Meltzer e Steiner).
La ricostruzione della storia emotiva del paziente mostra spesso come queste organizzazioni mentali siano il risultato d’antiche situazioni d’intollerabile scacco evolutivo che, trasformandosi da situazioni traumatiche in stabili tratti di personalità, mantengono inalterate le condizioni di sofferenza del paziente in una posizione di estrema confusione interna determinando l’impossibilità di raggiungere ed utilizzare la posizione depressiva.
Da questo punto di vista è importante evidenziare che il trauma si manifesta prevalentemente sotto la forma d’assenza di risonanza e ricettività emozionale (o in alternativa intrusività) da parte degli oggetti primari di relazione. Il deficit di sviluppo dell’inconscio inteso come funzione che permette di comprendere le emozioni proprie e degli altri è dovuto spesso nei borderline, a tali traumi precoci e ripetuti. In questi pazienti sono inoltre frequentemente osservabili stati di “dissociazione” mentale. Tali stati potrebbero essere definiti come un meccanismo di disintegrazione parziale del Sé (Winnicott, 1986), una fuga verso la fantasia dissociata ad occhi aperti.
Infine, per quanto concerne la comprensione del disturbo (e la sua cura) è centrale nei pazienti borderline anche la condizione di deficit di sviluppo della mentalizzazione.
Il termine mentalizzazione è stato usato per la prima volta da P. Fonagy nel 1989 proprio per la comprensione della psicopatologia dello sviluppo della personalità borderline.
La mentalizzazione è una forma di attività mentale immaginativa che riguarda sé stessi e gli altri e che permette di comprendere e spiegare il comportamento in termini di stati mentali intenzionali (per es. bisogni, desideri, emozioni, credenze e motivazioni).
Nello sviluppo normale, la madre e il bambino sono coinvolti in un processo intersoggettivo che implica la comunicazione di stati affettivi in cui la madre ha un ruolo vitale nel regolare, modulare e rispecchiare adeguatamente gli stati emotivi del figlio. Da qui la necessità che il terapeuta si ponga come nuovo oggetto trasformativo per il paziente borderline che può riuscire a trovare se stesso nella mente dell’analista inteso come essere pensante e capace di sentimento. Una rappresentazione che non si è mai totalmente sviluppata nella prima infanzia e che, probabilmente è stata in seguito ulteriormente danneggiata da esperienze interpersonali dolorose.
Bibliografia
Bateman, A.W. & Fonagy, P. (2004) Il trattamento basato sulla mentalizzazione Tr.it.. Raffaello Cortina Editore, Milano. 2006
Correale A, Alonzi A.M., Carnevali A., Di Giuseppe P., Giacchetti N. (2009) Borderline. Lo sfondo psichico naturale. Edizioni Borla. Roma
De Masi F.(2012) Lavorare con i pazienti difficili. Bollati Boringhieri. Torino.
Fonagy, P., Target, M. (1996). Giocare con la realtà: I. Teoria della mente e sviluppo normale della realtà psichica. Tr. It in Attaccamento e Funzione riflessiva Raffaello Cortina, Milano 2001
Gabbard G.O. (2004) La psicoterapia dei pazienti borderline. Quaderni del Centro Milanese di Psicoanalisi.
Winnicott DW (1986) Il bambino deprivato Cortina Editore, Milano.
Approfondimenti
REPORT: 2° seminario di ricerca sulle patologie borderline, 24 novembre 2012 MILANO
Bordi Sergio
Maestri della psicoanalisi
A cura di Pier Christian Verde
Bordi, Sergio (Roma, 1929 – Roma, 2006)
Sergio Bordi nasce l’8 gennaio 1929 a Roma, dove muore nel 2006, all’età di 77 anni.
E’ considerato uno dei più autorevoli membri della Società Psicoanalitica Italiana per il contributo da lui portato, sul piano della clinica e della teoria, al rinnovamento della psicoanalisi italiana. Il suo interesse, nell’esaminare e nel discutere il variegato panorama teorico offerto dalla psicoanalisi, è sempre stato rivolto a sviluppare una visione ampia e attenta dell’insieme del pensiero analitico, indagando lo sviluppo e la storia della psicoanalisi a livello internazionale. Bordi può essere considerato un pioniere nell’aver indirizzato la ricerca, rigorosa sul piano teorico e clinico, verso l’approfondimento degli elementi di contatto tra i diversi orientamenti analitici.
La vita
Dopo aver svolto gli studi classici, si laurea nel 1952, a 23 anni, in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La Sapienza”, dove si specializza in neuropsichiatria all’età di 27 anni.
Negli anni universitari nutre un vivo interesse per la politica, si iscrive al Partito Socialista; è membro del comitato scientifico dell’Istituto Gramsci per circa 15 anni.
Comincia la professione di psichiatra, lavorando con passione nell’ambito pubblico all’ospedale “Santa Maria della Pietà” e contemporaneamente inizia un’analisi personale e successivamente didattica con Nicola Perrotti.
Bordi si dedica alla professione di psicoanalista, lasciando dopo otto anni l’esperienza istituzionale.
La traccia della sua formazione giovanile si manterrà nel corso di tutta la sua vita di studioso e di psicoanalista: il forte impegno nell’ambito analitico, caratterizzato dalla passione per la clinica e dal fervido interesse nel lavoro scientifico all’interno della Società Psicoanalitica Italiana (SPI), è stato infatti accompagnato con continuità dal contatto con il lavoro istituzionale.
All’interno della SPI Bordi svolge le funzioni di analista di training e partecipa a molte iniziative in ambito nazionale e internazionale; favorisce nella SPI il disporsi al dialogo e all’apertura scientifica, contribuendo a mettere in contatto la psicoanalisi italiana con la cultura internazionale, psicoanalitica e non. Collabora, all’inizio degli anni ‘70, alla traduzione italiana e alla presentazione degli scritti di W. Bion e partecipa attivamente allo scambio teorico e clinico con psicoanalisti della società psicoanalitica anglosassone, tra i quali E. Brenman, M. Harris, D. Meltzer, H. Segal. In particolare, l’attività di supervisione svolta da Herbert Rosenfeld sarà da lui riconosciuta come decisiva per la sua formazione clinica.
Con il Servizio Pubblico, Bordi collabora dagli inizi degli anni ‘80 come consulente per la formazione e supervisore. E’ uno degli psicoanalisti che, con l’apertura dei Centri di Igiene Mentale, in seguito all’applicazione la legge Basaglia, intuisce la potenzialità dello scambio tra pubblico e privato, per l’approfondimento teorico e clinico del modello psicoanalitico. Nell’analizzare i rapporti che intercorrono tra psicoanalisi e psicoterapia nel pubblico, Bordi è attento alla distinzione tra traguardo conoscitivo e traguardo terapeutico, e a come il metodo debba essere sperimentato con gli elementi distintivi dei singoli pazienti. Bordi sottolinea la complessità della professione dell’analista, di colui che porta nel setting l’esperienza maturata in diversi contesti di formazione e cura.
Il contributo alla psicoanalisi
Bordi, nella sua teorizzazione, propone di esplorare i “common grounds”, i territori comuni, cercando di approfondire le connessioni della psicoanalisi con il contesto contemporaneo, teso al dissolvimento dei precedenti orizzonti culturali e ideologici. Bordi con il concetto di “common ground” evidenzia la necessità di riconoscersi uniti nei territori comuni della pratica e della teoria clinica, mettendo da parte tutte le teorie generali. “La vita odierna – dice Bordi – ha imposto la necessità di amalgamare una moltitudine di identità e di culture diverse, ha fatto cadere i preesistenti principi di coordinamento, di valori centrali e di autorità centrali” e quindi, con la sua indicazione di chi si orienta sul presente per coglierne le potenzialità ancora inespresse, invita a entrare in campo, in un confronto con “l’irriducibile fisionomia multidimensionale e pluralistica del mondo contemporaneo”.
Bordi sottolinea inoltre la contraddizione che intercorre nel rapporto tra la psicoanalisi e il clima circostante del contesto contemporaneo: da un lato la psicoanalisi ha aperto le porte al postmoderno attraverso la valorizzazione della libertà interiore, dall’altro è rientrata negli schemi della modernità, contribuendo a fissare l’identità del soggetto entro i confini del sistema di controllo. Il termine postmoderno sta a designare la posizione in cui si pone il mondo contemporaneo dopo aver giudicato irrealizzabile il progetto di progresso sociale e di emancipazione individuale portato avanti dalla modernità, in quanto i fondamenti della ragione “occidentale” al quale il progetto si affidava, hanno prodotto un sistema di controllo burocratico che contrariamente alle premesse, manipola e limita ogni espressione individuale legata alla creatività e all’immaginazione.
Questo stato di cose è stato condensato nel dualismo “postmodernizzare la psicoanalisi”, che vede proposte, come quella di G.Kelin, di abbandonare la metapsicologia o quella di R.Schafer, di usare il linguaggio d’azione e “psicoanalizzare la postmodernità”, caratterizzata dall’insieme delle risposte che la tradizione empirista cerca di dare alle tendenze di una visione della soggettività come “coltre rappresentazionale” di una trama intra- e intersoggettiva. Infatti, secondo Bordi, le risposte postmoderne ai problemi psicoanalitici, nel mettere in discussione il realismo del pensiero positivista, hanno sempre più sviluppato una concezione secondo cui le proprietà “oggettive” presenti nel mondo esterno riflettono due processi culturalmente fondati: il processo di costruzione soggettiva dell’esperienza e il processo di significazione dell’esperienza attraverso il linguaggio. Bordi sottolinea l’importanza di interrogarci entro quali condizioni, preferenze e credenze si svolge il nostro approccio alla conoscenza che costruiamo.
Alla luce di ciò la ricerca assume una funzione di primo piano per la teoria e la clinica psicoanalitica. In particolare la ricerca infantile, fondata sul metodo induttivo e condotta su dati osservabili (sui quali si fondano ipotesi destinate a ricevere conferma) si basa sul criterio di “corrispondenza”: i dati a disposizione dell’analista sono invece manifesti solo per la parte espressiva della comunicazione, fondandosi sul criterio di “coerenza”.
Bordi sottolinea la necessità di tenere viva la tensione tra il criterio della corrispondenza e quello della coerenza ed evidenzia come un tale accostamento, assai significativo per il metodo psicoanalitico, l’abbia spinto ad approfondire la “rappresentazione mentale inconscia”. In tal senso Bordi apre a un confronto tra la concezione tradizionale e quella che si profila alla luce delle scoperte del cognitivismo, della teoria dell’attaccamento, della psicologia dell’età evolutiva e della psicoanalisi relazionale. Bordi sottolinea diversi punti di convergenza: la regolazione, nell’interazione e nell’incontro; i momenti di fallimento e di recupero; i processi che intervengono a favorire l’integrazione tra momenti di riunione e di separazione.
E’ moderna, rigorosa e stimolante l’indagine che Bordi ha svolto nel campo del pensiero analitico per circa cinquanta anni, da studioso rigoroso e appassionato clinico, la sua azione è diretta a favorire l’apertura della psicoanalisi italiana al contatto con lo scenario internazionale e ad attivarne l’interesse e la curiosità verso le diverse concettualizzazioni prodotte da altre scuole, in primis quella anglosassone e da diverse discipline, in particolare la filosofia, la biologia e le neuroscienze.
Un particolare approfondimento è sviluppato da Bordi sullo statuto epistemologico della psicoanalisi e dei cambiamenti intercorsi, a partire della fine degli anni ‘90, nella stessa epistemologia nel percorso di avvicinamento tra scienze della natura e scienze della cultura e nello sviluppo dell’intersoggettivismo e della cultura della ricerca.
Anche l’approfondimento dei rapporti tra psicoanalisi e psicoterapia Bordi ci riporta nel vivo del concetto del “common ground”, e rinvia all’importanza di sviluppare un territorio comune di condivisione e di approfondimento delle diverse teorie e tecniche e della loro possibile integrazione.
Sergio Bordi considera la psicoanalisi come uno strumento aperto alla curiosità della conoscenza, pur sottolineando con energia l’importanza di mantenere il senso del metodo psicoanalitico (in primo luogo il setting), adottando un atteggiamento analitico flessibile.
Sin dagli inizi degli anni ‘80 Bordi intuisce e sottolinea l’importanza teorica dei cambiamenti introdotti nel dibattito psicoanalitico (in primis con l’opera di autori come O.Fenichel, D.Winnicott, W.Bion e J.Bowlby) che da una visione teorica esclusivamente intrapsichica e internalista hanno portato a una visione più articolata e interpersonale, che prevedesse un vertice relazionale ed esternalista per la comprensione del funzionamento mentale.
E non sono mai mancati nella vita professionale di Sergio Bordi attività di formazione e di supervisione e come testimoniato da molti suoi allievi, riferimenti al mondo dell’arte, richiami al mondo musicale, cinematografico e teatrale; la passione con cui ha contribuito nel pubblico e nel privato, all’arricchimento del pensiero analitico è stata parte integrante e fondamentale della sua persona e della sua identità di scrupoloso psicoanalista e acuto uomo di scienza.
BIBLIOGRAFIA
Sergio Bordi ha lasciato pochi lavori scritti, mentre ha svolto numerosissime conferenze e molte lezioni e seminari. Gli scritti che seguono sono prevalentemente articoli tratti da riviste o interventi letti in conferenze e seminari.
Bordi S. (1956). “Osservazioni su un caso di demenza epilettica”. Rivista sperimentale di freniatria, 53, pp. 675-679.
Bordi S.(1958). “Le personalità psicopatiche sotto l’aspetto medico-forense”. Il lavoro neuropsichiatrico, 33.
Bordi S. (1958). “Particolari aspetti di una sindrome delirante allucinatoria cronica”. Il lavoro neuropsichiatrico.
Bordi S. (1964). “Intervento sulla ‘responsabilità’ di Nicola Perrotti”. Psiche, 1, 2, pp.30-31.
Bordi S. (1964). “ Intervento su ‘L’Io e il Sé’ di Nicola Perrotti”. Psiche,1,2, pp. 95-110.
Bordi S. (1964). “Valutazione dell’Io all’inizio del trattamento psicoterapeutico”. Psiche, 1, 2, pp. 159-161.
Bordi S. (1964). “Intervento su ‘La personalità dello psicoanalista’ di Nicola Perrotti”. Psiche, 1, 2, pp. 264-265.
Bordi S. (1968). “Sulla fugacità (una nota sul processo creativo)”. Psiche, 1-2-3-4, pp.83-93, Edizioni dell’Ateneo, Roma.
Bordi S. (1970). “La psicoanalisi e le scuole dissidenti”. Archivio di Psicologia, neurologia e psichiatra, 31, pp.131-143.
Bordi S. (1970). Due contributi allo studio della Istituzione Psicoanalitica. Psiche, 7, pp. 73-90.
Bordi S. (1973). “Sull’approccio psicoanalitico al problema dell’apprendimento”. Rivista di psicoanalisi, 19, 2, pp. 127-142.
Bordi S. (1976). “Exploration in autism”. Rivista di psicoanalisi. 1, pp. 134-138.
Bordi S., Mattogno M., Muscetta S., Nencini G., Princivalle M., Rizzo L. (1976). “L’aborto come vissuto nella realtà psichica e nel mondo esterno”. Rivista di psicoanalisi, 2, pp. 243-294.
Bordi S. (1977). “Realtà psichica: mondo interno e mondo esterno”. Rivista di psicoanalisi, 25, 1, pp. 1-19.
Bordi S. (1980). “Relazione analitica e sviluppo cognitivo”. Rivista di psicoanalisi, 27, 2, pp. 162-181.
Bordi S. (1983). “Comunicazione madre-bambino e organizzazioni narcisistiche”. Giornale di neuropsichiatria dell’età evolutiva, 3, 3, pp.261-281.
Bordi S. (1985). “Le prospettive teoriche della psicoanalisi contemporanea”. Rivista di psicoanalisi, 31, 4, pp. 437-450.
Bordi S. (1985). “Lo statuto dell’inconscio fra etica e logica”. Quaderni del trentennale – 1975-2005, 4, Istituto italiano per gli studi filosofici, Napoli, 23 novembre.
Bordi S. (1986). “Psicoanalisi e dibattito epistemologico contemporaneo”. Quaderni del trentennale – 1975-2005, 4, Istituto italiano per gli studi filosofici, Napoli, 27-29 novembre.
Bordi S. (1987). “Epistemologia e psicoterapia: Voci a confronto”. Psicobiettivo, VII, 2-3, pp. 4-14.
Bordi S. (1987). “Il complesso itinerario della psichiatria, della psicoanalisi e della psicologia in Italia. La grande scacchiera della mente. Intervista a Sergio Bordi”. Rinascita, 2 maggio.
Bordi S. (1988). “La dimensione degli affetti nello sviluppo e nella clinica”. Quaderni del trentennale – 1975-2005, 4, Istituto italiano per gli studi filosofici, Napoli, 16-19 novembre.
Bordi S. (1988). “Tendenze attuali in tema di diagnosi: il punto di vista psicoanalitico”. Psicobiettivo, VIII, 3, pp. 9-18.
Bordi S. (1989). “La tecnica psicoanalitica: storia e mutamenti”. Rivista di psicoanalisi, 35, 3, pp. 547-615.
Bordi S. (1990). “Note sul problema continuo-discontinuo nello sviluppo”. Adolescenza, 1-1, pp. 10-19, Il Pensiero Scientifico, Roma.
Bordi S. (1993). “Psicoanalisi”. Enciclopedia Italiana, vol. 321, pp. 321-324. Istituto Enciclopedia Treccani, Roma.
Bordi S. (1995). “Lo stato attuale del concetto di neutralità analitica”. Rivista di Psicoanalisi, 41, 3, pp. 373-390
Bordi S. (1995). “Psychoanalysis, mind and person”. Italian Journal Psychiatry Behavioural Sciences, 5, 4.
Bordi S. (1995). “Il significato della ricerca infantile per la clinica psicoanalitica”. I seminari milanesi di Sergio Bordi. Quaderni del Centro milanese di psicoanalisi Cesare Musatti, Milano.
Bordi S. (1995). “Elementi di unione e di divisione in psicoanalisi”. I seminari milanesi di Sergio Bordi. Quaderni del Centro milanese di psicoanalisi Cesare Musatti, Milano.
Bordi S. (1995). “Le soluzioni postmoderne ai problemi della psicoanalisi”. I seminari milanesi di Sergio Bordi. Quaderni del Centro milanese di psicoanalisi Cesare Musatti, Milano.
Bordi S. (1995). “La rappresentazione mentale inconscia”. I seminari milanesi di Sergio Bordi. Quaderni del Centro milanese di psicoanalisi Cesare Musatti, Milano.
Bordi S. (1995). “Psicoanalisi e psicoterapia”. I seminari milanesi di Sergio Bordi. Quaderni del Centro milanese di psicoanalisi Cesare Musatti, Milano.
Bordi S. (1996). “La rappresentazione mentale inconscia nell’evoluzione del pensiero psicoanalitico”. In Accerboni A.M., Andreoli L., Barbieri V., Elia C., Maggioni D., Panero M. (a cura di). Affetti e pensiero. Orientamenti psicoanalitici (pp. 27-41). Moretti & Vitali, Bergamo, 1998.
Bordi S. (1996). “Considerazioni psicoanalitiche sul concetto di libertà”. Psiche, 2, pp. 11-21.
Bordi S. (1996). “Risultati e limiti della terapia psicoanalitica”. Nòos. Aggiornamenti in psichiatria, 2, 4, pp. 313-322, Il Pensiero scientifico, Roma.
Bordi S. (1997). Realtà psichica, trauma, difesa. Setting, 7, pp. 8-25.
Bordi S. (1998). “La psicoanalisi alla fine del secolo: una rassegna”. Scritti, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009.
Bordi S. (1999). “L’insegnamento della psicoanalisi in un’epoca di declino delle quattro -cinque sedute settimanali”. Scritti, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009.
Bordi S. (2000). “Il pluralismo nella psicoanalisi”. Scritti, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009.
Bordi S. (2001). “Il trauma: una, tante memorie”. In Pierri M. (a cura di). Qui e ora… con me. Bollati Boringhieri, Torino.
Bordi S. (2002). “Le fobie in adolescenza”. Quaderni del trentennale – 1975-2005, 4, Istituto italiano per gli studi filosofici, Napoli, 15 marzo.
Bordi S. (2002). “Prefazione”. In De Masi F. (a cura di). Il limite dell’esistenza. Bollati Boringhieri, Torino.
Bordi S. (2002). “La mente e il soggetto: appunti di uno psicoanalista”. Psiche, 2, pp. 63-76.
Bordi S. (2002). “Scopi clinici e culturali della psicoanalisi”. Scritti, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009.
Bordi S. (2003). “Pluralismo e commonground”. Scritti, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009.
Bordi S. (2003). “Ricerca infantile, teoria dell’attaccamento, crescita della mente e psicopatologia”. Scritti, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009.
Bordi S. (2003). “La persona dell’analista nelle diverse fasi della vita. Intervista a Sergio Bordi (a cura di G. Tavazza, G. Martini)”. Interazioni, 2, 20, pp. 126-130.
Bordi S. (2004). “A proposito dell’editoriale di Paolo Migone del n. 2/2004”. Psicoterapia e scienze umane, 38, 4, pp. 493-495.
Bordi S. (2004). “E’ cambiata la tecnica analitica? Come sono cambiate le nostre interpretazioni e come sono cambiati i nostri pazienti?”. Letto al Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti.
Bordi S. (2005). “Transfert e intersoggettività”. Scritti, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009.
Bordi S. (2005). “Rileggendo oggi Il disagio della civiltà”. Scritti, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009.
Bordi S. (2006). “Nota introduttiva. L’ermeneutica nella comunità psicoanalitica”. In Martini G. (a cura di). Psicoanalisi ed ermeneutica. Prospettive continentali. Franco Angeli, Milano.
Bordi S. (2006). “Le trasformazioni della teoria e l’avvento dell’ermeneutica”. In Martini G. (a cura di). Psicoanalisi ed ermeneutica. Prospettive continentali. Franco Angeli, Milano.
Bordi S. (2009) “ Scritti” (a cura di) Paola Capozzi. Raffaello Cortina Editore, Milano.
Pesce G. (2006). Un ricordo di Sergio Bordi. Setting. 22, pp. 91-94.
COLLEGAMENTI
Bordi S. (1997). Realtà psichica, trauma, difesa. Setting, 7, pp. 8-25.
Bordi S. (1998). “La specificità della psicoanalisi”. Presentato al Centro di Psicoanalisi Romano.
(Vedi in Area privata del sito del CdPR, http://www.centropsicoanalisiromano.it)
Bordi S. (1998). “La psicoanalisi alla fine del secolo: una rassegna”. Presentato al Centro di Psicoanalisi Romano.
(Vedi in Area privata del sito del CdPR, http://www.centropsicoanalisiromano.it)
Bordi S. (2004). L’interpretazione oggi. Come sono cambiate le interpretazioni dell’analista e come sono cambiati i nostri pazienti. Presentato al Centro Romano di Psicoanalisi, 4-5 giugno.
(Vedi in Area privata del sito del CdPR, http://www.centropsicoanalisiromano.it)
Intervista dr. S. Bordi (2004) a cura di Nicoletta Bonamone. Centro di Psicoanalisi Romano, dicembre.
Bugia
A cura di Giorgio Mattana
La bugia è generalmente definita come un’affermazione contraria alla verità, spesso consapevole e motivata dall’interesse personale. Specie se occasionale, tale genere di menzogna, che potremmo definire “utilitaristica”, non riveste in quanto tale un particolare interesse psicoanalitico. Quando, invece, per contenuto, significato e funzione, oltre che, eventualmente, frequenza, la bugia viene a coinvolgere più direttamente la personalità, essa diviene un fenomeno psicoanalitico. Come tale, la bugia è oggetto di uno spettro di considerazioni diverse che riflettono differenti configurazioni cliniche, le quali, tanto dal punto di vista evolutivo che “strutturale”, come assetto relativamente stabile della personalità, si dispongono lungo un continuum che va dalla normalità o quasi normalità alla patologia.Freud (1913), prendendo in considerazione le menzogne di due bambine, l’una relativa all’occultamento di una piccola somma di denaro e l’altra allo status sociale della propria famiglia, chiaramente descrive delle bugie motivate esclusivamente dall’“interesse” emotivo. Le bugie in questione, che potrebbero essere definite “nevrotiche”, in quanto non costitutive della personalità e pregiudizievoli per il suo sviluppo, sono da Freud collegate al complesso edipico e al forte attaccamento ai genitori. A patto che non si crei “un malinteso fra il bambino e la persona che egli ama”, esse tendono, inoltre, a essere associate a una prognosi favorevole, che escluderebbe lo sviluppo di un carattere “immorale”. Autori come Tausk (1919), Ferenczi (1927) e Kohut (1977), spingendosi oltre le considerazioni freudiane, ritengono la bugia un passaggio evolutivo importante, fattore e testimonianza del costituirsi di uno spazio interno sottratto allo sguardo dell’altro. Non è più la dinamica edipica, in questo caso, a occupare il centro della scena, bensì il costituirsi di una “teoria della mente” e della relazione fra il proprio spazio mentale interno, individuale e separato, e quello altrui. La bugia e il segreto, che ne rappresenta spesso l’altra faccia, costituiscono, in questa prospettiva, un fattore essenziale di costruzione e tutela dell’identità personale .In linea con ciò, la bugia che sconfina nella diplomazia e nella dissimulazione può essere vista come l’espressione di un “sano falso sé” posto a protezione del vero sé, inteso come sfera più intima e coincidente con il nucleo autentico della personalità. Altri autori, tuttavia, hanno sottolineato manifestazioni della bugia che, allontanandosi progressivamente dal “sano falso sé”, si avvicinano a condizioni francamente patologiche, come la personalità “come se” e l’impostura. Nella prima, seguendo la Deutsch (1942), quella “dissimulazione onesta” che già Torquato Accetto (1641), scrittore napoletano del seicento, considerava essenziale alla convivenza umana, diviene affettazione conformistica a tal punto costitutiva della personalità da sostituire completamente il vero sé. Come osserva Goisis (2009), mettendo a confronto il concetto di personalità “come se” con quello di falso sé, non esiste, in questo caso, un nucleo della personalità che il falso sé protegge dalle intrusioni dell’altro, ma l’adattamento compiacente tende a costituire l’essenza stessa del soggetto. La “bugia” non riguarda più eventi o comportamenti specifici, ma investe l’identità stessa della persona, erodendo progressivamente le basi di un suo corretto sviluppo: siamo nell’ambito di ciò che Bion (1970) definisce “essere una bugia”. A tale ambito appartiene anche l’impostura, distinta dalla personalità “come se” in quanto priva di quelle caratteristiche di “trasparenza” e adattamento conformistico che ne costituiscono il tratto peculiare. Abraham (1923) descrive il caso di un impostore “di professione”, che edifica la propria carriera sulla menzogna e il millantato credito, in un crescendo di falsificazione che viene ricondotto all’investimento narcisistico del sé e all’odio e alla svalutazione dei genitori. Nella stessa linea, la Deutsch (1955) e la Greenacre (1958), tratteggiano l’impostura come caratterizzata dall’assunzione di identità fittizie con forti tratti antisociali, riconducendo le menzogne dell’impostore a un processo di alterazione dell’identità basato su identificazioni patologiche e riconducibile all’ambito del narcisismo .La possibilità che l’analista risulti esposto alla falsificazione del paziente induce a sollevare il problema dell’analizzabilità: essendo la sincerità considerata un prerequisito dell’analisi, la bugia sembrerebbe in linea di principio una controindicazione al trattamento. Eppure, come afferma Bion (1970), la bugia è in certo senso il “pane quotidiano” dell’analista, che deve imparare a riconoscerla e ancor prima a rispettarla, poiché le formulazioni false sono mantenute “come una barriera contro affermazioni che condurrebbero ad un tumulto psicologico”. O’ Schaughnessy (1990) rivendica alla psicoanalisi la capacità di risolvere il suo specifico “paradosso del mentitore”, di un soggetto, cioè , che per essere se stesso è “costretto” a mentire, essendo, come afferma Bollas (1987), la bugia del bugiardo un’ espressione della sua realtà psichica. Senza negare i gravi problemi transferali che possono nascere nel trattamento del bugiardo abituale, di colui che è “caratterologicamente” un mentitore, O’Schaughnessy (1990) sottolinea come la possibilità d’intendere l’origine e la natura di tale disposizione, da ricercare nella relazione e identificazione con i primi oggetti, sentiti come inaffidabili e bugiardi, rappresenti spesso la chiave di volta del trattamento. Come ogni altro sintomo, in ogni caso, la bugia, quando incide in maniera abnorme e patologica, andrebbe intesa come una manifestazione di sofferenza, come la copertura di lacune dell’identità riconducibili al carattere fallimentare delle prime relazioni.
2013
BIBLIOGRAFIA
Abraham K. (1923). La storia di un impostore alla luce della conoscenza psicoanalitica. In Abraham K., Opere, vol. 1. Torino, Boringhieri, 1975.
Accetto T. (1641). Della dissimulazione onesta. Torino, Einaudi, 1997.
Bion W. (1970). Attenzione e interpretazione. Roma, Armando, 1973.
Bollas C. (1987). L’ombra dell’oggetto. Roma, Borla, 1989.
Deutsch H. (1942). Alcune forme di disturbo emozionale e la loro relazione con la schizofrenia. Psicoterapia e scienze umane, 1989.
Deutsch H. (1955). L’impostore. Contributo alla psicologia dell’Io in relazione a un particolare tipo di psicopatia. In Bugiardi e traditori, Torino, Bollati Boringhieri, 1994.
Ferenczi S. (1927). Il problema del termine dell’analisi. In Scritti, vol. 3, Bologna, Guaraldi, 1974.
Freud S. (1913). Le bugie di due bambine. O.S.F., 7.
Goisis P.R. (2009). Chi non ha mai detto una bugia? Tra normalità, “come se” e falso sé. Riv. Psicoanal., 1, 67-90.
Greenacre P. (1958). L’impostore. Firenze, Martinelli, 1979.
Kohut H. (1977). La guarigione del Sé. Torino, Bollati Boringhieri, 1980.
O’Shaughnessy E. (1990). Can a liar be psychoanalysed? Int. J. Psycho-Anal., 71, 187-195.
Tausk V. (1919). Scritti di psicoanalisi. Roma, Astrolabio, 1979.
Bullismo e società

Simpson_ Tre bulli
A cura di Tito Baldini
Il bullismo è una forma di comportamento violento, di natura fisica ma anche psicologica, attuato nei confronti di soggetti identificati dalla Società e dallo stesso “bullo” come deboli e incapaci di difendersi. Il termine è principalmente utilizzato per riferirsi a fenomeni di maltrattamento tipici di ambienti scolastici e più in generale di contesti sociali riservati agli adolescenti.
Spesso il “bullo” è sostenuto un gruppo che gli infonde la forza che da solo egli non avrebbe. Frequentemente è un soggetto affettivamente deprivato che vive ai margini della società e che dalla cultura di provenienza apprende come unica via di riscatto quella della supremazia del forte sul debole, illudendosi, così, di essere vincente. Un modo di pensare e fare primitivi, animaleschi, ove il più forte si ‘nutre’ anche sessualmente del più debole appropriandosi dei suoi diritti e dei suoi beni, e traendone facoltà dalla “legge naturale della sopravvivenza”, mentre il gruppo, spietato, batte il ritmo assordante della propria eccitazione.
E’ per questo che tale gruppo viene definito ‘branco’. Quando è riunito, come pure accade nel caso dei cani o dei lupi, il ‘branco umano’ esprime al massimo la sua primitività violenta: è esaltato dalla sua presunta supremazia, dalla capacità di togliere la vita all’altro per rinforzare la propria. Non vi è pietà per il presunto debole e questi non è tanto chi nella società ha difficoltà a realizzarsi quanto chi mostra più paura della legge del branco fondata sulla violenza.Il branco, infatti, odia la debolezza fisica e psicologica e soprattutto la paura, perché è in realtà composto da individui deboli e impauriti i quali si difendono illudendosi di condurre una vita da superuomini, fatta di azioni gagliarde frutto di pensieri veloci e risolutivi (i tifosi che applaudono il ‘fratello’ presunto omicida al suo processo). E’ come se il branco fosse un gruppo animalesco e non umano: quando è riunito non ragiona più. Tuttavia il singolo “bullo” può agire anche da solo perché si porta dentro il pensiero del proprio branco, anche se in solitudine la sua azione può risultare meno incisiva.
Il fenomeno del bullismo, studiato negli USA fin dagli anni ’50 del secolo scorso, dopo alti e bassi si è andato negli ultimi decenni incrementando nel mondo cosiddetto “occidentale” ed in modo tangibile in Italia, ma va anche detto che parallelamente si è acuita la sensibilità sociale verso tali condotte un tempo meno percepite e assunte quasi come una ‘fisiologia sociale’ (vedi ad esempio il “nonnismo” in caserma). Occorre inoltre sottolineare che tale fenomeno, ormai da tempo, è traversale rispetto alle diverse fasce sociali.
Il suo rafforzamento viene collegato a processi di decadimento dei valori sociali stessi, con indebolimento delle Istituzioni democratiche e del loro riconoscimento da parte dei cittadini.
Viene percepito quindi come segnale del lento declinare di una Società in parte mutilata dei suoi valori fondativi, e, di conseguenza, del parallelo prender piede di un pensiero rudimentale, arrogante, mirante a un benessere effimero e individualista.
Si presuppone che nel clima in cui le nuove generazioni si formano, la “legge del branco” abbia buone possibilità porsi come alternativa a quella della civiltà e i più deboli, facilmente illudibili, se ne possano appropriare.
Per quanto riguarda l’adolescenza, essa, come tutti sappiamo è un’età critica. Infatti, il raggiungimento della maturità sessuale fa spesso sentire i ragazzi, di fronte alle sfide della nuova condizione, fragili e con un sentimento di sé insicuro. Per questo motivo essi, difensivamente, possono assumere identità rassicuranti, prese a prestito dalla cultura del momento e dall’ambiente d’origine. La percezione di una società litigiosa e indebolita nei suoi valori, non in grado di assicurare un futuro certo, individualista e poco convincente nella sua capacità di accoglienza dall’altro da sé, pensiero o persona che sia, non favorisce né aiuta la crescita personale dei giovani. In altri termini, viene a mancare uno “Stato virtuoso” in cui identificarsi, esponendo le nuove generazioni al rischio di divenire facili prede di modelli che rispondono al paradigma del primitivo sopra accennato.
Che fare? Possiamo fare qualcosa direttamente quando si tratta di fenomeni di così ampia portata sociale? Un’ipotesi percorribile è realizzare o rinforzare condizioni aggregative per le famiglie e per gli adolescenti: pensiamo alle nuove Realtà di aiuto che il privato sociale ispirato a un metodo psicoanalitico sta già mettendo a disposizione degli adolescenti e delle loro famiglie. I centri di aggregazione giovanile, ad esempio, realizzano molteplici percorsi che vanno dall’aiuto in strada, o in casa con i compiti, fino all’invitare a “venire da noi che si sta bene” e trovare in ambienti protetti la possibilità di giocare, studiare, stare in gruppo misto, e di avere “psi” capaci di coniugare psicoanalisi e aiuto sociale, in grado di portare i ragazzi a lavorare psicoanaliticamente, dal gruppo alle terapie individuali. Tali nuove opportunità di sostegno dovrebbero entrare in un rapporto collaborativo intenso, detto “rete”, con le altre Agenzie e Istituzioni educative e curative dei giovani: la Scuola per prima, e il Servizio sociale, il Tribunale per i minorenni, il Dipartimento Minorile del Ministero della Giustizia, la RAI, le Associazioni per il tempo libero (sport, musica, teatro), quelle cosiddette “laboratoriali” e così via. Tanti punti di vista su una stessa realtà adolescente permettono di meglio inquadrarla ma se i punti poi non convergono ne risulta una condizione ancora più frammentata. La psicoanalisi ha modo di legare le varie articolazioni della proposta di aiuto intorno ai suoi modelli teorici e operativi e gli effetti che essa è in grado di produrre risultano straordinariamente incrementati.
Maggio 2015
Leggi anche
Senza paura, senza pietà. Valutazione e trattamento degli adolescenti antisociali. Recensione di Cristina Saottini
Bullismo: la relazione con la vittima e con gli adulti
Bullismo: la relazione con la vittima e con gli adulti
A cura di Jones De Luca e Galvano Pizzol
Il termine bullismo rimanda a situazioni nelle quali singoli individui o gruppi di individui aggrediscono coscientemente dei compagni con l’intenzione di far male (e ripetutamente). Il bullo imposta una relazione di potere caratterizzata da violenza fisica o da pressione psicologica tale da creare delle vittime predestinate. Il bullismo nasce in particolare in adolescenza, in situazioni in cui gli adulti significativi di riferimento hanno perso qualsiasi autorevolezza e di conseguenza si verifica una pervasiva sfiducia rispetto alla loro capacità di far fronte a tali situazioni. Il fenomeno si manifesta in ambiti di extraterritorialità dall’ autorità scolastica e familiare. In queste nicchie i comportamenti di aggressione possono trovare spazio e possibilità di ripetersi. Si tratta di una forma di sottrazione e misconoscimento dell’autorità che comporta l’instaurarsi di una “sub-cultura” della violenza. Parolacce, prese in giro, spintoni o botte, prevaricazioni e altri comportamenti riprovevoli, possono essere inquadrati nel loro insieme come bullismo, cioè azioni compiute intenzionalmente, ripetute e talora cronicizzate, con la presenza di ruoli definiti di vittime e di carnefici (il bullo il più delle volte si avvale di altri adolescenti quali gregari).
Il potere che sottende alla relazione di dominio-sottomissione determina una violenta asimmetria tra vittima e bullo, con impossibilità di negoziazione e di rispetto reciproco.
Viene meno il legame di fiducia tra adolescente e adolescente e soprattutto tra adolescente ed adulti, siano essi genitori, insegnanti, amministratori o personale ausiliario.
In situazioni di pericolo la fiducia negli adulti e la possibilità di chiedere loro aiuto, è determinante; infatti, di norma, la presenza di un adulto autorevole risolve immediatamente qualsiasi intenzione di bullismo ed è quindi la principale forma di prevenzione.
Va tuttavia sottolineato che il comportamento aggressivo tra adolescenti non sempre può essere definito come bullismo.
Il bullismo, infatti, va distinto dai comportamenti trasgressivi ed antisociali in adolescenza che possono essere inquadrati separatamente e come episodi singoli. In quest’ultimo caso si tratta di angherie, litigi e discussioni tra pari che non creano necessariamente un’ asimmetria nella relazione ed un vuoto di autorevolezza degli adulti; si può trattare di comportamenti legati alla difficoltà di apprendere e/o trovare un ruolo sociale, oppure di un tentativo d’individuare le modalità per prendere le misure tra sé e gli altri in un momento, qual è l’adolescenza, di grandi cambiamenti personali e sociali. In questa prospettiva l’aggressione verbale o anche fisica può essere inquadrata nell’ambito di episodi di conflitto tra coetanei, e quindi solo tra pari.
Quando il comportamento aggressivo è legato all’impulsività tipica della fase adolescenziale non si può dunque parlare di bullismo .
La specificità del bullismo, come abbiamo detto in precedenza, consiste invece in una relazione particolare tra una vittima ed un carnefice. Ciò che in primo luogo unisce la vittima al carnefice è una comune sfiducia nella possibilità degli adulti di capire i loro problemi e comporta di conseguenza un distanziamento da loro.
Il bullo non si fida del genitore perché teme di diventare a sua volta oggetto di derisione o di aggressività verbale o fisica. Rivolgersi al genitore è infatti impossibile in quanto il bullo si aspetta che questi reagisca contro di lui non permettendogli di entrare in contatto con i propri aspetti di vulnerabilità (dei quali non riesce a farsi carico). Egli teme che le sue emozioni creino irritabilità nel genitore più che una vera preoccupazione finalizzata al bisogno di comprendere il senso di azioni che esprimono un grave disagio.
Il bullo manca di “mentalizzazione” cioè di capacità di capire se stessi e gli altri in termini di emozioni, sentimenti e intenzioni.
Durante il trattamento del bullo si può osservare quanto egli sia carente dal punto di vista della capacità di provare empatia.
Anche la vittima non si rivolge al genitore in quanto è animata dall’aspettativa che questi venga ferito dalla sua vulnerabilità (in questo modo oltre ad essere ferito egli stesso finirebbe con il ferire l’oggetto di cui ha bisogno). La ferita narcisistica del genitore potrebbe poi dar luogo ad ulteriori situazioni di umiliazione: se il genitore della vittima si rivolge direttamente al bullo (o ai suoi genitori o alle autorità scolastiche) finisce con lo svilirlo ulteriormente. Ciò confermerebbe nell’adolescente- vittima la sensazione di essere “sbagliato”, che non se la sa cavare da solo e che crea problemi ai genitori in quanto li fa sentire umiliati, feriti e delusi.
Nel colloquio clinico la vittima di prevaricazioni imputa agli adulti in generale disattenzione, incoerenza, incapacità di assumere posizioni chiare e una certa insensibilità ai suoi problemi; mostra una scarsa fiducia in se stesso e un basso livello di assertività.
Il bullo, invece, nel colloquio minimizza i fatti accaduti, ne nega la gravità, ne presenta una percezione distorta (“non è successo niente”). Qualora vengano ammessi e verbalizzati i fatti, il bullo tende a non manifestare le esperienze affettive collegate ad essi. Non mostra sensi di colpa o dispiacere o vergogna. Si accorge del dolore e della sofferenza provocati, e della gravità del proprio comportamento, solo in quanto vede i propri genitori star male. A livello più profondo per il bullo la vittima, attaccata con tanta determinazione, rappresenta la parte debole di sé, intollerabile, da umiliare ed eliminare dal mondo per lasciare il posto all’eroe nato dalle sue ceneri.
Nel rapporto tra bullo e vittima si crea, da parte di quest’ ultima, una situazione d’identificazione con l’aggressore. Cristiano Rocchi sostiene che la vittima, sovrastata da un potere schiacciante e fuori controllo, non attiva una reazione di rifiuto o difesa, ma, soggiogata da una paura impotente, si sottomette alla volontà dell’aggressore. Come unica possibilità di sopravvivenza, la vittima abdica, rinuncia alla propria persona, consegnandosi all’aggressore ed identificandosi esattamente con ciò che egli si aspetta. Tende a sentire da un lato ciò che l’aggressore stesso sente, dall’altro ciò che l’aggressore vuole che la vittima senta. Può arrivare così ad anticiparne le mosse, per minimizzare il danno ed avere maggiori possibilità di sopravvivenza. Si viene a creare nell’adolescente-vittima una personalità “come se”. Questo è ben spiegato da Senise che afferma che “ il “come se” ha sempre una connotazione patologica.
WhatsApp e di You tube sono spesso i contesti dove il bullo può pensare di esaltare il suo operato: il “bullo” ad esempio pubblica su questi “social media” un video registrato con il telefonino, dove vengono esibite le sue gesta, o quelle eseguite dal suo gregario, nei confronti della vittima, cercando una sua ulteriore umiliazione. A volte è proprio il media stesso che viene utilizzato per esercitare il bullismo : serve per escludere, umiliare, ferire ripetutamente una vittima.
I partecipanti al gruppo di WhatsApp (spesso i compagni di classe) o i visitatori di “you tube”, a volte denunciano l’opera agli adulti di riferimento facendo emergere il fenomeno. Gli adulti significativi di riferimento a loro volta fanno entrare in gioco la giustizia minorile: quello che era iniziato come uno “scherzo” per diventare poi un atto di bullismo, ora diventa un “reato” (o più reati allo stesso tempo) quale stalking, lesioni, violazione della privacy, dando luogo all’affermarsi di un iter giudiziario.
E’ in questi casi che si può innescare una ricerca di aiuto, diretta o sollecitata dagli operatori sociali coinvolti. Questa richiesta, se ben accolta e analizzata, può evitare un destino. Una terapia può evitare che ci si avvii ad una carriera psicopatologica. Una terapia efficace richiede anche il coinvolgimento dei genitori, e può far ripartire una genitorialità consapevole in entrambi i soggetti in gioco.
Il coinvolgimento dei mezzi di comunicazione di massa da parte degli adulti interessati (giornali locali o simili) a scopo “educativo” è invece molto pericoloso poiché espone i ragazzi coinvolti ad una situazione di vergogna pubblica intollerabile e senza via d’uscita.
Bibliografia
Fonagy P. e AA. VV. Regolazione affettiva, mentalizzazione e sviluppo del sé. Cortina editore, 2010 Milano.
Nicolò A. M. (a cura di) Adolescenza e violenza Il Pensiero Scientifico editore, 2009 Roma.
Pra Baldi A. Pizzol G. (a cura di) “Indagine sui comportamenti e gli atteggiamenti verso i pari e gli adulti degli studenti di scuola media” Spazio Adolescenti 2006 Ulss 1 Belluno .
giugno 2015
Campo analitico (Modello)

David Hockney, North Yorkshire - 1996
A cura di Fulvio Mazzacane
Le origini del modello di campo si fanno risalire ai contributi di Kurt Lewin (1951) che definisce il campo, in ambito sociale e psicologico, come una totalità dinamica capace di creare all’interno di un gruppo un senso di coesione e appartenenza che si manifesta con l’emergere del sentimento del “noi” ed implica un’identità di gruppo, per cui il cambiamento di uno provoca il cambiamento anche degli altri (Neri, 2011).
Le ricerche sui funzionamenti gruppali di Foulkes (1964) che considera il gruppo un’entità psicologica e di Bion (1961) che studia gli assetti del gruppo di lavoro e in assunto di base, pur non esplicitando la nozione di campo ne costituiscono delle premesse.
Nella stessa direzione va la psicologia dell’uomo “in situazione” di Merlau Ponty (1945), un uomo che comprende i fatti psichici nel contesto di relazioni intersoggettive, in cui i pensieri di due persone sono un frutto comune e la conoscenza dell’altro è un fenomeno di accoppiamento.
Il concetto di campo analitico nasce negli anni sessanta dai lavori di W. e M. Baranger (1961-62), che immaginano la situazione analitica come un campo dinamico tra due persone ineluttabilmente connesse e complementari, per cui nessun membro della coppia può essere capito senza l’altro.
La loro teoria si basa sugli studi di Racker sul controtransfert e sul concetto di identificazione proiettiva della Klein, il campo si struttura con un gioco incrociato di identificazioni proiettive e introiettive, con un analista attento a limitare le proprie contro-identificazioni proiettive.
Nel loro modello un certo grado di impasse è fisiologico, c’è una continua alternanza di momenti di processo e di non processo, un periodico ripresentarsi, per il sommarsi di identificazioni proiettive incrociate, di zone di “resistenza” della coppia che ostacolano il progresso analitico.
Il concetto di “bastione” è rappresentativo degli arresti del processo analitico. Il bastione rimanda ad un settore scisso della vita dell’analizzando che entra bruscamente nel campo dell’analisi, dapprima all’interno di un vissuto catastrofico e, in seguito, come occasione di un profondo arricchimento. Pur sottolineando la certezza sull’origine dei bastioni (il paziente), i Baranger sottolineano un elemento importante, l’inevitabilità della loro irruzione in ogni campo analitico. E’ un concetto collegato alla coazione a ripetere e alla pulsione di morte, che loro considerano analogo alla nevrosi di transfert in una prospettiva bi-personale. Il bastione è il sintomo di una patologia del campo e non del paziente, modellata dalla specificità dell’incontro con l’analista.
L’analista deve lasciarsi inglobare, fino ad un certo punto, in questo gioco. Il momento interpretativo arriverà quando l’attenzione fluttuante, grazie ad una sorta di personale repertorio controtransferale (esperienze corporee, fantasie di movimento, comparsa di certe immagini) lascerà il posto al “secondo sguardo”, consentendo all’analista di interrogarsi sugli avvenimenti del campo.
I Baranger derivano da Pichon Riviere un’idea del percorso analitico come di un processo a spirale in cui l’hic et nunc della seduta è una dimensione ineludibile della realtà analitica.
Quello di campo è un modello volutamente aperto all’incontro con saperi diversi, che naturalmente tende al “meticciato” (Neri, 2011) e nella psicoanalisi italiana è stato introdotto grazie all’opera di Corrao (1986). Nella sua teorizzazione il modello di campo è stato caratterizzato dal fecondo incontro con tre saperi. Il primo è con la teoria delle funzioni di Bion, tale accoppiamento, nel suo sviluppo, consentirà a Ferro di ipotizzare una nosografia del campo analitico (Ferro, 2002). Il secondo è l’incontro con l’ermeneutica, Corrao (1987a) sottolinea l’importanza di considerare gli elementi analitici come risultato di osservazioni espresse da uno specifico punto di vista, non valutabili oggettivamente. I modelli analitici che prediligono l’insaturo per lui si inseriscono in un filone culturale che abbraccia tutti i campi del sapere, risultato di un’evoluzione etica dell’uomo che rinuncia alla sua hybris, alla sua arroganza cognitiva.
Il terzo è l’incontro con la narratologia (Corrao, 1987b). Narrativo per Corrao è uno stile, una delle dimensioni che assume ogni “costruzione di mondo”, che porta lo psicoanalista a immaginare una relazione bi-personale, costruita da due persone in circostanze dialogiche altamente specializzate, con caratteristiche di transitorietà e mutabilità tipiche delle attività narrative. Nella situazione analitica le versioni degli eventi significativi cambiano man mano che il lavoro progredisce e con esse cambia il vissuto degli eventi poiché versioni narrative e vissuti sono inseparabili. Anche le teorie analitiche si costituiscono come narrazioni che non possono mai considerarsi definitive.
Ferro e Bezoari (1992, 1997) hanno affrontato in due lavori importanti nodi del pensiero analitico, che successivamente Ferro svilupperà. Il primo riguarda il concetto di personaggio in seduta, che abbandona lo statuto storico-referenziale per assumere la caratteristica di “aggregato funzionale”, elemento proto-simbolico, frutto dei processi trasformativi della coppia analitica, che consente una visione condivisa di aspetti del campo emotivo non altrimenti rappresentabili: “Aggregati” in quanto sintesi di elementi eterogenei (verbali, emotivi, corporei), “funzionali” perché correlati al funzionamento mentale della coppia e alle necessità emotive del momento.
Collegato a questa prospettiva è il concetto di interpretazione “debole”, “insatura” che sottolinea la natura radicalmente dialogica e intersoggettiva del lavoro interpretativo e apre a sviluppi nella tecnica degli interventi dell’analista e al concetto di co-interpretazione narrativa e di oscillazione tra capacità negativa e fatto prescelto come matrice degli interventi dell’analista (Ferro, 2007).
Il terzo punto riguarda il sogno e sviluppa la prospettiva dei Baranger che parlano di “racconto del sogno”. Sogno che manda un messaggio che attiene alla storia dell’analizzando, al suo mondo interno ma soprattutto alla relazione analitica, che può essere commento agli interventi dell’analista.
Il sogno viene definito come opera narrativa aperta da sviluppare con la costruzione di nuove storie, come una metafora viva in grado di espandere il pensabile e il dicibile con la rinuncia a codici interpretativi forti, in un modello in cui non è centrale la ricostruzione ma l’alfabetizzazione.
Nei suoi lavori successivi Ferro definisce il campo come un luogo/tempo in cui si manifestano le turbolenze emotive attivate dall’incontro analitico, in cui vengono favorite narrazioni che sono il risultato di processi di alfabetizzazione delle proto emozioni della coppia. Attraverso la capacità negativa e l’attivarsi di rêverie, si ricercano situazioni di unisono che aumentano la funzione di contenitore della coppia, e quindi del paziente, e lo sviluppo della funzione alfa.
E’un modello che ridimensiona l’insight, decentra gli aspetti genetici, economici e dinamici e produce una sensazione di spaesamento nell’analista che deve riconoscere ampi margini di incompetenza nel seguire una rotta imprevedibile (Gaburri, 1997).
Vari autori italiani, oltre a quelli citati, hanno sviluppato temi inerenti al campo (Chianese, 1997; Di Chiara, 1997; Riolo, 1997), anche nei suoi aspetti legati al lavoro istituzionale (Correale, 1991).
L’evoluzione più recente del concetto di campo vede la convergenza di più autori su un modello di campo onirico, a partire dal concetto bioniano di pensiero onirico della veglia, che immagina una funzione continua della mente impegnata a trasformare gli stimoli esterni e interni, fisici e mentali in modo da renderli disponibili al pensiero. Campo onirico che si definisce come lo sviluppo delle capacità sognanti del campo che porteranno alla trasformazione e all’introiezione di funzioni (Ferro, 2013). Questa definizione trova consonanza nel concetto, centrale nel pensiero di Grotstein (2007), di “dreaming ensemble”, che così definisce l’insieme di tutte le funzioni sognanti della mente.
Nella teorizzazione di Ogden (1994, 1999), che converge con il modello di campo, la disponibilità come analisti ad essere inconsciamente recettivi a essere usati per svolgere una varietà di ruoli nella vita inconscia dell’analizzando porta a consegnare la propria individualità a un terzo soggetto, il “terzo analitico intersoggettivo”, generato inconsciamente dalla coppia analitica, risultato dello scambio di degli stati di rêverie dell’analista e dell’analizzando, in costante tensione con le loro individualità. Per Ogden ogni sintomo è il frutto di sogni non fatti o interrotti, che portano ad un accumulo di elementi beta, la finalità della cura è quella di riuscire a sognare col paziente i suoi sogni non sognati. Anche attraverso il “talking as dreaming” (Ogden, 2007) che definisce una modalità narrativa che la coppia analitica realizza in seduta in un clima in cui si allude al gioco, alla creatività libera simile all’improvvisazione musicale.
Nello stesso senso va lo strumento tecnico della “trasformazione in sogno” proposto da Ferro (2009, 2013). La seduta analitica è immaginata continuamente immersa in un’atmosfera onirica, un sogno delle menti, l’obiettivo della terapia è lo sviluppo delle capacità sognanti del campo che porteranno a nuove narrazioni e all’introiezione di funzioni.
Bibliografia
Baranger W., Baranger M. (1961-1962), La situazione analitica come campo bi personale, Cortina, Milano 1990.
Bezoari M., Ferro A. (1992), Percorsi bi personali dell’analisi. Dal gioco delle parti alle trasformazioni di coppia, in Nissim Momigliano L., Robutti A. (a cura di), L’esperienza condivisa, Cortina, Milano.
Bezoari M., Ferro A. (1997), Il sogno all’interno di una teoria del campo: aggregati funzionali e narrazioni, in Gaburri E. (a cura di) Emozione e interpretazione, Bollati Boringhieri, Torino.
Bion W.R. (1961), Esperienze nei gruppi, Armando, Roma (1971).
Chianese D. (1997) Costruzioni e campo analitico. Borla, Roma.
Corrao F. (1986), Il concetto di campo come modello teorico, in Orme, vol. II, Cortina, Milano (1998).
Corrao F. (1987a), L’interpretazione psicoanalitica come fondazione di un campo ermeneutico e dei suoi funtori, in Orme, Cortina, Milano (1998).
Corrao F. (1987b), Il narrativo come categoria psicoanalitica, in Orme, Cortina, Milano
Corrao F. (1991), Trasformazioni narrative, in Orme, Cortina, Milano.
Correale A. (1991) Il campo istituzionale. Borla, Roma.
Di Chiara F. (1997) La formazione e le evoluzioni del campo psicoanalitico, in Gaburri E. (a cura di) Emozione e interpretazione, Bollati Boringhieri, Torino.
Ferro A. (2002), Fattori di malattia, fattori di guarigione, Cortina, Milano.
Ferro A. (2007), Evitare le emozioni, vivere le emozioni, Cortina, Milano.
Ferro A. (2009), Transformations in dreaming and characters in the psychoanalytic field. Int.J. Psychoanal. 90:2009-2030
Ferro A. (2013), Modello onirico della mente. In Psicoanalisi Oggi. A cura di A. Ferro. Carocci, Roma
Foulkes S.H. (1964), Psicoanalisi e terapia di gruppo. Boringhieri, Torino (1967).
Gaburri E. (1997), Introduzione. In: Gaburri E. (a cura di) Emozione e interpretazione. Bollati Boringhieri, Torino
Grotstein J. (2007), Un raggio di intensa oscurità. Cortina, Milano
Lewin K. (1951), Teoria e sperimentazione in psicologia. Il Mulino, Bologna (1972).
Merleau Ponty M. (1945), Fenomenologia della percezione. Bompiani, Milano (2003)
Neri C. (2011), La nozione di campo allargato in psicoanalisi. In: Il campo analitico, Ferro A., Basile R. (a cura di), Borla, Roma.
Ogden T.H. (1994), Soggetti dell’analisi, Masson, Milano (1999).
Ogden T.H. (2007), On talking-as-dreaming. Int. J. Psycho-Anal., 88:575-589.
Ogden T.H. (1997), Rêverie e interpretazione. Astrolabio, Roma (1999).
Riolo F. (1997), Il modello di campo in psicoanalisi. In Gaburri E. (a cura di) Emozione e interpretazione. Bollati Boringhieri, Torino
Novembre 2013
Capacità Negativa
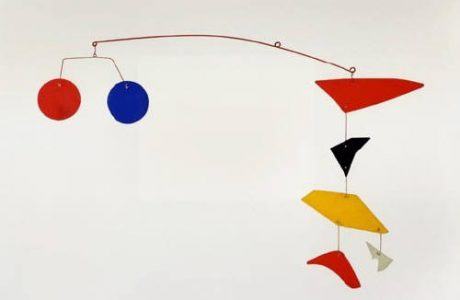
Alexander Calder
A cura di Ersilia Cassani
Capacità Negativa (Negative Capability) è un concetto di tecnica psicoanalitica usato da Bion per riferirsi allo stato mentale che lo psicoanalista dovrebbe raggiungere per venire in contatto con la verità emotiva sconosciuta (che Bion chiama O) di quel momento – unico punto importante della seduta – e comunicarla al paziente con l’interpretazione.
L’analista deve stare in attesa senza dire né fare nulla. Non si tratta di un’attesa carica di aspettative, né semplicemente passiva: è un’attesa ricettiva ai diversi livelli di comunicazione, verbali e non verbali, consci ed inconsci, del paziente e personali; su questi l’analista compie un lavoro psicologico inconscio, chiamato anche il lavoro del sogno della veglia, il quale dà segno di sé attraverso le sue reverie e la sua intuizione della esperienza emotiva del momento.
Con un linguaggio chiaro ed insolitamente prescrittivo Bion esorta l’analista ad ascoltare il paziente per il tempo necessario ad intuire l’esperienza emotiva informe, tollerando di rimanere nel dubbio e nell’ansia, senza affrettarsi a trovare spiegazioni razionali e senza aggrapparsi al già noto sul paziente e sulle teorie.Cioè l’analista deve rinunciare alla memoria, al desiderio e alla comprensione razionale.
La razionalità, la memoria, e il desiderio sono strumenti psichici più adatti a conoscere la realtà esterna percepita; le emozioni sconosciute si colgono, invece, attraverso l’intuizione e la reverie, nel dialogo tra la coscienza e l’inconscio. Pertanto, se la razionalità, qualità della coscienza, è usata in modo esclusivo, il lavoro psichico inconscio è ostacolato. Per quanto riguarda la memoria, Bion distingue la memoria evocata – che affiora per intuizione o per associazione nell’ascoltare il paziente in seduta – dal tentativo deliberato e cosciente di richiamare i ricordi di sedute precedenti o di frammenti di teorie. La prima è un derivato cosciente del lavoro psichico inconscio compiuto in quel momento; il secondo ostacola la ricettività inconscia dell’analista all’inconscio del paziente (in termini bioniani limita lo sviluppo della funzione barriera contatto intersoggettiva) e può favorire la stasi della seduta. Ascoltare il paziente ogni volta come se fosse un nuovo paziente può, inoltre, acuire la sensibilità dell’analista alle piccole variazioni di un contenuto o di un modo di esprimerlo apparentemente sempre uguale. Bion invita l’analista ad interrogarsi sui suoi desideri in seduta: per esempio curare il paziente, concludere la seduta, trovare una nuova teoria che spieghi quanto sta avvenendo, eccetera. I desideri dell’analista possono interferire con la sua visione del paziente (rendendola confusa), determinare interpretazioni fuori bersaglio e contribuire a rendere le sedute sempre più vuote e all’impasse.
Un altro modo di definire la capacità negativa è l’indicazione bioniana di avvolgere la verità emotiva sconosciuta con un raggio di intensa oscurità.
Il rispetto di queste raccomandazioni è difficile: il contatto con l’esperienza emotiva informe è motivo di angoscia, lo psicoanalista è parassitato da emozioni che il paziente non vuole vivere e che a volte anche l’analista vorrebbe evitare. È dunque forte la tentazione di illuminare ciò che è oscuro con ciò che si conosce, l’illuminazione però, mette fuori uso l’intuito.
Quanto detto potrebbe far pensare che la capacità negativa sia uno stato mentale impossibile da raggiungere o posseduto solo da individui eccezionali. Si tratta, invece, di una potenzialità della mente (il termine inglese ha questa sfumatura di significato che si perde in italiano), che può essere sviluppata negli anni attraverso l’analisi personale e la disciplina. Queste non eliminano l’angoscia, la rendono più tollerabile, perché permettono allo psicoanalista di sviluppare la fiducia nel metodo prescritto.
Il concetto di capacità negativa interseca altri concetti bioniani, sia precedenti sia della successiva evoluzione del suo pensiero.
Un accenno all’origine del termine permette di mettere meglio a fuoco la relazione tra la capacità negativa e l’interpretazione intuita o sognata.
Bion cita un brano di una lettera del poeta John Keats (1817) ai fratelli. In questo, la capacità negativa è definita la qualità dell’artista creativo, posseduta in massimo grado da Shakespeare. Il Bardo è capace di parlare ai lettori e agli spettatori in modo da portarli a sperimentare emozioni, fantasie, tensioni in presa diretta, perché egli stesso è stato in contatto con questi stati d’animo e sentimenti anche molto contraddittori, senza sottoporli ad un giudizio morale, e li ha lasciati evolvere. Per Bion anche lo psicoanalista deve venire in contatto con le emozioni sconosciute, senza interferire con la mobilità della mente vivente (come fa il bambino che osserva le sculture mobili di Calder), per riuscire a parlare al paziente (interpretare) con parole che non spiegano l’emozione, ma permettono al paziente di viverla e conoscerla. Il linguaggio dell’analista che nasce dalla sua esperienza dell’emozione è chiamato linguaggio dell’effettività, il linguaggio efficace.
La relazione tra la capacità negativa e l’interpretazione è descritta anche dalla oscillazione tra la capacità negativa ed il fatto scelto della comunicazione del paziente, che è l’elemento invariante tra i diversi contenuti verbali e non verbali del paziente che dà loro coerenza. La capacità negativa permette di reperire intuitivamente il fatto scelto e di dare una forma comunicabile all’esperienza emotiva del momento. La relazione tra capacità negativa e fatto scelto è dialettica: ognuno dei due concetti nega l’altro e gli dà senso, l’uno non può esistere senza l’altro (nel filmato proposto la relazione è rappresentata dal bambino che osserva le sculture mobili e dall’artista che le crea). Nella stanza di analisi, se l’analista, dopo diverse sedute, non giungesse a reperire il fatto scelto, la sua attesa sarebbe espressione di un mal funzionamento della capacità di sognare le emozioni presenti. Se, invece, l’analista intervenisse di continuo, probabilmente starebbe cercando di arginare l’angoscia di non sapere e di limitare la possibilità del paziente di associare liberamente.
Da quanto detto finora la capacità negativa interseca le trasformazioni di O e K. Bion, come ho già detto, indica con il segno O l’emozione sconosciuta del momento e con la lettera K il legame di conoscenza con l’emozione sconosciuta. L’esercizio della capacità negativa permette all’analista di sperimentare O fino a quando per intuizione riesce a dargli una forma. Quando l’analista interpreta con il linguaggio dell’effettività fa, non solo conoscere, ma anche vivere al paziente l’emozione, ovvero cerca di aiutarlo a compiere la trasformazione da K ad O, da un legame di curiosità con l’emozione sconosciuta ad essere quella emozione o quella fantasia.
La capacità negativa dell’analista incontra il concetto di at-one-ment, la sintonizzazione con l’emozione sconosciuta del paziente (la sua O). Questa sintonizzazione con O sta alla base di ogni conoscenza, anche delle scoperte scientifiche.
Il suggerimento di Bion all’analista di decentrarsi dal proprio pensiero cosciente (rinunciando a memoria, desiderio e comprensione) e porsi in una condizione di tolleranza e ricettività alle produzioni dell’altro ed alle proprie, consce ed inconsce, corporee e psichiche, pone lo psicoanalista in transito tra sé e l’altro; si potrebbe dire che Bion adombri l’esortazione all’analista di attraversare la cesura. Il concetto di Capacità Negativa pone dunque le premesse alle riflessioni post-bioniane sullo spazio intersoggettivo e sul campo bipersonale come luogo mentale in cui si trova l’analista che esercita la capacità negativa e dal quale comunica.
Bibliografia
Aguayo J (2013), Bion’s ‘Notes on Memory and Desire’—Between Text and Lecture, IPA Congress, Prague
Bion W (1967), Notes On Memory And Desire, Psychoan Forum, Vol 2, N. 3
Bion W (1967a), Wilfred Bion’s Los Angeles Seminars. Lectures given at the Los Angeles Psychoanalytic Institute, April, 1967. (Forthcoming: Aguayo, J. and Malin, B. (eds.). Karnac Books.
Bion W (1970), Attenzione ed Interpretazione, trad it. Armando, Roma, 1973
Grinberg L, Sor D, Tabak de Bianchedi E (1991), Introduzione al pensiero di Bion, trad it. Raffaello Cortina, Milano, 1993
Neri C (2009), La capacità negativa dello psicoterapeuta come sostegno al pensiero di gruppo, Rivista Italiana Di Gruppoanalisi, vol. 22; p. 159-175, ISSN: 1721-6664
Matter R (1950), “Works of Calder”, www.youtube.com
Syminghton J, Syminghton N (1996), The Clinical Thinking Of Wilfred Bion, Routledge London
Dicembre 2015
Carloni Glauco
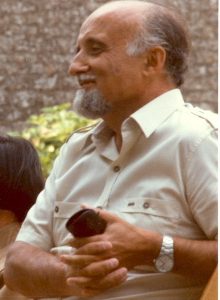
Glauco Carloni
Maestri della psicoanalisi
A cura di Laura Ravaioli
Carloni, Glauco (Cingoli, 1926- Bologna, 2000)
Psichiatra e psicoanalista, uomo di vasti interessi ed intellettuale attivo su più fronti: conferenziere, docente, pubblicista, viaggiatore, cinefilo, direttore editoriale, critico, polemista, rappresentante istituzionale. Ha introdotto in Italia il pensiero di Sandor Ferenczi curandone l’edizione italiana delle Opere, ma anche il pensiero di altri autori tra cui Michael Balint, Marie Bonaparte, Geza Roheim.
E’ stato Presidente della Società Psicoanalitica Italiana ed ha fondato con Egon Molinari il Centro Psicoanalitico di Bologna.
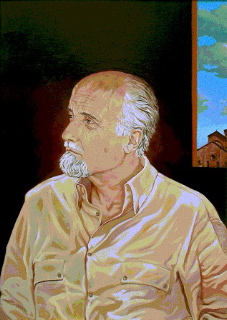
Ritratto ad opera di Leandro Cutti
La vita.
Glauco Carloni è nato a Cingoli, in provincia di Macerata, il 23 luglio 1926. Trascorse qui l’infanzia e l’adolescenza e si trasferì a Bologna per gli studi liceali. Si iscrisse alla Facoltà di Medicina e si laureò all’Università di Bologna nel 1950, specializzandosi in Clinica delle malattie nervose e mentali, ma predilesse la psichiatria e la formazione psicoanalitica alla neurochirurgia.
Lavorò all’Ospedale psichiatrico “Lolli” di Imola e successivamente all’Ospedale “Roncati” di Bologna, qui come Primario della Sezione femminile, e divenne uno dei capiscuola di una psichiatria coscienziosa, empatica e responsabile, che si distinse sia dalla psichiatria classica che dall’antipsichiatria basagliana.
Fu Professore all’Università di Trento negli anni Settanta e poi a Bologna presso le Facoltà di Magistero e Scienze della Formazione; divenne Professore associato di psicologia dinamica all’Università di Bologna, nonché Fondatore e Presidente del Centro Psicoanalitico di Bologna.
Nel panorama psicoanalitico istituzionale ha assunto il ruolo di Presidente della Società Psicoanalitica Italiana dal 1982 al 1986, di Vicepresidente dal 1977 al 1982 e di Tesoriere dal 1969 al 1977 (due esecutivi).
Morì a Bologna il 16 giugno 2000.

Glauco Carloni ed Egon Molinari (1963)

Glauco Carloni, Luciana Nissim (settembre 1985)
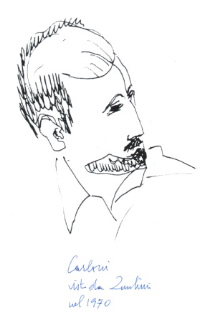
“Carloni visto da Zucchini” ad opera di Gino Zucchini

Egon Molinari, Alberto Spadoni, Glauco Carloni (giugno 1991)
 .
.
Giovanni Hautmann, Pier Mario Masciangelo, Egon Molinari, Glauco Carloni (giugno 1991)
Il contributo alla psicoanalisi
Glauco Carloni ha assunto un ruolo centrale nella diffusione della cultura psicoanalitica in Italia. Oltre ad avere avuto il grande merito di aver fatto conoscere al pubblico italiano e agli addetti ai lavori autori ancora poco conosciuti in Italia come Balint, Rank, Roheim, Jones, Lewin, Bonaparte, Salomè e molti altri, ha soprattutto per primo diffuso e valorizzato qui da noi l’opera di Sandor Ferenczi, di cui ha curato insieme ad Egon Molinari la traduzione e l’edizione dei Fondamenti di Psicoanalisi, riportando le sue preziose intuizioni, arricchite da contributi del tutto personali (vedi “Tatto, contatto e tattica” e “Lo stile materno”), nel suo insegnamento e nella pratica clinica tanto da improntarne tutta la “scuola” bolognese. Nella sua attività di psicoanalista di training ha inoltre approfondito con numerosi lavori il tema della crescita dell’ identità psicoanalitica (“Identità personale e professionale dello psicoanalista”) e della vocazione terapeutica con le sue motivazioni patologiche, che rendono ineludibile la necessità di sottoporsi ad un’ analisi personale (vedi “Sofferenza psichica e vocazione terapeutica”). Attento osservatore dei disagi della società moderna, ne fornì una chiave di lettura psicoanalitica profonda attraverso un linguaggio accessibile e diretto (La mamma cattiva, scritto con Daniela Nobili).
Si occupò di moltissimi argomenti “di confine” tra la psicoanalisi e le altre scienze o produzioni artistiche (fiaba, letteratura, cinema, teatro); tra le sue moltissime iniziative vi sono l’organizzazione di numerose collaborazioni e seminari, anche internazionali, il primo “cineforum psicoanalitico” stabile a Bologna e la creazione del terzo polo formativo in Italia: la Sezione Veneto-Emiliana.

Glauco Carloni
Psychiatrist, psychoanalyst, man of broad interests and intellectual active on several fronts: lecturer, professor, journalist, traveler, cinephile, editor, critic, polemicist, institutional representative. He introduced in Italy Sandor Ferenczi’s thought, editing the Italian version of his Works, but he also introduced the thought of other authors including Michael Balint, Marie Bonaparte, Geza Roheim.
He was President of the Italian Psychoanalytic Society and he founded with Egon Molinari the Psychoanalytic Center of Bologna.
Life.
Glauco Carloni was born in Cingoli, in the province of Macerata, on July 23, 1926. Here he spent his childhood and adolescence and moved to Bologna for his high school studies. He enrolled at the Faculty of Medicine and graduated from the University of Bologna in 1950, specializing in Clinic of Nervous and Mental Diseases, but he preferred Psychiatry and the psychoanalytic training to Neurosurgery.
He worked at the Psychiatric Hospital “Lolli” in Imola and later in the Hospital “Roncati” in Bologna, here as Head of the Women’s Section, and became one of the leaders of a new model in Psychiatry: conscientious, empathic and responsible, different from the classical psychiatry as from the “anti-psychiatry” model of Basaglia.
He was Professor at the University of Trento in the Seventies, and then in Bologna at the Faculty of Education and Science Education; became Associate Professor of Dynamic Psychology at the University of Bologna as well as Founder and President of the Psychoanalytic Center of Bologna.
Inside the psychoanalytic institutions, he assumed the role of President of the Italian Psychoanalytic Society from 1982 to 1986, Vice President from 1977 to 1982 and Treasurer from 1969 to 1977 (Two executives). He died in Bologna on 16 June 2000.
The contribution to psychoanalysis.
Glauco Carloni has assumed a central role in the spread of psychoanalytic culture in Italy. In addition to the great merit of having made known to the Italian public and to professionals authors little known in Italy as Balint, Rank, Roheim, Jones, Lewin, Bonaparte, Salomé and many others, he edited, together with Egon Molinari, the first italian translation of the work of Sandor Ferenczi Foundations of Psychoanalysis, bringing his valuable insights and enriching them with his personal contributions (see “Tatto, contatto e tattica” and “Lo stile materno”), in his teaching and clinical practice so to influence the whole “school” in Bologna. In his work as a Training Psychoanalyst he has also deepened with numerous works on the subject of growth of the ‘psychoanalytic identity (“Identità personale e professionale dello psicoanalista”) and therapeutic vocation, with its pathological motivations that make inevitable the need to undergo a personal analysis (see “Sofferenza psichica e vocazione terapeutica”).
Careful observer of the discomforts of modern society, he provided a key to understand it psychoanalytically through an accessible and immediate language (La mamma cattiva written with Daniela Nobili).
He dealt with many topics considered “borderline” between psychoanalysis and other sciences or artistic productions (fairy tale, literature, cinema, theater). He organized many collaborations and seminars, also international, the first ” Psychoanalytic Film Club” in Bologna. Moreover, he created the third training center in Italy, the Section Veneto- Emiliana.
Cronologia degli scritti
1.Carloni G., 1958. Contributo allo studio dell’alcoolismo. Rivista di Neuropsichiatria e Scienze Affini, 4: 47-67.
2.Carloni G., Spadoni A., 1959. Dell’opportunità di conservare e limitare l’uso del termine “schizomania”. Rivista Sperimentale di Freniatria, 83(3): 1070-1078.
3.Bosinelli M., Carloni G., 1960. I concetti di ansia e di angoscia. Criteri e limiti per una distinzione. Monografia di 249 pp. Supplemento alla Rivista Sperimentale di Freniatria, 84(5). Reggio Emilia, AGE.
4.Carloni G., Spadoni A., 1960. Tre anni di esperienze cliniche sull’impiego dell’iproniazide in sindromi depressive. Riv. Neuropsichiatria e scienze affini, anno VI, 2.
5.Carloni G., 1963. Traduzione di: Parin P., Morgenthaler F. e Parin-Matthèy G., Il complesso edipico nei Dogon dell’Africa Occidentale. Rivista di Psicoanalisi, 9: 143-150.
6.Carloni G., 1963. La fiaba al lume della psicoanalisi. Rivista di Psicoanalisi, 9: 169-186.
7.Carloni G., Di Giorgio A., Gozzi M.T., Vanzelli U., 1965. Bonifica dell’ambiente familiare in situazioni di disadattamento. La psicoterapia di gruppo alle madri di preadolescenti nevrotici. Rivista Italiana di Sicurezza Sociale, 3: 282-286.
8.Carloni G., 1965. Recensione a: G. Abraham, Psychodynamique essentielle, normale et pathologique. Parigi, Doin, 1964. Rivista Sperimentale di Freniatria, 83.
9.Carloni G., Spadoni M.G., 1965. Può l’assistente sociale svolgere un lavoro psicoterapico in ospedale psichiatrico? Istituto Italiano di Medicina Sociale, Roma.
10.Carloni G., Spadoni M.G., 1966. Psychothérapie de groupe de psychotiques à l’intérieur d’un hôpital psychiatrique. L’information Psychiatrique, 42: 235-240. (Traduzione francese di Carloni G. & Spadoni M.G., 1965).
11.Carloni G., 1967. I mostri delle fiabe. Atlante, 7: 70-77.
12.Balloni A., Carloni G., Montanini-Manfredi M., 1968. Considerazioni sui comportamenti sessuali devianti nella dissocialità minorile. Il Lavoro Neuropsichiatrico, 44: 1-4.
13.Carloni G., 1968. Motivazioni e meccanismi di adattamento. Assistenza Psichiatrica e Vita Sociale, 4: 9-25.
14.Carloni G., 1968. Erotomania, suicidio e riparazione. Rivista di Psicoanalisi, 14: 133-153.
15.Carloni G., 1968. Ernst Kris: Ricerche psicoanalitiche sull’arte, Einaudi, Torino, 1967. Il Verri, 28: 105-108.
16.Carloni G., 1968. Rivalutazione psicoanalitica della fiaba. Contributi dell’Istituto di Psicologia dell’Università di Bologna, pp.1-12.
17.Carloni G., 1968. Indagine sul gradimento dei più popolari tipi di fiaba e interpretazione di una singolare censura. Aggiornamenti di Psicologia dell’Istituto di Psicologia dell’Università di Bologna, pp.1-19.
18.Carloni G., 1968. Biancaneve e Rosaspina. Il motivo della catatonia nella fiaba. Aggiornamenti di Psicologia dell’Istituto di Psicologia dell’Università di Bologna, pp.1-24.
19.Carloni G., Spadoni A., Zucchini G., 1968. Su un’esperienza di psicoterapia con psicotici all’interno dell’ospedale psichiatrico. Rivista di Neuropsichiatria e Scienze Affini, 14: 303-326.
20.Campiani C., Carloni G., Pasquali L., Pasquali M., Spadoni M.G., Volterra V., 1970. Condizioni esistenti per lo svolgimento di un’attività psicoterapica nelle istituzioni psichiatriche. Rivista di Psichiatria, 5: 1-12.
21.Carloni G., 1971. Introduzione e cura di: M. Bonaparte, Psicoanalisi e antropologia, Guaraldi, Firenze.
22.Carloni G., Nobili D., 1971. Le condotte perverse come espressione di una condizione confusionale. Rivista Sperimentale di Freniatria, 95: 3-17.
23.Carloni G., 1972. Introduzione a: G. Róheim, Gli eterni del sogno, Guaraldi, Firenze, pp.11-21.
24.Carloni G., 1972. Sole, fiabe e Freud. In tema di, febbraio: 10-13.
25.Carloni G., 1972. Fiaba come sonnifero. In tema di, settembre: 14-17.
26.Carloni G., Molinari E., 1972. Introduzione e cura di: S. Ferenczi, Fondamenti di psicoanalisi, vol. I, Le parole oscene e altri saggi, Guaraldi, Firenze, pp.7-13.
27.Carloni G., Nobili D., 1972. Il Figlicidio. Parte I. Rivista Sperimentale di Freniatria, 96: 1093-1131.
28.Carloni G., Nobili D., 1972. Il Figlicidio. Parte II. Rivista Sperimentale di Freniatria, 96: 1337-1380.
29.Carloni G., Nobili D., 1972. Il Figlicidio. Parte III. Rivista Sperimentale di Freniatria, 96: 1593-1612.
30.Carloni G., 1973. Introduzione e cura di: G. Róheim, Le porte del sogno. Il ventre materno, Guaraldi, Firenze, pp.7-10.
31.Carloni G., 1973. La sana criminalità infantile. In: S. Manes, Racconti della Rustica. Guaraldi, Firenze.
32.Carloni G., 1973. Introduzione e cura di: G. Róheim, Le porte del sogno. La discesa agl’inferi, Guaraldi, Firenze, pp.3-4.
33.Carloni G., 1973. Introduzione e cura di: S. Ferenczi, Fondamenti di psicoanalisi, vol. II, Scritti sulla terapia attiva, Guaraldi, Firenze, pp.11-15. (In collaborazione con E. Molinari)
34.Carloni G., Molinari E., 1973. Introduzione e cura di: S. Ferenczi, Fondamenti di psicoanalisi, vol. III, Psicoanalisi delle abitudini sessuali e altri saggi, Guaraldi, Firenze, pp.11-15.
35.Carloni G., 1974. Introduzione e cura di: G. Róheim, L’enigma della sfinge, Guaraldi, Firenze, pp.7-11.
36.Carloni G., 1974. Introduzione e cura di: S. Ferenczi, Fondamenti di psicoanalisi, vol. IV, Articoli commemorativi, recensioni e presentazioni, Guaraldi, Firenze, pp.7-8.
37.Carloni G., Molinari E., 1975. Cura di: S. Ferenczi, Fondamenti di psicoanalisi, vol. V, Indice analitico, Guaraldi, Firenze.
38.Carloni G., Nobili D., 1975. La mamma cattiva. Guaraldi, Firenze, 208 pagg.
39.Carloni G., Nobili D., 1975. Madri cattive e cattive madri. Rivista Sperimentale di Freniatria, 99: 3-39.
40.Carloni G., 1976. Le nevrosi. In: L. Visconti, Professore sono malato?, I Quaderni del Carlino, pp.70-76.
41.Carloni G., 1976. Profumi e psicologia. Imagine, 2: 22-25.
42.Carloni G., 1976. Introduzione a: Mussolini contro Freud, a cura di P. Meldini, pp. 7-12. Guaraldi, Firenze.
43.Carloni G., 1976. Intervento al panel: L’aborto come vissuto nella realtà psichica e nel mondo esterno. Rivista di Psicoanalisi, 22: 291-294.
44.Carloni G., 1977. Psicoanalisi di sinistra e sinistra della psicoanalisi. Psicologia contemporanea, 4: 50-51.
45.Carloni G., 1977. Madre e figlio. In: Psicosomatica, il medico e la donna, a cura di R. Speziale Bagliacca, pp. 41-66. Serono Symposia, Genova, Rivarolo.
46.Carloni G., 1977. L’invidia per lo psicoanalista nelle istituzioni. In: Psicoanalisi e istituzioni, Atti del Convegno internazionale tenuto all’Università di Milano, 30 ottobre–1 novembre 1976, a cura di F. Fornari, pp.83-88. Le Monnier, Firenze.
47.Carloni G., Nobili D., 1977. La mauvaise mère. Payot, Paris. Prima delle due edizioni della traduzione francese di “La mamma cattiva”.
48.Carloni G., 1978. Il trattamento sanitario obbligatorio è sostanzialmente più illiberale della precedente coazione per pericolosità. I Martedì, 5: 13-14 e 23-24.
49.Carloni G., 1978. In memoria di Fabio Zambonelli. Rivista di Psicoanalisi, 24: 179-180.
50.Carloni G., 1979. La malattia mentale esiste. (Intervista di C. Bianchi.) Bologna incontri, 10(2): 16-20.
51.Carloni G., 1980. Introduzione a: G. Trombi, Psicoanalisi e comportamento criminale, Patron, Bologna.
52.Carloni G., 1981. Identità personale e professionale dello psicoanalista. Rivista di Psicoanalisi, 27: 123-126.
53.Carloni G., 1981. L’identità professionale dello psicoanalista. Rivista di Psicoanalisi, 27: 154-164.
54.Carloni G., 1981. Introduzione a: G. Fara e P. Cundo, Psicoanalisi, romanzo borghese, Martinelli, Firenze.
55.Carloni G., 1981. Aspetti psicologici e psicoanalitici dei racconti di fiabe. Quaderni di Libri e Riviste d’Italia, 15: 15-54.
56.Carloni G., 1982. Sofferenza psichica e vocazione terapeutica. In: Itinerari della psicoanalisi, a cura di G. Di Chiara, pp.13-48, Loescher, Torino.
57.Carloni G., 1982. L’identità dello psichiatra. Recenti progressi in Medicina, 72: 558-561.
58.Carloni G., 1982. Lo spazio della psicoterapia e il posto degli psicoterapeuti. Giornale Italiano di Psicologia, 98: 191-195.
59.Carloni G., 1982. Evoluzione del concetto di malattia mentale e i suoi risvolti in riferimento alla legge 180. Tavola Rotonda, Roma, 1982. Atti e Memorie dell’Accademia di Storia dell’Arte sanitaria, 1: 38-42.
60.Carloni G., 1982. Il concetto di abuso. In: Abusi e violenze all’infanzia, a cura di V. Caffo, pp. 107-111 e 119-120. Unicopli, Milano.
61.Carloni G., 1982. Prefazione a: F. Giberti, L’identità dello psichiatra. Problemi e prospettive. Il Pensiero Scientifico, Roma.
62.Carloni G., 1983. Con Melanie Klein e Anna Freud. Rivista di Psicoanalisi, 29(4): 429-434.
63.Carloni G., 1983. Siamo tornati al medioevo: accattonaggio per gli psicotici tranquilli, galera per gli agitati, suicidio per i disperati. Provincia (mensile dell’Amministrazione Provinciale di Bologna), 12(3): 14-15.
64.Carloni G., 1983. Il gioco dello psicoanalista. I Martedì, 7(3): 27-30.
65.Carloni G., 1984. Follia di sempre e pregiudizi nuovi. I Martedì, 8(9-10): 22-23.
66.Carloni G., 1984.Il trauma della nascita e la nascita di una rivista. Rivista di Psicoanalisi, 30(4): 494-508.
67.Carloni G., 1984. La depressione come sofferenza psichica fondamentale. In: Medicina psicosomatica e depressione: Nuove Diagnostiche, a cura di G. Trombini, pp. 55-64, Patron, Bologna.
68.Carloni G., 1984. La divergenza nell’ortodossia: Sándor Ferenczi e la sua Scuola. Il Piccolo Hans, 44: 121-133.
69.Carloni G., 1984. Otto Rank a sessant’anni dal “Trauma della nascita”. In: Il trauma della nascita e la nascita del trauma, a cura di E. Orlandelli et al., pp. 152-155, IES Mercury, Roma.
70.Carloni G., 1984. L’inflazione delle psicoterapie. Crescita, 11: 38-41.
71.Carloni G., 1984. Il gioco dello psicoterapeuta. In: Psicologia, Psicoanalisi e Istituti Socio-Sanitari, a cura di G. Pagliaro, pp. 189-194, Cluep, Padova.
72.Carloni G., 1984. Tatto, contatto e tattica. Rivista di Psicoanalisi, 30: 191-205.
73.Carloni G., 1984. Editoriale. Rivista di Psicoanalisi, 30: 491-493.
74.Carloni G., 1984. L’ultima Bonaparte di Celia Bertin. Rivista di Psicoanalisi, 30: 637-642.
75.Carloni G., 1985. Il sogno. In: Dieci psicoanalisti spiegano i temi centrali della vita, a cura di S. Rossini, pp. 127-150, Rizzoli, Milano.
76.Carloni G., 1985. Alla ricerca della chiarezza. I Martedì, 9(5): 19-20.
77.Carloni G., 1985. Franco Fornari 1921-1985. Rivista di Psicoanalisi, 31: 595-597.
78.Carloni G., 1985. La fuga dalla realtà. I Martedì, 9(5): 48-50.
79.Carloni G., 1985. Miopia e lungimiranza. In: Alla fine del buio, a cura di F. Verzella, pp. 51-55, Sugarco, Milano.
80.Carloni G., 1985. Il Laboratorio Psicoanalitico. Atti del Corso di aggiornamento clinico terapeutico 1984-85 per i medici di medicina generale e periatria, suppl. n.13(4). Bollettino Notiziario dell’Ordine dei Medici della Provincia di Bologna, 19: 85-87.
81.Carloni G., 1985. L’ansia come freno e come stimolo alla creatività. In: Psicologia e creatività, AA.VV., pp. 156-164, Selezione dal Reader’s Digest, Milano. (con dibattito pp. 170-173, Raccolta degli atti, convegno del 6 Febbraio 1985, MI)
82.Carloni G., 1985. Introduzione a: Psicosi e Arte. In: Atti del Convegno “Le psicosi e la Maschera”, a cura di E. Orlandelli, pp.120-121, IES Mercury, Roma.
83.Carloni G., 1985. Cinema e psicoanalisi. Cineteca, Perizoma, 3 maggio.
84.Bertini M., Cancrini L., Carloni G., Ossicini A., 1986. Psicoterapia la legge difficile. Tavola rotonda. Rinascita, 43, 15 (19 aprile): 12-14.
85.Carloni G., 1986. Le responsabilità di uno psicoanalista. Psicologia Clinica, 4: 115-121.
86.Carloni G., 1986. Gattini ciechi. Giornale Italiano di Psicologia, 13(3): 343-348.
87.Carloni G., 1986. Le nostalgie di Freud. Il Piccolo Hans, 50: 51-58.
88.Carloni G., 1986. Prefazione a: A. Freud, Conferenze per insegnanti e genitori. Boringhieri, Torino.
89.Carloni G., 1986. Presentazione di: M. Spira, Creatività e libertà psichica, Borla, Roma.
90.Carloni G., 1986. Cinema e psicoanalisi: 2° incontro. Cineteca, Bologna, 2: 3.
91.Carloni G., 1986. Alle sorgenti della creatività e della sterilità. In: La Sterilizzazione Volontaria. Atti del Congresso Internazionale sulla sterilizzazione, a cura di F. Bottiglioni e E. Guerresi, pp. 167-174, Monduzzi, Bologna.
92.Carloni G., 1987. La psicoanalisi torna a Trieste. In: La cultura psicoanalitica, a cura di A.M. Accerboni, pp. 11-21, Studio Tesi, Pordenone.
93.Carloni G., 1987. Mistero, magia e meraviglia. In: La cultura psicoanalitica, a cura di A.M. Accerboni, pp. 735-746, Studio Tesi, Pordenone.
94.Carloni G., 1987. La fiaba nella psicoanalisi, la psicoanalisi nella fiaba. In: Psicoanalisi e narrazione, a cura di E. Morpurgo, pp. 23-32, Il Lavoro Editoriale, Ancona.
95.Carloni G., 1988. Psicoanalisi. In: Quale psicoterapia?, a cura di S. Marhaba e M. Armezzani, pp.85-91, Liviana, Padova.
96.Carloni G., 1988. La psicoanalisi del cambiamento. In: Psicoterapia psicoanalitica, a cura di A. Arena e M. Casonato, pp. 29-44, Comune di Massa, Carrara.
97.Carloni G., 1988. La scuola ungherese. Un profilo storico-critico. In. Trattato di Psicoanalisi, Vol.1, a cura di A.A. Semi, pp.147-174 e 210-212, Cortina, Milano.
98.Carloni G., 1988. Presentazione e cura di: S. Ferenczi, Diario Clinico, Cortina, Milano.
99.Carloni G., 1988. History of the Italian Psychoanalytical Society. (I parte) News Letter, International Psychoanalytical Association, 20(3): 5-6.
100.Carloni G., 1988. Presentazione a: A.M. Accerboni, La Cultura Psicoanalitica. Rassegna di Psicologia, 5(3): 61-63.
101.Carloni G., 1989. Continuation of the History of the Italian Psychoanalytical Society. (2°parte) News Letter, International Psychoanalytical Association, 21(1): 3-4.
102.Carloni G., 1989. Dal restauro medicale alla ricreazione psicoanalitica. Il Piccolo Hans, 61: 47-63.
103.Carloni G., 1989. Tra memoria e desiderio. In: 20 anni al cinema d’essai, a cura di P. Bonfiglioli, p.24, Grafis, Bologna.
104.Carloni G., 1989. Freud e Mussolini. In: L’Italia nella psicoanalisi, a cura di A. Novelletto, pp.51-60, Enciclopedia Italiana, Roma.
105.Carloni G., 1989. Prefazione a: S. Ferenczi, Opere Vol. I, Cortina, Milano.
106.Carloni G., 1989. Nostalgia e necrofilia. In: La donna e la psicoanalisi, a cura di A.M. Accerboni, pp. 53-68, Rebellato, Treviso.
107.Carloni G., 1989. Fiabe. In: Trattato Enciclopedico di Psicologia dell’Età Evolutiva, Vol. II, Tomo I, a cura di M.W. Battacchi, pp. 535-546, Piccin Nuova Libraria, Padova.
108.Carloni G., 1989. Sessuali (Concezioni). In: Trattato Enciclopedico di Psicologia dell’Età Evolutiva, Vol. II, Tomo II, a cura di M.W. Battacchi, pp.1297-1305, Piccin Nuova Libraria, Padova.
109.Carloni G., 1989. Tragitti della nostalgia. In: Nostalgia, a cura di S. Vecchio, pp.119-130, Pier Luigi Lubrina, Bergamo.
110.Carloni G., 1990. Prefazione a: L. Pavan, Psicoanalisi, Medicina, Psichiatria: quale relazione?, Cortina, Milano.
111.Carloni G., 1990. Prefazione all’edizione italiana di: A. Haynal, Freud, Ferenczi, Balint e la questione della tecnica, Centro Scientifico Torinese, Torino.
112.Carloni G., 1990. Il dono dell’Hilara. In: Il simbolo, a cura di A. Racalbuto e M.R. De Zordo, pp. 91-98, Pier Luigi Lubrina, Bergamo.
113.Carloni G., 1990. Quel sesso così facile. I Martedì, 14(84): 21-23.
114.Carloni G., 1990. Pietro Veltri 1904-1989. Rivista di Psicoanalisi, 35: 473-477.
115.Carloni G., 1990. Formazione psicoanalitica e formazione dello psicoterapeuta. In: Formazione e Supervisione in Psicoterapia, a cura di A. Pazzagli, pp.7-13, Centro Scientifico Editore, Torino.
116.Carloni G., 1991. Restauro maniacale e riparazione psicoanalitica. (Riassunto). XIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Psicosomatica e III Convegno Nazionale di Psicometria, Bologna, 2-4 maggio 1991, p.24. O.S., Firenze.
117.Carloni G., 1991. La pulsione filiale, la sessualità e i suoi mutamenti. Il Piccolo Hans, 69: 187-202.
118.Carloni G., 1991. Prefazione a: A. Pagnoni, Assenze, tradimenti, pp.7-8, Prometheus Editrice, Milano.
119.Carloni G., 1991. Angoscia, colpa e depressione. In: Al di là del senso di colpa, a cura di A. Lambertino, pp.137-148, Città Nuova Editrice, Roma.
120.Carloni G., 1991. Cura di: S. Ferenczi, Opere Vol. II, Cortina, Milano.
121.Carloni G., 1991. Psicologia della vacanza. In: Freud e il Trentino. Otium e scrittura a Lavarone, a cura di A.M. Accerboni, pp. 53-58, U.C.T., Trento.
122.Carloni G., 1991. Il terzo orecchio dello psicoanalista. I Martedì, 96: 32-33.
123.Carloni G., 1991. Il sogno nella storia della psicoanalisi. In: Sogni: figli d’un cervello ozioso, a cura di M. Bosinelli e P. Cicogna, pp.79-90, Bollati Boringhieri, Torino.
124.Carloni G., 1991. Il sogno nella pratica psicoanalitica di oggidì. In: Sogni: figli d’un cervello ozioso, a cura di M. Bosinelli e P. Cicogna, pp.149-160, Bollati Boringhieri, Torino.
125.Carloni G., 1991. Interventi al 9° Congresso della Società Psicoanalitica Italiana (17 maggio 1990). In: Gli affetti nella Psicoanalisi, a cura di G. Hautmann e A. Vergine, pp. 463-464, 604, 618-620, Borla, Roma.
126.Carloni G., 1991. Prefazione a: S. Augelli, La cura del sogno. ES, Bologna.
127.Carloni G., 1992. Psicoanalisi e Antropologia. In: Origini e sviluppi della psicoanalisi applicata, a cura di A.M. Accerboni, pp. 37-45, Edizioni Centro Studi Gradiva, Lavarone.
128.Carloni G., 1992. Sigmund Freud medico, scienziato e psicoanalista. Il mare in luce 9: 9-10, Comune di Riccione.
129.Carloni G., 1992. Cura di: S. Ferenczi, Opere Vol. III, Cortina, Milano.
130.Carloni G., 1993. Dal latte alla psiche. Atti del convegno: Il latte e il bambino, 47-60. C.E.R.P.L., Bologna.
131.Carloni G., 1993. Il destino dell’adulto nelle vicissitudini del bambino. Il riconoscimento psicoanalitico della dignità del bambino. In: La medicina psicosomatica in età evolutiva, a cura di V. Rossolini, pp.34-41, Graphos, Fano. (Atti del Congresso 28 giugno – 1 luglio)
132.Carloni G., 1993. Il bipartito giogo. “Il dramma del bambino dotato” Giacomo Leopardi. Psiche, 1(2): 301-307.
133.Carloni G., 1993. La psicoanalisi nella cultura italiana. In: Freud e la ricerca psicologica, a cura di R. Canestrari e P.E. Ricci Bitti, pp.53-77, Il Mulino, Bologna.
134.Carloni G., 1994. Le divergenze parallele del potere e del sapere. Psiche, 2: 210-214.
135.Carloni G., 1994. Sándor Ferenczi, pioniere e contemporaneo. Rimini, Congresso nazionale di psicoanalisi, 6-9 ottobre 1994.
136.Carloni G., 1994. Il malato terminale e la fase terminale di ogni psicoterapia. Reggio Emilia, Convegno sul malato terminale, 2 dicembre 1994.
137.Carloni G., 1995. Due gemelli centenari: cinema e psicoanalisi. Cineteca, 11(8): 4.
138.Carloni G., 1995. Fornari amico e maestro. Milano, 11-11-1995, Convegno su Franco Fornari.
139.Carloni G., 1996. La creatività come autoterapia. Fellini e l’importanza di non prendersi troppo sul serio. In: Fellini e dintorni, a cura di F. Monti e E. Zanzi, pp. 41-61. Il Ponte Vecchio, Cesena.
140.Carloni G., 1996. Da Ferenczi a Winnicott, lo stile materno. Milano, 15-16 giugno 1996, Convegno di studi winnicottiani.
141.Carloni G., 1997. Fellini e il pataca. In: Le frontiere della psicoanalisi, a cura di A.M. Accerboni e A. Schön, pp. 179-194, Borla, Roma.
142.Carloni G., 1997. L’acqua nella psicologia del profondo e nel linguaggio simbolico. Il fisioterapista, 3, 37.
143.Carloni G., 1997. Il padre, eterno? In: Il Padre, mito e realtà nella psicoanalisi e cultura. Itinerari psicoanalitici, (Verona, 4 ottobre 1997),Associazione Itinerari Psicoanalitici, Verona, pp. 25-36.
144.Carloni G., 1997. Introduzione a: G. Di Chiara e N. Pirillo, Conversazioni sulla psicoanalisi, Liguori, Napoli.
145.Carloni G., 1998. L’indiscreta solitudine di Narciso. In: Le ragioni della psicologia, a cura di M.W. Battacchi e altri, Franco Angeli, Milano.
146.Carloni G., 1998. Vent’anni dopo. I martedì.
147.Carloni G., 1998. Fascino e rifiuto della psicoanalisi. Psiche, 6, 181-187.
148.Carloni G., 1998. Lo stile materno. Rivista di Psicoanalisi, XLIV(4): 753-767. Relazione presentata al Congresso Internazionale “Ferenczi and Contemporary Psychoanalysis”, Madrid, 7 marzo 1998.
149.Carloni G., 1998. Prefazione a R. Reichmann, Otto Rank tra psicoanalisi e arte. CUEM,Milano, pp. 9-12.
150.Carloni G., 1999. Senza il nome del padre. Cineteca, 15(1): 8.
151.Carloni G., 1999. Il tempo della fiaba. In: Lo spazio narrativo: la fiaba e il gioco, a cura di F. Monti e F. Crudeli, pp. 21-32. Società Editrice Il Ponte Vecchio, Cesena.
152.Carloni G., 1999. Prefazione a: Genitori e figli in consultazione, a cura di E. Trombini, QuattroVenti, Urbino.
153.Carloni G., 1999. Prefazione a: La partecipazione affettiva dell’analista. Il contributo di S. Ferenczi al pensiero psicoanalitico contemporaneo, a cura di F. Borgogno, Franco Angeli, Milano.
154.Carloni G., 2000. Due sogni di uno psicoanalista attempato. Rivista di Psicoanalisi, XLVI(1):141-148.
155.Carloni G., 2000. Inconsci suggerimenti di un drammaturgo a degli sconosciuti professionisti della psiche. In: Tra psicoanalisi e teatro, a cura di E. Zanzi e S. Spadoni, pp. 73-82. Bulzoni, Roma.
156.Carloni G., 2000. Inconscio e coscienza nella prospettiva psicoanalitica. In: Coscienza. Storia e percorsi di un concetto, a cura di L. Gabbi e V.U. Petruio, capitolo VIII, pp. 93-107. Donzelli Editore, Roma.
157.Carloni G., 2001. Lo stile materno. In: La catastrofe e i suoi simboli, a cura di C. Bonomi e F. Borgogno, capitolo 13: pp. 257-269. Utet, Torino. (ripubblicazione)
158.Carloni G., 2001. Tragitti della nostalgia. In: La nascita della rappresentazione fra lutto e nostalgia, a cura di A. Racalbuto, M. La Scala e M.V. Costantini, capitolo , pp. 161-173. Borla, Roma. (ripubblicazione)
159.Carloni G., 2003. Le illusioni della psicoanalisi. In: L’illusione una certezza, a cura di A. Saraval, cap. V, pp. 87-100. Raffaello Cortina ed., Milano.
160. Carloni G., 2005 “La meravigliosa avventura della psicoanalisi. Scritti scelti 1974- 2001” Guaraldi. (Introduzione di Stefano Bolognini. Selezione a cura di Angelo Maria Crisci, Magda C. Mantovani, Filippo Marinelli, Daniela Nobili ed Irene Ruggiero che hanno curato le diverse sezioni del volume. Prefazione di Mariella Schepisi)
Bibliografia su Glauco Carloni
Gino Zucchini “L’ultimo saluto a Carloni” Rivista di Psicoanalisi, 2000- 2. Pag 409-410
Vedi anche:
La Meravigliosa avventura della psicoanalisi
Breve storia del Centro Psicoanalitico di Bologna
“Alcuni contributi dalla letteratura psicoanalitica” a cura di Gabriella Giustino
4 Dicembre 2010 – BOLOGNA – Giornata Glauco Carloni – Centro Psicoanalitico di Bologna
Complesso Edipico

Fulchran, 1798
Complesso Edipico
A cura di Francesco Conrotto
Con la formula “Complesso Edipico” si designa la struttura fondamentale delle relazioni affettive e interpersonali nelle quali è immerso l’essere umano. Lo si può intendere come la totalità della strutturazione psicoaffettiva degli umani. Il termine, che deriva dal tema della tragedia di Sofocle, fu adottato da Freud a partire dall’esperienza della propria autoanalisi (Laplanche e Pontalis, 1967 pag. 84) e dall’analisi dei suoi pazienti. In base a queste esperienze, Freud ha ipotizzato che l’affettività dei bambini si organizza in questo modo intorno ai tre-cinque anni di età (Freud, 1905) e che, fisiologicamente, questa organizzazione debba declinare all’epoca della latenza per subire poi una parziale riacutizzazione all’epoca della pubertà.
Fisiologicamente, questa organizzazione psicoaffettiva si struttura in un sentimento di attrazione amorosa nei confronti del genitore dell’altro sesso e di una gelosia e ostilità verso il genitore del proprio sesso. Questa è la forma “positiva” del Complesso Edipico che però, a volte, si presenta in forma “negativa”, cioè attraverso un amore per il genitore del proprio sesso e una ostilità verso quello dell’altro sesso. Secondo Freud, il Complesso Edipico costituisce l’elemento fondante della strutturazione della personalità umana e, qualora esso non dovesse essere superato, costituirebbe il nucleo di base di tutte le psicopatologie.
La strutturazione triangolare dell’Edipo è, dunque, il fondamento universale della vita psichica degli umani (Freud,1912-13) e le strutture che compongono il mondo fantasmatico degli umani, i cosiddetti “Fantasmi Originari” – cioè la seduzione, la scena primaria e la castrazione, sono apparentate al Complesso Edipico che ne rappresenta lo sviluppo complessivo. Anche la formazione del Super-Io sarebbe il risultato della introiezione del divieto paterno di intrattenere relazioni sessuali con i genitori, i fratelli e i membri della famiglia in generale e così anche l’ “Ideale dell’Io”, inteso come espressione dell’ideale al quale il soggetto aspira di poter diventare.
Nella prospettiva freudiana esiste una fase precedente alla nascita del Complesso Edipico che può essere definita “fase preedipica”. Questa sarebbe una situazione di tipo duale dominata da sentimenti ambivalenti di amore e ostilità del bambino, sia di sesso maschile che femminile, verso la madre (Freud,1931). Secondo M. Klein, il Complesso Edipico è presente sin dai primi mesi di vita dell’infante.
Dobbiamo a J Lacan (1960) un interessante sviluppo del concetto di Complesso Edipico. Secondo questo autore, il divieto paterno all’intimità sessuale verso i genitori si estende all’introiezione di quelle che sono le leggi che regolano la convivenza umana in generale. In una serie di articoli, egli introduce la formula “Nome del Padre” che definisce l’accettazione della legge e segna il passaggio da una condizione potenzialmente psicotica e pre-umana a quella umana. Infatti, a suo parere gli psicotici non avrebbero interiorizzato la “legge del Padre” e quindi sarebbero al di fuori della sanità mentale. Questa posizione di Lacan si collega alla tesi di Lévi-Strauss secondo la quale il divieto dell’incesto costituisce una legge universale che differenzia lo stato della civiltà umana dallo stato di natura ( Laplanche Pontalis, 1967 pag.88).
Bibliografia
Freud S. (1905) Tre saggi sulla teoria sessuale, OSF, 4
Freud S. (1912-13) Totem e tabu, OSF 7
Freud S. (1931) Sessualità femminile, OSF,11
Lacan J. (1960) Sovversione del soggetto e dialettica del desiderio. In Scritti, Einaudi, 1974.
Laplanche J Pontalis J.B (1967) Enciclopedia della psicoanalisi, Laterza, Roma,1968
Consultazione partecipata

Louise Bourgeois
A cura di Giovanna Maggioni
Con questo termine Dina Vallino ha voluto indicare un percorso di consultazione psicoanalitica, rivolto a genitori e figli in età evolutiva. E’ un lavoro che non esclude la psicoanalisi individuale del bambino, ma la amplia, perchè coinvolge i genitori nella responsabilità della cura dei figli, prima di qualsiasi percorso clinico. E’ un tipo di intervento che esplora le problematiche che emergono in consultazione, per come si presentano nell’hic et nunc della seduta, rimandando ad un momento successivo progetti di approfondimento a più lungo raggio. Il setting prevede alcuni incontri articolati nel modo seguente: 1 colloquio con i genitori, 1 seduta di entrambi i genitori con il figlio/a, 1 seduta della madre con il figlio/a, una seduta del padre con il figlio/a, 1 colloquio con i genitori in corso d’opera, una seduta di restituzione con il figlio/a. Sebbene tale modalità di consultazione si sia rivelata utile anche in adolescenza, tuttavia è stata prevalentemente proposta a genitori, i cui figli avevano un’età compresa tra la prima infanzia e la preadolescenza ( 0- 12 anni). E’ richiesta al terapeuta una formazione psicoanalitica al lavoro con gli adulti, con i bambini e con gli adolescenti, che preveda una personale esperienza di Infant-Observation.
La Consultazione partecipata è nata, infatti, da un lungo lavoro di ricerca che Dina Vallino ha svolto nel campo dell’Infant-Observation, a partire dagli anni 80, come una estensione dell’Infant- Observation stessa. La pratica dell’Infant- Observation, è una esperienza formativa fondante la consuetudine nell’osservatore di stare con i genitori e il loro bambino, tutti insieme, ed è importante per affrontare l’ignoto della famiglia, in quanto aiuta ad avere congetture semplificanti la complessità. Questo lavoro di ricerca permette di conoscere i genitori sul campo (nella loro relazione con il bambino) e il bambino sul campo (nella sua relazione coi genitori al variare della sua età) e insegna a cogliere l’atmosfera emotiva in una famiglia. Nel primo colloquio di consultazione col terapeuta, generalmente i genitori espongono spontaneamente le ragioni della loro richiesta d’aiuto, cioè il disagio del figlio e le difficoltà che incontrano nel relazionarsi a lui. Talvolta è la prima occasione che i genitori hanno di chiedere aiuto, in altri casi invece è già stato compiuto un percorso psicodiagnostico o terapeutico e i genitori vorrebbero essere aiutati a comprendere meglio il lavoro svolto, o iniziare una terapia. L’atteggiamento mentale del terapeuta in questo primo incontro, è volto principalmente a facilitare la comunicazione dei genitori intorno al disagio del figlio, sospendendo temporaneamente, per quanto possibile, ogni “pregiudizio di valutazione ”. Il terapeuta deve accogliere l’emotività dei genitori, che si svela nel racconto di semplici episodi della vita quotidiana, incoraggiando domande e osservazioni, cercando sì di intercettare la sofferenza nascosta dietro i sintomi, ma astenendosi da premature ipotesi diagnostiche e da interventi intrusivi o troppo saturi. Ciò che è importante nel primo colloquio è permettere ai genitori di vivere un sentimento di minore solitudine rispetto al loro problema. E’ proprio per favorire la speranza di una possibile condivisione che il terapeuta propone ai genitori il progetto della consultazione partecipata e quindi le sedute congiunte con il figlio. Il terapeuta può invitare i genitori, se lo desiderano, a scegliere con il figlio/a documenti familiari ( foto, disegni, oggetti particolarmente significativi) da portare all’incontro successivo. E’ anche importante informarsi dai genitori sui giochi preferiti dal figlio, per potere, per quanto è possibile, predisporre adeguatamente la stanza per la seduta familiare. Le sedute congiunte naturalmente differiscono tra loro a seconda del tipo di psicopatologia e dell’età: é possibile comunque individuare un minimo comune denominatore. Il terapeuta, dopo aver dato alcune spiegazioni su ciò che si può fare insieme nella stanza, e cioè giocare, disegnare raccontare piccole storie con mamma e papà, si lascerà permeare dall’atmosfera emotiva dell’incontro, esercitando per quanto possibile la sua capacità negativa. E’ opportuno astenersi dal parlare con i genitori “del figlio” in sua presenza, incoraggiando invece per quanto possibile l’interazione con lui, attraverso semplici commenti e domande che permettano di sviluppare il gioco, il racconto il disegno. Una possibilità di avviare la seduta potrebbe essere per esempio quella di commentare insieme i documenti affettivi, ricostruendo momenti della storia familiare: nasce così una prima narrazione condivisa. Osservare, e giocare insieme a genitori e figli ci permette di intercettare il fraintendimento inconscio, cioè il disturbo della comunicazione familiare. Il fraintendimento deriva da un’attribuzione da parte dei genitori al figlio di qualcosa che non gli appartiene ed è pertanto un concetto strettamente collegato a quello di identificazione proiettiva patologica. Attraverso le sedute congiunte, il disagio del figlio trova una nuova modalità per essere raccontato e rappresentato davanti ai genitori (ad esempio un bambino con angosce persecutorie ha raccontato la storia di un terribile formicone che distruggeva tutto senza lasciare scampo). Lo sviluppo di un nuovo linguaggio, quello delle rappresentazioni condivise in seduta, permette di dare ai sintomi nuovi significati e dunque di introdurre una novità nel funzionamento del pensiero gruppale.
Nel colloquio con i soli genitori il terapeuta può commentare ciò che è avvenuto nella stanza con il figlio ponendo delle domande. Per esempio ci si può interrogare sul perchè di un certo gioco, come è iniziato, perchè si è interrotto, favorendo così la capacità dei genitori di sviluppare una sorta di identificazione con il terapeuta, che possa permettere loro di non sentirsi estromessi dal rapporto con il loro figlio, e di comprendere cosa avviene nella consultazione. Durante il colloquio si valuta insieme la situazione e come proseguire. E’ possibile che dalla consultazione scaturisca la domanda di una terapia per i genitori e/o per il figlio. Può accadere però che la famiglia non sia ancora pronta ad accogliere il progetto di una psicoterapia, oppure che il disagio, non si sia ancora strutturato in una psicopatoplogia conclamata ma che mantenga una certa mobilità ( come per esempio nei disturbi reattivi). In tali casi è opportuno proporre di prolungare la consultazione partecipata e il terapeuta continuerà a lavorare alternando le sedute con figlio e i genitori alle sedute con i soli genitori e anche, se possibile, con il solo figlio. Quando la consultazione diviene dunque prolungata? La consultazione diviene una Consultazione partecipata prolungata per creare le condizioni di una successiva psicoterapia per il figlio e/ o per i genitori oppure per svolgere, attraverso il chiarimento del fraintendimento inconscio nella relazione genitori figli, un’azione preventiva nei confronti dello sviluppo di una più severa psicopatologia.
Per esempio il gioco del negozio delle scarpe “ scoppiate ” ripetutamente proposto da una bimba di 4 anni, in una sequenza di sedute in presenza della mamma, ha permesso di iniziare ad avvicinare un nucleo simbiotico nella relazione mamma figlia, che rendeva la coppia particolarmente tirannica e rabbiosa, preparando così la strada per una successiva psicoterapia). Fraintendimenti di vario genere da parte dei genitori, mancanza di reverie, identificazione proiettive intrusive, costituiscono l’ingrediente principale dell’incomprensione verso i figli, i quali a loro volta rispondono con rimozione, scissione, ricerca di una identità adesiva, identificazione introiettiva patologica e disturbi vari a livello del super-Io e dell’Io ideale.
Anche la seduta di restituzione al figlio, che conclude la prima serie di incontri della Consultazione partecipata avviene in presenza dei genitori. Durante questa seduta sarà espresso il progetto terapeutico al figlio, naturalmente secondo modalità adeguate all’età e alla condizione psicologica, e si valuterà la risposta, rispettando la sua intenzionalità. ( Pedro un bimbo di 6 anni gravemente carenziato, nella seduta di restituzione, accompagna le parole della terapeuta, che propone di prolungare la consultazione con un gioco dove alcune macchinine che hanno subito gravi incidenti devono essere riparate. Coinvolge anche mamma, papà e terapeuta nel gioco, quasi ad indicare la necessità di un lavoro comune. E’ stato necessario lavorare per un certo periodo con mamma e papà e bambino, prima di pensare ad una psicoterapia ).
La Consultazione partecipata, ha suscitato interesse in alcuni colleghi della S.P.I che lavorano con bambini e in alcuni terapeuti esterni con formazione psicoanalitica, e ha trovato uno spazio di studio, ricerca e applicazione presso alcune sedi universitarie (Torino, Brescia, Venezia, Bologna) e presso alcune strutture per la prevenzione e la cura in età evolutiva. Nel Training S.P.I (sezione milanese ) dal 2010 Dina Vallino tiene per i candidati seminari sulla Consultazione partecipata. Durante il corso di Perfezionamento S.P.I. per l’Analisi di Bambini e Adolescenti, nel 2008, è stato possibile presentare e discutere casi riguardanti l’argomento. L’interesse di molti colleghi ha permesso di costituire un gruppo di ricerca e applicazione intorno a questo lavoro, di approfondire ed esplorare la metodologia stessa e il campo di applicazione.
BIBLIOGRAFIA
Vallino D. ( 1984), L’avvio della consultazione partecipata. In ( a cura di M.L.Algini) Sulla storia della psicoanalisi infantile ( 2007). Quaderni Psicoter.Inf. n55, Borla, Roma.
Vallino D.(1998) Raccontami una storia. Dalla consultazione all’analisi di un bambino. Borla. Roma
AA.VV. (1999) In ( a cura di A.Ferro e F. Borgogno) “ La storia ” e il Luogo Immaginario. Quad.Psicoter.Inf., 41.
Vallino D., Maccio’ M. (2004 b) Essere Neonati. Osservazioni psicoanalitiche. Borla. Roma
Vallino D. ( 2009) Fare Psicoanalisi con Genitori e Bambini. Borla. Roma
AA.VV.(2011) In ( a cura di M.Macciò e D.Vallino) Famiglie. Quad.Psicoterap.Inf, 63
ATTI-Convegno Osservatorio del C.M.P., Milano13 Aprile 2013. Psicoanalisti e genitori: come lavorare insieme. Dina Vallino. Incontrare l’inconscio di bambini e genitori con il gioco e con l’osservazione. Proposte della consultazione partecipata prolungata.
Controtransfert

Dal film Prendimi l'anima di R. Faenza
A cura di Irene Ruggiero
La concezione “classica” del controtransfert.
Freud (1910, 1912) definisce il controtransfert, allora chiamato controtraslazione, una forza interna che si attiva per influsso del paziente sui sentimenti inconsci dell’analista, determinando delle “macchie cieche” che ostacolano le sue capacità di comprensione dell’inconscio del paziente. La contro traslazione si connota dunque come una resistenza inconscia dell’analista. Preoccupato che il controtransfert mini la credibilità della nascente psicoanalisi, esponendola a critiche di scarsa serietà e scientificità, Freud lo considera un inconveniente spiacevole, seppure inevitabile, come panni sporchi da lavare in famiglia (1911).
Freud raccomanda pertanto agli analisti di mantenere un’attenzione fluttuante nell’ascolto del paziente e di attenersi a quella neutralità che rappresenta a quel tempo il modello ideale di funzionamento analitico, di procedere durante il trattamento psicoanalitico come “il chirurgo, il quale mette da parte tutti i suoi affetti e perfino la sua umana pietà nell’imporre alle proprie forze intellettuali un’unica meta: eseguire l’operazione nel modo più corretto possibile” (1912, 536). Tuttavia, poiché “ogni psicoanalista procede esattamente fin dove glielo consentono i suoi complessi e le sue resistenze interne” (1912, 201), per potersi servire “del suo inconscio come di uno strumento per l’analisi”, il medico deve sottoporsi a una “purificazione psicoanalitica”, che in un primo tempo Freud ritiene attuabile attraverso l’autoanalisi. Successivamente, è proprio la constatazione dell’inevitabilità del controtransfert, la scoperta dei potenziali ostacoli rappresentati dalle rimozioni e dagli affetti non padroneggiati dell’analista, ad indurlo a porre l’analisi personale del futuro analista come la base della formazione: infatti, solo se “purificato”, l’analista potrà “come una lastra di specchio mostrare [al paziente] soltanto ciò che gli viene mostrato”.
L’idea che il controtransfert rappresenti un ostacolo nel processo di rendere conscio l’inconscio, considerato all’epoca lo scopo del trattamento psicoanalitico, si mantiene sostanzialmente immutata per molto tempo e rimane il nucleo di quella che Kernberg (1965) definisce la concezione “classica” del controtransfert. Essa presuppone coerente un modello del processo analitico in cui il paziente rappresenta l’oggetto da conoscere e l’analista l’osservatore tendenzialmente neutrale. In questo modello, il controtransfert, che inquina questa distinzione di ruoli, non dovrebbe idealmente esistere (Albarella e Donadio, 1998).
Il controtransfert (e in generale il tema degli affetti dell’analista), la cui inevitabilità costituisce un’imbarazzante evidenza dei limiti dell’analisi personale – tema su cui Freud tornerà successivamente (1937) – viene così sostanzialmente trascurato per molti anni, con sparute eccezioni (il contributo di Ferenzci – pioniere nel riconoscimento del valore positivo degli affetti dell’analista e nella critica del mito della “neutralità analitica” – e dei Balint che, nel 1939, propongono di allargare il concetto di contro-transfert alla totalità dei sentimenti dell’analista verso il paziente).
Secondo Kernberg (1965), è l’ideale della neutralità analitica, agendo come istanza superegoica, a ritardare l’esplorazione delle potenzialità del controtransfert. Per poterle riconoscere, occorre che si modifichino la concezione dell’analisi e si sviluppi l’idea che essa costituisce una relazione tra due persone, che le coinvolge entrambe, sia pure con modalità e funzioni differenti.
La svolta degli anni ‘50.
E’ soprattutto il concetto di identificazione proiettiva introdotto da Klein (1946) e sviluppato da Bion nei suoi aspetti più comunicativi, a modificare il clima e a creare le condizioni per la valorizzazione del controtransfert, che trova il suo fulcro all’inizio degli anni ‘50, con i lavori contemporanei ma indipendenti della Heimann (1950) in Inghilterra e di Racker (1953; 1957; 1958) in Argentina.
Partendo dalla critica all’ideale di un analista “distaccato”, Heimann sottolinea che la natura più profonda della situazione analitica è costituita dall’essere una relazione tra due persone e che ciò che la rende specifica non è l’assenza di sentimenti nell’analista, bensì la sua capacità di sostenerli ed elaborarli invece di scaricarli. Affermando che il controtransfert costituisce “una creazione del paziente della mente dell’analista”, e quindi una via di accesso ai suoi affetti inconsci, Heimann capovolge la concezione freudiana. L’attenzione fluttuante va dunque integrata con risposte emotive fluttuanti. Anche se non le sfugge il rischio che l’analista attribuisca al paziente ciò che invece gli appartiene, la Heimann ritiene che, essendo troppo arduo distinguere il transfert dell’analista sul paziente dal controtransfert vero proprio, sia opportuno includere nel controtransfert la totalità degli affetti che l’analista prova verso il paziente.
In grande consonanza con Heimann, Racker – partendo dalla critica del “mito della neutralità analitica” – attribuisce la prolungata sottovalutazione dell’importanza del contro-transfert all’”idea illusoria che l’analisi sia l’interazione tra una persona malata e una sana” (1957, 177). Anch’egli considera gli affetti dell’analista un prezioso strumento di lavoro: in un primo tempo, l’analista non può che sopportare il controtransfert (l’effetto degli affetti del paziente, che gli vengono “comunicati” senza la mediazione del linguaggio verbale); successivamente, sarà l’analisi del contro-transfert a rendere comprensibili e rappresentabili gli affetti e le emozioni, che formeranno la base di interpretazioni efficaci e vitali. Così, anche le reazioni controtransferali più patologiche possono essere utilizzate per comprendere il transfert del paziente e la natura del rapporto analitico.
Questa importante svolta nel modo di concepire la relazione tra analista e paziente contribuisce al superamento dei precedenti limiti di analizzabilità: la valorizzazione della dimensione preverbale nell’analisi (in quanto le emozioni dell’analista diventano un canale privilegiato per accedere a quanto il paziente non può rappresentare ed esprimere attraverso il linguaggio) consente l’estensione del trattamento psicoanalitico ai casi limite e ai pazienti con personalità narcisistica, e facilita la via all’allargamento dell’analisi ai bambini e agli adolescenti.
Il concetto di contro-transfert della Heimann e di Racker si fonda su quello di identificazione proiettiva (M. Klein, 1946); alla base di esso, è il modello della relazione madre-infante, che verrà ulteriormente sviluppato da Bion, con una specifica sottolineatura delle funzioni comunicative dell’identificazione proiettiva e della sua elaborazione attraverso la reverie materna, volta a contenere, trasformare e dare un senso alle proto-emozioni (elementi sensoriali grezzi) del bambino, in modo che egli non ne sia sommerso.
I loro scritti avviano ampie rivisitazioni del concetto di controtransfert, a partire dalla sua stessa definizione, e discussioni accese sulla sua origine, il suo significato, il modo di utilizzarlo. Molti autori ne estendono il significato ben oltre i confini della concezione freudiana, fino ad includervi tutte le fantasie e i sentimenti dell’analista nei confronti del paziente (concezione “globalista”), ne evidenziano il ruolo di strumento atto a favorire un accesso diretto ai livelli più primitivi e meno strutturati della mente del paziente, sottolineano ruolo cruciale che nell’esperienza analitica giocano elementi quali il silenzio, il preverbale, il gioco e l’illusione ed evidenziano il contributo del paziente nel produrre le risposte controtransferali dell’analista, valorizzando gli aspetta relazionali e simmetrici della relazione analitica. Autori come Winnicott (1947; 1960), Searles (1958), la Little (1951) e la Tower (1956) contribuiscono alla comprensione delle emozioni controtransferali, ciascuno dal proprio punto di vista, accomunati però dalla concezione della situazione analitica come una relazione attraversata da continue e reciproche comunicazioni inconsce. Non tutti gli psicoanalisti, tuttavia, accettano questi nuovi punti di vista e sorgono vivaci controversie tra sostenitori della concezione “globalista” e rappresentanti della “concezione classica” del controtransfert (tra cui A. Reich, 1949, 1959; e R. Fliess, 1953).
Concezioni attuali.
Nel tempo, gli analisti sono diventati più avvertiti nel cogliere i pericoli insisti in un uso automatico del controtransfert, pur riconoscendone la fondamentale potenzialità euristiche. Già Racker, del resto, pur pure evidenziando magistralmente l’utilità del controtransfert come strumento di comprensione, non ne misconosce gli aspetti problematici di possibile contro-resistenza dell’analista.
Le posizioni degli analisti attuali sono molto variegate: alcuni, in linea con la concezione freudiana, propendono per una definizione del contro-transfert come evento delimitato e circoscritto e lo considerano la manifestazione di una resistenza (Semi, 1998, 2006), in quanto espressione dei bisogni e dei conflitti inconsci dell’analista; altri, sottolineando gli aspetti relazionali del processo analitico, evidenziano gli elementi di inevitabile interazione insiti nella dinamica transfert-contro-transfert, e optano per una concezione ampia del contro-transfert, concepito come una trama profonda del processo analitico piuttosto che come situazione acuta, come emergenza transitoria (Di Benedetto, 1991; 1998; Vallino Macciò, 1992). Molti di loro pensano che il controtransfert, pur rappresentando una preziosa via di accesso al non ancora rappresentato del paziente, non cessi per questo di essere un ostacolo e che, prima di poterlo utilizzare come base di un’interpretazione, vada elaborato attraverso l’autoanalisi dell’analista (Russo, 1998, 2003). Personalmente penso che, nonostante sia innegabile che in molti casi il contro-transfert costituisca un importante via di accesso ad elementi non ancora rappresentabili operanti nella relazione analitica, e pertanto un irrinunciabile punto di partenza per un processo figurativo e elaborativo, esso non possa essere pensato come uno strumento tecnico utilizzabile in modo agevole o automatico, per molteplici ragioni: perché il contro-transfert è per definizione inconscio e l’idea che sia possibile monitorarlo continuamente per tenerlo sotto controllo appare illusoria (Little, 1951; Tower, 1956; Pick, 1985; Turillazzi, 1994); perché la difficoltà di distinguere il contro-transfert “normale” da quello “patologico” (Money Kyrle, 1956) rende troppo opinabile la sua utilizzazione automatica come indicatore del mondo interno del paziente (Riolo, 1998); perché gli affetti dell’analista non sono né programmabili né decidibili (Bolognini, 2002); per il fatto che l’analista deve compiere un profondo e impegnativo lavoro di elaborazione interiore prima di poter utilizzare il contro-transfert come un’utile risorsa (Ruggiero, 2011); e infine, perché il contro-transfert, qualunque sia l’uso conoscitivo che l’analista ne fa, interferisce inevitabilmente con il processo analitico in quanto il paziente lo percepisce e ne è influenzato (Racker, 1957; Searles, 1958; Rosenfeld, 1987). Direi che la concezione del controtransfert prevalente oggi è che esso rappresenti sia un ostacolo che una risorsa (Ferruta, 1998; Turillazzi Manfredi, 1989) e che costituisca una formazione di compromesso una entità complessa contenente le risposte dell’analista fuse e mescolate con gli aspetti proiettati dal mondo interno del paziente (Jacobs, 1999).
Quello di controtransfert rimane a tutt’oggi un concetto piuttosto ambiguo. Grosso modo, le questioni più controverse riguardano: la possibilità o meno di distinguerlo dal transfert dell’analista; l’estensione del concetto di contro-transfert; la sua natura di ostacolo e/o di risorsa; il peso dell’analista nell’influenzare il transfert del paziente, e conseguentemente i livelli di simmetria e asimmetria presenti e auspicabili nel rapporto analitico.
Sebbene Gabbard (1993) lo ritenga il terreno comune emergente della psicoanalisi contemporanea, quello di contro-transfert permane a tutt’oggi un termine ambiguo e controverso, che designa una varietà di concetti teorico-clinici non facilmente sovrapponibili.
Bibliografia
Albarella C. – Donadio M. (1998). (a cura di) Il contro-transfert, Liguori, Napoli, 1998.
Balint M., Balint A. (1939). On transference and countertransference. Int. j. Psychoanal., 20, 223-30.
Di Benedetto A. (1991). Contro-transfert: sentire, ricreare, capire. Riv. Psicoanal.,37, 94-131
Di Benedetto A. (1998). Sperimentare un pensiero che verrà. Riv. Psicoanal., 44, 5-22.
Ferruta A. (1998). Tra Corinto e Tebe. Il contro-transfert all’incrocio tra riconoscimento e accecamento, Riv. Picoanal., 2, 1998, 300
Fliess R. (1953) Countertransference and counteridentification, J. Am.Psycho-Anal.,Assn., 1,268-84
Freud S. (1910). Le prospettive future della terapia psicoanalitica. O.S.F.,6
Freud S. (1911). Lettera a Jung, 31 Dicembre 1911.
Freud S. (1912). Consigli al medico nel trattamento psicoanalitico. O.S.F., 6
Freud S. (1937). Analisi terminabile e interminabile. O.S.F., 11.
Gabbard G.O., (1993) Contertransference: The emerging common ground, Int. J.Psycho-Anal., 74, 475 -486.
Heimann P. (1950). On countertransference. Int. j. Psychoanal. 31, 81-84. [Sul contro-transfert, in Albarella C. e Donadio M. (a cura di), Il contro-transfert, Liguori, Napoli, 1998, 73-79
Jacob T.J. (1999). In cerca della mente dell’analista. Gli Argonauti, 80.
Kernberg O. (1965). Notes on Countertransference, J- Am. Psychoan. Ass., 13,1, 38-56
Klein M. (1946). Note su alcuni meccanismi schizoidi. In Klein. Scritti 1921-1958. Boringhieri. Torino, 1978.
Little M. (1951). Il contro-transfert e la risposta del paziente. In Albarella C. e Donadio M. (a cura di), Il contro-transfert, Liguori, Napoli, 1998, 131-147.
Money Kyrle R. (1956). Contro-transfert normale e alcune sue deviazioni, In Albarella C. – Donadio M. (a cura di), Il contro-transfert, Liguori, Napoli, 1998,
Pick I. (1985). Working- through in the countertransference. Int. j. Psychoanal. 66, 157-166.
Racker H. (1953). La nevrosi di contro-transfert, in Studi sulla tecnica psicoanalitica, Armando, Roma, 1968, 143-170
Racker H. (1957). Il significato e l’impiego del contro-transfert, in Studi sulla tecnica psicoanalitica, Armando, Roma, 1968, 171-229
Racker H. (1958). Controresistenza ed interpretazione, in Studi sulla tecnica psicoanalitica, Armando, Roma, 1968, 249-256
Reich A. (1949). Sul controtransfert. In Albarella C. e Donadio M. (a cura di), Il contro-transfert, Liguori, Napoli, 1998, 42-55.
Reich A. (1959). Ulteriori osservazioni sul controtransfert. In Albarella C. e Donadio M. (a cura di), Il contro-transfert, Liguori, Napoli, 1998, 57-69.
Riolo F. (1998). Naufragio senza spettatori. Riv. Picoanal., 44,2, 283-294.
Rosenfeld H. (1987). Comunicazione e interpretazione, Torino, Boringhieri, 1989
Ruggiero I. (2011). Comunicazione inconscia e lavoro di controtransfert. Riflessioni sulla consultazione con un adolescente. Riv. Psicoanal.,1, 71-84.
Russo L. (1998). Sul contro-transfert. Riv. Picoanal., 44,2, 283-294.O
Russo L. (2003). Autoanalisi contro-transfert. Riv. Picoanal., 49,2, 283-294.
Searles H. (1958). La vulnerabilità dello schizofrenico al processi inconsci del terapeuta. In Albarella C. e Donadio M. (a cura di), Il contro-transfert, Liguori, Napoli, 1998, 163-188.
Semi A. (1998). Il contro-transfert nell’ottica freudiana. In Rivista di psicoanalisi., 2, 321, 319-328.
Semi A. (2006) Il transfert e le comunicazioni inconsce: controtransfert, teorie e narcisismo dell’analista. . Riv. Psicoanal., 2, 325-346.
Tower L.E. (1956). Counter-transference. J. Am. Psychoanal. Ass., 4, 1956.
Turillazzi Manfredi S. (1989) La nuova teoria del controtransfert. Riv. Psicoanal., 3, 617-641.
Turillazzi Manfredi S. (1994). Le certezze perdute della psicoanalisi clinica. Milano, Cortina, 1994.
Vallino Macciò D. (1992). Sopravvivere, esistere, vivere: riflessioni sull’angoscia dell’analista. In Nissim Momigliano L. – Robutti A. (a cura di (1992). L’esperienza condivisa, Cortina, Milano, 1992.
Winnicott D. (1947). L’odio nel contro-transfert. In Albarella C. e Donadio M. (a cura di), Il contro-transfert, Liguori, Napoli, 1998, 119-130.
Winnicott D. (1960). Il contro-transfert. In Sviluppo affettivo e ambiente, Armando, Roma, 1977
Novembre 2013
Corpo in psicoanalisi (Il) 2

H.Bellmer, 1937
Il Corpo in Psicoanalisi
A cura di Marta Badoni
Il paradosso della coppia corpo mente
In diversi lavori, e, in particolare in un lavoro del 1997, Grotstein prospetta un possibile modo di pensare alla “strana coppia” costituita dalla mente e dal corpo come a una unità ‘stranamente accoppiata’, in qualche modo obbligata a convivere, ‘come una coppia di gemelli siamesi’.
Questa affermazione mi ha colpito, perché la coppia di gemelli siamesi è, di per sé, una coppia disfunzionale: la prima cosa che viene in mente pensando ai gemelli siamesi è se e come separarli :la separazione non è senza gravissimi rischi, l’unione obbligata è scomoda, tuttavia interroga.
Questo è stato anche il destino della coppia corpo mente.
L’interrogarsi si è fatto ancora più pressante, più stimolante, ma anche più scomodo, man mano che, con le ricerche delle neuroscienze, il cervello ha occupato nel corpo un posto di rilievo: si è aperto così, negli ultimi decenni, un ampio dibattito tra psicoanalisi e neuroscienze, dibattito che ha visto schierarsi, in entrambi gli ambiti, posizioni tendenti alla assimilazione o invece al dialogo.
Ne discute dettagliatamente Michele Bezoari (2007) immaginando ‘Cosa si prova a essere un cervello’. L’autore sostiene l’interesse di un dialogo con le neuroscienze, operazione peraltro continuamente perseguita da Freud, evidenziando tuttavia la peculiarità dell’oggetto di interesse della psicoanalisi, l’inconscio, e la specificità del modello di indagine psicoanalitico.
Dal proprio punto di vista Gallese (2014) sostiene una tesi analoga quando afferma che il cervello esprima la propria piena funzionalità solo ed esclusivamente perché legato a un corpo situato in un particolare mondo materiale, sottoposto ad una serie di leggi fisiche, popolato da altri individui.
Si sottolinea da un lato la difficoltà di slegare il cervello dal corpo o il corpo da altri corpi, dall’altro il rischio di appiattire un lavoro di indagine e un metodo (il metodo psicoanalitico) su un sistema di competenze.
Il dialogo tra neuroscienze e psicoanalisi è comunque apertissimo, legato in particolare e, non a caso, all’area del trauma (Manica, 2005) e a quelle del lavoro con i bambini e con gli adolescenti (Monniello, Quadrana,2010).
Anche la problematicità dei diversi livelli di simbolizzazione, di cui si è particolarmente occupato in Francia René Roussillon, è densa di conseguenze.
La ricchezza di questo dialogo è d’altronde testimoniata dai 204 dati bibliografici, alla voce ‘neuroscienze’, presenti sul PEP (Psychoanlytic Electronic Publishing) relative alla sola Rivista di Psicoanalisi.
La questione del rapporto corpo mente/mente corpo, ci appare di fatto come una questione non affrontabile se non in termini di questione paradossale, come il paradosso proposto da Winnicott (1958), “essere solo in presenza”. Come ogni paradosso, anche questo della natura del rapporto corpo mente più che dare risposte a interrogativi, stimola un pensiero. Le scorciatoie, come la tentazione di rifondare la psicoanalisi sulle neuroscienze, potrebbe minacciare ‘l’autonomia epistemologica’ della psicoanalisi e lo statuto della psicoanalisi diventerebbe disfunzionale rispetto agli obiettivi che si propone. Psicoanalisi e neuroscienze sono discipline distinte, con metodi di indagine, sistemi linguistici e concettuali di codificazione delle conoscenze distinti (Mattana, 2017).
Se non vogliamo riproporre da un lato il dualismo cartesiano e dall’altro una confusione epistemologica, non possiamo che immergerci nel paradosso e vedere dove ci porta.
Per integrare il somato-psichico, Freud ha cercato di indicare possibili accordi: prima la teoria della seduzione (Freud, 1,1892-1895), poi la compiacenza somatica (Freud, 4,333), di seguito la pulsione, come misura delle operazioni che vengono richieste alla sfera psichica in forza della sua connessione con quella corporea (Freud, 8,17). Ancora più esplicita la nozione di un Io Corpo, non solo come entità superficiale, ma come proiezione di una superficie (Freud, 9, 488). Uno strumento, quello psichico, che non è affatto facile da suonare, scriverà Freud (4, 433).
Non è d’altronde infrequente che, traendo spunto dalla stessa affermazione di Freud, gli psicoanalisti arrivino a teorizzazioni affatto diverse, come ci mostra in un ben documentato lavoro sulla ‘clinica del corpo’ Fausta Ferraro (2011).
Tra i temi controversi il concetto di pulsione che viene da alcuni rivisitato (Imbasciati, 2010), e che non compare, come termine, nel dizionario di Bion (Lopez Corvo, 2005). Sarà comunque necessario immaginare una qualche risonanza tra psiche e corpo. Roussillon (2013), negli ultimi anni, ha proposto il concetto di “pulsione messaggera”.
Freud arriverà a due ipotesi per descrivere la ‘vita dell’anima’[1] , o apparato psichico.
Le due ipotesi sono tenute distinte, tratteggiate in punti diversi ne il Compendio (1938).
La prima ipotesi:
- La vita psichica è funzione di un apparato al quale ascriviamo estensione spaziale e struttura composita e che ci figuriamo dunque simile a un cannocchiale, a un microscopio e ad altri strumenti del genere ( 1938:572). Freud di seguito aggiunge che l’elaborazione coerente di un’idea come questa rappresenta, a prescindere da certe affermazioni già tentate in passato, una novità scientifica.
Più radicale la seconda ipotesi:
- La psicoanalisi reputa che i presunti processi concomitanti di natura somatica costituiscano il vero e proprio psichico, e che essi prescindano dalla qualità della coscienza (1938:585).
Cosa vuol dire l’ ‘elaborazione coerente’ della prima ipotesi? Gli strumenti scelti da Freud per figurare la ‘vita dell’anima’, non mi appaiono casuali. Il cannocchiale serve per avvicinare e poter descrivere paesaggi distanti, ‘province diverse’ altrimenti invisibili ad occhio nudo, mentre il microscopio esercita un focus in profondità, coglie dettagli che altrimenti sfuggono. Tuttavia, né il cannocchiale, né il microscopio si sovrappongono all’oggetto osservato. Gli strumenti menzionati descrivono un essere in contatto e una distanza. Quali sono poi le ‘affermazioni già tentate in passato’? Ci si può chiedere se, pensando alla prima ipotesi, Freud non avesse in mente, pur senza averla pubblicata, la “funzione dell’Intendersi[2]” (1895: 223). L’adulto soccorrevole ‘si intende’, con l’infante -sprovvisto di parola- attraverso ‘le vie della modificazione interna’.
È l’intesa a pilotare il soccorso, intesa che presume una tensione emotiva con le relative risonanze. Sia il cannocchiale come il microscopio chiedono di esercitare attenzione, verso un altro da sé e dentro di sé, una funzione fondante per Freud: la funzione dell’intendersi precede l’enunciato, è qualcosa che lo prepara, e l’accompagna; essa ha a che fare con la capacità di cogliere l’atmosfera emotiva nel divenire del soggetto come nella seduta analitica: accordare gli strumenti, prima di suonare. Questo è il soccorso dell’apparato psichico in ogni situazione di impotenza: hilflosigkeit è letteralmente ‘senza-aiuto’.
Bion (1962) svilupperà queste intuizioni con il concetto di reverie e di ‘pensieri in cerca di un pensatore’. Come intendiamo il concetto di reverie? Green (1990:402), sovrapponendola al concetto di libera associazione, scrive che la reverie è una attività psichica che vaga senza scopi precisi, senza rigore metodico, come un turacciolo che si lascia condurre dal moto delle onde, sotto l’influenza delle correnti che animano il mare. La libertà è legata al fatto di lasciarsi andare, rinunciando ‘liberamente’ a esercitare un controllo sugli avvenimenti. È interessante notare, come Green, lettore di Bion, ma fedele a Freud, sottolinei, nella metafora, un principio economico: il moto delle onde, e la temperatura degli affetti: le correnti possono essere calde, fredde, impetuose, calma piatta, lavoro del vento. La reverie, per come è descritta da Green, tende quindi a sovrapporsi al funzionamento delle libere associazioni.
Di diverso parere è Ferro (2014), che distinguendo nettamente le libere associazioni dalla reverie, sostiene come questa ultima sia in presa di contatto diretta con i pittogrammi che costituiscono il pensiero onirico della veglia (p. 40). Il pittogramma è un’immagine che segnala e condensa un punto di contatto e una trasformazione (nell’esempio di Ferro, l’analista che chiede un aumento di onorario e il paziente che risponde con la visione improvvisa, sulla parete di fronte, di un pollo spennato: affetto e rappresentazione convergono sul pollo spennato). Notiamo quanto, come nei sogni, l’evidenza del corpo venga a soccorso dell’immagine, impregnandola di contenuti emotivi. Di queste immagini condensate che chiamano in appoggio non solo il corpo, ma un corpo figurante, è colmo il linguaggio popolare. Ne cito alcuni esempi: salvare la pelle, essere tutt’orecchie, mangiar con gli occhi.
L’effetto di condensazione e, soprattutto, la paradossalità del pittogramma è bene illustrato da Piera Aulagnier (1975:48) nel descrivere il processo originario. Per l’autrice, le origini della vita psichica si fondano sul portato dell’esperienza di un incontro fondante tra un ‘organo sensoriale e un oggetto esterno che esercita sullo stesso un potere stimolante’[3]; la rappresentazione pittografica di questo incontro ha tuttavia la particolarità di ignorare la dualità che la compone.
Quello che invece questo incontro non può ignorare, pena una restrizione della vita psichica, è il tempo della attesa. Una attesa fondata su un ‘premio di piacere’, sul ritmo tra una esperienza di soddisfazione e la sua assenza; il compito dell’oggetto, secondo l’autrice, consiste nella capacità di sostenere il desiderio senza ridursi a far tacere il bisogno.
Mi sembra a questo punto importante sottolineare il clima emotivo di questo incontro e la necessaria partecipazione del corpo nel sostenerlo e definirlo: Winnicott sottolineava uno stato di rilassamento[4], Aulagnier la capacità di attendere, Bion, descrivendo la funzione di reverie, la capacità negativa: attesa e lavoro psichico. L’attenzione del corpo e al corpo sono entrambe fondanti.
Marion Milner (1974) è ancora più esplicita quando scrive che per anni era stata sempre sorpresa nel notare quanto scarsa fosse nella letteratura psicoanalitica l’attenzione alla funzione egoica consistente nell’imparare deliberatamente a rilassare il corpo intero, e, nello stesso tempo, la scarsa attenzione alla capacità del paziente di sentire il peso del corpo sul divano, oppure ai modi in cui tale rilassamento può essere raggiunto dirigendo volutamente l’attenzione sulle varie parti del corpo a contatto del divano ( 1974:521).
Tornando alle due ipotesi del compendio, entrambe richiedono, come sottolineava recentemente Riolo (2017), trasformazioni bidirezionali tra somatico e psichico, inconscio e conscio, interno ed esterno, con i relativi piaceri, dispiaceri, assenza di piacere (calma piatta).
Uno dei paradossi della coppia mente corpo è che, le trasformazioni tra somatico e psichico, inconscio e conscio, interno e esterno lavorano, paradossalmente, in simultaneità, ma con tempistiche diverse e ritmi propri. A proposito di simultaneità rispetto a uno spazio e a un tempo, riprendevo, in un precedente scritto (Badoni, 2014), il problema della comunicazione telepatica che tanto ha interessato Freud, come pure il fatto che due concetti fondanti per il nostro lavoro, esperienza e comunicazione, contemplino, allo stesso tempo, sia uno stato del sé, sia un essere in rapporto con l’altro. Il fattore tempo e il fattore ritmo sono fondanti per gli accordi o le stonature nella coppia mente corpo: lo strumento è difficile da suonare.
Basti pensare alla ripetizione, oggi considerata sia come un non tempo, o fuori dal tempo, sia come un lavoro nel tempo, resilienza più che resistenza, lavoro dolente, ma anche a suo modo curioso di un soggetto che non demorde, in cerca di soluzioni attendibili, se non soddisfacenti. Cosa sarebbe, senza ripetizione, il giocare dei bambini?
Quali i tempi di queste trasformazioni? Mi sono apparse altrettanto vere affermazioni molto diverse, rispetto al tempo nel lavoro psichico: così Freud parlava di un ‘calmo pensare per rappresentazioni’, mentre Danielle Quinodoz (2012) sottolineava l’importanza della intensità e dei riverberi del tempo presente, quando un accadimento puntuale è così ricco di immediata intensità, da lavorare dentro di noi per l’intero arco della vita: ‘secondi di eternità’.
Macchia (2008) ricorre invece alla metafora del lampo e del tuono: essi appaiono all’osservatore come due fenomeni diversi e distanziati nel tempo, ma in realtà originano da un unico fenomeno fisico.
Immediatezza, continuità, ritmo. Una musicalità e una poetica dell’incontro analitico, quest’ultima sottolineata da Balsamo (2015) che rammentava l’importanza del ritmo come strumento regolatore in grado di promuovere scambio e continuità, nuovo e identico, creazione e riscoperta di una forma stabile.
Torniamo ora al paradosso e pensiamo al Winnicottiano (1958) -essere solo in presenza- che si realizza quando l’immaturità dell’Io è naturalmente equilibrata dal sostegno dell’Io fornito dalla madre. Con il passar del tempo, l’individuo introietta la madre che dà sostegno all’Io ed in questo modo diventa capace di essere solo senza aver bisogno di fare frequente riferimento alla madre e al simbolo materno. Possiamo pensare che uno dei possibili sostegni che la madre fornisce all’immaturità dell’infante, sia proprio l’acquisizione di un ritmo, di un fiducioso sentimento di attesa, con i suoi tempi cruciali.
Winnicott (1975) descrive inoltre una condizione particolare, la ‘relazionalità dell’Io’(ego relatedness). Di nuovo siamo in presenza di un individuo immaturo, di nuovo occorre un adulto soccorrevole; Winnicott (1975, 36) afferma che quando è solo ( solo in presenza di qualcuno) e solamente quando è solo, l’infante è in grado di fare qualcosa di simile al rilassarsi dell’adulto, in grado quindi di diventare non- integrato, di agitarsi, di permanere in uno stato di disorientamento, di esistere per un po’ senza essere né qualcosa che reagisce a un urto dall’esterno, né una persona attiva con un’intenzione d’interesse o di movimento. È in tal modo che si costituisce la precondizione per un’esperienza dell’Id: secondo Winnicott grazie a questa precondizione e nel suo contesto, una sensazione o un impulso, quando arriveranno, sembreranno reali e costituiranno una esperienza personale autentica.
Quanto Winnicott c’è in Bion, ma mentre Bion ci cimenta attraverso concetti, Winnicott ci invita a partecipare, in diretta, a questo esistere per un po’, senza essere né una cosa, né un cervello, né soma, né intelletto, ma corpo mente che convergono, solidali, a consentire il senso di esistere. Winnicott è dentro la scena, ne ha fatto esperienza in vivo.
A partire da queste affermazioni, diventa indispensabile aprire e complicare il discorso a una relazionalità dove, i soggetti partecipanti, sono tutti espressione della coppia stranamente accoppiata costituita dal ‘corpo mente’ di ognuno. La clinica e la teoria del soggetto, allo stesso tempo, essere assoggettato e essere pensante, è una delle possibili declinazioni della capacità di essere solo in presenza. A questo serve l’oggetto ‘soggettualizzante’ (Cahn, 2006).
Oggi, dopo i pensieri di Winnicott e di Bion, consideriamo che la coppia ‘stranamente accoppiata’ prende forma e vive nel e del rapporto con un’altra coppia, anch’essa stranamente accoppiata: il corpo mente della madre, che, a sua volta, è intimamente a contatto col corpo mente del padre. Winnicott (ibid,32), in appoggio alla nozione di ‘essere solo in presenza’ considera anche la sessualità adulta. Egli afferma che dopo un rapporto sessuale soddisfacente ciascun partner è solo ed è contento di essere solo…di godere del condividere la solitudine, una solitudine che non è ritiro. In analogia, la turbolenza della coppia analitica al lavoro, gode di intimi silenzi che, lungi da essere momenti di ritiro, sono momenti di pensosa e goduta libertà.
Il recente congresso internazionale di psicoanalisi (Buenos Aires, 2017) ha tentato di esplorare questi eventi a partire dalla nozione di Intimità. Anche l’intimità è una questione paradossale, in quanto non è data senza portare in sé le tracce di un rapporto fidabile con un altro da sé, e, nello stesso tempo presume il ‘godere di condividere la solitudine’, una solitudine quindi che porta le tracce di un incontro e di un incontro godibile.
Wallon (1949), accennava a un ‘intimo sdoppiamento’ per descrivere la capacità del bambino di passare da un tempo in cui dà spettacolo di sé, a un tempo in cui può tollerare la ‘tristezza’ di intrattenersi da solo. La parola spettacolo ci immerge nella atmosfera emotiva dei teatri del corpo. Dare spettacolo è diverso dal proiettare, è più fiducioso nella presenza dello spettatore e di uno spettatore che provi emozioni: paura, rabbia, ma anche piacevole divertimento.
Anche il bambino, osservato e pensato così, non solo proietta, ma prova anche un qualche piacere nel dare spettacolo, tant’è che, se cala il sipario e il bambino resta solo, intimamente sdoppiato, dovendosi accontentare degli echi che lo spettacolo ha suscitato, proverà tristezza. L’intimità dovrà quindi comprendere, oltre alla esperienza del godimento, anche il senso del limite, a meno di affidarsi alla eccitazione, a un piacere masturbatorio.
In questo caso la parola tristezza, usata da Wallon, sta per essere solo in presenza o, osando un riferimento a Melanie Klein, come un sostare in una posizione depressiva. L’intimità è uno stato che richiede tempo e lavoro per essere raggiunto: si tratta infatti, contemporaneamente, di solitudine che non è ritiro e di un legame che si sviluppa nel tempo. Tensione e rilassamento regolano, in un unico movimento, la condivisione e il ritirarsi (Jullien, 2014). La dimensione del piacere non è assente in questa dimensione, ma la promuove e la trasforma.
La clinica
Dopo questa esposizione necessariamente condensata, riferirò elementi della mia esperienza di lavoro con la ‘coppia stranamente accoppiata’, una esperienza, fortunatamente, in continua trasformazione.
Molti anni fa, per caso e per curiosità, mi è capitato di fare esperienza, in presenza di un analista a questo formato, di quanto Marion Milner ipotizza nella breve citazione riportata precedentemente: portare attenzione al proprio corpo, portarla in presenza di un’altra persona, sentire il peso del proprio corpo quando si concede di potersi appoggiare: appoggiare non vuol dire arrendersi, neppure è ritirarsi, mentre avere un peso, metaforicamente e non solo, sta a significare il sentimento di esistere. L’infante è senza peso fin che è immerso nel liquido amniotico e sono le braccia pensanti della madre che lo convincono che il peso non solo può essere sostenuto, ma può essere la sorgente di un fiducioso sentimento di abbandono, di un lasciarsi andare al sonno e al sogno, portando dentro di sé l’attesa fiduciosa di un dopo, per aver sperimentato piacevolmente il ‘prima’. Ho così sperimentato le trasformazioni possibili legate al fatto di essere solo in presenza dell’altro. L’analisi mi ha successivamente permesso di approfondire questa breve esperienza, di assaggiarne il senso, di capire su che basi profonde si regge e soprattutto si mantiene.
Scandalosa e paradossale, questa esperienza contempla l’essere toccati dal terapeuta, scandalo perché gli analisti non toccano, paradosso perché il tatto, segnando contemporaneamente l’essere con e l’essere altro, rappresenta l’essere solo in presenza. Scriveva Carloni (1984) che Il tatto, ultimo per dignità, in quanto esteso anche alle parti meno nobili della persona, è il primo filogeneticamente dei nostri sensi ed è così elementare la sua funzione per la difesa della vita, che della possibilità di una sopravvivenza non puramente vegetativa rappresenta l’ultima prova. Continua l’autore affermando che, per traslato, s’indica con lo stesso termine l’arte di trattare il prossimo, fatta di accortezza, tempestività, opportunità, prudenza, garbo e misura: richiede elasticità e intelligenza, cioè, di continuo, adattabilità e inventiva per cogliere e risolvere ogni problema nuovo. Il traslato vuole evidentemente indicare l’acquisita consapevolezza che non si possa trattare con gli altri utilmente e senza danno se non facendo uso delle anzidette qualità alla ricerca del contatto migliore: il che non esclude che a volte migliore possa riuscire anche il contatto più risoluto e repentino. Si tratta di affermazioni lontane, ma molto attuali.
Solo recentemente si è iniziato a parlare di queste tematiche, non solo tra analisti addetti ai lavori, come da lungo tempo è pratica soprattutto tra gli psicoanalisti di lingua francese (Dechaud-Ferbus, 2011), ma dentro la quotidiana pratica analitica. Si segnala ad esempio, come l’attenzione del terapeuta e la sua responsività a comunicazioni non verbali, come pure a attività spontanee del corpo, compreso il toccare, possano consentire l’accesso alla intenzionalità dell’inconscio e a stati dissociati della mente (Cornell, 2016).
Forse potremmo ricordarcene non solo in presenza di quei pazienti che la Mac Dougall (1972) chiamava gli anti- analizzandi in analisi, ma anche imparando a intervenire con approcci più cauti e allo stesso tempo più incisivi, in quanto più vicini al funzionamento mentale dei pazienti. Si tratta di intercettare il livello della richiesta di aiuto e, come scriveva recentemente Virginia Ungar (2015), di poter disporre di una cassetta degli attrezzi, duttile e ben fornita.
Riflessioni su questo approccio terapeutico e sulla sua rilevanza nella situazione analitica, sono state da me riportate nel lavoro già citato (Badoni, 2014).
Quello che negli anni ‘70 ancora non sapevo, facendo la mia personale esperienza di “psicoterapia di rilassamento secondo de Ajuriaguerra”, era la mole di pensieri, di rapporti interculturali, di esperienza psicoanalitica che faceva e fa da sfondo a questa psicoterapia. Rimando, per approfondire queste tematiche, a un lavoro di prossima pubblicazione (Badoni, 2018) di cui riporto qualche concetto.
Riprendo, nel testo, il concetto di base proposto da Ajuriaguerra, quello di “Dialogo Tonico”, come sistema di comunicazione, iniziatico, tra infante e madre; prospetto la messa in forma di una “struttura dialogante” che vede agli inizi, madre e infante, comunicare per il tramite di stati tonici continuamente modulati” (Badoni, ibid.). Sottolineo l’importanza che, in questo dialogo, di natura non verbale, ma significante, l’infante possa ‘dire la sua’ e che la madre sappia porre attenzione, attendere, rispettare la qualità di queste comunicazioni.
Piera Aulagnier sottolinea questa capacità di attesa: su di essa si fonda la possibilità, per l’infante, di credere al suo sentire prima, ai suoi sentimenti poi, consentendo così una trasformazione continua dal sensoriale al sensuale.
La modulazione dell’affetto d’ansia sembra essere il messaggio privilegiato per i dialoghi della ‘coppia stranamente accoppiata’. Esso ha, anche nello stato tonico, il suo modo di espressione, dalla paralisi – angoscia automatica, ai pre-sentimenti, di cui l’affetto angoscia-segnale è il precursore. Freud ci ha reso attenti alle potenzialità trasformative di questo affetto: dall’angoscia che paralizza ogni attività mentale, all’angoscia che segnala uno stato di fatto e, per il solo fatto di segnalarlo, cerca di promuovere un lavoro mentale: la coppia stranamente accoppiata è obbligata a lavorare per trasformazioni. Tuttavia, molte di queste trasformazioni avvengono ‘a nostra insaputa’, come le neuroscienze ci insegnano, basti pensare al funzionamento dei neuroni specchio. Questo dovrebbe renderci curiosi, ma anche umilmente cauti nel nostro dialogo senza trarre giudizi affrettati sulla non rappresentabilità. Su questo concetto ha richiamato l’attenzione Roussillon (2015) riferendosi a diversi modi di simbolizzazione, un concetto di simbolizzazione quindi che contempli regimi diversi: simbolizzazioni primarie e secondarie. L’autore ritiene che la presenza di un affetto di spavento o terrore indica di per sé la presenza di una certa rappresentazione della scena traumatica, almeno in quanto segnala l’assenza di una rappresentazione accettabile.
‘Voir c’est recevoir, recevoir c’est donner à voir’, ripeteva Ajuriaguerra citando il poeta Eluard. Non a caso, nel descrivere il funzionamento del dialogo tonico, Ajuriaguerra parlava di ‘risonanze ansiose’. Perché vi sia risonanza occorre la presenza di un oggetto che risuoni, di un ‘ostacolo accogliente’, questo sottolinea la nozione di dialogo tonico. Il lavoro dell’ansia gioca qui la sua parte. Il tono del dialogo suggerisce non solo il tono muscolare, ma il grado di vitalità (su di tono, giù di tono, atonico) e la tensione emotiva.
Dovremmo non liquidare frettolosamente anche i minimi accenni di allerta, o anche di piacevole tensione emotiva, così come i lievi moti di contrarietà rispetto al modo e al contenuto delle comunicazioni dei pazienti. Se poi “ci sentiamo dire qualche cosa”, abbiamo altre risorse: risuonare non vuol dire colludere. Trattando di simbolizzazioni primarie e secondarie, Roussillon sottolinea la possibilità di rappresentare senza avere coscienza di rappresentare e di tutte le trasformazioni che l’esperienza subisce nel suo processo di interiorizzazione e di iscrizione psichica.
Ho cercato di mettere in luce le potenzialità degli attrezzi del nostro lavoro, al training analitico, nelle sue diverse articolazioni, spetterebbe il compito di saperli utilizzare.
Bibliografia
Aulagnier, P. (1975). La violence de l’interprétation Du pictogramme à l’enoncé. PUF, Paris.
Badoni, M. (2014). Corpo. Rivista di Psicoanal., 60(4):917-932.
Badoni, M. (2018) Dialogo tonico e Dialogo analitico. In: Comunicare, n.1, 1/2018, in corso di stampa.
Balsamo, M. (2015). The Area of the «Poetic» in Borderline States. The Italian Psychoanalytic Annual, 9:51-69
Bezoari, M. (2007). Che cosa si prova a essere un cervello?: La questione della specificità nel rapporto tra psicoanalisi e neuroscienze. Rivista diPsicoanal.,53(3):707-715.
Carloni, G. (1984). Tatto, contatto e tattica. Rivista di Psicoanal., 30(2):191-205.
Cahn, R. (2006). Origini e destini della Soggettivazione. In: Richard, F. Wainrib S. La Soggettivazione, Roma, Borla, 2008.
Cornell, W. (2016). The Analys’s Body at Work: Utllizing Touch and Sensory Experience in Psychoanalytic Psychothertapies. Psychoanalytic Perspectives, 13(2):168-185.
Dechaud-Ferbus M. (2011). Cet autre divan. PUF, Le fil rouge, Paris.
Ferraro, F. (2011). La clinica del corpo: Appunti per un confronto. Rivista di Psicoanal., 57(2): 349-367.
Ferro, A. (2014). Le viscere della mente. Sillabario emotivo e narrazioni. Raffaello Cortina ed., Milano.
Freud, S. (1895). Progetto di una Psicologia. (O.S.F., 2).
Freud, S. (1892-1895). Studi sull’Isteria. (O.S.F,1).
Fred, S. (1901). Frammento di un’analisi di isteria. (O.S.F.,4,333):
Freud, S. (1904). Psicoterapia. (O.S.F.,4, 433).
Freud, S. (1915). Metapsicologia. (O.S.F.,8).
Freud, S. (1922). L’Io e l’Es. (O.S.F., 9, 488).
Freud, S. (1938). Risultati, Idee, Problemi. (OSF.,11, 566).
Freud, S. (1938). Compendio di Psicoanalisi. (OSF., 11,572).
Gallese, V. (2014). Quali neuroscienze e quale psicoanalisi: Intersoggettività e Sé corporeo: Appunti per un dialogo. Rivista di Psicoanal., 60(3):687-703
Grotstein, J.S. (1997). ‘Mensa Sana in Corpore Sano’: The Mind and Body as an “Odd Couple” and as an Oddly Coupled Unity. Psychoanalytic Inquiry, 17(2): 204-222.
Green, A. (1990). La Folie privée. Gallimard, Paris.
Imbasciati, A. (2010). Toward New Metapsychologies. Psychoanal.Rev., 97(1):73-90.
Lopez Corvo, R.(2005). The Dictionary of the Work of W.R. Bion. Karnac ed. London
Jullien, F. (2014). Sull’ intimità. Lontano dal frastuono dell’Amore. Raffaello Cortina ed., Milano.
Macchia, A. (2008). Sul nastro con Moebius. Rivista di Psicoanalisi, 54(4):1057-1064
Manica, M. (2005). IPA 44th Congress. “Trauma:new development in psuchoanalysis”. Appunti di viaggio. Rivista di Psicoanal, 51(4):1331-1343.
Mattana, G. (2017). Psicoanalisi e filosofia della mente. Rivista di Psicoanal., 1, pp. 75-94.
MCDougall, J. 1972 The anti-analysand in analysis In Psychoanalysis in France ed. S. Lebovici & D. Widlöcher. New York: Int. Univ. Press, 1980 pp. 333-354.
Milner, M. (1969). Trad. italiana: Le mani del dio vivente., Armando, Roma, 1974.
Monniello, G., Quadrana L., (2010). Neuroscienze e mente adolescenziale. Magi ed., Roma
Quinodoz, D. (2012). Inscrire sa vie dans le temps. Rev. Belg Psychanal., 61:19-34.
Riolo, F. (2017). Del principio del piacere. Rivista di Psicoanal., 3, pp. 519-525.
Roussillon, R. (2013). Pluralité et complexité en psychanalyse. Rom.J.Psychoanal.,6(1):13-30.
Roussillon, R. (2015). Un’introduzione al lavoro sulla simbolizzazione primaria. Rivista di Psicoanal.2, pp.477-492.
Ungar, V. (2015). La cassetta degli attrezzi del mestiere dell’analista: L’interpretazione rivisitata. Rivista di Psicoanal., 61(2): 493-512.
Wallon H. ,( 1949 ). Le origini del carattere nel bambino. Trad. It. Editori Riuniti, Roma, 1974.
Winnicott, D.W. (1958). The Capacity to be Alone. Int. J. Psycho-Anal., 39:416-420. Trad. Italiana in: Sviluppo affettivo e ambiente. Armando ed. Roma, 1970, p.34.
Winnicott, D.W.(1965). Trad. It. Sviluppo affettivo e ambiente. Armando, Roma, 1974.Nte
[2] Inteso da Intendere : “Volgere i sensi e la mente a qualche oggetto…tendere a un fine, avere intenzione, volere…percepire e comprendere, che sono in un certo modo l’effetto del tendere l’attenzione”
[3] Nella teorizzazione della Aulagnier: bocca/seno materno
[4] Rilassamento non nel senso della distensione a ogni prezzo, ma del prendere quello che viene
Corpo nella psicoanalisi (Il)

Ives Klein, 1962
L’interesse per il corpo e la relazione corpo-mente è presente nella psicoanalisi fin dalla sua nascita, ed è, oggi, tornato al centro del dibattito.
Freud attribuì un ruolo centrale al corpo a partire dagli Studi sull’isteria (1895), in cui osservò che alcune sue pazienti presentavano sintomi somatici associati a disturbi psichici. Ravvisò una connessione tra fisico e mentale in conseguenza della quale elaborò il concetto di pulsione (Pulsione e loro destini 1915) come «limite tra lo psichico e il somatico» .
Il significato psicoanalitico del corpo assume ancora maggior centralità nella seconda topica, nell’Io e l’Es, in cui il corpo svolge quella funzione dell’Io necessaria alla costituzione del senso d’identità. «L’Io è innanzitutto un’entità corporea» (Freud,1928:488) e Freud più tardi aggiungerà: «L’Io è in definitiva derivato da sensazioni corporee, soprattutto dalle sensazioni provenienti dalla superficie del corpo. Esso può dunque venire considerato come una proiezione psichica della superficie del corpo». Il corpo e i suoi affetti, nonostante ancora un certo dualismo corpo-mente presente in Freud, diventano prioritari nella costruzione dell’Io.
Successivamente, la psicoanalisi ha considerato il legame tra il corpo e la mente fondamentale nella strutturazione dell’Io e nella relazione con la realtà. Winnicott e Bion svilupperanno una concezione più vasta rispetto a Freud, di maggiore continuità tra l’organico e lo psichico.
Winnicott (1949-1950) individua nella corporeità il punto di partenza e sviluppo dell’Io. Per l’autore, gradualmente arriviamo a vivere noi stessi come abitanti dei nostri corpi ed esiste una sola unità «psiche-soma». Quando la mente é legata al corpo, attraverso l’«holding materno» si sviluppa il vero Sé. Isolata dal corpo, si potrà soltanto sviluppare il falso Sé.
Bion (1950) concentra la sua osservazione sugli organi di senso come strumento di accesso alla percezione della realtà e condensa nella “griglia” un modello secondo il quale il pensiero è una diretta evoluzione dei livelli sensoriali. Partendo dallo scritto di Freud Sui due principi dell’accadere psichico (1911), Bion amplia l’ipotesi di Freud e ritiene che pensiero ed emozione siano inseparabili e che il corpo sia il punto di avvio per i fenomeni di pensiero. La mente si sviluppa attraverso un continuo processo di apprendimento dall’esperienza emotiva (Apprendere dall’esperienza, 1962) ed è in continua trasformazione, attraverso un processo dinamico. La capacità di contenimento ed elaborazione delle emozioni è alla base del fare esperienza e del poter utilizzare la funzione della mente, che viene esperita dal bambino sin dalla nascita «attraverso la reverie materna».
Il ruolo delle emozioni vissute – punto cardine per Bion – dà in questo modo avvio ad una nuova psicoanalisi. L’analisi e la relazione analitica attivano un funzionamento mentale capace di reggere l’impatto con le emozioni e permettono il cambiamento. Il corpo concreto, nel qui e ora della seduta psicoanalitica, viene considerato da Bion come una potenzialità di pensiero in divenire, come un pensiero in attesa di essere pensato, laddove il ruolo dell’analista può essere assimilato a quello della levatrice di un pensiero che sta per nascere (Lombardi 2016).
Sviluppi attuali
Attualmente il legame tra il corpo e la mente è considerato fondamentale dalla psicoanalisi e i numerosi contributi teorici sviluppano una concezione più ampia tra l’organico e lo psichico. Marty (1976-80) ipotizza la natura psicosomatica dell’inconscio e dell’emergere del corpo nella depressione essenziale. Mahler e McDevitt (1982) sviluppano osservazioni psicoanalitiche sulle fasi precoci dello sviluppo individuale, mettendo in evidenza l’importanza delle funzioni corporee e sensoriali nel bambino. Bick (1968) evidenzia come il ruolo della pelle influenzi l’interazione oggettuale precoce. Gaddini (1989), attraverso le sue osservazioni cliniche sui disturbi risalenti alle prime fasi dello sviluppo postnatale, descrive un’organizzazione mentale di base (OMB) che comprende fenomeni tanto elementari quanto complessi del primo organizzarsi della mente ai confini del corpo. McDougall (1982, 1995) mette in rilievo le implicazioni psicoanalitiche sulla corporeità dando voce al linguaggio del corpo, che trova espressione nella relazione analitica permettendo al corpo stesso di esprimersi in maniera simbolica. Didier Anzieu (1985) ritiene che la pelle serva come un modello di un Io primitivo, che definisce “Io pelle”. Assoun (1997), attraverso il suo lavoro sulla clinica del corpo, ripercorre le teorie di Freud ed evidenzia come nel pensiero freudiano non vi sia una categoria omogenea del corpo. Aron Anderson (1988) segnala come l’esperienza del corpo possa nascere nell’esperienza analitica. Ogden (1989) individua nella modalità contiguo-autistica la base sensoriale dell’esperienza (il Sè si sviluppa a partire dalle sensazioni corporee, in particolare su sensazioni cutanee). Egle Laufer (1991, 2005) considera il corpo come «un oggetto interno» che si crea fin dalle prime esperienze con la madre e con il suo corpo. Resnick (2002) individua nel ruolo del corpo la nascita della persona ed evidenzia come nella psicosi la negazione del corpo determini la depersonalizzazione.
Più di recente la psicoanalisi si è dovuta anche confrontare con i progressi nel campo psico-biologico e delle neuroscienze e ha dovuto recuperare la centralità del corpo sia nella teoria che nella clinica (Lombardi 2016), per rispondere, anche, alle nuove tipologie dei pazienti (Gaddini 1984, Lombardi 2016). Anche lo sviluppo dell’informatica e l’intelligenza artificiale hanno profondamente influenzato il funzionamento mentale (Lingiardi 2008, Lemma 2010), offrendo da una parte evidenti vantaggi, dall’altra rendendo ancora più problematica la relazione corpo-mente (Lombardi 2016). Già Freud (1929) nel Disagio della civiltà segnalava sia positivamente che in senso problematico quanto lo sviluppo della tecnica avesse ampliato il potere dell’uomo. Oggi siamo di fronte a una «mutazione antropologica», come disse Pasolini, e l’uomo, trasformato in macchina, si allontana dal corpo e quindi dal suo sentire-pensare e dalla relazione con sé stesso. Il corpo e la mente sono come catturati e talvolta intrappolati: computer e smartphone sempre più sofisticati hanno creato nuove forme di comunicazione sociale (Lombardozzi, 1977) e sono diventati «oggetti-protesi», con cui viviamo in perfetta simbiosi, con cui dialoghiamo e da cui dipendiamo. Oggetti sé, «sempre più umanizzati e dotati di funzioni mentali» (Lingiardi 2017), con cui interagiamo in un cyberspace dove possiamo correre il rischio di perdere l’ancoraggio al corpo e diventare «macchina acefala».
Una prospettiva clinica
Se l’identità in senso biologico – «Io sono corpo», scrive Merleau-Ponty (1945) – vacilla, siamo, come analisti, chiamati ad aiutare chi si rivolge a noi nel complesso cammino della soggettivazione. La soggettività, in accordo con Matte Blanco, ripreso da Grotstein (2004), è comprensiva dell’intera personalità e dei suoi sé componenti (Grotstein 2004) ed «emerge quando la mente diviene consapevole di sé stessa nell’atto del percepire e di rispondere ad un oggetto». Grotstein (2004) aggiunge, sulla scia di Tausk (1919) e Federn (1952 ), che il bambino nasce «con una psiche che ancora deve essere incarnata e solo quando la mente accetta la responsabilità della sua soggettività diventa “soggetto dell’essere”» (Grotstein 2004, pag. 152), ossia persona al centro della sua storia come protagonista responsabile della sua vita. Al di fuori di questo processo c’è l’«indifferenziato Io vuoto», che la Tustin (1990), nel parlare dei nuclei autistici, chiama «buchi neri» (S.Vegetti Finzi, 2002). Per accedere ad un Io vivo, è necessario partire dalle sensazioni e dalle emozioni generate dal corpo-mente.
- Ferrari e R. Lombardi sviluppano una innovativa concezione sul corpo e sulla relazione corpo-mente e sul valore del corpo rispetto alla realtà psichica. Le loro osservazioni cliniche si rivelano particolarmente efficaci con i pazienti per i quali è compromessa sia la capacità di pensiero che il contatto con le emozioni, e le loro ricerche rivelano elementi di accordo con altre discipline. Per esempio, concordano con Damasio nel riconoscere la necessità di una continuità tra mente e corpo, e con la Bucci (1997) in riferimento alla teoria del codice multiplo e al concetto di subsimbolico riferito al corpo, che comprende l’unità mente-corpo.
Ferrari sviluppa e amplia il pensiero di Bion e individua nel corpo, oggetto originario concreto della mente (OOC), il punto da cui ha origine il funzionamento mentale. Il corpo, inteso in senso fisico, genera sensazioni, percezioni ed emozioni a partire dagli organi di senso, gli «organizzatori fisici», che hanno funzione di coordinamento delle sensazioni percepite. Tale funzione é equiparata ad una funzione psichica. Grazie alla reverie materna, si abbassa la pressione marasmatica, il corpo si «eclissa» e si avvia la nascita dei primi fenomeni mentali.
Dalla registrazione del dato sensoriale hanno origine due relazioni primarie: “verticale” (corpo-mente), riferita alla relazione che il soggetto intrattiene con sé stesso, e “orizzontale” (bambino-madre), che attiene alle relazioni interpersonali, laddove nella relazione analitica il primo interlocutore è l’analista.
La relazione verticale si andrà articolando attraverso la capacità di simbolizzazione, rappresentazione e astrazione. Le emozioni, originate dalle sensazioni corporee, vengono filtrate attraverso una funzione che Ferrari ha definito «rete di contatto» e si attiva a partire dal corpo nell’interscambio tra sensazione, emozione e pensiero.
Alla luce di questa ipotesi la relazione corpo-mente è vista in una continua dinamicità e movimento disorganizzante-organizzante, armonico-disarmonico. Nella condizione armonica corpo e mente sono integrati e in dialogo tra loro; in quella disarmonica, in cui predomina una sensorialità marasmatica che compromette le capacita riflessive e di pensiero, si sviluppa una conflittualità tra corpo e mente, come nelle psicosi. Se, all’opposto, c’è un’eccessiva prevalenza di astrazione intellettuale e uno scarso interesse per le sensazioni e le emozioni e i sentimenti , il corpo può essere attaccato concretamente fino a scomparire all’orizzonte della mente, come avviene in particolare nelle patologie alimentari (Lombardi 2016). La disarmonia corpo-mente è spesso legata a lacerazioni molto precoci della personalità a causa della mancata reverie.
Lombardi individua nel corpo e nella relazione corpo-mente, così come nella conflittualità che si può generare tra queste due entità, il centro della sua ricerca clinico-teorica, il cui focus non è il corpo pulsionale, ma i limiti posti dal nostro stesso corpo, in grado di «generare una conflittualità specifica che ci fa sentire schiavi nonché prigionieri della nostra natura concreta» (Lombardi 2016). La conseguenza di questo conflitto, come è stato segnalato da molti autori e come esperiamo nella clinica oggi, è l’irraggiungibilità di certi pazienti nel contesto delle relazioni interpersonali, in cui é il corpo del soggetto a diventare irraggiungibile dalla mente, e viceversa, tanto che essi si escludono a vicenda ingenerando una dissociazione corpo-mente.
La dissociazione di cui si parla si differenzia da quella comunemente studiata, frutto di un conflitto non primario e legata a situazioni traumatiche non elaborate. Lombardi, in sintonia con Ferrari, si riferisce a forme disarmoniche in cui il conflitto corpo-mente diventa intollerabile e il corpo continua ad esistere concretamente, ma scompare all’orizzonte della mente. Se consideriamo che l’accoglimento e la considerazione che la mente ha del corpo è alla base di ogni operazione pensante, la conseguenza è che l’assenza di riferimento alla realtà del corpo implica l’assenza della mente.
La relazione e lo spazio analitico diventano il luogo dove il corpo reale del paziente e quello dell’analista sono in reciproca relazione, e in questa interrelazione si costruisce un ponte tra corpo, affetto e pensiero (Lombardi, 2000). Il transfert e il contro-transfert si declinano come «transfert sul corpo», inteso come prima risposta alla necessità di creare un primo nucleo di funzionamento nel paziente, il quale, riconoscendosi nella sua essenza corporea, sperimenta una base di partenza per un Io funzionante. Successivamente potrà consentire al paziente stesso un lavoro ricostruttivo quando è in relazione con il suo corpo e le sue emozioni (Lombardi 2016).
Il controtransfert corporeo è riferito al transfert dell’analista sul proprio corpo «come condizione necessaria per accompagnare l’elaborazione di avvicinamento dell’analizzando al proprio corpo» (Lombardi 2016). Nel controtransfert somatico è l’analista nella sua globalità ad essere coinvolto per contenere prima di tutto nel proprio corpo le manifestazioni pre-simboliche e concrete, che anticipano la nascita di fenomeni emozionali e mentali (Bion1979), affinché si creino le condizioni per l’attivazione della funzione Alfa e quindi la generatività dei primi fenomeni consci e inconsci (Bion 1962; Lombardi – Pola 2010).
BIBLIOGRAFIA
Anzieu D. (1985), L’io-pelle, Roma, Borla, 1997
Aron L., Sommer Anderson F. (1998), Il corpo nella prospettiva relazionale, Bari, La biblioteca, 2004
Assoun P.L. (1997), La clinica del corpo, Milano, Franco Angeli, 2004
Bick E. (1968), L’esperienza della pelle nelle prime relazioni oggettuali, in Isaacs S. et al., L’osservazione diretta del bambino, Torino, Bollati Boringhieri, 1984
Bion W.R. (1962), Apprendere dall’esperienza, Roma, Armando, 1972
– (1950) Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico. Saggi e considerazioni, Roma, Armando, 1979
Bucci W. (1997), Psicoanalisi e scienza cognitiva. Una teoria del codice multiplo, Roma, Fioriti, 2009
Cargnelutti E., Ciocca A., Ginzburg A., Lombardi R., Natali P. (2008), Disarmonie della relazione corpo-mente: osservazioni cliniche e tecnica psicoanalitica, in Riv. Psicoanal., 54, 11-29
Camassa P. (2010), Anoressia: un’epidemia del corpo come “oggetto superiore”, in Riv. Psicoanal., 56, 549-560
Ciocca A. (1998), La dissociazione psicosomatica, in Ciocca A., Larosa C., Lombardi R., Turno M., in Riv. Psicoterapia e Istituzioni, 1, 103-120
Damasio A.R. (1994), L’errore di Cartesio. Emozione ragione e cervello umano, Milano,
Adelphi, 1995
Ferrari A. (1992), L’eclissi del corpo, Roma, Borla
– (1994), Adolescenza. La seconda sfida. Considerazioni psicoanalitiche sull’adolescenza, Roma, Borla
Freud S. (1892-95), Studi sull’isteria, O.S.F, 1
– (1915 -1917), Pulsione e loro destini, O.S.F, 8
– (1922), L’Io e l’Es, O.S.F., 9
– (1911) Precisazione sui due principi dell’accadere psichico, O.S.F., 6
– (1929) Il disagio della civiltà, O.S.F., 10
Gaddini E. (1980), Note sul problema mente corpo, in Scritti (1953-1985), Milano, Cortina, 1989
– (1984), Se e come sono cambiati i nostri pazienti fino ai giorni nostri, in Riv. Psicoanal., 30, 560-80
Grotstein J.S. (2000), Chi è il sognatore che sogna il sogno?, Roma, Maggi, 2004
Laufer M. E. (2005), Le corps comme objet interne, in Adolescence, 52, 363-79
Lemma A. (2005), Sotto la pelle. Psicoanalisi delle modificazioni corporee, Milano, Cortina
– (2010), An Order of Pure Decision. Growning up in a Virtual Word and the Adolescent’s Experience of Being-in-A-Body, in Journal of American Psychoanalysis,78,855-75
Lingiardi V. (2008), Playing with Unreality. Transference and Computer, in The International Journal of Psychoanalysis, 89, 111-26
– (2017) Non sogniamo pecore elettriche ma smartphone, in La Repubblica 19 agosto 2017
Lombardi R. (2000), Corpo, affetti, pensieri. Riflessioni su alcune ipotesi di I. Matte Blanco
e A.B. Ferrari, in Riv.Psicoanal., 46, 683-706
– (2003), Catalyzing the Dialogue between the body and the Mind in a Psychotic Analysand, in The Psychoanalytic Quarterly, 72, 1017-41
– (2008), The body in the analytic session: Focusing on the body-mind link, in Int. Journal of Psychoanalysis, 89, 89 -109
– (2016), Metà prigioniero, metà alato. La dissociazione corpo-mente in psicoanalisi, Torino, Bollati Boringhieri
Lombardi R., Pola M. (2010), The body, Adolescence, and Psychosis, in Journal of the Ameican Psychoanalytic Association, 91, 1419-44
Lombardozzi A. (2007), Tecnologie mediatiche: nuovi paesaggi del Sé. Una prospettiva di antropologia psicoanalitica, in Psiche, 2, 61-81
Mahler, Margaret S., McDevitt J. (1982), Thoughts on Emergence of the Self, with Particular Emphasis on the body Self, in Journal of the American Psychoanalytic Association, 30, 837-48
Marty P. (1980), L’ordre Psychosomatique, Paris, Payot
Matte Blanco I. (1975), L’Inconscio come insiemi infiniti, Torino, Enaudi, 1981.
McDougall J (1989), Teatri del corpo, Milano, Cortina, 1990
Merleau-Ponty M. (1945), Fenomenologia della percezione, Milano, Il Saggiatore, 1972
Migliozzi A. (2017), Il Corpo strumento per vivere e comprendere. Una riflessione sul lavoro di R. Lombardi, relazione svolta presso il Centro di Psicoanalisi Romano il 9 giugno 2017, in corso di pubblicazione
Muroni M., Pola M. (2009), Sentire “le voci”: il delirio in adolescenza tra psicosi ed esperienza, in Busato C., Adolescenza e psicosi, Milano, Franco Angeli
Ogden T.H. (1989), Il Limite Primigenio dell’Esperienza, Roma, Astrolabio, 1992
Pola M. (2012), Fuga nella fantasia come dissociazione corpo-mente, in Riv. Psicoanal. 2, 437-452
Preta L. (2005), Editoriale, in Psiche, XIII, 1
Resnik S. (1972), Persona e psicosi, Torino, Enaudi, 1976
Solano L. (2013), Tra mente e corpo. Come si costruisce la salute, Milano, Cortina.
Tustin F. (1990 ), Protezioni autistiche nei bambini e negli adulti, Milano, Cortina, 1991
Tausk V. (1919), Sulla genesi della macchina influenzante nella schizofrenia, in Scritti psicoanalitici, Roma, Astrolabio, 1979
Veggetti Finzi S. (2002) Io-corpo-macchina e nuovi costrutti d’identità, in Psiche, 149-169
Winnicott D.W. (1949), L’intelletto e il suo rapporto con lo Psiche-Soma, in Dalla Pediatria alla Psicoanalisi, Firenze, Martinelli, 1975
– (1970), Sulle basi di Sé nel corpo, in Esplorazioni psicoanalitiche, Milano, Cortina, 1995
Cutting -Tagliarsi
A cura di Maria Naccari Carlizzi
Definizione
Si chiama Cutting la diffusa e attuale tendenza da parte dei teenager, di solito ragazze, a tagliare, incidere, ferire la superficie della propria pelle, soprattutto di gambe e braccia, con lamette, coltelli affilati, temperini, punte di vetro, lattine usate, o quant’altro. Può trattarsi di un singolo episodio o diventare abituale. Il cutting può diffondersi in modo epidemico in gruppi di amici, o di pari anche grazie alla rete, con un escalation di progressiva emulazione e autoemulazione.
Gli adolescenti di oggi, infatti, usano il corpo, la superficie della pelle e le sue modificazioni autoindotte come mezzo per reclamare il corpo e per comunicare con un segnale potente un potenziale disagio. In un crescendo variabile di concreti linguaggi lungo la linea che va dai tatuaggi, ai piercing, alle marchiature, alle bruciature, sino al self cutting, il cutting si colloca, nella maggior parte dei casi, nell’ambito dell’autolesionismo “superficiale/moderato” (DSM-5).
Ma perchè la pelle, viene adoperata come superficie d’iscrizione, una tela, suggerisce A. Lemma (Lemma, 2005), su cui la sofferenza psichica viene esteriorizzata e lavorata?
Il corpo è l’interfaccia tra l’individuale ed il sociale. Dall’origine della vita la superficie della pelle svolge molteplici funzioni nello sviluppo della personalità: quella di involucro psichico, di mediatrice dell’attaccamento e delle relazioni attraverso le esperienze corporee primarie madre bambino, legate alla vista, allo sguardo e al contatto fisico e emotivo. La percezione del corpo è una costruzione progressiva che si realizza a livello intrapsichico, intersoggettivo, interpersonale e sociale. In adolescenza le trasformazioni psichiche e somatiche contribuiscono a determinare la riorganizzazione delle rappresentazioni di sè, l’integrazione del nuovo corpo sessuato, dei nuovi aspetti dell’aggressività, del narcisismo, dell’identità.
Ogni lesione cutanea autoindotta ed il selfcutting, in particolare in adolescenza, rappresenta, un fenomeno complesso da decodificare, che risponde a diversi bisogni psicodinamici e a organizzazioni mentali spesso differenti.
A livello gruppale può essere sotteso da molteplici variabili sociologiche e antropologiche (Le Breton, 2004) come le dinamiche psichiche che legano l’adolescente al gruppo dei pari, dove il cutting può essere usato per sancirne l’appartenenza e per definire l’identità comune.
Bisogna, quindi, valutare in modo specifico quale funzione, nell’economia psichica di un ragazzo, ad un particolare punto del suo sviluppo psichico, in una data famiglia e in una specifica cultura, rappresenta l’uso del linguaggio del cutting.
Il cutting, di solito, costituisce un codice non verbale, per esprimere la sofferenza iconica, ancora non verbalizzabile ma proiettabile e rappresentabile sulla propria pelle, un tentativo di tagliarla via per il fallimento del contenimento dell’ambiente e dei processi di simbolizzazione.
Soprattutto in questo caso C. Chabert (2000) parla di “tentativi di figurazione” … “tra l’intenzionalità conscia e inconscia”che funzionano quindi come “una difesa e un’elaborazione”. L’adolescente prova a comunicare, talvolta in modo impulsivo col cutting, attraverso la superficie della pelle, tentando di trovare in se stesso e/o nell’ambiente a cui implicitamente chiede aiuto, delle risorse per prendere tempo, poter cambiare e trasformarsi.
Più il cutting è diffuso a tutto il corpo e grave, più la psicopatologia sottostante è complessa e suggerisce vari gradi di compromissione del processo, specifico dell’adolescenza, di integrazione del nuovo corpo sessuato. Così il corpo da “involucro narcisistico”che garantisce la sicurezza del bambino diventa un “involucro di sofferenza” (Anzieu 1985). Il corpo può essere negato, odiato e sottoposto a scissione, attaccato come un oggetto esterno o estraneo, sino ad agire veri e propri tentativi di suicidio, anche se nella maggior parte dei casi chi si ferisce con il cutting non vuole uccidersi.
Lemma (Lemma 2005) descrive numerose fantasie inconsce, che possono sostenere la ricerca di modificazioni corporee e, quindi, del cutting:
– Negare “la separazione o la perdita, con la fantasia inconscia di fusione con l’oggetto ed il rifiuto di elaborare il lutto per il corpo perduto”, ed in adolescenza a mio avviso, il riferimento va al corpo dell’infanzia ed al legame con il corpo della madre.
– Tentare “la separazione con la fantasia inconscia di strappare, tagliar via l’altro alieno, sentito risiedere dentro il corpo” ed, in adolescenza, ritengo che si tratti spesso della difficolta di riconoscere come proprio il corpo sessuato.
– “Coprire un corpo vissuto con vergogna, con la fantasia inconscia di distrarre e controllare lo sguardo dell’altro” ed in adolescenza, oltre che alle già citate problematiche, ci si può riferire al campo delle dismorfofobie e della bruttezza immaginaria.
– “Risanare un senso interno di frammentazione, con la fantasia inconscia di identificazione con l’immagine dell’altro che ristabilirà un senso di coesione interna”ed in adolescenza possiamo chiamare in causa, per esempio, le difficoltà di integrazione delle nuove sensazioni generate dal corpo e le difficoltà identitarie in genere.
– “Attaccare l’oggetto, con la fantasia inconscia di infliggere un dolore e punirlo”, dove l’oggetto in adolescenza è il corpo dell’adolescente stesso e il legame con il corpo della madre.
Il cutting svolge per l’adolescente molteplici funzioni (cfr. voce SPIPEDIA Autolesionismo, Rossi Monti e D’Agostino 2009) volte a:
– “Concretizzare” (Rossi Monti e D’Agostino, 2009): -Voglio tagliarmi per far vedere che soffro! … col taglio tiro fuori il dolore, guarda mamma come soffro!- Il cutting serve a trasformare il dolore psichico in dolore agito, fisico, corporeo distribuito sulla superficie del corpo, per dare una forma a sentimenti incontrollabili nel tentativo di conoscerli, o riempire il vuoto interno con il dolore, esterno, fisico, reale, quantificabile e controllabile, dato che è autoprodotto.
– “Punire, estirpare, modificare la parte cattiva di sé e purificarsi” (Haas, Popp, 2006).- Mi taglio quando sto troppo male e mi calmo solo quando inizia ad uscire il sangue!- Il cutting rappresenta un tentativo protoverbale di liberarsi da un passato traumatico, del nuovo corpo adolescenziale divenuto estraneo ed origine di sensazioni perturbanti per cui, diventa oggetto da attaccare, odiare, aggredire.
– “Regolare l’umore disforico” (Rossi Monti e D’Agostino, 2009) dell’adolescente borderline, impadronendosi del proprio dolore interiore. – Quando non cela faccio più vado al bagno a scuola e mi tagliuzzo un po’ con una lametta sul braccio, poi quando mi sento meglio, torno in aula!-.
– “Comunicare senza parole”e trovare un canale espressivo per qualcosa che le parole non riescono a dire perchè evocativo del trauma subito, come nei casi di abusi fisici e psichici, per controllare comportamenti ed emozioni altrui o per favorire risposte di accudimento come negli adolescenti deprivati che vivono in comunità o istituzioni – mi piace quando dopo che mi taglio vengo lavata, medicata e fasciata!-
– “Costruire una memoria di sé”, -Il mio corpo è un diario!- come si legge in “Quando la pelle parla” di Educazione siberiana, (Lilin, 2009) dove i tatuaggi rappresentano un linguaggio che aiuta le persone nella reciproca conoscenza. L’adolescente, o l’adolescente borderline, che ha difficoltà nell’integrazione della storia dei suoi eventi emotivi, usa il cutting per non dimenticarli, fissandoli sulla pelle con una cicatrice e poter così ritrovarli in futuro.
– “Volgere in attivo, cambiare pelle” – Del mio corpo faccio quello che voglio!- Il cutting ribalta l’esperienza di passività tipica dell’adolescenza trovando un senso, consentendo una nuova figurazione, o infrange “l’esperienza di depersonalizzazione” (Rossi Monti, D’Agostino, pag 85) in cui l’adolescente vive.
Bibliografia:
– Anzieu D. (1985), L’Io pelle. Roma: Borla 1987.
– Bick, E. (1968), L’esperienza della pelle nelle prime relazioni oggettuali. In L’osservazione diretta del bambino. Torino: Boringhieri, 1989.
– Chabert, C. (2000), Le passage à l’acte: une tentative de figuration? Adolescence, Monographie ISAP, pp57-62
– Fattori L. Un’adolescente disabile: la pratica del self cutting su un corpo già-ferito- Rivista di Psicoanalisi, 2013, LIX,1Gennaio/marzo 2013
– Freud S. (1922) L’Io e L’Es (pag 488) OSF , vol.9 Torino: Boringhieri.
– Haas, B., Popp F., (2006), Why DoPeople Injure Themselves?, in “Psychopatology”, 39, pp.10-8.
– Lemma A. (2005), Sotto la pelle. Psicoanalisi delle modificazioni corporee. Milano:Raffaello Cortina (2011).
– Le Breton, D. (2004), La profondeur de la peau: les signes d’identitè à l’adolescence. Adolescence, 22,2, pp.257-271
– Lilin N. (2009), Educazione siberiana. Torino: Einaudi
– Naccari Carlizzi M., Adolescenti postmoderni. Intervento nel dibattito SPIWEB L’adolescente e il suo corpo (15 febbraio-15 maggio 2013).
– Nicolò A.M., Corpo e difese patologiche in adolescenza. Relazione introduttiva nel dibattito SPIWEB L’adolescente e il suo corpo (15 febbraio-15 maggio 2013).
– Rossi Monti M., D’Agostino A. L’autolesionismo, Roma: Carocci editore (2009).
– Ruggero I., Il corpo dell’adolescente: un familiare estraneo. Relazione introduttiva nel dibattito SPIWEB L’adolescente e il suo corpo (15 febbraio-15 maggio 2013).
– Winnicott D.W. (1949), L’intelletto e il suo rapporto con lo psiche soma. In tr.it Dalla pediatria alla psicoanalisi, Firenze: Martinelli 1975.
– Winnicott D.W. (1967), La funzione di specchio della madre e della famiglia nello sviluppo infantile. Tr.it in Gioco e realtà, Roma: Armando, (1974), pp 189-200.
– Winnicott D.W. (1970) Le basi di sè nel corpo. Tr. it. In Esplorazioni psicoanalitiche.Milano: Raffaello Cortina, 1989, pp 284-295.
Aprile 2015
Vedi anche in Eventi, Report/Materiali:
Anna Maria Nicolò – Organizzazione difensive nei breakdown
Vedi anche in Dibattiti:
Dibattito su: “L’Adolescente e il suo Corpo” a cura di F. Carnaroli e A. Nicolò
De Martis Dario

De Martis Dario
Dario DE MARTIS
(Milano, 14 dicembre 1926 – Pavia, 18 dicembre 1996)
A cura di Pierluigi Politi
La vita
Figlio unico di un ingegnere di origine sarda e di una professoressa di radici venete, Dario De Martis nasce e cresce nella Milano inquieta ed effervescente del ventennio fascista. La professione del padre, ingegnere del genio civile, lo conduce spesso ad esplorare gli scenari lavorativi del genitore: l’arco alpino, dove in quegli anni nascevano le prime infrastrutture (dighe, canalizzazioni, centrali) idroelettriche. La professione della madre, insegnante di matematica e scienze naturali, facilita parallelamente la sua, altrettanto appassionata, vocazione al sapere. L’intreccio fra queste due componenti – amore per la natura, in particolare per la montagna, e interesse per la scienza – ne fanno presto uno studente brillante, ponendo le basi per un sapere vasto, curioso e critico. Le sue doti naturali, coniugate alla non facile situazione economica originata dalla perdita precoce del padre, lo stimolano inoltre a concludere rapidamente gli studi liceali ed universitari (Petrella 1997). La sua formazione avviene, in buona parte, negli anni della guerra, durante i quali trova il modo di aggregarsi alle formazioni partigiane della bassa Valsesia (Gattinara, Lozzolo, Sostegno, Serravalle Sesia sono i luoghi che lo vedono impegnato). Nel corso di questa esperienza egli matura una vocazione politica genuina ed intensa, che ne fa un medico schietto, dalla notevole attitudine al contatto clinico genuino, solidale, pur nella consapevolezza delle sue origini borghesi.
De Martis si laurea giovanissimo in medicina, si specializza in Clinica delle Malattie Nervose e Mentali, trascorrendo un anno accademico (1950/51) a Parigi e inizia a lavorare come neurologo a Crema e come psichiatra a Milano. In quegli anni (Galli 2004), la sola alternativa psichiatrica milanese al manicomio ottocentesco di Mombello e a quello, nuovissimo, di Affori, era rappresentata da due case di cura private: Ville Turro, a nord-est del centro, e Villa Fiorita, a Brugherio. A Turro, con il Prof. Carlo Brambilla, lavoravano molti giovani psicoanalisti in formazione: Franco Ciprandi, Elvio Fachinelli, Franco Fornari, Gaddo Treves. Più eterogeneo lo staff di Villafiorita, diretto dal Prof. Virginio Porta, che aveva con sé Edoardo Balduzzi, Evardo Codelupi, Berta Neumann e Mara Selvini Palazzoli; oltre a Dario De Martis, naturalmente, che lì incontrerà Anna Bogani, sua futura moglie, intelligente e supportiva collega e compagna di una vita. Dal privato, De Martis passa quindi al pubblico, succedendo al grande Alfredo Grossoni e divenendo responsabile di quel “Neurodeliri” di Niguarda, passato alla storia per “La forza dell’amore” di Enzo Jannacci.
Gli anni del boom economico hanno, nel frattempo, il loro impatto anche sulla psichiatria. Nel 1958, per iniziativa di Giuseppe Carlo Riquier, Direttore della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell’Università, grazie al supporto economico dell’Amministrazione Provinciale, Milano istituisce la prima Cattedra italiana di Psichiatria. Fino ad allora, infatti, il corso di laurea in medicina vedeva gli attuali insegnamenti di Neurologia e Psichiatria unificati nel corso di Clinica delle Malattie Nervose e Mentali, con la Psichiatria da sempre in posizione subordinata. Carlo Lorenzo Cazzullo, vincitore di un concorso a Cattedra per Malattie Nervose e Mentali viene così chiamato l’anno successivo dalla Facoltà meneghina come primo Professore di Ruolo di Psichiatria. In realtà bisognerà attendere ancora diversi anni (1976) perché l’insegnamento di Psichiatria entri a pieno titolo, e con pari grado rispetto alla Neurologia, nella formazione del giovane medico. Nel frattempo (novembre 1963), però, Cazzullo ottiene che il Policlinico di Milano apra un Padiglione di Psichiatria d’Urgenza (la cosiddetta Guardia II), sul modello di quanto istituito a Niguarda dodici anni prima ed offre a De Martis la posizione di aiuto ospedaliero. Nel giro di pochi anni, grazie alla robusta esperienza neurologica e psichiatrica maturata sul campo, ad una profonda cultura, ad una speciale dedizione lavorativa e alle sue grandi doti umane, De Martis è in grado di vincere un concorso nazionale a cattedra (1965). L’Università di Cagliari gli offre il posto di Professore di Psichiatria nel 1968. Egli si imbarca per la Sardegna, non ancora 42enne, insieme con Fausto Petrella, della cui tesi di laurea era stato alcuni anni prima tutor. Petrella diviene suo aiuto, sia nella direzione pro tempore dell’Ospedale Psichiatrico di Cagliari, sia per l’attività didattica e quella clinica, che “comprendeva persone di ogni estrazione sociale” (Petrella 1987)
La Rivoluzione Pavese
Dopo soli tre anni (1971), è l’Università di Pavia – per alcuni secoli la sola Università lombarda – ad offrire la cattedra di Psichiatria a Dario De Martis. Nell’antica capitale del Regno italico, si dipanerà tutta la sua successiva carriera. A Pavia egli insegnerà Psichiatria (indimenticabile, per gli studenti di allora, la sintesi critica della clinica psichiatrica realizzata in: De Martis 1978), dirigerà la scuola di specializzazione ma, soprattutto, ridurrà la distanza tra psicopatologia e quotidiano clinico, dapprima presso il nuovo Istituto universitario, realizzato accanto all’Ospedale Psichiatrico di Voghera, quindi nel capoluogo, dove, fin dai primi anni ‘70, nei locali della Provincia diede il via ad un’esperienza di psichiatria territoriale che anticipò notevolmente la legge di riforma psichiatrica. Sia che si trattasse di restituire una storia ai pazienti manicomiali che avevano smarrito la propria (De Martis et al 1980), sia che si trattasse di affrontare quadri di recente insorgenza attraverso il lavoro clinico quotidiano, l’organizzazione di servizi territoriali, la pratica di interventi domiciliari, tutto quanto nel segno della continuità terapeutica (De Martis & Bezoari 1978), De Martis si poneva controcorrente rispetto all’isolamento un po’ elitario della psichiatria universitaria italiana.
La Psicoanalisi
La formazione psicoanalitica di De Martis avviene parallelamente alla sua carriera accademica. Dario De Martis viene analizzato da Pietro Veltri, una tra le figure più riservate della psicoanalisi milanese delle origini. Apprezzato ed impegnato magistrato di Corte d’Appello (Sigurtà 2000), profondamente interessato anche alla psicologia dell’uomo che delinque e al suo trattamento (si veda la prefazione a: Alexander & Staub 1978), Veltri fu – insieme a Franco Fornari – uno dei primi analisti formatisi con Cesare Musatti a Milano. Il documento di fondazione del CMP vede infatti le firme congiunte di Cesare Musatti, che era allora presidente della SPI, di Franco Ciprandi, Renato Sigurtà e Pietro Veltri.
Nel quotidiano di De Martis l’attività psicoanalitica avveniva, in genere, “dopo” quella accademica ed istituzionale. Personalmente, ricordo bene – ad esempio – lo stupore di alcuni miei compagni di training, in supervisione con lui, ai quali veniva proposta la domenica mattina come momento formativo… Diviene presto analista didatta, ricopre diverse cariche istituzionali, tra cui quella di presidente del Centro Milanese di Psicoanalisi dal 1992 al 1994.
Insieme a Fausto Petrella, importa la “peste” a Pavia, senza dubbio il capoluogo italiano (e verosimilmente mondiale) con il più elevato rapporto tra analisti e popolazione (all’inizio del 2018 Pavia conta uno psicoanalista (27) ogni 2700 residenti nel capoluogo).
I contributi teorici
L’impasto di sapere psicopatologico, formazione psicoanalitica e lavoro psichiatrico impegnato trova la sua espressione in Sintomo psichiatrico e psicoanalisi (De Martis & Petrella 1972), piccolo ed intenso volume, che riscosse un meritato successo nel panorama scientifico letterario dell’epoca. All’altro estremo delle sue opere psicoanalitiche, Realtà e fantasma nella relazione terapeutica (1984) costituisce una ampia panoramica del suo pensiero. Il volume raccoglie diversi saggi, a partire da: Aspetti psicodinamici della corporeità (1968), fino agli sviluppi più recenti della sua riflessione, come: Lo stato attuale della prassi psicoterapica (1981)
I suoi lavori psicoanalitici più citati, sono però quelli che “leggono” in termini relazionali – la parola-chiave del suo operare (Petrella 1997) – il lavoro istituzionale e quello educativo/formativo al contatto con la sofferenza mentale (De Martis 1976). In essi emerge pressoché costantemente la sua grande capacità di “ascolto” della sofferenza mentale, in particolare quella psicotica.
Tale capacità di comprensione profonda della sofferenza mentale, a partire dagli anni ‘80 (la terza edizione del DSM è proprio del 1980), è andata sempre più scemando nella psichiatria contemporanea, a beneficio di istanze maggiormente oggettivanti e classificatorie da un lato, nonché alle pretese di razionalizzazione, economicità ed aziendalizzazione (Barale 2003) dall’altro.
In precedenza, Dario De Martis aveva ideato e coordinato la pubblicazione di diversi volumi collettanei, da Istituzione, famiglia, équipe curante (1978) a Il paese degli specchi (1980), resoconto di un impegno terapeutico con i cronici istituzionalizzati, sino al più recente Fare e pensare in psichiatria (1987), testimonianza viva della capacità di mobilitare, attorno alla sua impostazione, l’intero gruppo di lavoro (Petrella 1997).
Quanto alla qualità del suo operare, non può essere dimenticato come, nelle differenti articolazioni della sua attività, De Martis conservasse una piena interiorizzazione del setting, sia in aula universitaria, sia in reparto psichiatrico, come durante le consulenze negli altri reparti ospedalieri. Per scelta, egli non trattava in maniera sistematica la psicoanalisi durante le lezioni di psichiatria agli studenti di medicina (De Martis 1978), e neppure durante i seminari di specialità. Eppure, il procedere del suo discorso ex cathedra lasciava continuamente intuire l’importanza, se non la necessità, di un percorso personale di presa in carico degli aspetti motivazionali, disfunzionali, dei bisogni e dei punti ciechi di ogni persona che si confronti con la sofferenza mentale. Persino le sue proverbiali sfuriate con il gruppo di lavoro, apparentemente lontane dall’intervento terapeutico, a giochi fatti, consentivano quasi sempre di elaborare l’accaduto, apprendendo dall’esperienza. Questa sua attitudine psicoterapeutica, universalmente riconosciuta anche dai colleghi meno in sintonia con lui, lo portò a fondare, all’interno della Società Italiana di Psichiatria, la Società Italiana di Psicoterapia Medica, di cui fu il primo Presidente.
La politica
Ultimo aspetto, meno ricordato, ma non certo meno importante, fu la sua dimensione politica. De Martis, presentatosi come candidato indipendente nelle liste del PCI, fu eletto per due mandati come Consigliere comunale a Pavia, svolgendo tale compito in autentico spirito di collaborazione e servizio, in quegli anni “di piombo” in cui l’impegno civile non era certo facile.
A Dario De Martis sono state intitolate la Biblioteca del Centro Psicoanalitico di Pavia e l’Unità di Psichiatria del Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell’Università di Pavia. Il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento bandisce periodicamente un premio di studio a lui dedicato.
BIBLIOGRAFIA
Franz Alexander, Hugo Staub (1929). Il delinquente, il giudice e il pubblico. Un’analisi psicologica. (Trad. it.) Milano: Giuffré 1978
Paolo Ambrosi, Dario De Martis, Fausto Petrella (a cura di). Fare e pensare in psichiatria. Milano: Cortina 1987
Francesco Barale (2001). L’inconscio ai tempi dell’aziendalizzazione. L’istituzione e la memoria. In: Luigi Rinaldi (a cura di). Stati caotici della mente. Milano: Cortina 2003
Dario De Martis, (1968). Aspetti psicodinamici della corporeità. Rivista di Psicoanalisi, 14(2):93-103.
Dario De Martis, Fausto Petrella. Sintomo psichiatrico e psicoanalisi. Per una epistemologia psichiatrica. Milano: Lampugnani Nigri 1972
Dario De Martis. Narcisismo e perversione. In: Eros e onnipotenza. Studi psicoanalitici sul narcisismo (a cura di E. Gaburri), Guaraldi, Firenze, 1976, 35-54.
Dario De Martis. Il talismano inaccessibile. Problemi di dipendenza e di autonomia in un’esperienza didattica. Relazione al Congresso Internazionale su “Psicoanalisi e Istituzioni”. Milano, 30 ottobre-1 novembre 1976. In: Psicoanalisi e istituzioni (a cura di F. Fornari), Le Monnier, Firenze, 1978, 129-135.
Dario De Martis. Argomenti di clinica psichiatrica. Padova: Piccin 1978
Dario De Martis, Michele Bezoari (a cura di) (1978). Istituzione, Famiglia, Equipe Curante. Pratiche e Teorie a Confronto. Milano: Feltrinelli
Dario De Martis, Fausto Petrella, Edgardo Caverzasi. Il paese degli specchi. Confronto con lungodegenti manicomiali. Milano: Feltrinelli 1980
Pier Francesco Galli (2004): Silvano Arieti torna in Italia. Psicoterapia e Scienze Umane, 38(4):505-514
Fausto Petrella (1997): Dario De Martis: uno psichiatra, uno psicoanalista. Rivista di Psicoanalisi, 43(2):353-362
Enzo Morpurgo (1973). L’esperienza di Niguarda. In: I territori della psicoterapia. Milano: Angeli, pp. 76-93.
Diego Napolitani (2006) Di palo in frasca. Milano: Ipoc 2006.
Renato Sigurtà (2000): Musatti e l’Istituto milanese di psicoanalisi. In: Romano D., Sigurtà R. (a cura di), Cesare Musatti e la psicologia italiana. Milano: Franco Angeli, 2000
De Toffoli Carla

Carla De Toffoli
A cura di Francesca Izzo
Carla De Toffoli
PRESENTAZIONE
Carla De Toffoli, specialista di malattie nervose e mentali, psicoanalista con funzioni di training della Società Psicoanalitica Italiana e dell’International Psychoanalytic Association si è occupata a lungo dello studio e del trattamento psicoanalitico delle patologie gravi. La sua concezione del tutto originale del rapporto corpo-mente è il nucleo della sua ricerca psicoanalitica. Nonostante la complessità del suo lavoro, De Toffoli riesce a farsi ascoltare dal lettore, gli va incontro. Scrive “Ognuno di noi per imparare a passare dall’una all’altra parte senza perdere sé stesso ha bisogno di esservi accompagnato da qualcuno che conosce già il viaggio di andata e ritorno, il sonno, il sogno e il risveglio che sa stare nel paradosso senza tentare di risolverlo” (C. De Toffoli, 2009 in Transiti Corpo- Mente. L’esperienza della psicoanalisi, a cura di B. Bonfiglio, 2014, Franco Angeli, pag. 289 ). Sin dal suo primo lavoro “Note sullo scorrere del tempo e prime esperienze di identità” pubblicato nel 1984, l’autrice volge la sua attenzione all’area del preverbale della relazione analitica e ai funzionamenti primitivi della mente in cui “affondano le radici del lavoro psicoanalitico”, a quel livello in cui “i fenomeni di fusione, identificazione e accadimenti somatici” intessono il legame analitico di elementi di entrambi i partecipanti, in modo tale “che il lavoro e la presa di coscienza sono possibili solo se bilaterali” (ib. pag.33). E’ in questa articolata comunicazione inconscia tra paziente e analista che si fonda la possibilità di un passaggio dall’area preverbale a quella simbolica e comunicabile.
Questa citazione, letta a posteriori, è al contempo l’enunciazione di un metodo, una presentazione di sé e la definizione del campo in cui Carla De Toffoli promuove la sua ricerca.
La sua concezione della relazione analitica “almeno bipersonale”, che coinvolge non solo le menti ma anche i corpi del paziente e dell’analista, richiede un’espansione della coscienza e la concezione di una coscienza incarnata. In accordo con il pensiero dell’ultimo Bion, la riflessione sulle condizioni di espansione della coscienza onirica e della veglia, la porterà nel tempo verso una teoria del funzionamento della mente che da campo psichico “almeno bipersonale”, evolve in un campo psichico multidimensionale in cui è possibile includere fenomeni di comunicazione inconscia infrasensoriale. Come ben rappresentato nel suo lavoro clinico, in cui proposizioni teoriche e agire clinico non sono mai disgiunti, quando nella relazione analitica si crea “ un luogo affettivo-mentale coincidente per il paziente e l’analista” esso diviene luogo d’incontro “a prescindere dagli usuali strumenti comunicativi” (ib., pag. 99)
Nel suo vibrante apporto alla psicoanalisi Carla De Toffoli può essere considerata una pioniera ed evoca alcuni tratti che Gerald Holton, fisico, storico della scienza della Harvard University, nel suo libro “L’immaginazione scientifica” ( Einaudi, 1983) osserva nell’opera di molti scienziati creativi: “l’adesione a pochi temi a cui sono legati da una grande fedeltà esplicita o implicita; la trattazione di questi temi che sin dagli inizi comunicano l’energia nascente delle grandi intuizioni scientifiche; la consapevolezza che ogni scoperta richiede un’espansione della coscienza umana.” (ib., pag. XII )
Il CONTRIBUTO ALLA PSICOANALISI
Il pensiero di Carla De Toffoli, per la sua ricchezza e originalità è uno dei contributi più innovativi della psicoanalisi italiana. La raccolta dei suoi scritti, tra cui alcuni inediti, pubblicata nel 2014 a cura di Basilio Bonfiglio, “Transiti corpo-mente. L’esperienza della psicoanalisi” , costituisce uno strumento prezioso per conoscere la proposta teorico-clinica di questa maestra della psicoanalisi. In ognuno dei lavori della raccolta, i riferimenti teorici ad autori psicoanalitici a lei vicini,- in primis Bion e Winnicott- così come le sue proprie teorizzazioni, sono intessuti in intense sequenze di interazioni psicoanalitiche. Si potrebbe dire che è proprio dal lavoro elaborativo dell’esperienza analitica che nascono interrogativi e intuizioni teoriche che poi tornano alla clinica in un andamento circolare. In questo ha molte similitudini al modo di procedere e teorizzare della Milner. (Illuminante sul suo metodo, oltre che commovente, la rilettura a pag. 249, del caso di Susan dal testo Le mani del Dio vivente che chiuderà questo lavoro).
Carla De Toffoli è sempre partecipe dell’esperienza, con la sua mente e con il suo corpo inteso come materia pensante, depositario al pari del corpo del paziente, di memorie inconsce corporee e di un sapere inconscio anche transgenerazionale. Corpo e mente che, nella sua teorizzazione, sono concettualmente inquadrati in un rapporto di tipo complementare e quindi secondo una modalità d’interazione non gerarchica ma paritaria. Quando Bohr nel 1927, al Congresso Internazionale di fisica di fronte a scienziati del calibro di Fermi, Heisenberg, Planck, Lorentz, Pauli ed altri, presentò per la prima volta il suo concetto di complementarità, fu perché alla luce degli esperimenti era arrivato alla conclusione che in certi casi :”è possibile esprimere la totalità della natura soltanto attraverso forme di descrizione complementari.” ( G. Holton, L‘immaginazione scientifica, pag.100). Allo stesso modo per Carla De Toffoli, la totalità di psiche-soma richiede analoghe forme complementari di descrizione senza dover risolvere artificialmente dicotomie e senza cadere in una posizione dualistica o in un monismo riduzionista.
Questi aspetti, che esprimono la ricchezza del suo percorso e delle sue intuizioni, sono anche ciò che rende la lettura dei suoi lavori complessa. Come accadeva a chi ha potuto ascoltare le sue relazioni ai convegni, nel lettore si produce lo stesso tipo di silenzio attento. Una forma di coinvolgimento che lo avvicina al piano della dimensione inconscia, creando in lui a volte quasi un senso di spaesamento e perdita di coordinate abituali, perché ogni lavoro ha un’area che è anche un’immersione in una dimensione di cui non si vedono i confini. Si è portati vicini “all’ombelico del transfert”, secondo una felice parafrasi dell’autrice, porta dell’ignoto, a cui in qualche modo è necessario “arrendersi”. Nelle vignette cliniche si è introdotti in un ‘area di complessità, in cui l’accadere psichico della coppia psicoanalitica non si può comprendere seguendo la logica della sequenzialità lineare di causa-effetto. Quando il campo analitico si espande, il corpo e la mente del paziente e dell’analista comunicano inconsciamente a diversi gradi di consapevolezza; quando entrambi sono partecipi di un’esperienza di risonanza all’unisono, lo stesso lettore ne diviene partecipe. Per questo la suddivisione per temi che seguirà spero non sacrifichi troppo la ricchezza della tessitura con cui Carla De Toffoli espone il suo pensiero.
TRANSITI CORPO- MENTE
Il nucleo dell’originale contributo di Carla De Toffoli è incentrato intorno alla sua concezione del rapporto corpo-mente. La sua prima e fondante asserzione è che corpo e mente sono profondamente co-determinati e che “I processi per cui il soma viene dotato di vita psichica e la psiche si rappresenta nel corpo necessitano di una costante oscillazione tra l’essere uno e l’essere due” ( De Toffoli, 2009 in Transiti corpo-mente, pag. 292). Dal lavoro somato-psichico della coppia materno-fetale nel “laboratorio perfetto” della gravidanza, alle prime fasi dello sviluppo, fino alla riattualizzazione nel processo analitico, “la continuità tra gli inconsci è anche una continuità psicosomatica tra corpi e psiche della coppia “( ib., pag. 39). E’ solo nella cornice di un modello bipersonale, “che si può comprendere come l’individuo si formi e si costituisca fin da principio come unità psicosomatica all’interno di un unico sistema biologico implicante due esseri umani: due unità corporee e due avventure psichiche inestricabilmente connesse e che vicendevolmente si riverberano in un ininterrotto processo di trasformazioni dal somatico allo psichico e di nuovo al somatico” (ib., pag. 175). Da qui l’ affermazione “che la matrice psicosomatica dell’esperienza di sé si forma e può essere compresa solo all’interno di un contesto almeno duale” (ib., pag. 142)
In accordo con le concezioni di Winnicott, De Toffoli osserva che quando irrompono eventi traumatici precoci che esitano in uno scollamento dell’unità psicosomatica del sé in formazione, l’analista può trovarsi a cercare il paziente nel luogo di quello scollamento originario “ fino ad un transfert di tipo neonatale o placentare” (ib. pag. 45) A questo livello di funzionamento primitivo e non simbolico della mente, le tracce traumatiche “sono al contempo ineffabili e tangibilissime per i vissuti di non esistenza che generano” (D. Cinelli, 2015). Includere anche gli accadimenti somatici del paziente e dell’analista tra i fenomeni di transfert, e prestare loro attenzione per capire a cosa si leghino o cosa essi esprimano nella relazione analitica, rende il corpo “luogo concreto delle valenze transizionali, nel senso che l’esperienza incarnata può essere considerata l’inizio della creazione di uno spazio potenziale tra sé e l’altro, di uno spazio psicologico potenziale tra l’esperienza riflessiva e l’esperienza percettiva” ( P. Passi, 2015). Se in quest’ottica si riconosce anche al corpo un “conosciuto non pensato” (Bollas), è anche immaginabile arrivare a riconoscere nel linguaggio sintomatico del corpo, un altro “codice di elaborazione dell’esperienza” ( De Toffoli, 2001, in Transiti Corpo-Mente pag. 154); un altro modo di trascrivere le memorie implicite che l’affinamento del metodo psicoanalitico e le ricerche scientifiche sulla memoria, comprese quelle che indagano gli esiti del loro recupero con il metodo psicoanalitico, dovrebbero nel tempo sempre più poter decifrare. (C. Alberini, 26 novembre 2016, relazione alla Giornata Nazionale del gruppo di Ricerca Psicoanalisi e Neuroscienze, Roma )
La seconda asserzione è che all’interno di questa visione non dualistica, corpo-mente sono un’unica realtà. Lo psichico e il somatico non sarebbero quindi in un rapporto gerarchico con Mente che domina Corpo, (Bion, 1979 cit. pag. 288) in quanto il corporeo è esso stesso un evento psichico anche se in una forma a noi sconosciuta. (Freud, 1940, 585, cit. a p. 148), il modello bipersonale apre spazi “ di significazione affettiva, o di incarnazione somatica dei reciproci vissuti, emotivi, psichici o corporei che siano.” (ib., pag. 143) e necessita per l’analista di “una dotazione ideo-affettiva capace di transitare in entrambe le direzioni”. La tesi di Carla De Toffoli è che “questo sia possibile in particolari contesti relazionali utilizzando come veicolo e tramite, la risposta affettiva dell’analista, intendendo gli affetti come legame di elezione tra la psiche e il soma” (ib. pag. 72). Le illustrazioni cliniche offrono esempi di questa oscillazione tra l’Io e il Tu, tra Psiche e Soma, descrivendo bene la possibilità di significare, in particolari condizioni, tracce traumatiche che si possono presentare anche sotto forma di sintomo sia nel paziente sia nell’analista, quando questi incarna nel suo corpo le memorie somatiche ancora inaccessibili del paziente. La realizzazione di questi fenomeni transferali in cui la coscienza-corpo dell’analista entra in risonanza con le aree preverbali e prerappresentative del paziente, attiva nell’analista l’”immaginazione speculativa” (Bion) e crea un ‘sogno della veglia’ che attraverso la voce del campo analitico può attribuire senso e parola alle esperienze traumatiche precoci inscritte nel corpo del paziente. Per questa via si può iniziare a tracciare un sentiero che conduce dal segno al significato. Nell’altra direzione è altrettanto significativo, “di fronte ad un fatto psichico, riconoscere in quale corpo o in quale storia del soma si radica e si rappresenta” (ib., Winnicott, 1989, cit. pag. 143). Ma se corpo e mente sono un’unica realtà viene meno non solo la posizione dualista propria del pensiero occidentale, ma anche quella concezione che interpreta il sintomo somatico come un difetto di mentalizzazione, o buco nella capacità di simbolizzazione o ancora come scarica di elementi mentalmente indigeribili nel corpo. “Il metodo analitico offre l’opportunità che un evento originario conosciuto come somatico da parte dell’uno, si riattualizzi e venga contestualmente conosciuto come psichico da parte dell’altro, rendendo visibili contemporaneamente le due facce della stessa realtà umana che denominiamo psiche-soma”(ib. Pag.152). Suggerisco in proposito la lettura di due casi clinici ( da pag. 78 a 83 e da pag.254 a pag. 256).
Se mente e corpo sono un’unica realtà, la terza asserzione è che corpo e mente sono fatti della stessa materia e questa materia assomiglia sempre più al pensiero (ib., pag. 249). Questo significa ampliare la concezione della mente intendendola come “una mente estesa al corpo ed inerente ai processi somatici, una mente delle cellule, anche se la sua elaborazione come pensiero necessita del funzionamento cerebrale.”(De Toffoli, 2007a, ib, pag. 246) Questa posizione, nella linea del pensiero freudiano, (Freud 1922) è stata maturata nel corso degli anni. Nel 2007 scrive “chiamiamo corpo-mente l’esperienza di noi stessi in quanto oggettivamente pensabile, e psiche-soma la stessa esperienza nel suo essere percepita come soggettiva e vivente” (ib., pag. 246). Nel 2009 scrive “..chiamiamo soma ciò che può essere percepito attraverso i cinque sensi e sottoposto a valutazione oggettiva, chiamiamo psiche ciò a cui diamo soggettivamente significato.” Quindi un unico processo del reale in cui corpo e psiche sono fenomeni complementari che sono sensorialmente diversi solo per il nostro intelletto. In cui la relazione causa-effetto con il fisico che causa lo psichico o viceversa, non è da considerarsi valida in quanto corpo e mente sono governati dalla stessa legge fisica della complementarità di Bohr, per la quale non possono manifestarsi contemporaneamente allo stesso modo in cui nel mondo della fisica sono complementari l’onda e la particella. Quindi non si tratta della natura della realtà ma del modo in cui essa viene percepita. In quest’ottica psiche, corpo, mente, soma, sono categorie della coscienza e il lavoro che ci è richiesto non può riguardare questi processi in sé inconoscibili per le nostre attuali capacità percettive e cognitive ma piuttosto quello di portare l’attenzione sugli stati di coscienza.
Un bell’esempio di questo esercizio lo troviamo ne “Il sapere inconscio inscritto nel corpo” del 2007 in cui Carla De Toffoli si immerge nella rilettura del famoso caso, tratto da “La creatività e le sue origini”, in cui a Winnicott il paziente maschio disteso sul lettino appare come una ragazza. La riflessione di De Toffoli si focalizza sulla comprensione dei livelli di coscienza multipli sperimentati da Winnicott in quella seduta. Con grande naturalezza l’ analisi dei 3 diversi livelli di coscienza viene esplicata secondo categorie bioniane.
1. La coscienza sensoriale. Che si realizza nel percepire attraverso i sensi, la presenza di un paziente di sesso maschile. ( Espansione nel campo del senso).
2. La percezione attraverso la coscienza di ciò che viene “intuito” attraverso la comunicazione inconscia infrasensoriale. “Il vedere lo psichico (una femmina, cioè l’incarnazione della follia della madre) e insieme la prefigurazione di un significato nascente qualora la percezione sensoriale venga illuminata da ciò che è giunto intuitivamente dall’inconscio; l’accettazione del paradosso (Espansione nel campo del mito)” (ib. pag. 247)
3. La coscienza della presenza della passione, che attraverso il “registro dell’immaginario” introduce nel legame analitico un significato sconosciuto “che consente a un sogno libero da spazio e tempo di muoversi tra le individualità e le generazioni ( Espansione nel campo della passione)” ( ib. pag. 248)
L’INTELLIGENZA UNICA FONDANTE IL TESSUTO DELLA VITA.
Ma se la realtà della nostra esperienza umana è unitaria, allora è necessario riferirsi ad un campo di conoscenza unificato che includa altri saperi e allo studio di quei principi che regolano la natura di cui l’umano è parte. Scrive il fisico Rovelli “..Non c’è nulla in noi che sfugge le regolarità della natura […] Non c’è nulla in noi che violi il comportamento naturale delle cose. Tutta la scienza moderna, dalla fisica alla chimica, dalla biologia alle neuroscienze, non fa che rafforzare questa osservazione… Non ci sono “io” e “ i neuroni del mio cervello”. Si tratta della stessa cosa. Un individuo è un processo, complesso, ma strettamente integrato.”( C. Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica, Adelphi 2014, pag.79). Nella ricca bibliografia di questa maestra della psicoanalisi troviamo molti riferimenti a importanti scienziati, biologi, fisici, chimici oltre che filosofi e letterati così come ai contributi di altre culture. Profonda conoscitrice dei lavori di Bion, apprezza la sua idea di cercare in altri linguaggi non solo psicoanalitici modelli di comprensione della mente. Ma la conoscenza di questi linguaggi non la conduce ad innesti impropri tra discipline tanto diverse, quanto ad utilizzarli, in attesa di prove scientificamente sostenibili, alla stregua di miti scientifici con cui sostenere la sua immaginazione speculativa. (Bion 1998 pag. 63) Nei suoi lavori troviamo ampi riferimenti alle concezioni della biologia evoluzionista di Maturana e Varela, o a quelle dell’etologo Lorenz , ma è soprattutto l’ampliamento del suo interesse verso la fisica quantistica e al suo principale paradigma che orienta il suo pensiero negli ultimi lavori. Il paradigma quantistico afferma che non esiste nessun oggetto al mondo che sia isolato, e questo in tempi moderni, in un certo senso, offre una base scientifica al concetto di sentimento oceanico che Romain Rolland intendeva come un essere partecipi ed immersi in un universo condiviso – concetto da cui il Freud psicoanalista era fortemente attratto nonostante la fede “positivista”, come è riportato nel suo lavoro del 1929 “ Il Disagio della civiltà”- per fondarlo in un nuovo olismo dinamico. Nel suo lavoro De Toffoli si è ispirata all’osservazione del fisico premio nobel De Broglie che riteneva che la struttura dell’universo materiale avesse qualcosa in comune con le leggi che governano il lavorio della mente umana come oggi gli studi più attuali sembrano confermare. O a Pauli che nel 1946 scriveva a Jung come gli stessi concetti psicologici di coscienza e inconscio sembravano presentare molte analogie con “la situazione della “complementarità” nell’ambito della fisica” (Jung e Pauli Il carteggio originale: l’incontro tra psiche e natura). O alle ipotesi di Bohr che osservava una relazione di complemetarità tra materia vivente e non vivente analoga a quella che esiste nella fisica tra posizione e velocità di una particella. Ipotesi quest’ultima, che ha portato C. De Toffoli a domandarsi se il metodo psicoanalitico non si dovesse accreditare tra gli strumenti più adatti ad indagare la materia vivente della mente umana. Come per lo stesso Bion, lo strumento psicoanalitico, per la sua capacità di oscillare dall’esperienza soggettiva alla comprensione oggettiva per ritornare nuovamente all’esperienza, le sembrava particolarmente prezioso per indagare la vita psichica. Certamente queste letture hanno costituito un background che ha informato il suo pensiero.
IL CONTRIBUTO CLINICO
Tratto distintivo dell’operare clinico di Carla De Toffoli è: la ricerca dell’unisono come luogo psichico da cui nasce e funziona l’intervento dell’analista.
Sia che si tratti del resoconto di un primo colloquio, o di una seduta particolarmente dolorosa per la paziente, o del lungo percorso che condurrà alla nascita psichica un paziente grave con un funzionamento primitivo della mente, Carla De Toffoli con grande sensibilità riesce a condurci nel punto d’incontro con il paziente che è anche il luogo della risonanza all’unisono. (nota 1)
Nel suo lavoro clinico questa maestra della psicoanalisi, non si occupa solo del transfert “ conoscibile e interpretabile”, ma di quei punti oscuri, che costituiscono la relazione analitica come un “campo psichico” da lei ridefinito “spazio transferale”, in cui l’analista è così implicato che una comprensione o una cura vengono trovate per entrambi o per entrambi falliscono.
E’ un transfert che può dilatarsi in modo multidimensionale, che può spaventare lo stesso analista, “qualora non abbia facilmente accesso all’area della creatività. Qualora, sentendosi responsabile per la sua parte, non abbia fede sufficiente nel fatto che il gioco delle rappresentazioni di transfert è giocato dall’energia creatrice della vita stessa, che è appunto quell’ignoto in cui lo spazio transferale affonda le sue radici ” ( De Toffoli, 2007, pag. 229).
E’ un transfert dove la funzione generativa del legame analitico si esplica nella convinzione che “l’elaborazione del passato anche transgenerazionale, avviene attraverso il passaggio cruciale dell’assunzione di responsabilità dell’analista dei nuclei traumatici del paziente per il tramite dei suoi propri errori. (Winnicott, La paura del crollo, 1963, cit. in Izzo 2013)
Un lavoro clinico orientato quindi, alla “ ricerca di quel sapere sconosciuto che tesse incessantemente la trama del corpo e della mente di ognuno di noi” ( De Toffoli 2001, pag. 155) e che richiede all’analista la capacità di sostenere la sospensione della mente individuale e di accogliere la comunicazione inconscia infrasensoriale – la realtà a-sensoriale dell’ultimo Bion (Vermote 2011).
Su questo punto nel 2009 Carla De Toffoli scrive:“ Le comunicazioni inconsce senza base sensoriale a cui a volte assistiamo potrebbero essere interconnessioni mediate da scambi di energia ed informazioni a livello elettromagnetico e quantistico. La condizione perché questi fenomeni diano vita a trasformazioni evolutive (K- O), sembra essere uno stato mentale difficilmente definibile, che Bion ha descritto come “assenza di desiderio”, “fede”, “pazienza” e“risonanza in O”. Questi stati di coscienza consentono di sperimentare uno spazio della mente non concettuale, di osservare il flusso delle emozioni e dei pensieri senza giudicarli e senza perdersi in essi” ( De Toffoli 2002 cit. in Izzo 2013)
L’uso vivo della teoria di Bion attraversa tutti i lavori di Carla De Toffoli e si sviluppa lungo linee di ricerca tanto rigorose quanto originali, trovando nel concetto di espansione della mente nel campo del mito, del senso e della passione ciò che è specifico della psicoanalisi e la differenzia dalla psicoterapia. Nella convinzione che l’espansione della mente e l’espansione della coscienza “siano funzioni della realtà e della mente umana, che l’analista può attivare e con cui può entrare in risonanza per dare coesione ad elementi sparsi e privi di significato, finora privi di legame e significato”, mantenendo tuttavia la consapevolezza della dualità fenomenica. ( ib. ).
L’espansione della coscienza verso orizzonti sempre più estesi, espande il campo analitico verso molteplici livelli della realtà e diversi momenti temporali, perché “Quando analista e paziente vibrano all’unisono essi entrano in risonanza con l’infinito” (ib.).
Da questo punto di vista, l’espansione della coscienza può creare, in particolari condizioni, la scoperta di un significato che genera una sorta di “messa in forma organizzatrice risonante”, che allarga il campo significabile a piani plurimi dell’esperienza dotando simultaneamente quegli “elementi sparsi “ di senso e coerenza. Una sorta di insight multidimensionale di cui, negli scritti di Carla De Toffoli, troviamo diversi esempi. (Un esempio tra tutti, la splendida rilettura del testo di Bollas nel lavoro del 2011).
In questo, Carla De Toffoli ha Fede, fede nel sapere dell’inconscio. “Un inconscio che non deriva da negazione, rimozione o spostamento, e neppure da una collezione di programmi e procedure, ma che piuttosto (si lega) a un processo emergente dall’esperienza della vita, quando le sue componenti costitutive risuonano armoniosamente, come il suono di un’orchestra ben accordata, che non ha esistenza di per sé, e tuttavia ha un grande potere quando ci sintonizziamo nell’ascolto” ( De Toffoli, 2011 cit. in Izzo 2013)
Concludo questa presentazione con la rilettura del caso di Susan ascoltando dalla voce di Carla de Toffoli , il suo personale modo di essere una psicoanalista.

“Al punto dell’analisi di cui ci stiamo occupando, la Milner era arrivata a supporre che nel lavoro con Susan ci fosse bisogno di attuare una completa attenzione corporea, una specie di riempimento deliberato di tutto il proprio corpo con la propria coscienza. (Milner, 1969,94) insieme ad uno stato mentale concentrato in cui uno crea la propria cornice interna, uno spazio in cui si “tiene”. Fu a questo punto che Susan portò in seduta un disegno fatto dieci anni prima, durante la notte precedente il loro primo incontro, e la Milner vedendolo comprese che una delle lontane radici di questa funzione psichica di cui Susan aveva bisogno potrebbe essere l’esperienza di essere tenuti tra le braccia della propria madre. Comprese anche che Susan aveva atteso dieci anni per portarlo al momento giusto, in cui non sarebbe andato perduto. Il disegno provocava “uno stato emotivo così complesso fatto di angoscia e di tragedia che non sapevo davvero cosa farne”. Una cosa però la fece- e a posteriori se lo rimprovera: lo ripassò tutto ad inchiostro allo scopo, pensava, di vederlo meglio.
Infatti vide, o forse creò incarnandosi nel disegno attraverso il gesto grafico di ripassarlo, anche un vago barlume di speranza: la speranza di riuscire in qualche modo l’equivalente psichico delle braccia; vide che non c’erano seni, ma piuttosto le curve di un braccio che avrebbe dovuto tenere il bambino, ma era lo stesso bambino, vide che la prima preoccupazione di Susan era quella di essere tenuta in maniera sicura, prima ancora di porsi il problema di essere affamata. Prefigurò uno stato in cui Susan sarebbe stata capace di tenere sé stessa e di trarre la vita dal centro del proprio corpo, nel quale sarebbe discesa dalla testa, rinunciando al tentativo di tenersi su dall’alto per mezzo della testa. Comprese quindi che quello che avrebbe potuto realizzare anche corporalmente in se stessa durante le sedute, per rispondere al bisogno della paziente. Perché forse la paziente l’avrebbe sperimentato soltanto se l’analista ci fosse riuscita per prima. Seppe anche che avrebbe dovuto fare tutto questo restituendo a Susan la sua conoscenza unica di se stessa e della sua storia, appena possibile,” senza strapparle il cuore del suo mistero”. Tutto questo vide nel disegno, e prese su di sé ripassandone ad inchiostro i contorni, per poter vivere con la paziente l’esperienza di ricreare simbolicamente il corpo, di ricreare il mondo e la propria storia. Il dio vivente per abbracciare il corpo della piccola Susan aveva bisogno di almeno quattro braccia.
Da una nota, una tra le tante, che mi era sfuggita alla prima lettura, veniamo a sapere che solo molti anni dopo Susan racconterà alla sua analista che quando la sua nonna materna, allora diciottenne, fu trovata morta per denutrizione, la madre di Susan fu trovata stretta tra le braccia del cadavere materno (Milner, 1969, 46).
Improvvisamente il campo si espande, è come essere trasportati su un’altura da cui vediamo le linee del tempo intersecarsi e una nuova trasparenza rivelare dimensioni nascoste negli strati sovrapposti della rappresentazione grafica. Vediamo ciò che la Milner non aveva visto: nella trama del disegno, in ogni suo tratto, vediamo il tessuto del corpo trasformarsi in informazione. Vediamo rappresentata nel corpo non solo l’esperienza attuale di Susan, così acutamente decifrata dalla Milner nel qui ed ora, ma possiamo vedere -in trasparenza- anche la madre di Susan, piccola di sei mesi, in braccio alla propria madre morta per denutrizione, e lì davvero non ci sono seni, e la bambina diventa il braccio morto della madre con cui tiene se stessa. Vediamo l’esperienza originaria della propria madre passare come un fiume sotterraneo attraverso il cuore di ogni cellula del corpo della figlia, fino ad emergere in superficie in una rappresentazione da fuori del più intimo dentro dello psiche-soma transgenerazionale, il cuore del suo mistero sepolto vivo nel corpo di Susan”(De Toffoli, 2007, pag.249-251)
BIBLIOGRAFIA
Carla De Toffoli, Transiti Corpo-Mente. L’esperienza della psicoanalisi, a cura di B. Bonfiglio, 2014, Franco Angeli.
Bibliografia
C. Alberini, Relazione della Giornata Nazionale del Gruppo di Ricerca Psicoanalisi e Neuroscienze, Roma 26 novembre 2016
W. R. Bion, Addomesticare i pensieri selvatici, 1998, Franco Angeli
W. R. Bion, Memoria del futuro, 1979, Cortina, Milano 1988
D. Cinelli, Due mappe, un solo mondo: il dialogo tra soma psiche nel pensiero di Carla De Toffoli, Relazione al convegno Essere e Divenire, l’esperienza della psicoanalisi, Centro di psicoanalisi Romano, Roma 31 gennaio 2015
E. Del Giudice, L’auto-organizzazione degli organismi viventi alla luce della moderna teoria quantistica dei campi, IIB, Neuss, Germania
C. De Toffoli, Transiti Corpo-Mente. L’esperienza della psicoanalisi. A cura di B. Bonfiglio, 2014, Franco Angeli
A. Falci, Articolo inedito sul pensiero di Carla de Toffoli. Comunicazione privata.
A. Ferro, G, Civitarese, Il campo analitico e le sue trasformazioni, 2015, Raffaello Cortina Editore
S. Freud, L’Io e l’Es, 1922, Opere, vol. 9, Bollati Boringhieri
S. Freud, Disagio della civiltà, 1929, Opere, vol. 10. Bollati Boringhieri
G. Holton, L’immaginazione scientifica, 1983, Einaudi
F. Izzo, L’ultimo Bion, Relazione al convegno L’Ultimo Bion, Centro Psicoanalitico Romano, 25 ottobre 2013, Roma
Jung e Pauli: Il carteggio originale: l’incontro tra psiche e materia, a cura di Antonio Sparzani con Anna Panepucci, Moretti & Vitali 2016
P. Passi, Comunicazioni inconsce: ipotesi, Relazione al convegno Essere e divenire. L’esperienza della psicoanalisi, Centro psicoanalitico romano, 31 gennaio 2015, Roma
C. Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica, 2014, Adelphi
Vermote R., On de value of late Bion to analytic theory and practice. Int. Journal of Psychoanalysis 2011, 92:1089-1098. Traduzione italiana Daniela Cinelli
Winnicott D. W., La paura del crollo, in Esplorazioni psicoanalitiche1989, Cortina 1995, Milano
( Nota 1) Propongo la lettura di 3 casi tratti dal volume dei suoi scritti che in ordine alla loro brevità e al loro valore esemplificativo, possono aiutarci a comprendere meglio la complessità e la ricchezza del suo operare clinico. Nel primo caso (2008, a pag. 281), troviamo descritte le emozioni e la sorpresa dell’analista di fronte a “fenomeni di sincronicità” e a “coincidenze” che allargano il campo psichico ad accadimenti “difficilmente contenibili negli abituali paradigmi conoscitivi” e che dall’analista , “vengono sentiti come un attacco all’io individuale che teme di perdersi nell’infinitamente grande” (ib., pag. 281). In cui l’interpretazione data alla paziente, qualcosa di più e qualcosa di meno di un pensiero, assomiglia ad un’invenzione che è insieme un atto creativo ed arbitrario allo stesso tempo. Nel secondo caso (2009 da pag. 298 a pag. 299), troviamo un esempio di come la risonanza all’unisono possa riguardare l’area somatica che viene così inclusa nel campo dei fenomeni significabili.
Attraverso l’uso della speculazione immaginativa tanto cara a Bion, Carla De Toffoli riesce in questo resoconto clinico a dare senso e parola, a elementi inscritti nella memoria somatica che trovano un punto di contatto comune al paziente e all’analista. Nel terzo caso (2009 da pag. 294 a pag. 295 ), la profonda risonanza emotiva attiene invece ad uno stato primitivo della mente e si realizza solo ai livelli primari di soggettivazione, senza essere oggetto di una trasformazione narrativa, o di messa in forma metaforica. ( A. Ferro, G. Civitarese “Il campo analitico e le sue trasformazioni”, 2015). In questo esempio, “la consapevolezza dell’evento è sostenuta dall’analista e rimane nell’ambito delle sue responsabilità. Viene fruita e percepita inconsapevolmente dal paziente, attraverso canali di comunicazione non verbali, in quanto partecipe dello stesso stato di coscienza.” (De Toffoli, 2002, pag. 168).
gennaio 2017
Delirio

Salvador Dalí, La persistenza della memoria - 1931
A cura di Franco De Masi
L’esperienza delirante
L’esperienza delirante può comparire in diverse sofferenze mentali anche di natura organica ma in questa nota parlerò unicamente del delirio psicotico. Solo nella psicosi il delirio assume un carattere strutturato e progressivo e, una volta formato, è molto difficile da trasformare. Al pari delle allucinazioni è un evento sensoriale reale e non un sogno o una fantasia.
L’esperienza delirante non riguarda la coscienza ma la consapevolezza. Il paziente è cosciente della sua vicenda delirante ma non è consapevole della sua natura. Il delirio si produce in uno stato alterato della mente quando l’immaginazione viene trasformata in percezione sensoriale. Non è un prodotto dell’inconscio come il sogno che normalmente usa simboli o narrazioni emotive per produrre la trama onirica. L’esperienza delirante si avvale, invece, della capacità della mente psicotica di rendere sensoriale un pensiero immaginativo. In questo stato mentale la psiche non viene usata come un mezzo capace di comprendere la realtà ma come uno strumento che produce sensazioni e percezioni, cioè come un organo sensoriale. La capacità di costruire un mondo immaginativo sensoriale, creato nel ritiro, sfugge al controllo del paziente ed egli non è più in grado di distinguere la realtà neocreata da quella che esiste fuori di lui.
Nello stato delirante il paziente non pensa, ma “vede” o “sente” come se stesse sognando da sveglio. Il delirio, tuttavia, non ha alcuna parentela con il sogno. Quando sogniamo consideriamo reale la vicenda sognata, ma al momento del risveglio capiamo che il sogno corrisponde a una narrazione emotiva diversa da quanto percepiamo nella realtà. Per questo motivo il sogno è un’esperienza simbolica perché rimanda a un significato emotivo inconscio, un desiderio, un conflitto o un’angoscia del sognatore. Dall’esperienza delirante, invece, non c’è risveglio né presa di distanza perché il delirio è una percezione concreta e non una narrazione simbolica. Anche quando la parte sana guadagna gradualmente prevalenza, l’esperienza delirante rimane “un fatto reale” a differenza di un sogno che viene dimenticato quando se ne è compreso il significato.
Un problema analogo a quello posto dal delirio riguarda le allucinazioni che nella psicosi si accompagnano al delirio e che interessano particolarmente la sfera auditiva. Analogamente a quanto accade nell’esperienza delirante il paziente conferisce un carattere di realtà a un fatto che, al di fuori di ogni possibilità, nasce dalla sua mente. La capacità di creare un mondo sensoriale svincolato dalla realtà rappresentato dallo stato allucinatorio e delirante deriva dallo stato dissociato che si crea nel ritiro psichico. Questo stato mentale compare già nella prima infanzia in bambini isolati che si ritirano in un loro mondo di fantasie dissociate dalla realtà relazionale. Spesso non è facile per i genitori distinguere il mondo del ritiro in cui questi bambini vivono dal normale mondo della fantasia infantile.
La psicosi che si sviluppa come un graduale processo di regressione in cui la persona si ritira in uno spazio completamente isolato può essere considerata come la continuità e la prosecuzione del ritiro infantile. Lo stato delirante testimonia lo sviluppo estremo di un ritiro in cui la realtà interna neocreata viene proiettata all’esterno con la perdita completa di separatezza tra interno ed esterno. La confusione non è solo tra mondo interno e mondo esterno ma soprattutto tra mondo sensoriale e mondo psichico. Nella esperienza delirante il mondo sensoriale creato attraverso un distorto uso dei canali percettivi prende il posto del mondo psichico. La realtà dell’esperienza delirante-allucinatoria è tale perché il paziente usa “gli occhi e le orecchie” della mente. La mente, in altre parole, costruisce l’immagine internamente e poi la “vede” proiettata esternamente.
Di solito l’esperienza delirante ha all’inizio un carattere positivo e seducente, in forma di voci carezzevoli ed affascinanti, ma si trasforma poi in voci accusatorie, sprezzanti o terrorizzanti. Gradualmente lo stato di grandiosità si muta in una condizione di persecuzione. E’ il primitivo carattere piacevole e gratificante del mondo della fantasia delirante che attrae il paziente che sarà poi confinato in una prigione da cui non sarà possibile uscire perché ha perduto il controllo della mente e l’uso del pensiero.
Depressione

John William Waterhouse, Boreas - 1903
A cura di Stefano Tugnoli
Definizione
Quando si parla di depressione è utile distinguere un termine più generico che si riferisce ad un’ esperienza affettiva che può limitarsi ad uno stato d’animo di tristezza anche momentaneo da una vera e propria sindrome depressiva. Questa è una condizione psicopatologica caratterizzata da sintomi ben precisi che includono anche altri elementi del vissuto soggettivo e del comportamento (il concetto di “sindrome” rimanda alla presenza di un gruppo di sintomi che definiscono un quadro clinico specifico).
La condizione depressiva si descrive dunque come uno stato di sofferenza soggettiva che rimanda a specifiche modalità di funzionamento psichico in cui convergono, variamente intrecciati, sintomi emotivo-affettivi (umore depresso, perdita di interesse e delle possibilità di piacere, sentimenti di impotenza e disperazione, colpa , vergogna, inutilità, indegnità, inferiorità), sintomi cognitivi (pensieri a contenuto negativo su di sé, una visione negativa del mondo e della vita, aspettative negative sul futuro, idee di suicidio), rallentamento psicomotorio, sintomi neurovegetativi (come insonnia e riduzione dell’appetito) e fisici (soprattutto dolori, astenia, disturbi gastrointestinali). Siamo nell’ambito dei cosiddetti “disturbi dell’umore”, area della psicopatologia caratterizzata primariamente da una compromissione della qualità del vissuto affettivo: il termine “umore” rimanda, infatti, allo sfondo emotivo dell’esperienza, a quella dimensione della vita psichica che colora di segno positivo o negativo il senso che l’individuo attribuisce a se stesso e al proprio rapporto con la realtà.
Sul piano epidemiologico, la depressione ha una grossa rilevanza in tutto il mondo, è sempre più diffusa ed è il disturbo psichiatrico più comune: dal 10% al 20% della popolazione adulta viene colpito dal disturbo depressivo nel corso della vita (Gabrielli, 2009; Altamura et al., 2006). Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, oggi circa 300 milioni di persone soffrono di depressione, patologia che, in base alle stime, entro il 2020 sarà la seconda più comune causa di disabilità per malattia (Siracusano, Niolu, 2007).
Per quanto riguarda le cause della depressione, dobbiamo considerare una complessità di fattori che comprendono: la predisposizione genetica, gli eventi di vita e la dimensione psicologica della soggettività nelle sue varie articolazioni cognitive e affettive.
La psicoanalisi, che ha come specifico oggetto d’indagine la realtà psichica, individua le radici della depressione nelle profondità dell’inconscio e nel mondo interno.
Dal punto di vista della psicoanalisi dello sviluppo la depressione è intesa anche come dimensione dello psichico che attiene alle vicende evolutive di ogni individuo.
Dalla nascita in poi il bambino incontra molteplici momenti di dolore emotivo che, nel caso di uno sviluppo sufficientemente sano, sono funzionali alla crescita.
Quando le cose non vanno per il meglio, quando l’ambiente non è sufficientemente in grado di rispondere ai bisogni del bambino (che a sua volta può essere particolarmente vulnerabile o predisposto) le vicende depressive infantili possono assumere valenze patogenetiche, tracciando linee di fragilità strutturale nella psiche dell’individuo. In questi casi può svilupparsi una vera e propria depressione infantile, oppure tali fragilità possono rimanere silenti per molto tempo, rivelandosi solo nella vita adulta in occasione di particolari difficoltà.
Ciò che può rendere patologica questa situazione non è soltanto la presenza di uno stato d’animo depressivo, ma il fatto che questo vada a delinearsi con particolari qualità, intensità e durata nel tempo: la depressione diventa malattia quando finisce per occupare in modo pervasivo la vita psichica dell’individuo determinando importanti limitazioni, impedimenti o significative alterazioni a livello relazionale, lavorativo e sociale.
L’intensità del male depressivo può andare da livelli relativamente lievi o moderati, che fanno soffrire ma che non impediscono di lavorare e di avere una vita di relazione (sono le cosiddette “depressioni nevrotiche”), sino a situazioni cliniche molto gravi e disabilitanti, che determinano una frattura nella continuità del corso dell’esistenza, la compromissione del contatto con la realtà e la comparsa di pensieri deliranti di colpa, di rovina o ipocondriaci (in questi casi si parla di “depressione psicotica”).
La depressione in psicoanalisi
Freud in Lutto e Melanconia (1917) delinea con estrema precisione le dinamiche intrapsichiche inconsce che determinano l’insorgenza della depressione, confrontandole con quelle che caratterizzano l’esperienza del lutto.
Egli nota che il dolore del lutto permane per un certo tempo, almeno fino a quando il soggetto non è in grado di accettare realisticamente la perdita e di rivolgere la sua affettività ad altri oggetti, ad altre persone o cose, concrete o astratte che siano (questo processo è ciò che viene chiamato comunemente “elaborazione del lutto”) . In alcune persone il lavoro psichico del lutto si rivela impossibile: l’Io è pieno di colpa e senso d’ indegnità e s’instaura una depressione.
Freud intuisce che ciò che appare come autoaccusa e senso di colpa in realtà è un rimprovero colpevolizzante diretto all’oggetto (interiorizzato) d’amore perduto, rimprovero che si ritorce sull’Io del soggetto che è inconsciamente identificato con l’oggetto.
La manovra difensiva si rivela tuttavia perniciosa a causa dell’intensa ambivalenza che caratterizza la relazione oggettuale.
L’oggetto perduto, con cui l’Io del soggetto s’ identifica, fu tanto amato ma anche molto odiato, e quella ostilità che, insieme all’amore, inizialmente era orientata verso l’oggetto, ora investe quella parte dell’Io che si è identificata con esso: “l’ombra dell’oggetto ricade sull’Io”.
Il carico di odio ritorna quindi sull’Io come autoaccusa e senso di colpa in un circolo vizioso che, in casi estremi, può portare al suicidio.
L’affetto depressivo
Nella sua forma più elementare l’affetto depressivo corrisponde ad un vissuto d’impotenza (helplessness) cioè all’essere inermi e disperati di fronte ad una situazione che è intervenuta e che non si può cambiare (Bibring, 1953); un fatto compiuto e sentito come irrevocabile che ha introdotto un cambiamento negativo della propria condizione. L’evento “chiave” che può innescare l’affetto depressivo è la perdita, la perdita di qualcuno/qualcosa che si ritiene necessario per il mantenimento del benessere psichico. Allo stesso tempo questo cambiamento si denota anche come perdita di uno stato del Sé, come un venir meno della stabilità interiore e del sentimento del proprio valore, della propria capacità. L’affetto depressivo implica sempre quindi un calo dell’autostima e un impoverimento del Sé: chi è depresso si sente scarico, svuotato, non crede più in se stesso e può ritenersi un fallito.
Ma perché l’autostima sia compromessa, e si produca così l’affetto depressivo, è necessaria anche la presenza di altri fattori.
Bleichmar (1996, 1997), riprendendo Freud (1926), evidenzia come oltre alla perdita oggettuale, debba sussistere anche la mancata accettazione della perdita e il permanere del desiderio nei confronti dell’oggetto perduto, desiderio destinato a rimanere insoddisfatto per sempre perché la propria aspirazione al ricongiungimento con esso rimarrà sempre tale.
Infine, perché si determini una compromissione dell’autostima e si configuri un’esperienza depressiva, è necessaria la presenza dell’aggressività, un’aggressività diretta contro se stessi che, sia pur con rilievi e significati diversi, ritroviamo in tutte le forme di depressione (Bleichmar,1996, 1997). Questo aspetto, peraltro, è ciò che differenzia la depressione dalla semplice tristezza, condizione che non ferisce il sentimento di sé, non implica un calo di autostima e non toglie la speranza.
Fatte queste premesse sul nucleo costitutivo di ogni esperienza depressiva (l’affetto depressivo), va precisato che parlare di “depressione” non significa riferirsi ad un’unica condizione clinica: la psicoanalisi contemporanea affronta il problema considerando le eterogenee configurazioni del mondo interiore che sta dietro le quinte della sofferenza, i livelli di funzionamento mentale e di organizzazione strutturale della personalità che sottendono diverse espressioni cliniche della depressione.
Senso di colpa e senso di vergogna
La depressione può caratterizzarsi per la presenza di un senso di colpa che opprime la coscienza dell’individuo con autoaccuse, recriminazioni, rimorsi. E’ come se la persona depressa sente di aver fatto qualcosa di contrario ai propri princìpi o di lesivo del bene degli altri, soprattutto delle persone che gli sono affettivamente più vicine.
A volte nell’esperienza depressiva non vi è tanto il sentimento di colpa quanto piuttosto un animo mortificato, travolto da un senso di sconfitta e di fallimento: sono qui in primo piano la vergogna, l’umiliazione e l’autosvalutazione legati al non essersi dimostrati all’altezza delle proprie aspettative, incapaci di raggiungere o confermare ciò che da se stessi si pretendeva.
Sono circostanze nelle quali risulta centrale una fragilità narcisistica a causa della quale, ogni volta che la realtà non corrisponde alle aspettative, gli equilibri affettivi si dimostrano precari e vulnerabili, nel segno del fallimento e della delusione verso se stessi.
Il soggetto vede compromessa l’immagine di sé e sperimenta traumaticamente l’impossibilità di corrispondere ad un proprio ideale e di disporre sempre e comunque dell’attenzione, dell’approvazione e dell’ammirazione dell’altro (Battacchi, Codispoti, 1992; Chasseguet Smirgel, 1975; Lewin, 1971; Nathanson, 1987). A questo livello l’esperienza depressiva può essere vissuta come un insulto, come uno scarto intollerabile tra un concetto idealizzato di sé e l’evidenza delle cose che lo smentiscono. La rabbia narcisistica (Kohut, 1978) suscitata dalla vergogna e dall’umiliazione può dominare il campo e può anche tradursi in comportamenti autodistruttivi.
Altre volte le difficoltà narcisistiche sono alla base di depressioni croniche che opacizzano la vita di chi si sente sistematicamente incapace, inadeguato, inferiore, impossibilitato a realizzare ciò che desidera. L’individuo avverte un’insufficienza fondamentale nel suo essere, soggiogato da un ideale di sé eccessivamente pretenzioso che lo pone drammaticamente in rapporto con i suoi limiti (Pasche, 1963). Egli si sente schiacciato da uno scarto tra desiderio e realtà mai completamente colmabile, nell’incapacità di corrispondere a ideali infantili smisurati che non si sono mai ridimensionati con lo sviluppo, con il riconoscimento del limite umano, con l’accettazione delle inevitabili frustrazioni della vita.
La fragilità costitutiva del sentimento di sè può talvolta portare a cercare affannosamente i rifornimenti per l’autostima soprattutto nel mondo esterno, nelle situazioni di vita e nelle relazioni.
È questo il caso di individui che mostrano una difficoltà “strutturale” nel dare continuità al senso del proprio valore in assenza di conferme e di riconoscimenti provenienti dall’esterno. Si parla in questi casi di “depressione anaclitica” (Blatt, 1974) (il termine “anaclitico” fa riferimento all’appoggiarsi su qualcuno/qualcosa), caratterizzata prevalentemente da angoscia di abbandono e senso di isolamento, da un pervasivo bisogno di essere amati “nutriti” e protetti da persone o situazioni particolarmente investite sul piano affettivo.
Esistono infine forme depressive particolarmente radicate nel carattere degli individui.
Kernberg (1988), a questo proposito, parla di “disturbo di personalità depressivo-masochistico”, segnalando la stretta commistione tra depressione e aspetti del carattere che rimandano al “masochismo morale”, concetto introdotto da Freud (1924) per descrivere un assetto caratteriale centrato su un senso di colpa inconscio che porta l’individuo a ricercare situazioni punitive, procurandosi una sofferenza psicologica che, sia pur inconsciamente, gli appare come necessaria, mentre agli occhi degli altri risulta assurda e incomprensibile.
In questi soggetti prevale l’idea di poter essere amati solo mortificando se stessi, di riuscire ad evitare la perdita dell’amore con la sofferenza con il risultato di essere trascinati nella perdita di sé (Bieber, 1980). Il masochista morale “è un depresso che continua a sperare” (McWilliams, 1994) mantenendo a tutti i costi una relazione con l’oggetto, anche se a prezzo della propria infelicità.
Un ultimo aspetto da considerare, in questa breve e inevitabilmente parziale ricognizione della depressione, riguarda il fatto che non sempre l’affettività, il funzionamento cognitivo e il comportamento del soggetto presentano i tratti ben riconoscibili della “sindrome depressiva”.
Ci sono circostanze in cui l’affetto depressivo “non trova le parole” e si esprime nel corpo, con somatizzazioni di vario genere che rientrano nella configurazione della cosiddetta “depressione mascherata”: non si osserva il tipico abbassamento del tono dell’umore, mentre prevalgono i sintomi somatici, come dolori diffusi, disturbi gastrointestinali, cefalea, insonnia, stanchezza persistente o altri sintomi fisici. L’espressione nel corpo del disagio depressivo risulta particolarmente importante nei bambini – che ancora non dispongono di adeguati mezzi verbali e di capacità cognitive che consentano di dar voce alle loro emozioni – e negli adolescenti o negli anziani, per i quali il corpo, anche se per motivi molto diversi, assume nel vissuto soggettivo un’importanza centrale .
Talvolta è invece un ricorrente stato di agitazione a mascherare un sottostante assetto depressivo: il sentimento di incapacità e fragilità intrinseco alla depressione fa sì che ogni cosa, ogni impegno, scelta o relazione, possa diventare una minaccia al proprio equilibrio. L’allerta permanente che ne consegue si manifesta con una sintomatologia ansiosa, in apparente assenza di depressione; nella pratica clinica sono frequenti i casi di ansia che, ad un esame più approfondito, si precisano in realtà anche come disturbi depressivi (depressione agitata).
Infine la depressione può presentarsi insieme alla patofobia, con il convincimento angoscioso, più o meno tenace, di essere affetti da qualche malattia fisica, grave o mortale, in assenza di una corrispondente patologia organica riscontrabile nella realtà.
Spesso questa condizione si accompagna al corteo dei diversi sintomi che caratterizzano il quadro clinico tipico della depressione, ma a volte appare essenzialmente come angoscia ipocondriaca, come terrore di fronte alla malattia di cui ci si crede portatori, come una “depressione senza affetto depressivo” (Asch, 1966).
BIBLIOGRAFIA
Altamura A.C., Cattaneo E., Russo M. (2006) Disturbi dell’umore. In: G. Invernizzi, Manuale di psichiatria e psicologia clinica, McGraw-Hill Ed., Milano.
Asch S.S. (1966) Depression: three clinical variations, Psychoanal. St. Child, 21:150-171.
Battacchi M.W., Codispoti O. (1992) La vergogna, Il Mulino Ed., Bologna.
Bibring E. (1953) Il meccanismo della depressione. In: Il significato della disperazione (a cura di W. Gaylin), Astrolabio Ed., Roma, 1973.
Bieber I. (1980) The meaning of masochism in cognitive psychoanalysis, Jason Aronson, New York, London.
Blatt S.J. (1974) Levels of object representation in anaclitic and introjective depression, Psychoanal. St. Child, 29:107–157
Bleichmar H.B. (1996) Some subtypes of depression and their implications for psychoanalytic treatment, Int. J. Psycho-Anal., 77:935-961.
Bleichmar H.B. (1997) Psicoterapia Psicoanalitica, Astrolabio Ed., Roma, 2008
Chasseguet-Smirgel J. (1975) L’ideale dell’Io, Raffaello Cortina Ed., Milano, 1991
Freud S. (1917) Lutto e Melanconia. In: Opere di Sigmund Freud, Vol.8, Boringhieri Ed., Torino, 1976.
Freud S. (1924) Il problema economico del masochismo. In: Opere di Sigmund Freud, Vol. 10, Boringhieri Ed., Torino, 1978
Freud S. (1926) Inibizione, sintomo e angoscia. In: Opere di Sigmund Freud, Vol. 10, Boringhieri Ed., Torino, 1978
Gabrielli F. (2009) Disturbi dell’umore. In: F. Giberti¸ R. Rossi, Manuale di psichiatria, Piccin Ed., Padova, 2009
Kernberg O. F. (1988) Clinical dimensions of masochism, Journal of the American Psychoanalytic Association, 36: 1005-1029
Kohut H. (1978) La ricerca del Sé, Bollati Boringhieri Ed., Torino, 1982
Lewin S. (1971) The psychoanalysis of shame, Int. J. Psycho-Anal., 52:355-362
McWilliams N. (1994) La diagnosi psicoanalitica, Astrolabio Ed., Roma, 1999
Nathanson D.L. (1987) A timetable for shame. In: The many faces of shame (D. L. Nathanson ed.), The Guilford Press, Los Angeles
Pasche F. (1963) De la depression, Revue Francaise de Psychanalyse, XVII
Siracusano A., Niolu C. (2007) La depressione. In: Siracusano A. (coordinatore), Manuale di psichiatria, Il Pensiero Scientifico Ed., Roma, 2007
Tugnoli S., Tra le pieghe dell’ombra, Foschi Ed., Forlì, 2010
Giugno 2014
Desiderio

Jeff Koons, Hanging Heart – 1995
A cura di Sarantis Thanopulos
La definizione del desiderio è resa problematica dalla sua confusione semantica con il bisogno. Se la differenziazione tra i due termini è già difficile sul piano concettuale, la loro sovrapposizione nel linguaggio comune è quasi la prassi. Nondimeno, tra desiderio e bisogno esistono tre differenze fondamentali che riguardano: a) il tipo di piacere che procura il loro appagamento; b) il loro rapporto con il funzionamento dell’apparato psicocorporeo; c) la natura della relazione con l’altro che essi tendono a determinare.
L’appagamento del bisogno dà un piacere che è il sollievo derivante dalla diminuzione di una tensione psicocorporea spiacevole. Scarica la tensione in superficie, evita la sua propagazione in profondità. La soddisfazione del desiderio è un’esperienza complessa, profonda, che coinvolge sensualmente l’intera struttura psicocorporea. Produce un piacere che deriva dalla persistenza di una tensione piacevole.
Il bisogno implica il ritorno a uno stato precedente a quello di una tensione, una liquidazione degli stimoli che la provocano. Implica un funzionamento psicocorporeo omeostatico, centrato sulla stabilità e la costanza, che si oppone alle trasformazioni che vengono vissute come fonti di destabilizzazione. Insegue la prevedibilità, non ammette il fallimento, “ragiona” necessariamente in termini di quantità: calcola quantitativi di tensione e scarica.
Il desiderio crea una destabilizzazione, sbilanciamento della struttura psicocorporea, produce una sua trasformazione. Segue una visuale di qualità fondata sull’esperienza “gustativa”: insegue il piacere dei sensi, persiste nelle variazioni di intensità e di ritmo, nell’assaporare il mutare delle proprietà, nei cambiamenti di visuale e di prospettiva. Diffida del calcolo, della prevedibilità e della stabilità, che producono assuefazione, non disdegna l’incertezza e il rischio, tiene conto della possibilità di un suo fallimento. Dischiude la materia della soggettività alla realtà, crea l’interesse per il mondo.
Nel campo del bisogno puro l’altro funziona come protesi, si annette al soggetto bisognoso ed è assimilato alla sua materia. È trattato in modo impersonale: può essere usato come oggetto strumentale di scarica o eliminato se crea tensione. Nel campo del desiderio l’altro si congiunge al soggetto. È riconosciuto e rispettato nel suo modo di essere e di desiderare.
Ne L’interpretazione dei sogni (1899) Freud ha concepito il desiderio, nella sua forma sorgente, nel lattante, come “moto psichico” teso alla riproduzione dell’immagine mnestica associata all’appagamento di un bisogno fisico (nell’esempio che egli ha fatto, la fame). È la riproduzione dell’immagine, che si realizza in modo allucinatorio, a rappresentare la soddisfazione del desiderio e non la reale esperienza di appagamento. Questa visuale di Freud, di cui sarebbe opportuno ricordare la stretta connessione con la definizione del sogno come appagamento allucinatorio di un desiderio infantile, è foriera di problemi. Se da una parte fa una chiara distinzione tra desiderio e bisogno, dall’altra rende il primo subalterno al secondo. Non solo perché l’immagine da riprodurre riguarda il bisogno, ma anche perché senza un tempestivo intervento dell’appagamento reale, l’edificio della riproduzione allucinatoria crollerebbe.
L’intenzione di Freud è quella di accordare il desiderio alla sua concezione di un’iniziale onnipotenza dell’apparato psichico, garantita dalla costanza delle cure materne che impediscono il distacco tra l’appagamento reale e la sua allucinazione. L’onnipotenza iniziale protegge l’apparato psichico da un precoce adattamento alla realtà, che avrebbe minato il suo sviluppo conferendogli un carattere compiacente, reattivo. Nondimeno, Freud limitando il dispiegamento del desiderio nel solo spazio psichico, lo dissocia dal movimento corporeo e dalla reale esperienza di piacere dei sensi verso la quale tale movimento tende. L’apparato psichico che egli configura in questo modo è di natura omeostatica, conservativa: insegue il piacere sulla via dell’appagamento del bisogno, cerca il sollievo.
Ne Il problema economico del masochismo (1924), Freud riafferma con forza la centralità del principio del piacere non solo come “custode della nostra vita psichica, ma della nostra vita in genere”, dopo averla messa in discussione in Al di là del principio di piacere (1920). Costretto ad affrontare il problema del piacere associato al dolore, mette in discussione la sua concezione del piacere e del dispiacere come diminuzione o incremento di una quantità di tensione provocata da uno stimolo. Partendo dall’incontestabile esistenza di rilassamenti spiacevoli e di tensioni piacevoli (in particolare quella sessuale) introduce, come strumento di spiegazione più adeguato della differenza tra dispiacere e piacere, un fattore qualitativo. Della natura di questo fattore, la cui conoscenza permetterebbe di fare “un grande passo avanti in psicologia”, non è certo. “Forse”, dice, è il ritmo: la sequenza temporale degli aumenti e delle diminuzioni della quantità dello stimolo.
Questa promettente trasformazione della visuale di Freud non è stata ulteriormente elaborata ed è rimasta marginale nella sua teorizzazione. Egli ha lasciato in eredità una rigorosa definizione dell’apparato psichico in assetto difensivo, la cui descrizione migliore si trova in Inibizione, sintomo e angoscia (1925). Questo apparato è alla ricerca delle condizioni esterne più prevedibili e meno passibili di trasformazione.
Freud ha disincarnato, di fatto, il desiderio, separandolo dal piacere dei sensi e dal movimento, gesto del corpo che accompagna il movimento psichico al godimento dell’oggetto desiderato. Lacan (1958) ha proseguito ulteriormente sulla strada della disincarnazione, definendo il desiderio come “metonimia della mancanza a essere”, una maniacalità perpetua dell’esistenza. L’infinito scorrere del desiderio da un oggetto all’altro, la fuga permanente dal lutto. Collocando il godimento dei sensi nel registro dell’animalità, dell’annientamento dell’oggetto di cui si gode, Lacan l’ha interpretato, di fatto, come appagamento del bisogno, consumo della cosa goduta. Al desiderio non ha riconosciuto altro destino che l’affannosa ricerca dell’oggetto piccolo a, residuo di carnalità sottratto alla sublimazione, umanizzazione del rapporto con la Cosa, il corpo materno: l’oggetto di un godimento originario supposto senza limiti, assoluto.
Il desiderio non passa da un oggetto all’altro nel tentativo senza fine di sottrarsi a una sua costitutiva mancanza, negandola. Ha una costituzione antinomica: insegue la permanenza del suo oggetto e, al tempo stesso, evita l’assuefazione. Deve ritrovarlo sempre nella sua riconoscibile identità e scoprirlo sempre in forme inconsuete, nuove. Lo allontana dal luogo di un legame assoluto, unico, ma cerca di non disperderlo in mille luoghi. Lo colloca in una moltitudine di oggetti in cui vive e si dispiega, per perderlo e ritrovarlo in una o un’altra forma privilegiata. Abita la mancanza, tra assenza e presenza dell’oggetto, tra lontananza e prossimità, plasmando la distanza come differenza.
Il desiderio è un derivato della pulsione erotica. Quest’ultima non è un istinto che mira all’eliminazione di stimoli sgradevoli, ma la spinta che impegna l’intera struttura psicocorporea nella ricerca di una persistente, intensa tensione gradevole procurata dai sensi. La pulsione in se stessa ignora l’alterità, particolarità dei suoi oggetti rispetto alla sua meta, riconosce solo cose in grado di produrre piacere. Il desiderio nasce dove il soggetto spinto dalla pulsione incontra la differenza del proprio oggetto: il suo idioma nel manifestarsi piacevole secondo le sue intrinseche proprietà, che orientano, dandogli profondità e intensità, il proprio godimento. Differenza è desiderio sono indissociabili: la prima fa esistere il secondo viceversa.
Legato alla differenza del suo oggetto, che subisce, soffre e, al tempo stesso, cerca e crea, il soggetto desiderante è in relazione con essa, anche quando all’inizio della sua esperienza non la concepisce e non la riconosce. Il desiderio si configura originariamente come movimento psicocorporeo di estroversione della soggettività in gestazione verso l’incontro sensuale con il corpo materno. L’ estroversione, apertura dell’essere al mondo è silenziosa e il desiderio è desiderio di sé, movimento incompiuto: paradossale destabilizzazione omeostatica, tensione verso il fuori da sé priva ancora di un oggetto esterno. Il piacere dei sensi trascende i confini psicocorporei del soggetto e li estende a sua insaputa.
Il desiderio assume la sua forma compiuta, di desiderio rivolto all’altro, quando il venir meno dell’iniziale costanza delle cure materne mette il bambino di fronte alla perdita della madre come parte di sé, lo espone a un riconoscimento di separatezza drammatico, vissuto come mutilazione della propria esperienza. La ricerca del piacere incontra il dolore della mancanza: la lontananza che continua a dialogare con la prossimità, con la disponibilità dell’oggetto -la cui appropriazione ripara la mutilazione- che non è preclusa né scontata. Il desiderio esce dal narcisismo e dall’autoreferenzialità, diventa sconvolgimento, terremoto della soggettività. Pathos, sofferenza, ma anche “provare” profondo, che ex-tende la materia del soggetto verso l’alterità, lo sbilancia e lo fa sporgere, inclinare nel suo spazio. Il patire, combinazione della spinta interna di appropriazione dell’oggetto mancante e dell’attrazione che esso esercita dall’esterno, è sperimentazione, configurazione di potenzialità che pre-sente, pregusta l’incontro con l’oggetto desiderato.
Il desiderio ama il lutto perché è il lutto che lo fa nascere, lo costituisce (Thanopulos 2016). La relazione di desiderio insegue la disponibilità dell’oggetto desiderato, vive in compagnia di un’esperienza luttuosa. Il lutto dà la misura del lavoro di trasformazione che il soggetto deve compiere su di sé per ritrovare l’oggetto desiderato accordandosi, su un piano nuovo, esprimente un’altra possibilità, con la sua differenza. L’elaborazione del lutto, che richiede che l’oggetto perduto resti disponibile, sia pure su un piano potenziale, lo restituisce, al tempo stesso, identico -riconoscibile nella sua profondità temporale, nella sua persistenza e nella sua identità, cifra originale- e trasformato -aperto alla sperimentazione e all’esplorazione di modalità d’uso inconsuete.
Le radici del desiderio che è rivolto all’altro riconosciuto nella sua differenza sono passionali. Sotto l’effetto immediato del dolore della separazione e della mancanza, mirano alla realizzazione senza compromessi e mediazioni di un godimento non più scontato e stabile. Frutto dell’apertura sanguinante del narcisismo all’alterità, la passione del desiderio è ancora sotto il suo effetto: porta il soggetto a occupare il luogo dell’altro -sul versante del sadismo, definito da Winnicott “amore spietato”, che non riconosce all’oggetto la sua soggettività- o a farsi occupare nel proprio luogo dall’altro – sul versante del masochismo, del lasciarsi andare, abbandonarsi all’oggetto, abdicando alla propria prospettiva. Queste due correnti passionali del desiderio, nel luogo in cui il narcisismo si apre, in due modi opposti, alla vita, mettono in pericolo la relazione erotica: possono portare il soggetto a “uccidere” il desiderio dell’altro dentro di sé o a farsi “uccidere” nel proprio da lui.
La moderazione del desiderio, la modulazione che l’allontana dai suoi eccessi, non è opera di una regolazione esterna al suo dispiegamento, una repressione a fin di bene che lo rende “ragionevole”. È un’intrinseca necessità del desiderio stesso: se l’oggetto desiderato non è rispettato nella sua soggettività, cessa di essere sufficientemente vivo e desiderabile; se l’abbandonarsi nelle mani dell’altro è eccessivo, la capacità di desiderare è in forte pericolo. Proteggere l’altro dalla propria passione e proteggersi dalla sua, è la condizione necessaria per poter restare desideranti. Il desiderio scopre che è proprio ciò che si oppone al suo eccesso che lo fa persistere, permanere. Il soggetto desiderante impara a prendere cura di sé e dell’altro sviluppando un desiderio responsabile. La passione si responsabilizza attraverso l’accordarsi degli amanti nella loro esperienza intima di amarsi guidata dall’esigenza di mantenersi reciprocamente desiderabili e desideranti. (F.Ciaramelli, S. Thanopulos 2016)
La responsabilizzazione della passione avviene nel segno del riconoscimento della differenza tra le soggettività desideranti che le mantiene libere e vive nel loro impegnarsi. Non è esatto dire che desideriamo il desiderio dell’altro (Hegel, Lacan). Desideriamo che l’altro sia desiderante perché sia davvero desiderabile e questo implica la sua libertà di desiderare altro da noi o di costituirsi come nemico, piuttosto che amico, del nostro desiderio. Inseguendo la differenza, il desiderio ama l’incertezza tra l’essere e non essere desiderati.
La differenza è la forza motrice della sublimazione del desiderio. La sublimazione non è disincarnazione, de-sessualizzazione dell’esperienza, appagamento consolatorio, la simbolizzazione come astrazione dalla carne viva della materia psicocorporea. È l’estensione dell’esperienza sensuale, erotica, sessuale al di là dei confini della contiguità corporea e sensoriale. Amplia all’infinito il gioco delle differenze tra due corpi erotici, la cui congiunzione evoca, anche quando ne è tanto lontana da sostituirla del tutto. (S.Thanopulos 2016).
Bibiografia
F. Ciaramelli, S.Thanopulos Legge e desiderio, Mursia Editore, 2016
S. Freud (1899) L’interpretazione dei sogni, O.S.F. Vol. 3
S. Freud (1920) Al di là del principio di piacere O.S.F. Vol. 9
S. Freud (1924) Il problema economico del masochismo, O.S.F. Vol. 10
S. Freud (1925) Inibizione, sintomo e angoscia, O.S.F. Vol. 10
J. Lacan (1958) La direzione della cura e i principi del suo potere in Scritti, Einaudi, Torino 1974
S Thanopulos Il desiderio che ama il lutto, Quodlibet, Macerata 2016
Diagnosi Psicoanalitica

H.Bosch, La pietra della follia, 1494
Diagnosi Psicoanalitica
A cura di L. IANNOTTA
L’etimologia del termine “diagnosi” (letteralmente: conoscenza in progress) rimanda al processo (dia) per mezzo del quale si arriva alla conoscenza (gnosis), nel nostro caso l’identificazione del funzionamento psichico di un’individuo e, allo stesso tempo, al nome che si attribuisce a tale funzionamento.
Dopo secoli in cui la malattia mentale soggiaceva ad una visione magica, religiosa o alla demonologia, si è arrivati nel corso del XIX secolo sempre di più a considerare la follia come espressione di una malattia e una grande mole di ricerche degli psichiatri intenti a definire i quadri morbosi sono confluite negli scritti dello psichiatra Emil Kraepelin (1856-1926) e Sigmund Freud (1856-1939).
Si sono così prodotti tre distinti approcci alla salute mentale:
– l’approccio psicoanalitico si basa essenzialmente sulla conoscenza idiografica, ossia si concentra sulle peculiarità di un singolo individuo (idios), sulla sua specificità e irripetibilità e fa riferimento al proprio corpus teorico. Questo approccio, che si basa su rappresentazioni e processi consci e inconsci, considera le specifiche entità morbose come deviazioni quantitative di un continuum relativo alla personalità, alla percezione, alla cognizione, all’umore, e ad altre caratteristiche derivanti dalla teorizzazione di Sigmund Freud e degli psicoanalisti che si riconoscono nel suo modello e nelle sue dirette evoluzioni;
– la tradizione psichiatrica, che persegue l’obiettivo di associare la diagnosi alla prognosi e ad uno specifico trattamento. Questa tipologia di diagnosi si basa sulla conoscenza nomotetica, ossia identifica un gruppo di criteri e implica che, per fare la diagnosi, quegli specifici criteri debbano essere soddisfatti. Il disturbo è inteso come un insieme di tratti o caratteristiche stabili, le categorie diagnostiche sono differenziate qualitativamente, separate tra loro e mutuamente esclusive;
– la psicometria che attraverso test, questionari e interviste valuta il soggetto tenendo conto di una serie di dimensioni che intendono approdare alla misurazione del funzionamento della personalità; queste dimensioni non hanno l’obiettivo di considerare il caso specifico ma tendono alla conoscenza nomotetica, ossia l’individuazione di leggi (nomos) e ricorrenze che accomunano il funzionamento delle persone nelle diverse situazioni.
Lo psicoanalista Fausto Petrella in “Nosologia e psicoanalisi” (1989) dimostra come Freud (1892-1897), pur lasciando trasparire un interesse specifico per la nosologia, abbia ben presto mostrato l’incompatibilità che si genera tra l’istanza classificatoria e descrittiva della psichiatria e la concezione dinamica e mobile del funzionamento mentale che lui stesso andava elaborando.
A partire da un quadro osservativo e relazionale del tutto inedito ed estraneo alla psichiatria, Freud (1915-17) arriva ad affermare che la psichiatria cerca di caratterizzare il sintomo con una qualità essenziale ma che non ha la capacità di andare oltre. D’altra parte, si va sempre più convincendo che i sintomi altro non sono che manifestazioni ingigantite di fenomeni presenti nella vita psichica di ognuno.
A questo proposito, Westen, Gabbard e Blagov (2006) hanno evidenziato che Freud (1892-97) inizialmente, ha proposto un modello di sindromi discrete e solo successivamente ha maturato la convinzione che non era possibile comprendere i sintomi dei pazienti, isolati da ciò che viene definito carattere, o struttura di personalità. Si passa così dalla nevrosi sintomatica, intesa come sacca di patologia relativamente isolata, al concetto di nevrosi di carattere, ossia una patologia che pervade tutta la personalità.
Pertanto, Freud (1915-17) iscrive il tema della diagnosi nel modello psicoanalitico del funzionamento della mente e afferma di non voler semplicemente descrivere e classificare i fenomeni, ma concepirli come indizi di un gioco di forze che si svolge nella psiche, come espressione di tendenze orientate verso un fine che operano insieme, o l’una contro l’altra per arrivare ad una concezione dinamica dei fenomeni psichici. La diagnosi in psicoanalisi è dunque imprescindibile dal modello complesso della teoria psicoanalitica e include diversi livelli: dinamico (considera i processi mentali come risultato dell’interazione di forze che possono essere in conflitto tra loro), economico (considera la quantità e l’intensità di tali forze); topografico o strutturale (l’apparato psichico è considerato uno strumento composito, si tende a stabilire in quali parti si compiono i diversi processi psichici); evolutivo o genetico (valuta il continuum del ciclo di vita a partire dall’infanzia); adattativo (tiene conto del contesto sociale e ambientale con cui l’individuo interagisce, a cui si adatta o che si adopera per modificarlo).
Il livello evolutivo acquista una particolare rilevanza dal momento che Freud concepiva l’idea che la matrice della salute e della malattia psichica è rintracciabile nell’esperienza infantile e che è questa esperienza che viene riattualizzata nella relazione con lo psicoanalista (transfert). La struttura e il funzionamento psichico, e in particolare la dimensione inconscia, emergeranno man mano all’interno della relazione grazie allo specifico setting previsto dal metodo psicoanalitico.
È questa la cornice che permette a Freud (data) e ai primi psicoanalisti di individuare tre grandi classi di patologie psichiche: a) la Nevrosi che raggruppa l’isteria di conversione (corrisponde grosso modo agli attuali disturbi somatoformi), l’isteria di angoscia (fobie) e la nevrosi ossessiva; b) le Nevrosi narcisistiche: forme melanconiche (depressive) non psicotiche; c) la Psicosi: schizofrenia, paranoia e psicosi maniaco-depressiva/disturbi bipolari. Le patologie collocate all’interno di queste tre macrocategorie si differenziano in base ai loro punti di “fissazione”, alle diverse fasi dello sviluppo psicosessuale e dell’Io, ai meccanismi di difesa e alle angosce prevalenti (Ponsi, 2009).
Sul piano descrittivo e organizzativo della vita psichica sono stati individuati tre livelli che caratterizzano la diagnosi psicoanalitica. Il livello delle difese: le caratteristiche, la frequenza e l’intensità; il livello psico-genetico, che tende alla descrizione delle relazioni tra processi psichici, stadi di sviluppo e relative funzioni; il livello della struttura della personalità relativo all’organizzazione complessiva e alle modalità precipue, relativamente stabili, con cui un soggetto si pone in relazione con gli oggetti del suo mondo esperienziale (Sarno, Caretti, 1999).
In questo modello della diagnosi, concepito come processo dimensionale, l’assunto è che esista un continuum salute-malattia, che la sofferenza abbia un suo significato che viene deformato o occultato dal sintomo, che quell’individuo va visto rispetto alla sua storia e al contesto e solo tenendo conto di queste diverse estensioni si può arrivare ad una comprensione integrata di quella persona e del suo funzionamento. Si differenzia così il processo del diagnosticare dalla diagnosi come “verdetto”, superando il concetto di staticità sia in termini categoriali che temporali (Westen, Gabbard, Blagov, 2006). Rossi Monti (2008) ha posto il problema di che cosa ci si attende dalla diagnosi e che uso se ne fa. Dopo aver dichiarato che la diagnosi che addormenta ogni ulteriore possibilità di conoscenza si pone come ostacolo nella relazione terapeutica, ha indicato la assoluta necessità di difendere ad ogni costo la differenza dell’approccio «clinico» dall’approccio «cinico», dove la ‘l’ comporta una enorme differenza (2008, p. 797). Ma proprio l’approccio clinico alla diagnosi ha determinato una concezione così complessa che, con Petrella (1989), dobbiamo convenire che non si può arrivare ad una tavola schematica che integri tutte le posizioni psicoanalitiche che considerano le diverse sfaccettature del processo e della denominazione diagnostica.
È utile, per concludere, richiamare un saggio scritto da Melanie Klein alla fine della sua vita (1960), e pubblicato postumo, in cui sintetizza il suo pensiero sul tema di cui si era occupata per tutta la vita: che cosa determina la salute mentale? Klein argomenta che, considerando la “natura articolata e complessa della mente”, alla base della salute mentale c’è una buona integrazione della personalità. Le caratteristiche di una personalità integrata, quindi in buona salute, sono: maturità emotiva, forza di carattere, capacità di trattare i conflitti emotivi, equilibrio tra mondo interno e adattamento alla realtà, coesione delle diverse parti della personalità. Melanie Klein specifica che la salute mentale poggia sulla interazione tra le due forze fondamentali della vita psichica, ossia gli impulsi d’amore e di odio, interazione nella quale deve essere la capacità di amare ad essere predominante (Klein, 1960).
Bibliografia
AA.VV. (2013). La diagnosi in psichiatria, Rivista «aut aut», 357, a cura di M. Colucci.
Dazzi N., Lingiardi V., Gazzillo F. (a cura di), (2009). La diagnosi in psicologia clinica. Personalità e psicopatologia. Milano: Raffaello Cortina.
Freud A. (1965). Normalità e patologia nell’età infantile. Valutazione dello sviluppo. In Opere, vol. 3, Torino, Boringhieri, 1979.
Freud S. (1892-97). Minute teoriche per Wilhelm Fliess. O.S.F., 2. Torino: Boringhieri.
Freud S. (1915-17). Introduzione alla psicoanalisi. OSF: 8. Torino: Boringhieri, 1976.
Freud S (1923) Nevrosi e Psicosi , OSF : 9 Torino, Bollati Boringhieri, 2000
Freud S. (1932a). Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie di lezioni). O.S.F., 11, Torino: Boringhieri.
Gabbard G.O. (2014). Psichiatria psicodinamica. Milano: Raffaello Cortina, 2015.
Guerriera C. (a cura di) (2013). Il senso e la misura. Processi valutativi nella presa in carico e nella cura psichica in una prospettiva psicoanalitica. Milano: FrancoAngeli.
Klein M. (1960). “Sulla salute mentale”. Trad. it., Richard e Piggle, 2, 1, 1994.
McWilliams N. (1994). La diagnosi psicoanalitica. Struttura della personalità e processo clinico. Roma: Astrolabio, 1999.
Petrella F. (1989). “Nosologia e psicoanalisi”, in Trattato di psicoanalisi (a cura di A. Semi), vol. 2, Milano: Raffaello Cortina.
Ponsi M. (2009). “Come usa la diagnosi lo psicologo psicodinamico”. In Dazzi N., Lingiardi V., Gazzillo F. (a cura di), (2009), Citato.
Quagliata E. (a cura di) (1994). Un buon incontro. La valutazione secondo il modello Tavistock. Roma: Astrolabio.
Rossi Monti M. (2008). “Diagnosi: una brutta parola?” Rivista di Psicoanalisi, 2008-3.
Sarno L., Caretti V. (1999). “Introduzione all’edizione italiana”. In Mcwilliams N. (1994), citato.
Westen D., Gabbard G.O., Blagov P. (2006). “Ritorno al futuro. La struttura di personalità come contesto per la psicopatologia”. Trad. It. in Dazzi N., Lingiardi V., Gazzillo F. (a cura di), (2009). Citato.
Winnicott D.W. (1959). “Classificazione: esiste un contributo psicoanalitico alla classificazione psichiatrica?” In Sviluppo affettivo e ambiente, Roma: Armando, 1970.
Wittemberg, I. (1982). “Assessment for psychotherapy”. Journal of Child Psychotherapy, 8, 131-144.
Wittenberg I. (1987). “Valutazione in ambito psicoanalitico”. Rivista Prospettive psicoanalitiche nel lavoro istituzionale, 1: 23-41.
Strumenti in ambito psicodinamico
De Coro A. (a cura di) (1996). OPD – Diagnosi psicodinamica operazionalizzata. Milano: Masson, 2002.
Lingiardi V., Mc Williams N., (ed). Manuale diagnostico psicodinamico PDM-2. Milano: Raffaello Cortina, 2017.
Westen D., Shedler J., Lingiardi V. (2003). La valutazione della personalità con la SWAP-200. Milano: Raffaello Cortina.
Dipendenza da internet IAD
A cura di Andrea Marzi e Guido Saltamerenda
L’uso massivo di internet, questa connessione facilmente fruibile attraverso mezzi e dispositivi prima fissi (pc) ed oggi anche mobili (cellulari, palmari, smartphone, tablet) quindi trasportabili con poco o nessun ingombro, è un’icona dei nostri tempi, segno culturale che consente sviluppi in varie direzioni.
Il mondo di internet fornisce un forte contributo attraverso email, social network, chat, blog, skype, alla possibilità di contatti immediati e continui a basso costo, messaggeria spicciola con scambi continuativi (whatsApp).
Gli utenti che usano internet, quotidianamente, sono in Europa quasi il 70%, 30mil in Italia.
Fin dagli anni ’90 e prima del 2008 cercavano prevalentemente informazioni ed usavano email, negli ultimi anni è gradualmente aumentato l’uso delle chat, degli sms, la frequentazione di social network e giochi, siti porno.
Vi è un abbassamento dell’età: lo usa il 52% dei ragazzi (11-15aa), il 60% dei 12enni ha il cellulare, il 50% degli adolescenti europei ha lo smartphone e la metà di loro lo usa online.
La diffusione di questo mezzo può essere visto come affermazione di libertà(vedi anche recente libertà di espressione contro i regimi), possibilità illimitata di accesso ad infinite informazioni, esaltazione delle capacità conoscitive della mente, istinto epistemofilico, ma altresì può divenire una schiavitù, rinchiudere in un meccanismo di controllo e manipolazione, una pseudo realtà.
Goldberg (1995) è stato il primo studioso ad inquadrare la presenza del disturbo di dipendenza da internet e a descriverne i criteri diagnostici (IAD: Internet Addiction Disorder) .
La psicologa Kimberly S. Young (1996) parla di Pathological Internet Use (PIU) e descrive un’ossessione maladattiva all’uso di internet accompagnata da stress e difficoltà a scuola, lavoro, vita relazionale, con alterazioni del comportamento, disturbi dell’umore, fastidi fisici.
Concettualmente è un disordine impulsivo compulsivo che coinvolge l’uso del pc e suoi derivati mobili, soprattutto in modalità on line ma anche off line.
Le classificazioni sono molte, si intersecano, si mischiano: alcuni autori preferiscono usare il termine Internet related psycopathology (Cantelmi-Talli 2007) legato ad un eccessivo uso di internet con un disordine impulsivo compulsivo in giochi, sesso virtuale, email.
Kimberly S. Young rileva tre caratteristiche del disturbo: la tolleranza, come necessità di un forte aumento del tempo passato al pc o derivati mobili; l’astinenza cui un soggetto va incontro quando prova a non usare internet, vivendo così un’esperienza negativa con effetti sul comportamento; infine il craving(irresistibile desiderio di usare la rete web).
Cantelmi-Talli descrivono vari tipi di dipendenza:
-cyber sexual addiction (visitazione siti porno, pratica sesso virtuale)
-cyber relationship addiction: intrattenimento per larga parte del giorno attraverso email, social network, chat lines
-net compulsion: giochi d’azzardo (gambling) online, giochi di ruolo, shopping, trading
-information overload (di cui parla anche Kimberly S. Young): infosurfing
-computer addiction: giochi, gaming, solitari, play station
Gli studi statistici sull’incidenza della dipendenza web rilevano importanti percentuali:
Usa 0,7%, Cina-Grecia 2-11%, Italia 5,6% di studenti, Corea 3 mil. addicted (12% nel 2005, 7 % nel 2012), in Giappone un milione di adolescenti in isolamento sempre più restrittivo (Hikikomori). Internet, il cyberspace, come spazio in parte virtuale, forma di comunicazione mediata da un mezzo, dove l’impatto emozionale subisce una dilatazione e filtro attraverso il viaggio nello spazio e tempo tecnico, divenendo pertanto indiretto, non immediatamente psicocorporeo, ci porta a muoverci su un crinale aperto su due visioni: può così divenire un ambiente favorevole al manifestarsi di aspetti di sé (anche sofferenti), facilitando passaggi ed elaborazioni tra mondo interno ed esterno, liberando parti inespresse, possibile aiuto alla con-figurazione, attraverso immagini virtuali, di esperienze vissute ma non ancora simbolizzate ed emersione di tracce mnesiche inconsce. Può facilitare la capacità di simbolizzare, così come la fantasia creativa: una sorta di cyberspace transizionale tra immaginazione e realtà, una cornice che può attutire il dolore mentale, dove gioco e modalità neosimboliche, consentite e consensuali, rispondono al bisogno di trovare e accogliere nuove dimensioni e ruoli nel registro identitario (adolescenti), emancipando la costruzione della libera soggettività. Può inoltre svolgere una funzione importante nell’esperienza umana della lontananza: qualcosa in absenzia può essere meditato, ipotizzato, adombrato, figurato attraverso il cyberspace, che diviene espressione d’arte con i suoi talentuosi strumenti, quindi trovare traducibilità in immagine suono e parola non necessariamente separati. Si può compiere l’allestimento di una profondità di campo, di un framezzo in cui uno spazio sottratto alla presa diretta si dispone alla nostra immaginazione, meditazione temporo spaziale, simbolizzazione.
Ma al contempo può rischiare di spingere ad una dissociazione dalla propria vita ed immaginazione in un rifugio autistico e un’arena incapsulata, nell’evanescenza di sogni ad occhi aperti (revasserie), o divenire catalizzatore dell’espressione di patologie preesistenti, favorendo la dissoluzione dell’io attraverso la dipendenza estrema, esacerbando instabilità nelle relazioni oggettuali, rinforzando rigidità e difendendo posizioni immobili. Può illudere sull’esistenza di un presente immediato, con simulazione di un oggetto sempre disponibile (magicamente) in un tentativo illusorio di azzeramento della frustrazione dovuta alla mancanza. Tali fattori possono assumere anche carattere di dipendenza più o meno già presente, quindi rinforzarla o evocarla, agevolare un parziale distacco ed allontanamento dall’ambiente reale (relazionale e non) con un viraggio a favore di un ritiro nel virtuale.
E ci si interroga sull’effetto tampone di tale modalità, che allontana dalla possibilità di stare veramente soli, così come da quella di essere veramente insieme.
Allora il contatto ambientale è fortemente impoverito dal risucchio e dalle gravitazioni web.
Un’intrusione massiccia nel quotidiano, quasi un’estasi mediatica.
Merlini (2012) parla di Schizotopia: spazio definito dall’assenza di soglie, dove vi è un crescente bisogno di simultaneità, indifferenza dei contesti con indebolimento dello spazio privato a favore del pubblico, una contestualità estesa, trasversale, sovrapposta, con tendenza alla presenza assoluta: non importa dove sono ma che io sia sempre presente.
Vi è una corrosione della dimensione privata del sé, un’inflazione del pubblico sul privato.
Al qui e ora è contrapposto l’essere anche altrove, quindi qui e ovunque, sradicatezza nella logica dei flussi. Al tempo stesso spazio che confonde (fondere insieme) e spazio che espone (porre fuori).
C’è una riduzione della prescrittività del contesto: Essere ovunque è non essere da alcuna parte (Seneca).
Quindi riassumendo nella dipendenza entrano in gioco diversi fattori, tra cui:
– Distacco dall’ambiente reale e ritiro nel virtuale
(essere con l’altro attraverso un filtro-barriera tecnologica, quindi paravento virtuale)
– antidoto alla solitudine (cordone ombelicale): la realtà virtuale può incarnare l’aspetto attuale di una potenzialità ben più antica, la lunga storia di simulazioni iconiche e linguistiche a partire dalle grotte preistoriche con disegni e dipinti per colmare l’assenza
– controllo dell’altro: vi è prossimità funzionale, il mondo a portata di mano e gli individui a portata del mondo. E l’utente web può divenire risorsa pronta all’uso in entrambe le direzioni, può passare da una risorsa all’altra dopo averne approfittato. Ciò viene definito ontologia economica: si diviene oggetti strumentali, capitale umano, in un clima di appropriabilità istantanea.
– possesso magico di un bagaglio illimitato informazioni a pronto uso e consumo (onnipotenza web)
– facilitazione e slatentizzazione di modalità ossessive, meticolosità compulsiva, manierismi.
La terapia della dipendenza internet si avvalora di una visione etiopatogenetica multifattoriale, che considera cause mediche, psichiche, sociali (socio-antropologiche, macrogruppi virtuali).
Dal punto di vista medico organicistico le neuroscienze indagano sia sul funzionamento di differenti aree cerebrali (io emotivo sottocorticale, io raziocinante corteccia prefrontale) sia sul ruolo dei neurotrasmettitori, due fattori che sembrano entrambi coinvolti nella dipendenza da internet:
-lobo frontale: nella ricerca dello stimolo, abuso e dipendenza, craving, vincita, vi è aumento della funzionalità della corteccia cingolata anteriore e orbito frontale, prefrontale. Al contrario l’attivazione diminuisce in perdita e mediazione emotiva
-aria tegmentale ventrale-nucleo accubens: sono coinvolte nella ricompensa-rewarding system, quando ciò che è buono si ripete
-circuito ricompensa: entrano in gioco anche l’amigdala che immette dopamina, mentre l’ippocampo memorizza l’esperienza piacevole
– influenza dei neurotrasmettitori, tra cui la dopamina (la sua disponibilità diminuisce nei dipendenti), noradrenalina, serotonina (minor disponibilità negli adolescenti), melatonina.
La psicoterapia delle forme più gravi di dipendenza web tende ad essere combinata, attraverso vari interventi:
-gruppo terapeutico come equipe curante, con continua cooperazione tra le diverse figure professionali (psicoterapeuti, medici psichiatri e psicologi d’appoggio per le urgenze, preferibilmente tutti psicoanalisti)
-psicoterapia individuale
-programma tutoraggio
-gruppo polifamiliare (per familiari dei pazienti)
Attualmente gli analisti sono sempre maggiormente impegnati direttamente con un’utenza giovane e web dipendente.
Chi si sta occupando dei casi più gravi in questa dipendenza del comportamento (senza sostanza) pensa che possa assumere il ruolo di una gratificazione senza oggetto, un’attività autoerotica soprattutto presente nella net compulsion (giochi d’azzardo o gambling online, giochi di ruolo, shopping, trading) per certi versi accostabile a quella presente nell’alcolismo (Freud, l’alcool come attività autoerotica): il bisogno di gratificazione deve essere immediato, ricercato nonostante il danno arrecato a se stessi e agli altri; già noto e studiato il ruolo della distruttività auto ed etero diretta nei giocatori patologici ed alcolisti, parenti nella dipendenza.
Il dipendente, divorato e divorante, spesso mostra una regressione orale dove internet diviene droga ed oggetto masturbatorio.
De Paula Ramos ed altri autori (2004) elencano diversi disturbi spesso presenti nel IAD: narcisismo, gratificazione senza oggetto, fantasie di creazione e di controllo onnipotenti, invidia primaria espressa con impulsi distruttivi sadici orali ed anali, relazione simbiotica che perpetua il funzionamento narcisistico con possibili regressioni a comunicazioni primitive.
Sembrano più esposte personalità borderline con scarsa capacità di self caring o narcisistiche con aspetti onnipotenti.
L’uso continuo di internet attraverso email, messaggeria, chat e social network (cyber relationship addiction) sembra una difesa coatta per eludere il vuoto delle separazione, non elaborato ma colmato da oggetti/feticcio intercambiabili, sostituibili, un passaggio da cosa a cosa, connessi ma lontani in spazio virtuale non fisico.
Cosi come spesso è presente una difesa fobica dal vero contatto personale con superficializzazione delle relazioni, eccesso di reale senza profondità con indebolimento dell’analisi induttiva, decremento del pensiero critico, immaginazione, riflessione.
L’affollamento sensoriale presente nel web può facilitare la caduta dell’elaborazione profonda, della trasformazione e simbolizzazione. Il simbolo rischia di perdere la sua funzione e di venire percepito come oggetto reale (equazione simbolica, pensiero concreto in un mondo sterile e persecutorio), immagine non più simbolo ma icona e segnale.
I macro gruppi virtuali web espongono ad un rischio di immersione in un clima di indistinzione confusiva (confusione persona/macchina), identificazioni a massa ed adesive con sfaldamento dei ruoli interpersonali, una voragine asimbolica nella dipendenza distruttiva.
Quindi una pseudo realtà nel virtuale, fagocitati in un mondo alieno con identificazioni proiettive di stampo evacuativo, ritiro disumanizzante.
Bibliografia
Berlincioni V., Bruno D. (2012), Irretiti o liberati. Positività e criticità delle connessioni tra web e psiche, in Quaderni degli Argonauti n° 24, Cis Ed., Milano
Bittanti M. (2008), Intermedialità. Videogiochi, cinema, televisione, fumetti, Unicopli Ed., Milano
Bollas C. (2007), “Cyberspace”, in Phychoanal. Rev., 94, pp 6-9
Carr N. (2011), Internet ci rende stupidi? Come la rete sta cambiando il nostro cervello, R. Cortina Ed., Milano
De Paula Ramos S. (2004), What can we learn from psychoanalysis and perspective studies about chemically patients in Int. J. Psychoanal, 85, pp 467-488
Di Gregorio L. (2012), Le connessioni pericolose, sesso e amori virtuali, Unicopli Ed., Milano
Ferraris M. (2011), Anima e Ipad, Guanda Ed., Parma
Gabbard G.O. (2001), Cyberpassion: E-rotic transference on the internet in Psychoanal Q., 70,
pp 719-737
Longo M. (2012), Uso e abuso della comunicazione digitale, in Quaderni degli Argonauti n° 24,
pp 91-116, Cis Ed., Milano
Marzi A.(2013), Psicoanalisi, identità e Internet. Esplorazioni nel cyberspace, F. Angeli Ed., Milano
Panel Report (2010), Phychoanalysis and virtual reality, in Int. J. Psychoanal, 91, pp 985-988
Price R. (2001), Identity and relationship on the internet, in Psychoanalytic Psychology, 18,
pp 566-571
Suler J. (1996-2005), Personality types in cyberspace, in The Phychology of Cyberspace, Hypertext book
Tisseron S. (2012), Clinic du virtuel: rèvasser, revèr ou imaginer, in L’ Esprit du Temps, 79,
pp 145-157
Zizek S. (2004), What can psychoanalysis tell us about Cyberspace, in Psychoanal rev., 91,
pp 801-830
giugno 2014
Discussioni Controverse

Melanie Klein e Anna Freud
Discussioni Controverse
A cura di Sandra Maestro
Le “discussioni controverse” è il termine dato ad una serie di conferenze (sei) organizzate dalla Società Britannica tra il Gennaio 1943 e il Febbraio del 1944 per discutere le divergenze teoriche e scientifiche, createsi tra i due gruppi della società stessa, capeggiati rispettivamente da Melanie Klein e Anna Freud.

Contesto Storico
Tra il 1934 e il 1938 un nutrito gruppo di analisti viennesi si trasferì a Londra per sfuggire alla persecuzione nazista. Freud con la sua famiglia fu tra gli ultimi a lasciare Vienna. All’epoca la Società Psicoanalitica Britannica contava non più di una 40 di membri ed era influenzata dalle teorie di Melanie Klein, trasferitasi a Londra nel 1926. Le sue idee consistevano fondamentalmente in una estensione delle teorie della psicoanalisi ai bambini ed erano guidate prevalentemente dall’osservazione clinica dei piccoli pazienti; il suo modo di procedere era passionale e impetuoso, a discapito a volte della chiarezza e sistematizzazione del suo corpo teorico per la cui comprensione i suoi stessi seguaci sentivano la necessità di momenti di discussione e chiarificazione delle sue posizioni. Malgrado ciò, le sue teorie avevano informato in modo molto significativo la formazione teorica e tecnica dei candidati fino all’arrivo dei “viennesi” nel 1938.
Con lo scoppio della guerra, tra il 39 e il 42 gli analisti inglesi o naturalizzati inglesi si erano rifugiati in varie zone dell’Inghilterra e della Scozia per sfuggire ai bombardamenti della capitale; altri analisti erano entrati nell’esercito ( J.Bowlby, E. Balint, W.R.Bion) e quindi non partecipavano se non sporadicamente alle riunioni della società. In quel periodo i legami tra gli altri analisti e in particolare tra la Klein e i suoi sostenitori venivano mantenuti soprattutto a livello epistolare. Nel frattempo Edward Glover portava avanti la vita societaria a Londra, con pochi incontri a cui partecipava il gruppo sparuto degli analisti di recente immigrazione a cui non era consentito allontanarsi dalla capitale. Tra questi c’era Anna Freud. Anna Freud aveva raccolto attorno a sé un gruppo di analisti con cui organizzava degli incontri a cadenza quindicinale a casa propria per discutere le sue idee sulla possibilità di applicare la psicoanalisi ai bambini .

All’impoverimento numerico dei partecipanti attivi alla vita istituzionale si sommava l’ulteriore problema della concentrazione di più cariche all’interno di una stessa persona. Glover , ad esempio, era Direttore della Clinica Psichiatrica dove lavorava, segretario scientifico della Società Britannica, segretario della Associazione Psicoanalitica Internazionale e presidente del Comitato di training.Quindi i problemi della vita societaria si intrecciavano con le vicissitudini dei singoli analisti, costretti a migrare e alle ristrettezze economiche. In sintesi nel backgrown delle discussioni controverse va considerato il contesto della guerra e il trauma conseguente allo stravolgimento della vita dei singoli individui, tra cui la separazione dagli affetti, l’arruolamento nell’esercito degli uomini, e la povertà economica dovuta alla mancanza di pazienti e di candidati disponibili per il training.
In questo clima, la portata rivoluzionaria, e per alcuni sovversiva, delle teorie di Melanie Klein ebbero un forte impatto sul gruppo dei freudiani che si era ricostituito a Londra e che si considerava il portatore della tradizione. A questo punto, però, nella Società Britannica si erano creati tre gruppi. Il gruppo dei Kleininai che comprendeva oltre a Melanie Klein Joan Rivier, John Rickman, , Susan Isaacs, Money-Kyrke e inizialmente anche D.W.Winnicott; il gruppo dei Viennesi con Anna Freud, Barbara Law, Marjorie Birerly, Dorothy Burlingam, Ella Sharpe appoggiato da Glover ;infine un gruppo intermedio di cui facevano parte Bowlby, Balint , la Pyne ed altri.
Nel 1942, a seguito dell’accesa conflittualità, fu deciso di organizzare una serie di “riunioni straordinarie” per affrontare le divisioni all’interno della Società Britannica. Durante l’ultimo di questi incontri, nel Giugno 1942, fu deliberato di proseguire con una serie di conferenze per discutere le divergenze teoriche e scientifiche tra i due gruppi, divergenza che avvrebbero avuto ricadute sulla formazione degli allievi, sulla vita societaria e sullo sviluppo della psicoanalisi. Lo scopo delle discussioni era di presentare alcuni concetti estratti dalle teorie della Klein e argomentarne la validità e la congruenza con la tradizione psicoanalitica. Secondo Glover infatti l’onere della prova spettava ai seguaci della Klein, ogni nuova ipotesi doveva dimostrare la congruenza e la contiguità con i concetti della tradizione. Gli analisti coinvolti nelle presentazioni furono Susan Isaacs, W Ronald Fairburn, Paul Heinmann , Melanie Klein stessa mentre tutti gli altri partecipavano alla discussione.
Contenuti delle discussioni controverse
Nella prima conferenza, Susan Isaacs chiarisce la distinzione tra la phantasy, prodotto dell’inconscio, ed il fantasticare ad occhi aperti (l’immaginazione). La phantsy come prodotto diretto dell’inconscio era un corollario della psiche e in quanto rappresentante psichico della pulsione, è innata e coincide con l’appagamento allucinatorio del desiderio. Isaacs riteneva che, per Freud, le pulsioni nella prima infanzia potessero agire solo attraverso il meccanismo della regressione ma che sarebbe giunto a conclusioni diverse se avesse avuto l’opportunità di osservare clinicamente i bambini piccoli. Isaacs aggiungeva che Anna Freud avesse modificato la teoria Freudiana relativa alla nascita dell’Io. Nel libro scritto insieme a Dorothy Burligham, veniva osservato che sebbene introiezione e proiezione siano meccanismi che necessitano di un Io differenziato, già dal secondo semestre di vita il bebè è in grado di riconosce l’esistenza dell’oggetto e di percepirne la gratificazione legata alla sua presenza o la frustrazione all’assenza. In definitiva il disaccordo riguarderebbe solamente il primo semestre di vita in quanto introiezione e proiezione sono meccanismi strutturanti lo sviluppo dell’Io e quindi presenti fin dalle origini della vita psichica. Conclude con un’osservazione relativa al fatto che la vita nelle prime fasi dell’infanzia è ben lungi dall’essere piacevole, per cui tutti gli urti del “non me” formano la base delle angosce persecutorie e necessitano anche la strutturazione di meccanismi di difesa.
Anna Freud osservò che le teorie della Isaacs spostavano lo sviluppo dell’Io nelle primissime fasi della vita e si chiedeva che implicazioni avrebbe avuto questa anticipazione dal punto di vista della tecnica. La Payne osservò che pur considerando la risoluzione del complesso edipico la fase conclusiva dello sviluppo del bambino, alcune difficoltà di natura psichica potevano insorgere anche in fase pre-edipica, suggerendo implicitamente la necessità di una meta-psicologia degli stati primitivi dello sviluppo
Nella seconda conferenza Glover propose la lettura di un articolo di Fairbairn che arrivava a conclusioni molto simili a quelle di Melanie Klein. Secondo l’autore il concetto di fantasia andava integrato più direttamente con il concetto di realtà interna dell’Io, che è popolata dai suoi oggetti interni. Gli oggetti interni sono entità dotate di una identità propria con cui l’Io intrattiene rapporti analoghi a quelli che ha con gli oggetti della realtà esterna. Quindi il concetto di fantasia inconscia va integrato con l’intensa rete di relazioni che l’Io stabilisce con suoi oggetti interni.
Nella terza conferenza, Anna Freud chiarì la sua posizione riassumendola in tre punti fondamentali. Dissentiva dall’idea di Melanie Klein per la quale il bambino fosse consapevole di una realtà esterna al sé prima dei sei mesi. Nel primo semestre di vita, a sua detta, il bambino è solo preoccupato dal raggiungimento del proprio piacere e benessere, quella condizione che Freud definisce come narcisismo primario. La consapevolezza di un oggetto esterno viene acquisita solo dopo il primo semestre ed è mediata dall’esperienza di gratificazione e manipolazione da parte della madre. Dissentiva dall’idea di una percezione dell’oggetto, anche su base allucinatoria. Ipotizzava una netta prevalenza della pulsione libidica sulla pulsione di morte pulsione che Klein ipotizzava alla base dell’atteggiamento ostile del neonato nei confronti degli stimoli esterni.
Nella quarta conferenza, la Heimann partiva dal presupposto che Freud avesse lasciato in sospeso ciò che accade fra il periodo dell’esperienza al seno e le fasi successive dello sviluppo. Definiva i processi di introiezione da parte dell’ Io come l’equivalente di un incorporare e un divorare, parallelamente la proiezione era l’equivalente dello sputare, rigurgitare, evacuare. Il bebè non può tuttavia disfarsi della pulsione di morte, perché è intrinseca all’organismo, innata ed endogena. La relazione precoce con il seno viene interiorizzata e precede la fase auto-erotica. Precocemente viene interiorizzato un seno-buono e il bebè tenta di espellere il seno cattivo. Da questa scissione nascono le radici del super-io; angoscia e colpa si generano nell’attacco all’oggetto interno. Gli oggetti interni possono essere anche benevoli e incoraggianti, non solo persecutori e terrificanti. Durante la discussione della sua paper le furono fatte alcune obbiezioni sull’uso indiscriminato di divoramento incorporazione/introiezione/identificazione e questo richiese l’organizzazione di altri due incontri.
Nell’ultima discussione controversa che si tenne nel Febbraio 1944, Melanie Klein intervenne per chiarire che il punto non era negare o affermare la pulsione di morte, ma esplorare le origini dell’aggressività rivolta verso l’oggetto. La Klein poneva l’accento sullo sviluppo delle fantasie pre-edipiche, teorizzando che l’organizzazione della vita psichica del bambino partiva dal rapporto col seno, e della loro analizzabilità attraverso gioco del bambini nella stanza d’analisi. Al contrario, Anna Freud non credeva che si potesse attribuire al rapporto col seno la funzione organizzativa dei primi stati mentali e valorizzava il materiale clinico relativo allo sviluppo psicosessuale come effettivamente analizzabile.
Conclusioni Le discussioni controverse non portarono a nessun accordo dal punto di vista teorico. Fu deciso infatti che Melanie Klein e Anna Freud avrebbero continuato a tenere nell’ambito del training due seminari paralleli sulla psicoanalisi infantile dove ciascuna avrebbe continuato a sviluppare le proprie teorie e le loro implicazioni per la tecnica. La discussione all’interno della Società proseguì sugli altri punti sollevati e in particolar modo su come le controversie teoriche potevano influenzare la formazione dei candidati e come ristrutturare l’intero comitato didattico e l’iter formativo degli allievi. L’intera vicenda rappresenta una occasione molto ricca di apprendimento sulle radici delle principali teorie e scuole di pensiero che hanno influenzato lo sviluppo della psicoanalisi dei bambini; rappresenta inoltre un esempio dell’accesa conflittualità che si attivò all’interno della comunità psicoanalitica intorno al tema dell’identità e delle appartenenze al gruppo nonché delle resistenze che le nuove idee e teorie hanno incontrato prima di affermarsi.
Bibliografia
Fairbairn W. Ronald D (1944) Endopsychic structure Considered in terms of object relationships, IJPXXV (pp70-93)
-Freud A (1926)Quattro conferenze sulla psicoanalisi infantile, Opere, Vol I Boringhieri editore,
-Grosskurth P. (1986) Melanie Klein il suo mondo e il suo lavoro, Bollati Boringhieri editore
-Heimann P (1952) Certain Functions of Intojections and projections in Early Infancy, in Melanie Klein et all Developments in Psycho-Analysis, Hogart Press, London
-Isaacs S(1948) The nature and Function of Phantasy, IJP XXIX, pp73-97
-Klein M (1927) Symposium sulla analisi infantile, in Scritti 1921-1958, Bollati Boringhieri Editore
Disforia di Genere

SALUSTIANO GARCIA CRUZ
Disforia di Genere
A cura di A. Gesuè
Nel quinto Manuale Diagnostico e Statistico dell’American Psychiatric Association (DSM 5) si è adottato il termine “Disforia di genere” al posto del precedente “Disturbo dell’identità di genere” a causa dello stigma che il termine “disturbo” comportava. La Disforia è definita dal malessere generato dalla mancata corrispondenza tra il genere percepito ed il corpo biologico con cui si è nati, rispetto quale le persone con Disforia avvertono un senso di estraneità e di rifiuto.
Sotto la denominazione di Disforia di genere vengono comprese:
– le forme caratterizzate da tale tipo di sofferenza che oggi si riscontrano, molto più frequentemente che in passato, anche nei bambini e negli adolescenti;
– le persone transgender, che hanno risposto al disagio provato ottenendo la trasformazione verso il genere cui sentono di appartenere con trattamenti ormonali ed estetici,
– le persone transessuali, che richiedono anche gli interventi chirurgici sui genitali in modo da avvicinarsi il più possibile a quel corpo che sentono più adeguato a rappresentare il genere desiderato.
Mentre i transessuali sembrano voler tornare nell’area del binarismo sessuale, molto più variato è il panorama degli altri.
Nella letteratura anglosassone si usa il termine Queer Identity per sancire l’estraneità ad una identità fissa, a categorie precostituite e dicotomiche tipo eterosessuale/omosessuale, maschile/femminile. Tale termine viene usato dagli anni ‘90 per indicare tutte le soggettività non eterosessuali. Un articolo di K. Steinmetz sulla rivista Time (27 marzo 2017) ha riportato i risultati di una ricerca, compiuta negli Usa per conto dell’LGBT, su un vasto campione di adolescenti. In essa risultava che il 20% dei ragazzi “millenial” usava più di cento modi per definirsi (oltre a gay, lesbica, bisessuale e transgender, anche pansessuale, asessuale, genderqueer, ecc.) rispetto alla propria preferenza sessuale e di genere.
La Disforia di genere è indipendente dall’orientamento sessuale e non va confusa con esso. Le persone con disforia di genere possono avere qualsiasi orientamento sessuale e sentimentale. Possono essere ad esempio eterosessuali, omosessuali, bisessuali, asessuali.
Perché quest’incertezza? Quali fattori dobbiamo interrogare?
Oggi concepiamo la formazione dell’essere umano come “unità bio-psico-sociale”, concetto che risale ai tempi del Glossario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la promozione della salute, 1948, che lo adottò.
- Se pensiamo alla parte “bio” dell’unità menzionata, si presuppone possano influire fattori genetici e interazioni ormonali di natura tuttavia non ancora specificata. (La Disforia non si associa ad alterazioni cromosomiche specifiche, come ad es. nella sindrome di Turner, XO).
- Se pensiamo all’influenza sociale sulla formazione dell’identità di genere, si può notare che i fondamenti dell’identità stessa sono oggi più fluidi e precari: Z. Bauman parla di identità liquide e R. Kaës di indebolimento, fino alla scomparsa, dei “garanti metapsicologici” nella società attuale [1].
- La parte psicologica è l’elemento dell’unità menzionata che ha avuto la storia più complessa, soprattutto in tempi recenti.
Secondo Stoller (1964), uno dei primi studiosi che se ne è occupato, l’identità nucleare di genere si forma nei primi 3-4 anni di vita ed è il prodotto dei seguenti fattori: l’anatomia e la fisiologia dei genitali esterni; l’influenza attitudinale di genitori, fratelli e pari (se costoro rimandano al neonato di essere un maschio o una femmina, ciò giocherà una parte importante nello stabilire e confermare l’identità di genere); la forza biologica. Quest’ultima, sebbene nascosta alla consapevolezza conscia e preconscia, sembra fornire una parte dell’energia pulsionale per sostenere l’identità di genere.
Stoller (1968) fu anche tra i primi a inaugurare il filone delle indagini sulla psicogenesi della transessualità, indicando nelle femmine transessuali un frequente legame invischiante con una madre adesiva, ma fredda, ed un padre troppo poco presente.
C. Chiland (2011), nel suo libro Changer de sexe. Illusion e réalité, ipotizza che entrambi i genitori non abbiano favorito un investimento narcisistico in senso fisiologico sul corpo sessuato biologico delle persone transessuali da lei osservate, perché a loro volta essi erano a disagio con il proprio corpo sessuato; in generale, all’autrice sembra che i genitori avessero uno scarso investimento sulle relazioni sessuali perché la sessualità era sentita come distruttrice.
D. Di Ceglie (1998) ha portato l’attenzione sugli eventi traumatici precoci nella vita dei bambini quale fonte di quella che chiama Atypical Gender Identity Organisation (AGIO), in particolare sui lutti precoci; per esempio, la perdita per malattia di fratelli o sorelle di sesso opposto cui si è legati da amore e ostilità, e verso i quali si è vista l’abnegazione dei genitori prima della fine. Essendo impossibile elaborare il lutto, in tali casi i bambini possono ‘entrare nei panni’ del fratello o della sorella perduti, assumendone l’identità di genere.
A. Saketopoulou (2014) ritiene che una migliore comprensione della Disforia si ottenga considerando il problema di genere non come un sintomo, ma come una vitale realtà soggettiva. Definisce quest’esperienza “massivo trauma di genere” e la pone all’incrocio di due condizioni: il sentimento doloroso che il proprio corpo fisico ed il proprio genere siano sconnessi; l’esperienza di essere malintesi nel proprio genere, cioè male interpretati dai propri oggetti primari come appartenenti al sesso natale, nonostante l’esplicita affermazione di una differente identità di genere. Anche per questa autrice la disforia può manifestarsi già nei primi due o tre anni di vita, e condivide alcune caratteristiche formali con l’esperienza traumatica (dissociazione, angoscia, depressione). Al centro dell’angoscia disforica ci sarebbe dunque, come recita il titolo del lavoro dell’autrice, La perdita del corpo come fondamento. I problemi e le difficoltà che ne scaturiscono, anche relazionali, sono le conseguenze di questa situazione, non l’origine.
In un dibattito dal vivo via Zoom (Blass et al., 2021), Saketopoulou ha proposto che non sia “un fatto biologico” che la dotazione sessuale alla nascita conduca verso una identità di genere, bensì un fatto sociale che siamo inclini a trattare come un fatto biologico. La nozione stessa di dimorfismo sessuale potrebbe essere “una costruzione di fantasia fatta dagli esseri umani, non un fatto ontologico”. Se qualcuno si qualifica come una donna trans, mentre a noi appare solo come un uomo assai femmineo, l’interpretazione che sia un uomo che rifiuta la sua femminilità potrebbe indicare un nostro problema a cogliere quanto la sua percezione di sé violi le nostre credenze normative. A livello di metapsicologia potrebbe sfuggirci quanto l’idea della fluidità sessuale (l’apparenza di uomo femmineo) manchi nel cogliere la varianza di genere di qualcuno (il vissuto della donna trans), verso la quale, a questo punto, ci atteggeremmo più o meno consciamente in modo ideologico. Ciò potrebbe rivelarsi dannoso non solo per le persone con Disforia di genere, ma per la Psicoanalisi stessa.
D. Bell ha controbattuto le opinioni di Saketopoulou. In primo luogo, la Disforia è clinicamente una condizione complessa e con un’alta comorbidità; uno dei possibili esiti (per una sparuta minoranza), è di rientrare in una categoria a sé, per la quale solamente si renderà necessaria la transizione medica. Inoltre, se l’identità di genere è largamente (ma non totalmente) un costrutto sociale, negare al sesso corporeo una realtà materiale, e postulare un’identità di genere innata, non sembra possibile.
Sul concetto di transfobia.
Dobbiamo prendere in esame sia il concetto di transfobia esterna che interna. Come per l’omofobia interna ed esterna, esse sono separabili solo per comodità espositiva, mentre in realtà sono fortemente intricate tra di loro. (Gesuè, 2015).
– La transfobia esterna. La maggior parte delle persone tende a vedere il corpo biologico maschile o femminile con cui è nata come il germe della propria identità, cui dà sicurezza ancorarsi. È una sicurezza che non vogliono venga scossa. Per questo le persone con disforia di genere, nel rifiutare il corpo biologico come fondamento, suscitano un’angoscia che tocca le radici del Sé, ed evocano più o meno intense reazioni di paura e di rifiuto in chi ha un’incertezza su queste problematiche.
– La transfobia interna. È il malessere che deriva dalla perdita del corpo reale come fondamento del genere cui si sente di appartenere, quando non si abbracci subito la fantasia di “essere nel corpo sbagliato”. Ci si sente a cavallo tra un corpo biologico maschile o femminile, scritto nei cromosomi, ed un genere in contraddizione con quel corpo.
Ne deriva che la transfobia interna è tanto più intensa: a) quanto più il soggetto è immerso in un ambiente, ostile al suo problema, che riverbera il malessere interno che già avverte; b) quanto lo scenario interno, che alimenta la disforia di ognuno, è denso di emozioni spinose difficili da padroneggiare; c) quanto meno ciascun soggetto riuscirà ad accettare il limite della trasformazione ottenuta con le cure di tipo ormonale, estetico, chirurgico. La trasformazione può realizzare solo un simulacro del corpo desiderato, anche se si spera il più adeguato possibile al genere cui si sente di appartenere.
La presa in carico di persone con disforia di genere.
Per impostare una corretta presa in carico bisogna prima avere una visione corretta della situazione nelle diverse età della vita.
Nell’infanzia e nell’adolescenza è necessario un lavoro di consultazione approfondito rivolto sia al paziente, sia alla famiglia, spesso seguito da un lavoro psicoterapico. Ciò permette di accompagnare da vicino l’evoluzione di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, e delle loro famiglie, con lo scopo (D. Di Ceglie, citato) di sostenere la loro capacità riflessiva nell’esplorare la relazione tra mente e corpo, di tollerare l’incertezza nello sviluppo dell’identità di genere, di mantenere la speranza di trovare una soluzione all’incongruenza nella percezione di genere e corpo, o, quando questo non è possibile, facilitare l’accettazione dei temi relativi all’identità di genere atipica, accompagnare il processo di trasformazione quando questo sia sentito come necessario. Può capitare che soprattutto nell’infanzia i segni della disforia di genere regrediscano e lo sviluppo proceda come per gli altri bambini. Meno frequentemente questo può verificarsi in adolescenza.
Se il disturbo compare in giovani adulti, o adulti, è importante riconoscerlo, approfondirne lo scenario interno e differenziarlo da eventuali patologie psichiatriche, perché la presenza di queste potrebbe rendere problematico il percorso di trasformazione quando venisse posto in atto. Per questo gruppo di pazienti la trasformazione consiste nella somministrazione di ormoni che adeguino il corpo al genere cui si sente di appartenere, in interventi chirurgici di tipo estetico, o di modifica dei genitali, che abbiano la stessa finalità.
Mentre la legge 164 del 1982 prevedeva che la rettificazione anagrafica del sesso sui documenti comportasse l’intervento chirurgico di trasformazione dei genitali, intervento non facile, con possibili complicazioni e non da tutti desiderato, una successiva sentenza della Corte Costituzionale (la 221/2015), con valore di legge, ha stabilito che per la rettifica non è più necessario l’intervento, perché tale procedimento non privilegia la tutela della salute dell’individuo, questa sì fondamentale per la nostra Costituzione.
Bibliografia
Bauman Z., (2001) Modernità liquida, Laterza, Roma.
Blass R., Bell D., Saketopoulou A. (2021) Can we think psychoanalytically about transgenderism? An expanded live Zoom debate with David Bell and Avgi Saketopoulou, moderated by Rachel Blass. Int. J. Psychoanal., 102, 5, 968-1000.
Chiland C., Changer de Sexe. Illusion et Réalité, Odile Jacob, Paris, 2011.
Di Ceglie D., (1998) trad. it. in: Straniero nel mio corpo. Sviluppo atipico dell’identità di genere e salute. Franco Angeli, Milano, 2003
Gesuè A., Un futuro a ciascuno. Omosessualità, creatività e psicoanalisi, Mimesis, Milano, 2015.
Kaës R., Le identificazioni e i garanti metapsicologici del riconoscimento del soggetto. In “Atti del XIV Congresso SPI, Giornate Italiane”, Roma 23-25 maggio 2008.
Sachetoupoulu A., (2014) Mourrning the Body as Bedrock: Developmental Considerations in Treating Transsexual Patients Analytically. Journal of the American Psychoanalytic Association, 62, 773-806.
Stoller R.J., A Contribution to the Study of Gender Identity. Int. J. Psychoanal., 45, 220-226.
Stoller R.J., Sex and gender, Science House, New York, 1968.
[1] I garanti metapsicologici si possono esemplificare con le funzioni che in qualsiasi gruppo sono svolte dalle leggi, dagli ideali comuni, dalle rappresentazioni e dai patti, largamente inconsci, che tessono “i principi organizzatori della psiche individuale e le condizioni intersoggettive sulle quali essa si basa” (Kaes, 2008, p. 167).
Dissociazione (trauma)

Renè Magritte, Il doppio segreto - 1927
A cura di Gabriella Giustino
Definizione
Nella sua accezione più ampia il termine dissociazione psichica indica l’esclusione di alcuni contenuti mentali dalla coscienza. Gli elementi dissociati non sono integrati nella consapevolezza cosciente, nella memoria e nell’identità. Dissociare, infatti, significa tenere distinte idee, cose o persone che stanno solitamente insieme.
La dissociazione può riguardare i processi di pensiero, le emozioni, la funzionalità senso motoria e i comportamenti.
E’ ormai assodato che i disturbi dissociativi possono essere concettualizzati come una modalità disfunzionale di autoprotezione dalla minaccia. Da qui la concezione che la dissociazione sia una condizione correlata a situazioni traumatiche. Secondo la durata (un singolo evento o un’esposizione prolungata) e il periodo di vita (ad esempio quello dello sviluppo) dell’esperienza traumatica possono esserci diversi danni ai meccanismi d’ integrazione dell’esperienza che tutti quanti naturalmente possediamo.
Storicamente il concetto di dissociazione è stato introdotto per la prima volta alla fine dell’ottocento da Janet (désagrégation) che lo ha definito come fallimento nell’integrazione di esperienze (percezioni, memorie, pensieri, ecc.) che sono normalmente associate tra loro nel flusso di coscienza . Egli evidenziò un’eziologia traumatica del disturbo ritenendo, infatti, che i ricordi traumatici non venissero del tutto assimilati, ma che continuassero ad esistere nel soggetto come idee fisse. Secondo l’interpretazione di Janet, a seguito di tali esperienze traumatiche, alcune funzioni mentali divengono autonome rispetto al controllo centrale, a causa del grave indebolimento delle energie nervose che sostengono il coordinamento delle funzioni mentali stesse.
Diagnosi
Le diagnosi psichiatriche di Disturbo da Stress Post-Traumatico (Post-Traumatic Stress Disorder – PTSD) e Disturbo Acuto da Stress (DAS) sono le uniche a tenere in considerazione fra i criteri diagnostici l’aspetto eziologico, il trauma appunto, ma non sono sufficienti a dare conto di una serie abbastanza specifica di sintomi che ritroviamo con una certa frequenza in pazienti affetti da disturbi differenti ma accomunati dall’aver vissuto storie di sviluppo costellate da traumi relazionali.
In questo senso gli stati dissociativi della mente possono intendersi come categoria diagnostica o come gruppo di sintomi ma anche come processi patogenetici legati ad esperienze traumatiche relazionali dell’infanzia che interferiscono con l’integrazione delle funzioni psichiche.
Carlson et al. hanno proposto per questi ultimi il termine developmental trauma (trauma dello sviluppo).
Le esperienze traumatiche infantili spesso non sono sottoposte a rimozione ma dissociate, incapsulate ed isolate dal flusso di coscienza. Nei trattamenti psicoanalitici abbiamo spesso a che fare con pazienti adulti che hanno subito un trauma nell’infanzia.
In questi casi s’incontrano frequentemente parti della psiche che sono state dissociate dal Sé e che, quando riemergono, producono stati di coscienza alterati. I pazienti solitamente riferiscono la perdita del senso di se stessi, sentimenti di alienazione e paralisi. Queste descrizioni indicano l’esistenza di stati mentali dissociati che producono un intollerabile senso di disagio e che sono scatenati da stimoli esterni o dall’improvvisa apparizione di pensieri associati con un evento traumatico. La loro improvvisa e violenta intrusione nella coscienza genera nei pazienti un profondo senso d’impotenza e, durante questi stati mentali, talora i pazienti riferiscono che tagliarsi o danneggiarsi fisicamente comporta un senso di sollievo: è come porre fine a un’ intollerabile tensione ritrovando la capacità di sentire se stessi.
Da questo punto di vista i ricordi dei traumi infantili possono presentare una particolare fissità e il recupero del loro significato emotivo è molto complesso .
Questi ricordi dissociati possono anche riemergere nei sogni come frammenti estremamente vividi, veri e propri flashback, della storia traumatica infantile (Giustino, 2009).
Il concetto di dissociazione in psicoanalisi
Freud dalle osservazioni delle pazienti isteriche approdò alla teoria della difesa e della rimozione mentre Breuer continuò invece a ipotizzare l’esistenza, oltre alla presenza della scissione trasversale tra conscio e inconscio, anche del meccanismo della dissociazione verticale tra stati coscienti e inconsci.
Freud sosteneva l’esistenza di un netto divario tra conscio e inconscio e per questo aveva pensato a una barriera il cui scopo era quello di salvaguardare la coscienza dai contenuti inconsci, i quali, essendo simili al pensiero onirico, esprimevano un funzionamento mentale più primitivo.
Breuer pensava invece che l’esperienza traumatica fosse tenuta in vita non tanto da un suo stazionamento nell’inconscio quanto piuttosto da uno stato di autoipnosi che, obnubilando i poteri percettivi, impediva un pieno rapporto con la realtà e toglieva al soggetto il mezzo più efficace per contrastare le idee responsabili della conversione.
Nella disputa scientifica tra Freud e Breuer, vinse Freud e Breuer si allontanò dalla psicoanalisi.
A causa del prevalere dell’impostazione di Freud a scapito di quella di Breuer, l’isteria diventò la malattia della rimozione e non della dissociazione.
La difesa e il conseguente corrispettivo concetto di conflitto caratterizzarono, infatti, tutta la concettualizzazione psicopatologica psicoanalitica che nacque dallo studio dell’isteria.
Più tardi la psicoanalisi kleiniana con l’esplorazione delle patologie narcisistiche e dei disordini borderline portò in evidenza il termine di “scissione” strettamente legato al meccanismo dell’identificazione proiettiva e alla scissione orizzontale di parti dell’Io e dell’oggetto (divise in buone e cattive). E’ importante notare che il meccanismo della scissione non può spiegare adeguatamente gli alterati stati di coscienza e gli stati mentali dissociativi che derivano da esperienze traumatiche.
Il termine dissociazione torna poi con Kernberg che, integrando il modello kleiniano con la concettualizzazione di Jacobson, parla di stati dell’Io che sono dissociati uno dall’altro e che sono organizzati intorno a polarità affettive (che si trovano in una posizione conflittuale tra loro); anche Kohut parla di una scissione verticale, che permette ad atteggiamenti psicologici incompatibili (un Sè grandioso e un Sè orientato secondo il principio di realtà) che coesistono fianco a fianco. Tuttavia entrambe queste concettualizzazioni non prendono in considerazione la dissociazione come conseguenza di eventi traumatici.
Trauma, dissociazione e memoria
Per trauma in psicopatologia s’intende di solito un’ esperienza minacciosa estrema, insostenibile e inevitabile, di fronte alla quale l’ individuo è impotente (van der Kolk 1996 ).
In questi casi si attiva un sistema di difesa che provoca la disconnessione tra i diversi livelli funzionali della mente e che, producendo i sintomi dissociativi di distacco, impedisce l’integrazione dell’evento traumatico nella vita psichica a causa della discontinuità e frammentazione della coscienza e della memoria.
Il tema comune condiviso dai disturbi dissociativi è la perdita parziale o completa della normale integrazione tra i ricordi del passato e la consapevolezza dell’identità personale.
Giacché i ricordi traumatici spesso non sono soggetti a rimozione ma a difese dissociative essi sono come impressi a fuoco nella nostra mente, isolati ed inclusi in una particolare fissità : a volte sono impossibili da ricordare ma talora anche da dimenticare e sottoporre ad un oblio necessario e ritornano come memorie indelebili ed intrusive.
Ciò accade senz’altro negli eventi traumatici acuti e devastanti (come ad esempio lo scoppio di una bomba o un incidente) ma è possibile anche ritenere che il ricorso continuato a processi dissociativi di distacco durante lo sviluppo, per il ripetersi di traumi relazionali precoci, insieme ad altri meccanismi patogenetici, possa ostacolare in maniera permanente le capacità integrative dell’individuo provocando i sintomi da compartimentazione e una dissociazione strutturale della personalità . Vi è dunque una dimensione psicopatologica che presenta manifestazioni dissociative e che è legata alle esperienze traumatiche dello sviluppo. Questa può verificarsi quando il trauma è ripetuto, cumulativo (per dirla con Masud Khan) e riguarda soprattutto la presenza di traumi emotivi ripetuti durante lo sviluppo infantile.
Il processo di recupero della memoria implica un’ interazione complessa fra circostanze della vita presente, fra ciò che ci proponiamo di ricordare, e il materiale che abbiamo ritenuto dal passato. I ricordi sono perciò (ri)costruzioni del passato, che sono codeterminate dal presente. Per contro, come abbiamo accennato in precedenza, i ricordi traumatici non sono soggetti a queste trasformazioni provocate dal presente.
L’angoscia che supera le capacità di contenimento emotivo del soggetto altera in modo significativo il processo di codificazione, stivaggio, la conseguente consolidazione di un ricordo e il suo recupero. Le funzioni integrative della memoria in questi casi sono state sommerse e compartimentate. I ricordi traumatici vengono incapsulati e isolati dal restante flusso di coscienza. A volte lo stato dissociativo scompone la memoria degli eventi traumatici nelle sue diverse componenti: somatica, sensoriale, cognitiva, emotiva. Le esperienze dissociate sono simultaneamente sia conosciute che non conosciute (il conosciuto non pensato di Bollas).
Un ricordo traumatico dunque è soggetto a poca o a nessuna revisione o trasformazione da parte della situazione presente . Proprio perché le funzioni integrative della mente possono essere compromesse vi può essere l’affiorare improvviso e involontario di memorie traumatiche e questo fatto spesso si accompagna alla sensazione di perdita di controllo delle emozioni.
Sogni traumatici e memoria nel sogno
Freud nell’Interpretazione dei sogni (1900), aveva individuato i sogni biografici che sono descrittivi della storia e del vissuto infantile del paziente, non sono frutto del lavoro onirico della censura e non necessitano pertanto di un’interpretazione simbolica che riguarda il contenuto inconscio. I sogni traumatici furono descritti anche da altri Autori (tra cui Garma 1946, De Moncheaux1978) come sogni tipici che saltano la censura onirica ed hanno uno statuto particolare.
I recenti progressi delle neuroscienze sulle memorie traumatiche ci dicono che in alcuni pazienti che hanno subito un trauma violento (come un abuso sessuale o l’essere sopravvissuti a un evento realmente catastrofico), il ricordo del trauma può presentarsi improvvisamente, di solito in uno stadio avanzato del processo analitico, con un sogno o con un ricordo della veglia. Spesso lo stato mentale dissociato irrompe durante l’analisi come un acting non mentalizzato e difficilmente comprensibile (Varvin, 2003). In questi casi si verifica il riemergere improvviso di situazioni traumatiche violente che la mente ha tenacemente dissociato e apparentemente non registrato.
Yoram Yovell (2000) è un autore cerca di integrare i contributi delle neuroscienze con la psicoanalisi e parla dei rapporti fra trauma e memoria. Egli afferma che il disordine della memoria esplicita conseguente a un trauma violento può determinare sia fenomeni ipermnestici (flashbulb memories) che amnesia rimotiva o dissociativa intensa. Entrambe queste due condizioni possono essere presenti nello stesso paziente traumatizzato; ma ciò che è più importante è che il trauma dissociato tende a riemergere quando, nella relazione terapeutica, si crea un certo clima emotivo. Infatti, la memoria implicita ed emotiva del trauma è conservata in modo indelebile dall’amigdala e può essere stimolata e riemergere quando si verificano eventi che si collegano associativamente con il clima angoscioso del trauma.
Spesso la comprensione di questi improvvisi ricordi o sogni post traumatici si presenta difficile e laboriosa perché il paziente mostra di non avere alcuna consapevolezza inconscia dell’evento. Yovell afferma anche che le false memorie legate al vissuto traumatico infantile, anche se distorte, hanno sempre un significato per il paziente e vanno comunque considerate come fenomeni comunicativi importanti della storia traumatica dell’individuo.
In un lavoro pubblicato sull’International Journal of Psychoanalysis nel 2009, ho descritto una particolare tipologia di sogni in cui non si esprime il trauma infantile classicamente inteso come memoria rimossa bensì emergono frammenti di memoria traumatica dissociata. I sogni che ho descritto sono fenomenologicamente densi di aspetti concreti e sensoriali (flashback visivi, memorie intrusive) lasciano il paziente attonito e sono espressione di un inconscio emotivo preriflessivo. La componente d’immersione sensoriale nell’esperienza del sogno è prevalente e non permette inizialmente al paziente di fornire alcuna associazione.
Nonostante la chiarezza del contenuto manifesto, il paziente non riesce a riflettere sul sogno, a dargli un senso e a fornire associazioni ad esso. Seguendo il pensiero di Grotstein (2000) in questi casi è possibile individuare il sognatore che fa il sogno (lo esperisce) ma non è presente il sognatore che lo comprende e l’analista deve funzionare come un contenitore dotato di funzione alfa (Bion, 1962) che accoglie il racconto del sogno e aiuta il paziente a dargli un significato proprio nella misura in cui la memoria del passato non è comprensibile allo stesso paziente.
Bibliografia
Bion WR (1959). Cogitations London, Karnak 1992 pp. 186-190.
Bollas C (1987). The Shadow of the Object: Psychoanalysis of the United Kingdom
London, Free Association Books 1987.
Carlson EA, Yates TM, Sroufe LA (2009). Dissociation and the Development of the Self. In Dell P, ONeil JA (Eds.), Dissociation and Dissociative Disorders: DSM-V and beyond. New York: Routledge.
De Moncheaux C (1978). Dreaming and the organizing function of the Ego. Int J Psychoanal 59: 443-453.
Freud S (1900). The interpretation of dreams SE 5.
Freud S (1914). Remembering, repeating and working through SE 12.
Garma A (1946). The traumatic situation in the genesis of dreams. Int J Psychoan 27: 134-139.
Giustino G (2009) “Memory in dreams” (Memoria nel sogno) International Journal of Psychoanalysis 90: 5 pp1057-1073 .
Grotstein J S (1978). Who Is the Dreamer Who Dreams the Dream and Who is the Dreamer Who Understand It ? in Do I Dare Disturbe the Universe? London, Karnac, 1983 pp. 358-416.
Yoram Y (2000). From Hysteria to posttraumatic stress disorder.
Psychoanalysis and the Neurobiology of Traumatic Memories. Journal of Neuro-psychoanalysis 2:171-181
Van der Kolk ( 1996 )The complexity of adaptation to trauma: Self-regulation, stimulus discrimination and characterological development. In van der Kolk BA, McFarlane AC, Weisaeth L (Eds.), Traumatic stress: The effects of overwhelming experience on mind, body, and society (pp. pp. 182-213). Guilford Press, New York. Psychiatry, 167(6), 640-647.
Emergenza in adolescenza

Rooze Mirjan
A cura di Anna Maria Nicolò
Esiste un’emergenza adolescenza? Molti adulti, specie operatori in vari settori (psicologico, socio-sanitario, giuridico, educativo), guardano sgomenti i più di ventimila siti pro-anoressia, le immagini di nudo proprio o del proprio partner o di compagni occasionali che molti adolescenti esibiscono su Facebook. Statistiche incredibili ci dicono che uno su due dei nostri adolescenti ha subito o agito episodi di bullismo a scuola o nei gruppi tra pari. Le prime esperienze sessuali si sono spesso fatte fugaci, occasionali, scisse dalla dimensione affettiva che talora viene raggiunta molto tempo dopo.
L’adolescente privilegia così le sensazioni invece di vivere una relazione con l’altro, con la sua ricchezza e creatività, ma anche con i naturali limiti e la possibile frustrazione che nasce nella relazione con l’altro.
Stiamo anche parlando di un modo peculiare di vivere il corpo, caratterizzato da una sorta di dissociazione affettiva da esso. Fino a qualche anno fa, a dominare la scena delle psicopatologie legate all’integrazione del corpo sessuato erano solo l’anoressia, le dismorfofobie, alcune forme di breakdown; oggi sempre più frequente è l’osservazione di comportamenti auto lesivi che trovano la loro espressione in pratiche comuni come i tatuaggi, i piercing, le cicatrici. Tali pratiche si fanno talora più complesse arrivando al self cutting o alle scarificazioni.
Tuttavia ogni momento storico ha i suoi rituali e le sue pratiche, pertanto i comportamenti di un’adolescente che si segna il corpo con un tatuaggio uguale all’amica, che fa un piercing come i suoi compagni, che esprime con un segno sul corpo un pensiero difficile da simbolizzare, devono essere considerati manifestazioni attuali di un processo evolutivo caratterizzato dal bisogno di appartenenza e dalla difficoltà a simbolizzare il corpo e le sue sensazioni.
La prima domanda da porsi, quindi, è: quando momentanei disturbi della crescita devono essere considerati ‘fisiologici’ e quando indice di un disturbo evolutivo? E’ possibile individuare il rapporto tra tali agiti e il tipo di fallimento del processo di crescita?
Il primo aspetto da sottolineare è la spinta sociale all’individualismo e al protagonismo attraverso il paradosso dell’imitazione e dell’adesione ad un modello condiviso dal gruppo sociale. Riuscire a sentirsi unici e originali, sfida propria dell’età, sembra coincidere in molti adolescenti oggi con il tentativo di costruirsi una sorta di “identità estetica” che sia accettata dal gruppo dei pari. Apparire più che essere – a tutti i costi anche attraverso un’originalità negativa (Erikson) – alimenta la fantasia di emergere dalla massa, che viene sentita di per sé annullante. Non c’è dubbio che il complesso senso della nostra identità ha stretta relazione con lo sguardo di noi su noi stessi e dell’altro su di noi, l’apparenza è una dimensione della nostra identità. A volte tale apparenza conferma l’identità, a volte ne offre un’immagine contrastante e opposta. A volte una personalità fragile sostituisce al senso stabile dell’identità la sua apparenza. Spesso osserviamo quanto gli adolescenti mostrino la ricerca della loro identità attraverso l’angoscioso e incessante mutare della loro apparenza, mostrandosi con i look più differenti e contrastanti. L’adolescente guarda perfino se stesso come se fosse all’esterno di sé, è lo spettatore di se stesso ed esiste nel sentire, nelle sensazioni che prova, sulla superficie della pelle, vista dall’esterno o vissuta sul piano sensoriale. Con questo apparire puoi sentirti nel gruppo e perciò non sei uno “sfigato” e puoi anche entrare in competizione con gli altri. Per non essere sfigato dovrai alla fine essere forte e questo significa per molti adolescenti tenersi lontani dalle emozioni che conferiscono senso di fragilità. «Sono spietato, perciò mi guardano», diceva un adolescente di 14 anni, conferendo alla parola “spietato” un senso di valore e superiorità. E la usava sia lui sia i compagni per dire “ho fatto bene”, “ho risposto bene”. Accanto a tutto ciò, c’è una soluzione inquietante che molti adolescenti usano ed è l’uso delle droghe per calmare l’angoscia, per prodursi sensazioni e come aspetto aggregante. Si sta con i coetanei, ma si è soli con le proprie sensazioni.
Il senso del limite è uno dei compiti dell’adolescenza possibile, in primo luogo proprio grazie alla condivisione del corpo nelle relazioni con l’altro. Assistiamo invece troppo spesso al fallimento di tale processo tra i ragazzi, che invece viene sostituito dalle enormi possibilità correlate allo sviluppo della realtà virtuale che consentono un abnorme mantenimento di un senso di onnipotenza infantile. La vita in internet è una dimensione senza corpo e quindi senza limiti che rappresenta più della metà delle esperienze che i ragazzi vivono quotidianamente. Se da un lato infatti l’adolescente è chiamato a confrontarsi con lo sviluppo sessuale e con la perdita della bisessualità, è turbato dalla prepotente presenza delle sensazioni corporee e dall’impossibilità ad esperirle in modo onnipotente, da un altro il virtuale è governato da leggi differenti, dove i limiti del corpo non esistono e dove sensazioni e confini sono sostituite da pensieri infiniti. Una paziente, qualche anno fa, aveva sviluppato in coincidenza con il menarca una dipendenza da una chat virtuale nella quale aveva assunto l’identità di un amico deceduto, divenendo prima maschio come lui e nel tempo un essere asessuato, che nel mondo dei giochi virtuali viene definito ‘neutro’.
Cosa pensa lo psicoanalista delle nuove adolescenze? Per comprenderle deve certo riandare alla propria adolescenza e sviluppare gli strumenti per navigare in questo mare. Ma quale è la risposta? Come suggeriva Winnicott, è il tempo e attendere nella bonaccia? Ma talora questa attesa è pericolosa e fa perdere occasioni preziose. Oggi con l’adolescente e i suoi genitori abbiamo imparato e stiamo imparando a usare la fantasia, a pensare, a sognare.
Giugno 2015
Enactment

Max Ernst - 1923
A cura di Maria Ponsi
Definizione e storia del concetto
Il cambiamento a cui è andato incontro il paradigma concettuale della psicoanalisi contemporanea, con l’enfasi posta sugli aspetti relazionali rispetto a quelli pulsionali ed intra-psichici, ha orientato l’attenzione verso gli aspetti interattivi che percorrono il trattamento analitico – e cioè verso quel flusso continuo di micro-azioni che accompagna lo scambio verbale fra paziente e analista. E’ vero, come diceva Freud, che fra paziente e analista non si scambia nient’altro che parole; ma le parole non esprimono solo dei contenuti, esercitano anche – attraverso la dimensione pragmatica del linguaggio – un’influenza sull’interlocutore. Parlare è un atto relazionale; come tacere del resto. Le parole ‘agiscono’, ovvero implicano delle azioni, anche se non nel senso motorio del termine.
Come, da un lato, viene messa in evidenza la dimensione interattiva presente nell’espressione verbale, così, dall’altro, viene recuperata la dimensione comunicativa presente in ogni comportamento; ciò vale in particolare per quei comportamenti cosiddetti ‘agiti’ nei quali è comunque rintracciabile un’intenzione, ancorché inconscia, di mettersi in relazione con l’altro.
Negli approcci relazionali si è anche sviluppato un modo nuovo di concepire il controtransfert e il ruolo dell’analista: questi non viene più visto come una presenza anonima e asettica, come uno ‘schermo opaco’ su cui si riflettono i movimenti psichici del paziente, ma come un partecipante attivo al processo analitico, nel quale entra con la propria specifica soggettività.
In questa prospettiva teorico-clinica particolarmente attenta alle dinamiche interattive hanno assunto un particolare rilievo quei momenti in cui l’analista si accorge di trovarsi lui stesso ad’agire’, come se il paziente ve lo avesse sottilmente indotto. E’ a questo proposito che si è cominciato a utilizzare il termine di enactment – un termine peraltro da tempo in uso nel vocabolario psicoanalitico, con il quale si designava, in senso lato e generico, l’ ‘attualizzazione’ o la ‘messa in atto’ di una fantasia inconscia.
In una concezione più relazionale, bi-personale e interattiva dell’analisi, il significato di questo termine è diventato più specifico ed è passato a designare un evento analiticamente rilevante, che coinvolge contemporaneamente paziente e analista. L’enactment si può dunque sinteticamente definire così: un episodio relazionale a reciproca induzione che si evidenzia attraverso un comportamento.
Sull’enactment, come del resto su qualsiasi nozione psicoanalitica, non c’è unanimità di definizione fra le varie scuole psicoanalitiche: c’è chi ne accentua l’eccezionalità, la dinamica inconscia e regressiva, e chi la dimensione normalmente interattiva di ogni rapporto umano. Per gli analisti più classici, l’enactment è un evento che segnala una collusione transfert-controtransfert, da imputare essenzialmente a un mancato controllo del controtransfert: è dunque in qualche modo un errore, o una smagliatura nella relazione analitica, anche se poi, una volta elaborato, questo errore può venire superato e convertirsi in un’occasione per approfondire il lavoro analitico. All’estremo opposto ci sono i modelli di psicoanalisi per i quali gli enactments sono evenienze ordinarie che percorrono continuamente la relazione paziente-analista – evenienze non solo inevitabili, ma anche ubiquitarie, dal momento che la dimensione di azione, o di inter-azione, è parte intrinseca del processo analitico. In questa prospettiva gli enactments sarebbero come la punta dell’iceberg, quella più evidente, di questo continuo flusso interattivo.
Al di là di questi problemi concettuali e definitori, la nozione di enactment è senz’altro molto utile nella clinica, soprattutto quando si trattano pazienti con disturbi narcisistici e borderline di personalità, nei quali le carenze della mentalizzazione rendono le loro comunicazioni più ‘agite’ che ‘verbalizzate’.
BIBLIOGRAFIA
Filippini S. & Ponsi M. (1993). “Enactment”. Riv.Psicoanal. 39 (3): 501-518.
Ponsi M. 2006: Voce “Acting (in e out), enactment, agire” per Psiche. Dizionario storico di psicologia, psichiatria, psicoanalisi, neuroscienze, a cura di Barale F., Bertani M., Gallese V.,Mistura S., Zamperini A. Einaudi, Torino.
Ponsi, M. (2012). Evoluzione del pensiero psicoanalitico. Acting out, agire, enactment.Riv.Psicoanalisi, LVIII (3): 653-670.
Età evolutiva/Psicoanalisi
A cura di Emanuela Quagliata
Il primo anno di vita
Dall’acqua all’aria
Quale inizio ha avuto la nostra vita? Spesso le madri tendono a dimenticare l’esperienza del parto, tanto più se è stata dolorosa e traumatica e noi apparentemente non conserviamo tracce coscienti di quella epocale transizione. L’esperienza che il neonato affronta durante l’evento della nascita è stata oggetto di crescente interesse solo negli ultimi trent’anni, soprattutto da quando il medico francese Frederick Leboyer ha cominciato a studiare l’evento del parto dal punto di vista del bambino. Le sue ricerche hanno evidenziato l’importanza del momento in cui viene reciso il cordone ombelicale, che fornisce sangue e ossigeno al bambino tenendolo in vita fino a quando non è in grado di farcela da solo.
Il “passaggio dall’acqua all’aria” è un’immagine che rappresenta il sentimento terrificante di perdita e impotenza collegato al cambiamento che il neonato prova quando si sente non “contenuto”, dopo aver perso l’aggancio con la sua fonte di vita. La psicoanalista Esther Bick scrive: “Il bisogno di un oggetto contenente, nello stato di non integrazione in cui si trova inizialmente il bambino, sembra spingerlo alla frenetica ricerca di un oggetto – una luce, una voce, un odore, o un altro oggetto sensibile – capace di attirare l’attenzione e di essere quindi sperimentato, almeno momentaneamente, come qualcosa che tiene insieme le componenti della personalità. L’oggetto ottimale è costituito dal capezzolo in bocca, insieme con la percezione di essere tenuto tra le braccia della madre, della sua voce e del suo odore ormai familiari (1956, p. 91).
La trama che madre e figlio hanno cominciato a tessere nell’utero prosegue subito dopo la nascita: madre e bambino cominciano, o meglio “continuano” a conoscersi nelle prime settimane.Il neonato è dipendente dalla madre non solo per essere nutrito e accudito, ma anche per dare senso al nuovo “mondo” nel quale si trova e affrontarlo; lo psicoanalista Donald Winnicott (1958) definì “preoccupazione materna primaria” l’atteggiamento della madre verso il suo neonato: tenere il bambino nella mente, sintonizzarsi con lui, trasmettergli pazienza e attenzione. Tuttavia, a volte è difficile per un adulto comprendere appieno come può sentirsi un neonato quando si confronta con sensazioni corporee come la fame, il freddo o il caldo, un rumore improvviso, oppure la paura e l’angoscia che sperimenta quando si sveglia e si ritrova solo, separato. Nel neonato il corpo e la mente sono molto vicini e i bisogni fisici hanno un equivalente mentale, ma deve ancora imparare a decifrare e ad affrontare queste sensazioni, perché dentro l’utero viveva in un mondo dove non le ha mai sperimentate.
Più che mai nei primi mesi mamma e bambino sono alla faticosa ricerca di un ritmo: la sintonizzazione sui ritmi del sonno e della veglia, il ritmo del latte che sgorga dal seno, o dal biberon, e quello del succhiare del bambino. Sono questi scambi, che nascono dalle prime esperienze non solo nutritive, a dare origine a processi psichici che permangono nel corso della vita. Il successo dell’adattamento reciproco si costruisce anche attraverso molti fallimenti e momenti di mancata di sintonizzazione. In questa ricerca dell’adattamento il bambino non è assolutamente un recipiente passivo – lo abbiamo visto fin dalla vita intrauterina – ma un partecipante attivo del dialogo e del processo di maturazione. Lo sviluppo, emotivo e mentale, è strettamente legato alle prime esperienze nutritive: la fame, da questa prospettiva, assume allora diversi significati: fame di imparare, di affetto e di comprensione, fame di vita (Quagliata, 2002).
Il primo anno può essere molto difficile, per la madre diventano centrali un senso di fiducia e il sapere che agli errori si può rimediare. Così come al bambino il messaggio che arriva quando si sente compreso è che il dolore, sia fisico che mentale, può cessare – “C’è un aiuto qui vicino, non sono solo…”-, allo stesso modo la madre ha bisogno di sentire supporto e aiuto e poter pensare “Non sono sola”.E questo soprattutto quando non riesce a dormire! Anche l’addormentamento e il sonno, come l’allattamento, sono processi che implicano un ritmo condiviso: non sempre un’interruzione del sonno è un segnale di necessità del bambino e la descrizione dei cicli del sonno può aiutare i genitori a capire quali sono i segnali di passaggio da una fase a un’altra (Daws, 1989). A volte, per esempio, il bimbo va solo “riaccompagnato” in un nuovo sonno.
La comprensione sempre più profonda della madre dell’individualità del suo bambino, lo sbocciare della relazione e la reciproca crescita di amore e affetto creano il processo di attaccamento verso l’oggetto primario, cruciale nel corso dello sviluppo e per la crescita, e segnano il bambino, gettando le basi di tutte le sue relazioni future. Ma come è necessario che madre e figlio formino un legame e che il neonato sperimenti la dipendenza dall’oggetto materno, allo stesso modo è necessario che il bambino si separi dalla madre. Come pre-requisito per gli altri compiti primari dell’infanzia, il bambino ha, infatti, bisogno di trovare un se stesso diverso, distinto dalla madre, di conoscersi finalmente come separato, di esplorare ed apprezzare la sua identità e le sue risorse personali. In questo senso, per esempio, il passaggio al biberon crea una situazione di maggiore autonomia e di diminuzione della dipendenza, emotiva e fisica, e spesso genera un sollievo per la diade o per uno dei due.
Dall’inizio della vita i genitori aiutano il bambino a capire che ogni cosa ha un inizio, una transizione e una fine. La presenza continua del genitore e il sostituirsi a lui evitandogli frustrazioni non gli renderà la vita più facile ma al contrario gli impediranno di sviluppare le sue risorse e illudendolo di avere il controllo e il dominio dell’altro. Il ritmo dell’andare e venire del seno, dell’andare e venire della mamma, allenano le capacità del bambino di affrontare i transiti successivi: il passaggio alle scuole elementari come la fine di una vacanza come l’ora di smettere di giocare per andare a dormire. Lo aiutano a capire che anche le cose belle finiscono per poi, a volte, ritornare. Al tempo stesso la madre sa di avere un bambino mobile e indipendente, affamato di libertà. Non è più un neonato, non lo sarà mai più. La separazione richiede uno sforzo continuo. L’iniziale svezzamento dal seno o dal biberon è seguito da altre separazioni pianificate dalla madre, che prepara il bambino ad affrontarle. Donald Winnicott (1956) ha sottolineato l’importanza di “presentare il mondo al bambino in piccole dosi”, altrimenti l’esperienza della separazione diventa terrificante. Suggeriva così che le separazioni devono essere graduali, in modo che il bambino possa avere un ruolo nel processo e non sentirlo solo come un’imposizione.
La capacità di affrontare la realtà dipende dalla capacità di internalizzare una base. “Lo sviluppo di una base, a partire dall’incontro con il seno, verso la madre come persona intera e poi verso la coppia di genitori, fino all’idea di una casa, di un paese a cui appartenere e così via” (Money-Kyrle 1968, p.612). Nella misura in cui la relazione interna e esterna con queste è preservata, noi non siamo disorientati. Così la psicoanalisi, nelle sue varie forme, può aiutare ad andare oltre, a costruire un nuovo inizio. L’interesse è centrato sull’osservazione dell’esperienza emotiva, sulla comprensione della verità di ciò che sentiamo e sulla possibilità di digestione delle esperienze emotive – la capacità di modulare la rabbia e l’aggressività, di tollerare le frustrazioni e le delusioni, di ritrovare la fiducia e le risorse. Questo fornisce il nutrimento che tiene in vita l’apparato mentale e gli permettere di apprendere dall’esperienza.
A piccoli passi, il bambino verifica la sua indipendenza e la sua individualità, sempre in riferimento alla presenza o all’assenza della madre. Si fida degli altri membri della famiglia o altri caregivers, ai quali si rivolge come fossero un’estensione delle cure materne. In compagnia di un gruppo più largo di adulti e bambini, cercherà per esempio di allontanarsi da sua madre aumentando gradualmente la distanza, per poi ritornare da lei per essere rassicurato e trovare conforto. La sua curiosità ha spazio per svilupparsi, e il bambino adesso ha la calma emotiva necessaria per aprirsi al mondo intorno a lui. L’amore per la conoscenza è presente dalla nascita e attraverso gli stimoli di coloro che si prendono cura di lui, il piccolo emerge gradualmente nel mondo fatto di suoni, sensazioni, visioni, responsività e sensibilità, mettendosi a cercare, a cercare di capire il mondo intorno a lui….
Bibliografia
Bick E., 1968 “The experience of the Skin in Early Object Relation” Int Jour Psychoanalysis vol 49 “L’esperienza della pelle nelle prime relazioni oggettuali”, in L’Osservazione Diretta del Bambino, Boringhieri 1984.
Bion W. 1962 Apprendere dall’Esperienza Armando, Roma
Daws, 1989 Through the night Free Association Books, London. Nel Corso della Notte, Liguori, Napoli 1992
Ferrara Mori G., 2008, Un tempo per la maternità interiore, Borla, Roma
Freud S., 1925 Inibizione Sintomo e Angoscia vol.10 Boringhieri.
Leboyer F Per una nascita senza violenza, Bompiani, Milano 1975
Money-Kyrle 1968 Cognitive Development Int Journ Psychoanalysis vol 49. Scritti 1927-1977 Introduzione e cura di Mauro Mancia. Loescher Editore, Torino, !985.
Piontelli 1992 From Fetus to Child The New Library of Psychoanalysis
Quagliata E., 2002 Un Bisogno Vitale, Astrolabio
Winnicott D., 1956 “Primary Maternal Preoccupation” in Collected Papers Through Pediatrics to Psychoanalysis, Tavistock Londra. Dalla Pediatria alla Psicoanalisi Martinelli, Firenze 1975.
APPROFONDIMENTI
Come s’impara a parlare
A cura di Francesca Piperno
Molto spesso genitori insegnanti, educatori chiedono allo specialista “quando deve cominciare a parlare un bambino?”, in generale si pensa che il bambino inizi a parlare intorno ai diciotto mesi quando produce le prime parole.
Ma per parlare di sviluppo del linguaggio è necessario inserirlo all’interno di una capacità più articolata: la capacità comunicativa. Per acquisire la capacità di comunicare, il bambino deve da un lato maturare la coscienza di esistere come individuo separato psicologicamente e fisicamente dalla madre, dall’altro deve sostituire agli atti e azioni motorie segni convenzionali come il gesto prima e poi la parola.
Freud ( 1911; 1915; 1922) ha attribuito al linguaggio un peso particolare:
– la parola permette di prendere coscienza, di elaborare e rappresentare i contenuti dell’inconscio
– la parola si interpone come oggetto mentale tra pulsioni ed azioni nel rapporto con gli altri, e diviene sostituto dell’azione diretta.
Spitz (1967) ha riconosciuto in un’ottica evolutiva tre funzioni che il linguaggio svolge nel sostenere lo sviluppo psichico:
1) la parola consente di evocare l’oggetto assente
2) la parola permette di entrare in rapporto con gli altri
3) la parola permette di affermare, negare, trasformare la presenza degli oggetti interni ed esterni.
Per affrontare la descrizione di come s’impara a parlare è necessario premettere due concetti: il bambino è precocemente in grado di comunicare prima di imparare a parlare; il bambino è in grado di capire il linguaggio prima di imparare a parlare.
Se tracciamo un ideale percorso evolutivo, il bambino per costituirsi come essere pensante che dice agli altri ciò che pensa, deve maturare complessi meccanismi che poggiano:
– sulle prime esperienze corporee, in cui la pelle costituisce il filtro per gli scambi tra mondo interno e mondo esterno
– sulle esperienze di distacco dalla madre
– sul costituirsi dell’immagine mentale dell’assenza.
Il bambino cresce inserito in un contesto di cure, definite “la preoccupazione materna primaria” e inserito anche in un ambiente di suoni: il linguaggio materno.
Il bambino sviluppa un’attività intenzionale comunicativa propria quando sa differenziare pensieri ed emozioni propri da quelli della madre. Le prime parole nascono nella bocca della madre che si interroga su quale bisogno del bambino debba essere soddisfatto, da questo primo e basilare interrogativo si avvia il processo comunicativo. “hai fame..? hai sonno…? hai mal di pancia..?”.
Da parte del bambino la comunicazione verbale nasce con il primo grido della nascita. Il bambino cresce immerso nella voce della madre, suoni le cui qualità accompagnano e cullano, tramite l’udito, il bambino. Il linguaggio nasce nella complessa dinamica, attivata dalla madre, tra assenza e presenza e viceversa. Presenza: del viso, del corpo, del seno, della voce, madre che parla e rispecchia i suoni, i rumori, il pianto del bambino. Assenza: del viso, del corpo, della voce, della madre. Questa assenza, matrice di ogni desiderio, viene sostituita dalla parola. Nel silenzio, nello spazio vuoto lasciato dalla madre, può comparire il pensiero simbolico: con il pensiero nasce il linguaggio.
Nel corso della crescita le esperienze sensoriali, percettive, somatiche che il bambino ha del proprio corpo in rapporto alle cure materne, divengono immagini interne, rappresentazioni di se stesso e della realtà esterna (Bollas, 1987; Winnicot, 1965; Vallino, Macciò, 2004).
Intorno ai due anni la comparsa della comunicazione verbale, ovvero del linguaggio ha un effetto strutturante sulla mente e favorisce l’organizzazione di un più complesso livello psichico che a sua volta stimola la potenzialità trasformativa del linguaggio. Parallelamente, il processo di simbolizzazione si stabilizza nella continua dialettica tra Io-Altro e nel confronto con le personali significazioni affettive e cognitive.
La realtà, gli oggetti, le emozioni, le sensazioni non sono solo vissuti ma rappresentati con segni o meglio mediante significanti, ovvero la parola. Mentre il bambino impara a parlare costituisce la sua soggettività, poiché, come descritto, parlare significa distinguere sé e la madre, differenziare tra intenzioni proprie ed intenzioni dell’altro ed in questo scambio di contenuti mentali si snodano i processi di identificazione. Il linguaggio è sempre un dialogo in cui le parole sono oggetti mentali scambiati tra due persone.
Le tappe seguenti portano il bambino a perfezionare il linguaggio, si amplia il vocabolario e le parole vengono collegate tra loro secondo le regole della grammatica e della sintassi, producendo inizialmente frasi composte da un soggetto ed un verbo o da un soggetto ed un aggettivo. In seguito, le frasi si collegano tra loro.
Per concludere questa sintetica descrizione sulla nascita del linguaggio, vorrei ricordare che negli ultimi anni nel campo dello studio della psicologia del bambino accanto ai paradigmi teorici della psicoanalisi infantile si sono sviluppati interessanti filoni di ricerca per studiare lo sviluppo relazionale ed emotivo, studi che sottolineano l’importanza della matrice relazionale come base per lo sviluppo dei primi nuclei di personalità del bambino.
Gli studi delle teorie interattive convergono nel dimostrare che, nei primi anni di vita l’interazione tra madre e bambino svolge un ruolo centrale (Schaffer, 1977, Stern, 1985; Sameroff e Emde, 1989). Secondo Stern la necessità di manifestare i propri bisogni motiva il bambino ad agire. L’attenzione della madre nel dare significato e senso alle richieste dl bambino avvia una particolare condivisione definita: sintonizzazione affettiva. Ma il rapporto tra madre e bambino non è descritto soltanto alla luce del processo di sincronizzazione reciproca ma anche come un complesso processo comunicativo dove si alternano sintonizzazione, rottura e riparazione (Beebe, Lachmann, 2002). Concetti ponte utilizzabili in differenti modelli teorici per ampliare la conoscenza dello sviluppo emozionale, comunicativo e linguistico del bambino.
Bibliografia
Schaffer H.R. (a cura di) (1977) L’interazione madre-bambino: oltre la teoria dell’attaccamento, Franco Angeli, Milano, 1984.
Maggio 2014
Fachinelli Elvio

Fachinelli Elvio
Scheda a cura di Anna Ferruta
ELVIO FACHINELLI
Luserna (Trento), 29 Dicembre 1928 – Milano, 21 Dicembre 1989
La vita e il pensiero di Fachinelli sono tesi a liberare il desiderio ‘dissidente’ inconscio (1968, in Il bambino dalle uova d’oro) e a farlo emergere alla superficie della vita quotidiana (i gruppi, il femminile, la scuola, il corpo, le istituzioni), là dove cambia di accento e si declina in forme socialmente condivise ma porta la traccia delle forze originarie che lo hanno mosso. Fachinelli partecipa a esperienze di vita e a iniziative culturali molteplici, ma l’elemento fondamentale che lungo tutto il percorso lo caratterizza resta la centralità della dimensione euristica della psicoanalisi come strumento di ricerca di territori sconosciuti del soggetto e della comunità umana, da esplorare e comprendere. Il saggio ‘Che cosa chiede Edipo alla sfinge?’ (1970, in Il bambino dalle uova d’oro) può essere considerato il manifesto di uno psicoanalista e di un intellettuale che non cerca risposte che chiudano il discorso e la mente, ma che lavora con la sonda psicoanalitica per ampliare l’area che esplora. La sua vicenda esistenziale porta le tracce di dislivelli abissali tra la partecipazione a minime esperienze della vita quotidiana e sublimi vertici di condivisione del pensiero con alcuni dei più brillanti intellettuali degli ultimi decenni del ‘900.
Fachinelli nasce a Luserna, un paesino di montagna in provincia di Trento (dove ora è la biblioteca che porta il suo nome e che conserva i suoi 3072 volumi), un’isola linguistica in cui si parla un dialetto tedesco-boemo, il cimbro. Nel 1930 la sua famiglia di modeste condizioni emigra in Francia, a Menune, dove segue le scuole francesi fino a quando nel 1940 è costretto dall’inizio della guerra a rientrare in Italia. Frequenta il liceo classico a Merano e poi, sollecitato dallo zio medico Ottone e dalla madre Gemma appassionata di letteratura, si iscrive alla Facoltà di Medicina dell’Università di Pavia, come studente del Collegio Cairoli, dove incontra altri studenti che diventeranno intellettuali conosciuti, come Alberto Arbasino. Nell’estate per mantenersi lavora alla raccolta delle mele e come ‘marcatempo’ nelle acciaierie di Bolzano (forse la sua sensibilità alla dimensione del tempo in psicoanalisi proviene da questa esperienza). Caratterizzano questa fase la molteplicità delle esperienze e la brillantezza dei risultati accademici: si laurea con la lode nel 1952 con una tesi ‘biologica’ con il prof. G. A. Maccacaro.
Una prima svolta avviene in occasione dell’incontro con la psichiatria tramite il lavoro nel reparto di Neuropatologia all’Ospedale di Niguarda a Milano dove diviene allievo e amico di Enzo Morpurgo: consegue la specializzazione in Psichiatria presso l’Università di Milano nel 1961 con una tesi su Il contributo del Rorschach all’analisi strutturale della nevrosi fobico-ossessiva. Nel 1962 incontra Cesare Musatti, con il quale inizia l’analisi, nella prospettiva di entrare nella Società Psicoanalitica Italiana, società della quale a partire dal 1966 continua a fare parte per tutta la vita, nonostante i momenti di pubblica e aspra critica per le dimensioni autoritarie e conservatrici.
A partire dal 1966 la sua vicenda intellettuale e professionale è attraversata da due correnti che scorrono parallele e che spesso si intrecciano.
Una corrente è quella del lavoro psicoanalitico come analista individuale e di gruppo, studioso appassionato e rigoroso del pensiero freudiano: dalla traduzione, insieme alla moglie Herma Trettl, di L’interpretazione dei sogni nell’edizione Boringhieri delle Opere complete di Freud (1966) alla rilettura, fatta insieme a Enzo Morpurgo in un Seminario della SPI a Bologna negli anni 80, di un testo freudiano enigmatico, Un disturbo della memoria sull’Acropoli (1936), in cui approfondisce i fenomeni di telepatia come comunicazione tra inconsci senza la mediazione della parola. Il rigore filologico accompagna la sua ricerca psicoanalitica nella direzione delle zone inesplorate dell’inconscio, e la sua critica a un’interpretazione riduttiva della psicoanalisi intesa solo come strumento di modificazione delle difese e presa di coscienza delle spinte pulsionali rimosse.
Nella pratica analitica Fachinelli si scontra con la difficoltà a procedere nel lavoro di liberazione delle forze inconsce, nella direzione dall’Io all’Es: nei meccanismi ossessivi la freccia del tempo resta ferma (La freccia ferma,1979), nei meccanismi di coppia il claustrum resta chiuso e l’analisi interminabile (Claustrofilia 1983). La sua riflessione sulla interpretazione delle difese si arena di fronte alla coazione a ripetere o alla ricostituzione di nuove difese. Si interessa alla teorizzazione lacaniana, un Lacan che aveva incontrato nel 1969 al tempo della contestazione al Congresso dell’IPA a Roma e con il quale continua a mantenere uno scambio di pensiero, legato all’interesse per salvaguardare il desiderio, quello che per lui diventerà ‘il roveto ardente’ della gioia massima del rapporto di parziale indistinzione tra il bambino e la madre all’inizio della vita. Nell’ultimo libro, La mente estatica (1989) va oltre la ragione scientifica, tecnica, burocratica e si avventura in un’area di frontiera, rischiosa per l’Io individualizzato, quella delle esperienze estatiche di apertura a ciò che viene da un’altra parte, che riimmergono l’individuo nella dimensione di co-identità sperimentata all’origine della vita tra bambino e mamma, contigua al terrore di annichilimento. Fachinelli si affaccia qui a nuovi orizzonti di pensabilità e di riorganizzazione delle strutture psichiche, anticipando molta psicoanalisi contemporanea di matrice bioniana, attenta allo sviluppo di apparati per pensare le esperienze inconsce non simbolizzate: “Accogliere chi? Un ospite-interno. Accoglierlo prima di esaminarlo ed eventualmente respingerlo. Intrepidezza, atteggiamento infinitamente più ricco e alla fine forse più efficace della prudenza di chi edifica muraglie. (…) [accogliere] le cose che vengono da un’altra parte: come un accento imprevisto che muta, che sposta l’intera figura.” (p.23-24)
L’altra corrente di pensiero è quella interessata ai fenomeni sociali, di cambiamento, individuale e di massa, sollecitata dai fenomeni di contestazione giovanile del’68, volta a comprendere le radici inconsce del desiderio dissidente e a immetterlo nel flusso comunicativo ed esperienziale come un’energia preziosa. Partecipa insieme a un gruppo di intellettuali di sinistra (Giancarlo Majorino, Luciano Amodio, Elio Pagliarani) alla creazione della rivista Il corpo (1965-68), nella quale pubblica la traduzione del saggio di Freud La negazione (1925), accompagnata da un commento ‘L’ipotesi della distruzione in Sigmund Freud’, in cui sostiene che nel lavoro analitico la negazione della verità consente il suo emergere. Pubblica anche la traduzione dello scritto di Wilhelm Reich Materialismo dialettico e psicoanalisi, di cui mette in discussione il riduzionismo biologico a favore di una concezione antropologica legata alle interazioni con l’ambiente. Partecipa ai movimenti di critica e rivolta sociale in diverse forme, tese a raggiungere le radici inconsce del desiderio infantile (la rivista «L’erba voglio.» (1971-77), l’asilo autogestito di Porta Ticinese di cui parla nello scritto “Masse a tre anni”,1974), e a comprendere le dinamiche tra individuo e gruppo a cui attinge per irrigare i terreni inariditi della vita quotidiana e delle ideologie politiche autoritarie che non tengono conto delle soggettività (il controcorso ‘Psicoanalisi e società repressiva’ all’Istituto Superiore di Scienze Sociali di Trento; “Gruppo chiuso o gruppo aperto”?, 1974).
In Il paradosso della ripetizione (1974), Fachinelli osserva che un’attenzione eccessivamente concentrata sull’apparato di dominio volto al controllo delle masse, caratteristica degli anni intorno ai movimenti del 1968, ha messo in secondo piano l’analisi della tendenza alla passività e alla soggezione presente negli individui. La sua attenzione si focalizza sulla relazione tra il bambino piccolo e il caregiver: il passaggio del bambino da essere biologico a essere inserito nell’universo biologico proprio dell’uomo avviene sulla base di una inter-relazione tra il bambino e l’altro, rappresentante dell’ordine simbolico, vicenda individuale e generale che contribuisce a dare forma definita e spesso definitiva al rapporto dell’individuo con il desiderio e con la morte.
In Che cosa chiede Edipo alla sfinge? (1969) osserva: “…per incontrare Edipo bisogna trovarsi sulla strada di Tebe; bisogna cioè che l’analista costituisca in altri luoghi condizioni, possibilità, linguaggio dell’interrogazione analitica (…) L’ascolto analitico deve manifestarsi come capacità di percepire il negativo, l’irregolare, l’aritmico, le situazioni che, appena accennate, e quali che siano, rischiano di essere subito soffocate o, meglio ancora, inquadrate e funzionalizzate (…) in più, deve però anche manifestarsi come capacità e possibilità di interrogare i tentativi che, spesso in modo rozzo, elementare, disordinato, vengono continuamente sorgendo nella nuova generazione come risposta a nuovi problemi” (p.155).
Finita l’onda del ’68, Fachinelli continua a interessarsi dei fenomeni sociali (droga, crisi energetica, religione, educazione, femminismo, terrorismo) intervenendo su riviste come Quaderni Piacentini e su organi di stampa come L’Europeo, l’Espresso, Panorama e il Corriere della Sera, Il Manifesto, sempre attento a svolgere una funzione critica relativa a fenomeni di chiusura e sterilità, presenti nella SPI come nella vita sociale più ampia, in particolare collaborando con studiose del femminile come Luisa Muraro e Lea Melandri.
Proprio il suo interesse per il femminile e per l’analisi del rifiuto del femminile nella cultura psicoanalitica e nell’organizzazione sociale hanno a che fare con il desiderio vivo e temuto della ‘gioia smisurata’ e con le domande che Edipo pone alla Sfinge, volte a riattivare il potenziale liberatorio dai vincoli inconsci della psicoanalisi delle origini. La sua prematura scomparsa per una patologia tumorale affida a tutti i cultori della psicoanalisi la responsabilità di continuare a svilupparne il potenziale inespresso: “Mi sembra chiaro che reincontreremo, sulla strada di Tebe, una sfinge senza più maschera, e un soggetto, di cui non conosciamo ancora il nome, col quale potremo forse scambiare giuste domande e giuste risposte.“ (Che cosa chiede Edipo alla sfinge?,p.157).
Scritti di Elvio Fachinelli
(1971). L’erba voglio. Pratica non autoritaria nella scuola. Torino: Einaudi.(1974); Il bambino dalle uova d’oro. Milano: Feltrinelli (ora Adelphi, 2010).(1979); La freccia ferma. Tre tentativi di annullare il tempo. Milano: L’erba voglio (ora Adelphi, 1992).; 1983). Claustrofilia. Saggio sull’orologio telepatico in psicanalisi. Milano: Adelphi.; 1989). La mente estatica. Milano: Adelphi; ( 2012) (a cura di Lamberto Boni). Su Freud. Milano: Adelphi.
Bibliografia
Bonoldi, G.( a cura di). (1976), Il corpo, 1966-1968. Milano: Moizzi.
Conci, M. & Marchioro, F. (1998) (a cura di). Intorno al ’68. Un’antologia di testi. Roma: Massari.
Melandri L. (a cura di). 1998). Il desiderio dissidente. Antologia della rivista ‘L’erbavoglio’ (1971-1977). Milano: Baldini&Castoldi.
Conci, M. (1996). Introduzione. In : Catalogo bibliografico trentino, a cura di, Frutti della claustrofilia. Catalogo del Fondo Fachinelli della Biblioteca Comunale di Lucerna. Trento: P.A.T.
Pirillo, N. (a cura di) (2011). Elvio Fachinelli e la domanda della sfinge. Tra psicoanalisi e pratiche filosofiche. Napoli: Liguori.
Elvio Fachinelli. Un freudiano di giudizio (2011) (numero monografico). Aut aut, 352, ottobre-dicembre.
Arbasino, A. (2014). Ritratti italiani. Milano: Adelphi.
Fantasia Inconscia

E.HESSE, 1975
FANTASIA INCONSCIA
a cura di Marinella Lia
La Fantasia Inconscia è un concetto molto importante in Psicoanalisi, sia dal punto di vista teorico che clinico, e diverse scuole psicoanalitiche ne hanno prodotto differenti versioni. Freud,(1887-1904, 1899,1911,1915-17,1932) pur non dedicando mai una trattazione specifica al concetto, distribuirà le sue elaborazioni in molti dei suoi scritti, e le discrepanze fra le diverse accezioni del concetto non verranno mai sistematizzate o risolte.
L’idea Freudiana di Fantasia Inconscia è strettamente collegata al suo modello topografico della mente, come si evince da capitolo 7 della Interpretazione dei sogni. Le Fantasie, nella maggior parte dei casi, originano come sogni diurni consci o preconsci e vengono successivamente represse quando il loro contenuto è inaccettabile per la coscienza. Inizialmente sono soggette alla logica del processo secondario, ma quando vengono respinte nell’inconscio partecipano della logica del processo primario, e diventano indistinguibili dalle memorie.
Nella Enciclopedia della Psicoanalisi (Laplanche e Pontalis,1967), si legge che la Fantasia Inconscia (Fantasma) si riferisce allo scenario immaginario dove è presente il soggetto, dove vengono rappresentati, in modo più o meno deformato, i processi difensivi, l’appagamento di un desiderio e, in ultima analisi, di un desiderio inconscio. La F.I.[1] si presenta in forma di sogni diurni consci, fantasie inconsce sottostanti ad un contenuto manifesto, fantasie originarie.
La F. I. del Dizionario di Psicoanalisi Kleiniana ( Hinshelwood,1989) è radicalmente diversa. Le fantasie inconsce stanno alla base di ogni processo mentale e ne accompagnano tutta l’attività. Rappresentano il mentale degli eventi corporei, che comprendono gli istinti, e sono sensazioni fisiche interpretate come relazioni con oggetti che le provocano. Esprimono sia gli impulsi libidici che quelli aggressivi e i meccanismi di difesa. Le Fantasie sono in costante interazione con la percezione della realtà esterna.
I primi riferimenti, più o meno impliciti, alla esistenza di fantasie inconsce risalgono agli Studi sull’Isteria (Breuer e Freud 1893-95), come il ‘teatro privato’ di Anna O.
Nelle Lettere a Fliess (Freud, 1892-99) vi sono alcuni passaggi epocali.
Nella lettera del 21 settembre 1897, Freud annuncia l’abbandono della teoria della origine traumatica della nevrosi. Sono le fantasie sessuali inconsce presenti nel bambino a creare il disturbo mentale e il trauma, non è l’evento fisico in sé.
Nella lettera successiva del 15 ottobre 1897, Freud parla della presenza universale di fantasie di colpa e punizione e ritorsione legate ai desideri libidici e aggressivi del bambino.
Più tardi, in ‘Precisazioni sui due principi dell’accadere psichico’ (1911), troviamo la trattazione metapsicologica più chiara del concetto di fantasia inconscia: la fantasia è una attività mentale di realizzazione di desiderio che sorge quando un desiderio istintuale viene frustrato. Questa particolare modalità di pensiero viene scissa con l’introduzione del principio di realtà, viene esonerata dall’esame di realtà e rimane subordinata al solo principio di piacere.
In Lezione introduttiva 23 (1916-17), Freud presenta il concetto di realtà psichica : le fantasie sono reali psichicamente anche se non materialmente e, nel mondo della nevrosi, la realtà che conta è quella psichica. La realtà psichica non è illusoria e neppure effimera. Ha una sua consistenza, organizzazione e coerenza e resiste al confronto con la realtà materiale. Egli distingue però dalla fantasia come sogno diurno alcune fantasie di base rintracciabili in tutti gli esseri umani che sono sempre state inconsce e che non sono prodotte dalla repressione: sono la fantasia della castrazione, della seduzione per opera di un adulto, e della scena primaria del rapporto sessuale fra i genitori. Nel tentativo di collegare le fantasie alla memoria di eventi percepiti, Freud postula un tipo di realtà storica ‘ricordata’ nelle fantasie primarie: si tratta di eventi reali accaduti nella preistoria dell’umanità, la cui memoria è trasmessa filogeneticamente.
Laplanche e Pontalis (1968) ritengono che le fantasie primarie che Freud attribuisce ad una eredità filogenetica possano essere pensate come una pre-struttura che viene attualizzata e trasmessa dalle fantasie dei genitori. Questa lettura ‘strutturalista’ della teoria freudiana delle fantasie primarie resterà un cardine della psicoanalisi francese.
Perron (2001), altro esponente della scuola francese, ribadisce che se le fantasie sono costruite secondo lo stesso schema generale in tutti gli esseri umani è perché ognuno è inserito nelle stesse condizioni generali, ovvero tutti hanno una madre e la psiche di ognuno si sviluppa all’interno di una cornice in cui interviene una seconda figura parentale con cui la madre è in relazione
Klein (1932), come Freud, non dedicherà mai una trattazione specifica alla fantasia inconscia, ma il concetto è presente in tutti i suoi scritti ed è alla base di tutto il suo pensiero. L’idea della fantasia come attività inconscia è presente fin dall’inizio del suo lavoro. La psicoanalisi dei bambini e la scoperta della tecnica del gioco la mettono a confronto con la straordinaria e spontanea propensione dei bambini a produrre fantasie. Spesso si tratta di teorie cariche di ansia e intrise di intensi sentimenti di amore e di odio su nascita, morte, sessualità dei genitori, processi corporei, fantasie in cui vengono immaginate azioni punitive o riparative perpetrate o subite. Klein scopre che la esplicitazione e la interpretazione di queste fantasie da parte dell’analista tende a far sì che i bambini si sentano liberi usarle in modo meno inibito e più comunicativo, e collaborino più attivamente al lavoro analitico producendo ulteriori fantasie, più personali e precise e ricche di dettagli. Molte di queste fantasie riguardano processi introiettivi e proiettivi, e le relazioni di oggetti interiorizzati fra di loro e con il mondo esterno. Le varie fantasie che Klein riscontra sia nei bambini che negli adulti verranno successivamente da lei concettualizzate nelle posizioni schizo-paranoide e depressiva.
Dal punto di vista della tecnica psicoanalitica nella analisi infantile, Klein è convinta che il gioco del bambino rappresenti le sue fantasie inconsce e sia equivalente alle libere associazioni nella analisi degli adulti che il bambino piccolo formi un transfert e che il compito dell’analista sia di interpretare nel modo più completo possibile le fantasie e i conflitti e le difese come si manifestano in esso, come si farebbe con un paziente adulto.
Le posizioni teoriche e cliniche della Klein suscitano presto la opposizione degli analisti viennesi che si raccolgono attorno a Freud e alla figlia Anna. Quando Freud e gli psicoanalisti in fuga dalle persecuzioni razziali si rifugiano a Londra nel 1938 la tensione fra il gruppo kleiniano e il gruppo degli analisti “ortodossi” si fa acuta. Per evitare una scissione fra i due gruppi si apre un infuocato dibattito scientifico, raccolto nelle cosiddette Controversial Discussions (1941-45). Il concetto di fantasia inconscia è al centro di questo dibattito e il compito di illustrare e chiarire la posizione dei kleiniani è affidato a Susan Isacs, una analista con una solida reputazione scientifica e accademica.
Le Controversial Discussions si aprono con la sua relazione intitolata “La natura e la funzione della fantasia”, una pietra miliare del pensiero psicoanalitico.
A Klein e a Isacs viene contestato di attribuire al bambino piccolo delle attività e competenze mentali che non si possono osservare direttamente ma solo inferire, che sono troppo evolute per l’età, e che sono incompatibili con la teoria del narcisismo primario.
Anna Freud sostiene che nei primi mesi di vita il bambino attraversa una fase auto-erotica che precede le relazioni oggettuali e le fantasie che le accompagnano. Il bambino è consapevole di stati di piacere o di dolore ma non ha la capacità di attribuire questi stati alle vicissitudini emotive inerenti al suo rapporto con i genitori, ed è solamente interessato al proprio benessere. Pensa anche che la definizione che Isacs propone di fantasia inconscia modifica il concetto stesso di inconscio in Freud, introducendo troppo presto la ‘funzione sintetica’, cioè la capacità di sperimentare il conflitto fra sentimenti divergenti. Una accusa particolarmente aspra è quella di svuotare e rendere inutili concetti fondamentali del pensiero psicoanalitico classico, come la progressione delle fasi libidiche, la regressione e la fissazione, il complesso stesso di Edipo, sostituendoli con un unico concetto, quello della fantasia inconscia, talmente esteso da includere la attività mentale inconscia nella sua interezza.
Isacs (1948), nel rispondere alle obiezioni, sostiene in tutti i modi la compatibilità delle posizioni kleiniane con il pensiero di Freud e presenta la sua visione della fantasia inconscia come una semplice espansione ed elaborazione del concetto freudiano di inconscio, resa possibile dai nuovi dati portati dalla psicoanalisi infantile e dagli studi sullo sviluppo cognitivo. In realtà la sua teorizzazione introduce una teoria del pensiero che anticipa quella di Bion e costituisce una profonda revisione, come sostiene Thomas Ogden (2012), delle metafore centrali della concezione freudiana del lavoro mentale, sostituendo il modello strutturale con il modello di un mondo interiore strutturato dalle relazioni oggettuali.
Le accuse di ‘non ortodossia’ che vengono mosse alla Isacs sono in gran parte motivate. E’ vero che Klein trascura la teorizzazione in termini di fasi dello sviluppo libidico a favore di una nuova strutturazione dello sviluppo del pensiero in termini di posizioni (schizo-paranoide e depressiva) che sono atteggiamenti mentali fra cui l’individuo oscilla per tutta la vita. Trascura il modello topografico, vede una continuità genetica fra forme primitive e forme evolute di pensiero. Rende complicato inquadrare il fenomeno della repressione, che implica un conflitto fra desideri istintuali e realtà esterna, dato che il conflitto è prima di tutto interno, fra sentimenti contrastanti.
Il pensiero della Isacs sulla fantasia inconscia è talmente innovativo che alcuni vi riconoscono una anticipazione delle teorie neuropsicologiche della coscienza e del pensiero in piena fioritura nei nostri anni. Alcuni esempi: per Lakoff, il pensiero è corporeo, inconscio, relazionale e metaforico; per Damasio, il pensiero nasce a partire dalla costante mappatura che il nostro organismo fa del proprio stato nella sua relazione con l’esterno.
Per finire, vorrei ricordare che Segal (1991) afferma che leggendo Freud si ha l’impressione che le fantasie inconsce sono come isole nel mare della vita mentale, mentre leggendo il lavoro di Klein con i bambini si ha l’impressione di un continente sommerso in cui le isole sono le manifestazioni consce e osservabili.
Bibliografia
Bion WR (1962) Apprendere dall’esperienza. Trad. it. Roma: Armando, 1972
Damasio A.R. (1999) Emozione e coscienza. Trad. it. Milano: Adelphi, 2000
Freud S. (1887-1904) Lettere a Wilhelm Fliess. Trad. it.Torino: Bollati Boringhieri, 1986
Freud S (1899). L’interpretazione dei sogni. In: OSF, vol. III. Torino: Boringhieri
Freud S. (1911) Precisazioni sui due principi dell’accadere pscichico. In OSF, vol.VI, Torino: Boringhieri
Freud S. (1915-17) Introduzione alla psicoanalisi. OSF, vol:VIII, Torino: Boringhieri
Freud S (1932) Introduzione alla psicoanalisi (Nuova serie di lezioni) OSF, vol. XI. Torino: Boringhieri.
Hinshelwood R. (1989) Dizionario di psicoanalisi kleiniana. Trad. it. Milano: Cortina, 1990
Isaacs S. (1948) The nature and function of phantasy. International Journal of Psycho-Analysis 29: 73-97
King P., Steiner R. (1991). The Freud-Klein Controversies 1941-1945. London & New York: Tavistock/Routledge
Klein M (1932). La psicoanalisi dei bambini. Trad. it. Firenze: Martinelli
Lakoff G and Johnson M (1999) Philosophy in the flesh. New York: Basic Books
Laplanche J., Pontalis J.B. (1967). Enciclopedia della psicoanalisi. Trad. it. Bari: Laterza, 1968
Ogden T (2012) Creative Readings. East Sussex: Routledge
Segal H. (1991). Sogno, fantasia e arte. Trad. it. Milano: Cortina 1991
Steiner R. ed (2003). Unconscious phantasy. London: Karnac Books
[1]Fantasia Inconscia
Fatto scelto

Da La lettera rubata_di E. A. Poe
A cura di Fulvio Mazzacane
Per Bion l’espressione “fatto scelto” descrive un’esperienza emotiva in cui avviene un processo di sintesi che l’analista fa, attraverso sentimenti di coerenza e scoperta, passando da una situazione schizoparanoide ad una depressiva, da una sensazione di vuoto di senso con vissuti di angoscia e persecutori a una transitoria sensazione di sollievo (Lòpez Corvo, 2006).
Precursori del concetto
Hume elabora il concetto di congiunzione costante che è in qualche modo precursore del concetto psicoanalitico di fatto scelto. La connessione tra idee, che punta all’identificazione di congiunzioni costanti, si regola in base a tre principi: la somiglianza, la contiguità nel tempo e nello spazio e la causalità. Tre principi che funzionano come una “dolce forza” di attrazione. Le relazioni che la mente costruisce possono essere tra idee e idee e tra idee ed esperienze. Le prime conducono alle certezze apodittiche delle verità matematiche, la cui negazione porta a contraddizione. Le seconde riguardano le nostre conoscenze sperimentali, non dipendono dal principio di non contraddizione e producono una conoscenza solo probabile. Hume critica un uso automatico della relazione causa effetto, che spesso parla solo della nostra abitudine a perpetuare le regolarità che si presentano nella nostra esperienza. Mette in guardia dal fatto che il fondamento della relazione causa effetto è psicologica e non è lecito trarre conclusioni senza l’autorizzazione di esperienze ripetute.
L’identificazione di una congiunzione costante attraverso il rilevamento di indizi che necessitano di essere pensati, tenendo conto della realtà dell’esperienza e della forza emotiva delle passioni in gioco, pone la psicoanalisi all’interno di quello che è stato definito il paradigma indiziario (Ginzburg, 1981).
E. A. Poe (1845) crea l’investigatore Dupin, personaggio che possiede doti logico deduttive che gli consentono di risolvere i casi trionfalmente. In effetti il modo di procedere di Dupin appare meno rigidamente scientifico, Poe utilizza il concetto di ratiocination per definire il modo di procedere di Dupin, uno stato mentale del narratore che rende possibili un ragionamento fondato sulle ipotesi. Nel modo di indagare di Dupin ci sono inferenze, attenzione al non verbale, al percettivo, alla lettura delle espressioni.
Pochi decenni dopo Peirce (1929) afferma l’importanza dell’interazione per l’attività investigativa, per apprendere dai comportamenti, dalla mimica e dalla fisiognomica. Si tratta di riattivazioni di impressioni che fanno parte di un nostro bagaglio acquisito nel tempo, sensoriali e corporei. Saper tenere insieme il massimo di intenzionalità con il massimo di ricettività per cogliere le piccole percezioni e le nostre risposte più profonde o antiche è un tratto artistico.
L’abduzione è per lui il primo passo del ragionamento scientifico, l’unico tipo di ragionamento che origina una nuova idea, fa conto su percezioni inconsce di connessioni tra aspetti diversi del mondo, comunicazioni subliminali di messaggi ed è associata ad un’emozione, prende spunto dai fatti senza, all’inizio, avere alcuna particolare teoria in vista.
Il fatto scelto
Nel testo della seduta convergono i contributi verbali e non verbali di paziente ed analista e, inevitabilmente, delle loro storie. L’analista è chiamato ad organizzare ipotesi di attribuzione di senso attraverso operazioni che illuminano alcune parole, espressioni, sensazioni, fantasie e ne narcotizzano altre. Nella selezione del materiale da illuminare emerge la qualità artistica del lavoro analitico. Di ogni scelta sarà sempre difficile dire se sia la migliore possibile, ma sarà sempre possibile verificare o chiedersi comunque quando sia errata attraverso le risposte del paziente o in maniera più eclatante per il concretizzarsi di fenomeni di blocco della comunicazione.
Ne “Il gemello immaginario” (1967) Bion chiama “Evoluzione” il “collegarsi mediante un’improvvisa intuizione, di una serie di fenomeni apparentemente slegati tra loro e che, dopo l’intuizione, hanno assunto una coerenza e un significato che prima non possedevano”. Connessioni che emergono dal discorso del paziente inimmaginabili ma inequivocabili.
Più tardi definisce questi fenomeni “fatto scelto”, prendendo questa espressione da H.Poincaré che nel 1908 la utilizza per spiegare come avviene la formazione di un pensiero creativo all’interno di una ricerca in campo matematico. L’obiettivo è tendere ad un ordine in una complessità altrimenti inaccessibile attraverso la coesistenza di prospettive diverse.
Bion sottolinea come si tratti di un’esperienza emotiva che sorge da un sentimento di coerenza e di scoperta, non necessariamente risponde ad una logica e avviene in un assetto dell’analista “rilassato” che si accompagna a una sensazione di sintesi o di associazione creativa.
L’emergenza del fatto scelto è un processo sincronico, non è uguale al procedimento diacronico che stabilisce catene causali, lega tra loro elementi slegati fino a un attimo prima. In questo modo, nella pratica clinica, l’emergenza del fatto scelto viene associato prevalentemente all’ambito delle microtrasformazioni che avvengono in seduta, più che a quello delle costruzioni in cui la coppia riorganizza vari momenti di lavoro per ripensare in maniera più sistematica a pezzi della storia del paziente o della coppia analitica. .
Come accade sempre nella teorizzazione bioniana, il concetto di fatto prescelto, va inteso più che come concetto singolo come nodo di una rete cui appartengono altre nozioni, poiché la particolarità del modello bioniano che si fonda sulle analogie, intese come percezione di relazioni tra oggetti, rende difficile e inadeguato cogliere il singolo concetto al di fuori delle sue relazioni (Civitarese, 2011). In questo contesto va sottolineata la relazione con i concetti di capacità negativa, rêverie, trasformazioni in O, preconcezione-realizzazione, congiunzione costante, bi-direzionalità dei movimenti PS/D.
Oscillazione Capacità Negativa/Fatto scelto
Bion afferma che il modello del fatto scelto è bimodale, un primo aspetto è nella pazienza dell’analista, nella sua fede nella propria intuizione e che esista in lui una pre-concezione del fatto prescelto. Il secondo è del paziente e delle sue associazioni libere
Il fatto scelto è cioè l’elemento che dà coerenza agli oggetti della posizione schizoparanoide e dà così inizio alla posizione depressiva, può fare tutto ciò grazie al fatto di stare al punto di intersezione di una serie di diversi sistemi deduttivi e di appartenere così a tutti loro… L’analista deve occuparsi di due modelli: uno che egli deve costruire e l’altro implicito nel materiale prodotto dal paziente. (Bion, 1970, 149 150)
L’emergenza del fatto scelto all’interno di una dialettica (oscillazione) con la capacità negativa (Ferro, 1999) è intesa come la capacità di imporsi un’astinenza dalla ricerca attiva di elementi della memoria, che siano elementi della storia del paziente, delle teorie dell’analista. “Quella capacità che un uomo possiede se sa perseverare nelle incertezze, attraverso i misteri e i dubbi, senza lasciarsi andare ad un’agitata ricerca di fatti e ragioni” (Bion, 1970).
Vi è un continuo oscillare tra la capacità dell’analista di permanere in posizione schizoparanoide priva di persecuzione e l’opzione per il fatto scelto. L’ipotesi di lettura che porta al fatto scelto nasce da un’emozione che aggrega elementi prima non collegati in una forma che privilegia un vertice e ha la sua inevitabile caratteristica di transitorietà e non di parola finale. Il lutto del passaggio in una posizione depressiva viene mitigato dall’idea che quello che abbiamo narcotizzato può sempre tornare in campo (Ferro, 1999).
Patologia del fatto scelto
Britton e Steiner (1994) partono dalla considerazione di un’estrema vicinanza tra il fatto scelto e un overvalued idea. I sentimenti di incertezza e di confusione provocati, a volte, dal materiale della seduta spingono paziente e analista a cercare un senso compiuto con sentimenti di urgenza.
La ricerca e l’apparente emergenza di una congiunzione costante su cui costruire un’ipotesi interpretativa non lo pone al riparo da false piste o fraintendimenti. Britton e Steiner definiscono overvalued idea i pensieri dell’analista che si presentano come fatti prescelti, in realtà determinati da reazioni difensive dell’analista, dal suo bisogno di confermare le proprie teorie o di tenere lontana l’ansia relativa ad un certo materiale. L’ overvalued idea si configura quindi come rifugio dell’analista o della coppia per mancanza di stabilità psichica in momenti di particolare confusione, un uso improprio delle proprie teorie che da patrimonio si trasformano in aree di non pensiero
Un profondo esercizio del dubbio e l’attenzione dell’analista alle risposte del paziente sono due componenti fondamentali dell’indispensabile funzione di controllo. Testare l’effetto dell’interpretazione fa parte dell’interpretazione stessa, sono due momenti non distinguibili. Il rischio più grosso è l’analista senza dubbi, indottrinante, che uccide la creatività e l’autenticità del paziente.
Bibliografia
Bion W.R. (1967) Il gemello immaginario in Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico. Armando, Roma (1970).
Bion W.R. (19629 Apprendere dall’esperienza. Armando, Roma (1982).
Britton R., Steiner J. (1994) Interpretation: selected fact or overvalued idea? Int. Jour. Psy. 75, 1069-1078.
Civitarese G. (2011) La violenza delle emozioni. Cortina, Milano.
Ferro A. (1999) La psicoanalisi come letteratura e terapia. Cortina, Milano.
Ginzburg C. (1983) Spie. Radici di un paradigma indiziario, in (a cura di Eco U., Sebeok T.A.) Il segno dei tre. Holmes, Dupin, Peirce. Bompiani, Milano.
Lòpez Corvo R.E. (2006) Dizionario dell’opera di Wilfred R. Bion. Borla, Roma
Peirce C.S. (1929) Guessing. In Opere. Bompiani, Milano (2011).
Poe E.A. (1983) I racconti. Einaudi, Milano.
Novembre 2014
Ferenczi Miskolc Sándor

Ferenczi Miskolc Sándor
SÁNDOR FERENCZI Miskolc,
a cura di Silvia Anfilocchi
7 luglio 1873 – Budapest, 22 maggio 1933
Sándor Ferenczi si definì l’enfant terrible della psicoanalisi. Fu, infatti, un grande innovatore, anticipatore di proposte che sono divenute parte integrante della psicoanalisi attuale, precursore di temi centrali nel dibattito contemporaneo. Amico e allievo prediletto di Freud, che ne lodò la versatilità, l’originalità e la ricchezza di talento[1], ebbe con lui una relazione in parte paritaria e fraterna, con le rivalità e le ambivalenze tipiche di un rapporto profondo, in parte di tipo genitoriale, con richieste e tensioni unilaterali.
Cenni Biografici
Nacque in una cittadina nel nord dell’Ungheria, ottavo di 11 figli di una famiglia ebrea liberale di classe media in cui si parlava correntemente ungherese, polacco, tedesco e yiddish, perse il padre a 15 anni e crebbe in un ambiente culturalmente stimolante ma carente dal punto di vista affettivo. La madre, descritta come una donna severa, accrebbe l’attività del marito (una libreria-tipografia vivace centro culturale frequentato da intellettuali e artisti) ma dedicò scarse attenzioni ai figli.
Queste brevi note biografiche forse rendono ragione della sensibilità di Ferenczi per le aree traumatiche precoci e di altri suoi tratti distintivi (l’acume spiccato, la genialità e la dipendenza emotiva) tipici di quei bambini precocemente saggi di cui si occuperà come analista.
Dopo la laurea in medicina a Vienna avviò le carriera di neuropsichiatra all’ospedale St. Rókus di Budapest dove intraprese osservazioni ed esperimenti psicologici su se stesso con il metodo della scrittura automatica e si avvicinò all’idea di apparato psichico inconscio. Dal 1897 al 1908, anno in cui presentò il suo primo lavoro psicoanalitico, pubblicò 98 tra saggi, articoli, recensioni e studi di casi su temi come: gli stati inconsci, l’ipnotismo, i sogni, la scissione psichica; scritti in cui riservava già grande attenzione alla relazione di cooperazione tra medico e paziente quale elemento fondamentale per la buona riuscita del trattamento.
Al primo approccio, l’Interpretazione dei sogni non suscitò il suo interesse ma, dopo aver riletto questo ed altri lavori di Freud, volle conoscerlo. Si incontrarono nel 1908 grazie all’intermediazione di Jung e l’anno successivo lo accompagnò negli Stati Uniti.
Da allora, Ferenczi fu un instancabile ed entusiasta promotore della psicoanalisi: fu sua l’idea di fondare l’International Psychoanalytic Association (1910), la Società Psicoanalitica Ungherese (1913) di cui fu presidente per 20 anni, l’International Journal of Psychoanalysis (1920) e di istituire un programma di training psicoanalitico formalizzato in cui era richiesta un’analisi didattica approfondita (la seconda regola fondamentale) agli aspiranti analisti. Grazie alla sua vasta cultura e alla sua apertura verso altre discipline, contribuì enormemente alla diffusione della psicoanalisi tra letterati, scienziati ed artisti. Come Freud, fu un convinto sostenitore dell’analisi laica e si oppose al predominio che la classe medica statunitense cercava di guadagnare sulla disciplina.
Uno dei primi concetti psicoanalitici da lui proposti, ripreso da Freud ed entrato a far parte dell’impianto teorico condiviso, fu quello di introiezione (1909 e 1912a), termine che coniò per integrare il movimento di proiezione e spiegare il processo di formazione del mondo e degli oggetti interni all’Io; lo riprese e sviluppò (1913a e 1926a) alla luce delle innovazioni nel frattempo introdotte da Freud affiancando alle fasi dello sviluppo psicosessuale gli stadi di creazione del senso di realtà.
Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale fu richiamato sotto le armi e lavorò come medico da campo, esperienza che gli consentì di approfondire la teoria e il trattamento delle nevrosi post-traumatiche. In questo periodo fece con Freud un’analisi breve e sommaria che lo lasciò insoddisfatto soprattutto per la mancata elaborazione del transfert negativo (lamentela comune ai primi analisti che non poterono beneficiare di un’analisi personale approfondita).
Tuttavia, Ferenczi e Freud mantennero un rapporto profondo di scambio sincero sul piano personale e professionale. Lo testimoniano l’intensa corrispondenza, i numerosi viaggi e vacanze che fecero insieme, le ripetute citazioni e riconoscimenti nei testi freudiani e l’evoluzione quasi parallela dei loro scritti, tanto da non poter distinguere quanto l’uno dovesse all’altro[2].
Nel 1919, all’epoca del matrimonio con la donna con cui aveva intrattenuto per 20 anni una complicata relazione clandestina, gli fu offerta la prima cattedra di psicoanalisi al mondo istituita all’Università di Budapest. La perse poco dopo, quando una reggenza di destra spodestò il Soviet nel tentativo di restaurare la monarchia e provocò l’allontanamento degli psicoanalisti ungheresi suoi allievi (S. Rado, M. Klein, M. Mahler, i Balint, F. Alexander) verso Vienna e Berlino.
A partire dagli anni ’20, Ferenczi si concentrò sul suo interesse principale: le modifiche tecniche tese ad accrescere l’efficacia terapeutica della psicoanalisi con un’attenzione privilegiata alle dinamiche transferali e contro-transferali nella relazione analitica, considerata un rapporto bi-personale[3]. Insieme a Rank, fu il primo a mostrare che quanto emerge in seduta deriva dall’incontro tra il transfert del paziente e il controtransfert dell’analista (1924a). Mostrò che il fenomeno del transfert è onnipresente nella cura e che tutto va interpretato come espressione del rapporto di transfert e di resistenza (1926b) e che tutti i sintomi fisici e psichici che si presentano durante il trattamento vanno interpretati come manifestazioni del processo analitico (1912b, 1913b). Nel tracciare una metapsicologia del funzionamento mentale dell’analista al lavoro, individuò il controtransfert narcisistico, ovvero il rischio che il narcisismo dell’analista influenzi i pazienti e inconsciamente li spinga a portare in seduta solo materiale a lui gradito, epurato da sentimenti ostili, finendo per rafforzare il senso di colpa inconscio e impedire il progresso della cura (1919a, 1919c, 1927-28), esattamente come accade ai bambini che si sentono costretti ad accondiscendere gli adulti.
Teoria e Tecnica
Le innovazioni tecniche da lui introdotte nella ricerca di modi corretti, rispettosi, opportuni che, senza mai superare il livello di tensione e dispiacere sopportabile dalla struttura dell’Io del paziente (la sofferenza tollerabile), consentono di raggiungere le aree più precoci e approfondire la cura, hanno permesso di ampliare i campi di indagine e intervento della psicoanalisi al trattamento delle patologie non-nevrotiche. La sua scrittura ricca di osservazioni e di esempi clinici fornisce indicazioni preziose per superare i momenti di impasse.
La comprensione dell’importanza che il rapporto precoce madre-bambino e il ruolo genitoriale giocano nello sviluppo psichico e nella strutturazione della personalità, il concetto di impronta lasciata dall’oggetto sulla psiche del soggetto in via di sviluppo, di ipnosi materna e paterna, di fallimento ambientale, fanno di Ferenczi il padre delle teorie delle relazioni oggettuali. La sottolineatura di come in analisi si ricreino l’ambiente infantile e adolescenziale, per il desiderio inconscio del paziente di vedere rettificato e riscattato l’accudimento inadeguato ricevuto in famiglia e che ogni terapia è l’analisi del bambino che sopravvive nell’adulto è un richiamo dell’analista alle proprie responsabilità (1930).
Tra il 1926 e il 1927 fu invitato dalle società psicoanalitiche locali a tenere conferenze a New York e a Washington e lì rimase un punto di riferimento per la nascente psicoanalisi interpersonale, a differenza di quanto accadde in Europa, dove fu quasi dimenticato fino alla recente «Ferenczi renaissance[4]». Nel Vecchio Continente, infatti, fu a lungo frainteso e marginalizzato dalle correnti prevalenti, soprattutto a causa dei giudizi malevoli di Ernest Jones, suo allievo e biografo di Freud, probabilmente geloso del trattamento privilegiato che questi riservava a Ferenczi[5], e della censura che lo stesso Jones e Anna Freud hanno operato sulla corrispondenza tra i due.
La riscoperta e completa riabilitazione dello psicoanalista ungherese ha in Italia alcuni rappresentanti tra i più autorevoli: Glauco Carloni[6] che ha esplicitamente passato il testimone a Franco Borgogno[7], cui siamo debitori dell’intenso e capillare lavoro di diffusione e valorizzazione di Ferenczi come analista e come uomo.
In realtà, per le qualità umane e professionali di cui aveva dato prova, i colleghi inviavano a Ferenczi i casi considerati impossibili, cioè pazienti profondamente regrediti ed egli continuò fino all’ultimo a rielaborare le sue prime intuizioni sulla necessità di prestare un ascolto sincero, interessato, affettivo al paziente, per sentire con il cuore e accogliere sensazioni, angosce, comunicazioni, per toccare con tatto, cogliere e dare senso anche alle più piccole sfumature, sperimentare e trasmettere il desiderio di aiutare.
In molti suoi scritti, forse soprattutto negli articoli più brevi, Ferenczi regala al lettore osservazioni cliniche puntuali e originali, oltre a utili consigli tecnici per favorire il raggiungimento dell’empatia, la capacità di sentire dentro, di mettersi nei panni del paziente senza confondersi con lui.
Grazie all’esperienza acquisita nell’analisi dei casi più difficili, rivoluzionò la teoria del trauma (non solo sessuale e non solo fantasmatico) e il concetto di traumaticità di un evento; approfondendo l’analisi dei processi intrapsichici e interpersonali che coinvolgono vittima e carnefice arrivò a elaborare i concetti di scissione e frammentazione dell’Io come difesa dal dolore e di identificazione con l’aggressore, intesa come la possibilità di sopravvivenza in cui la vittima rinuncia a sé e si consegna all’aggressore identificandosi con ciò che egli si aspetta. Spiegò che il disconoscimento dei sentimenti dei bambini e il silenzio degli adulti sono elementi aggravanti (1927, 1929, 1933) e, conseguentemente, sostenne la necessità che l’analista sia sincero per consentire al paziente di recuperare fiducia nelle proprie sensazioni, che riconosca la propria partecipazione e influenza, potenzialmente anche maligna, lungo tutta l’analisi e in ogni singola seduta (1908, 1924a).
Nelle sue ultime opere (1932, pag. 55) indicherà con il nome di Orpha gli istinti vitali organizzatori che presiedono alla scissione per garantire la sopravvivenza psichica in situazioni traumatiche, una sorta di Vero Sè che rimane protetto, e spiegherà la funzione traumatolitica del sogno (1931).
L’amore per la ricerca e la verità, evidente sin dai primi scritti pre-analitici, rimarrà una caratteristica costante della sua produzione. Invariata resterà anche la sua fedeltà alle teorie freudiane, nonostante gli esperimenti, non sempre felici, che gli costarono critiche e divergenze con il Maestro a partire dagli anni ‘20. I due poterono discuterle e superarle fino alla rottura definitiva nel dicembre 1931, quando Freud scrisse a Ferenczi, già malato, una lettera di biasimo pur mantenendo un atteggiamento indulgente, rimproverandogli il rischio per l’intera teoria psicoanalitica a causa delle voci che giravano sul suo conto.
Secondo Freud, Ferenczi assumeva con i suoi pazienti un atteggiamento troppo materno, cosa che avrebbe potuto sviare la posizione degli analisti in formazione ma, come commenta il suo allievo M. Balint, forse, le eccezionali qualità di accudimento di cui Ferenczi era capace mettevano in difficoltà Freud che non avrebbe saputo sostenere un carico emotivo così intenso.
Particolarmente apprezzata dal Maestro, che la definì la più audace applicazione dell’analisi mai tentata e una possibile precognizione della futura bioanalisi, fu l’opera (1924b) in cui l’autore applica alcuni modelli psicoanalitici, tratti prevalentemente dai Tre saggi sulla teoria sessuale, allo studio della vita organica per far luce sui fenomeni psichici.
Le critiche che gli sono state rivolte, e che hanno contribuito a tenerlo per decenni in posizione marginale, sono conseguenza del fraintendimento dei suoi esperimenti di psicoanalisi attiva e di analisi reciproca.
L’analisi attiva, cui dedicò diversi lavori (1919b, 1921, 1924c) densi di preziose osservazioni cliniche, consisteva per Ferenczi nel sostenere, anche realmente, il ruolo che l’inconscio del paziente attribuisce all’analista in modo da facilitare la ripetizione delle esperienze traumatiche e il loro superamento dopo la rivelazione del contenuto: una tecnica che induce il paziente verso un atteggiamento attivo nei momenti in cui il trattamento sembra ristagnare e le associazioni esaurirsi. Pur riconoscendone l’interesse, lo stesso Ferenczi ricusò questa modifica; concluse che non ci possono essere scorciatoie nel processo analitico e che neanche gli analisti più esperti possono pensare di abbreviare il lavoro senza correre rischi (1926b).
L’analisi reciproca, esperimento che Freud bocciò risolutamente, è riportata nel Diario clinico, testo molto originale per l’epoca, che, insieme agli appunti pubblicati con il titolo Frammenti e annotazioni, testimonia le sue doti di osservatore attento e clinico di valore.
Sicuramente nessuno oggi potrebbe sostenere un simile approccio tuttavia, le associazioni di Ferenczi e dei suoi pazienti sulle rispettive fantasie inconsce e le loro mutue analisi mostrarono come i processi psichici dell’analista e del paziente si mescolino e come la loro rivelazione simultanea arricchisca e approfondisca la comprensione da parte di entrambi. Queste novità hanno aperto la strada alle tecniche di self-disclosure delle scuole intersoggettiviste.
Ferenczi si ammalò di anemia perniciosa con gravi conseguenza neurologiche nel 1931 e morì 2 anni dopo.
BIBLIOGRAFIA
Articoli di Sándor Ferenczi citati nel testo:
(1908) Psicoanalisi e pedagogia
(1909) Introiezione e transfert
(1912a) Il concetto di introiezione
(1912b) Sintomi transitori nel corso dell’analisi
(1913a) Fasi evolutive del senso di realtà
(1913b) Un sintomo ‘transitorio’. La posizione del paziente durante la seduta
(1919a) La tecnica psicoanalitica
(1919b) Difficoltà tecniche nell’analisi di un caso di isteria
(1919c) Il problema dell’influsso sul paziente nel corso dell’analisi
(1921) Ulteriore estensione della ‘tecnica attiva’ in psicoanalisi
(1924a) Prospettive di sviluppo della psicoanalisi
(1924b) Thalassa. Saggio sulla teoria della genitalità
(1924c) Le fantasie indotte. L’attività nella tecnica dell’associazione
(1926a) Il problema dell’affermazione del dispiacere. Progressi della nozione del senso di realtà.
(1926b) Controindicazioni della tecnica psicoanalitica attiva
(1926c) L’importanza di Freud per il movimento di igiene mentale (in occasione del suo 70° compleanno)
(1927) L’adattamento della famiglia al bambino
(1927-28) L’elasticità della tecnica psicoanalitica
(1929) Il bambino non desiderato e il suo istinto di morte
(1930) L’analisi infantile negli adulti
(1931) Una revisione dell’interpretazione dei sogni
(1932) Il diario clinico
(1920-32) Frammenti e annotazioni
(1933) Confusione delle lingue tra gli adulti e il bambino. Il linguaggio della tenerezza e il linguaggio della passione
L’edizione italiana più completa dei lavori di Ferenczi, recentemente ripubblicata, è edita da Cortina in 4 volumi:
Ferenczi S. Opere vol 1° 1908-1912 (2008)
Ferenczi S. Opere vol 2° 1913-1919 (2009)
Ferenczi S. Opere vol 3° 1919-1926 (2009)
Ferenczi S. Opere vol 4° 1927-1933 (2002)
cui si aggiungono:
Ferenczi S. (1933) Diario clinico. Gennaio-ottobre 1932. Cortina, Milano. 1988
Sigmund Freud, Sándor Ferenczi Lettere 1908-1914 vol. I. Cortina, Milano.1993
Sigmund Freud, Sándor Ferenczi Lettere 1914-1919 vol. II. Cortina, Milano.1998
Ferenczi S. (1899-1908) (a cura di Mészáros J., Casonato M.) La mia amicizia con Miksa Schächter. Scritti preanalitici, Bollati Boringhieri, Torino. 1992
Da qualche anno, un nutrito gruppo di psicoanalisti sta lavorando alla ripubblicazione dell’Opera omnia di Sándor Ferenczi; Franco Borgogno e Peter Rudnytsky ne sono stati nominati General Editors.
Per un elenco completo delle opere italiane e internazionali ispirate da Sándor Ferenczi www.sandorferenczi.org/publications/books-and-articles-inspired-by-ferenczi/#toggle-id-2
NOTE
[1] Freud in Per la storia del movimento psicoanalitico (1914, OSF vol. 7, pag. 407) definì il suo valore pari a quello di un’intera società psicoanalitica e nel Necrologio di Sándor Ferenczi (1933, OSF vol. 11, pag. 320) scrisse che ogni analista può sentirsi suo allievo
[2] Carloni G. (1988) Sándor Ferenczi e la scuola ungherese in Semi A.A. (a cura di) Trattato di psicoanalisi. Cortina, Milano
[3] Borgogno F. (2019) Sándor Ferenczi, psicanalista classico e contemporaneo (con particolare riferimento a transfert e controtransfert). Riv. Psic. LXV, 2, 267-279
[4] Dopo la pubblicazione (1985) del Diario clinico, che contiene appunti e commenti sui pazienti seguiti dal 7 gennaio al 2 ottobre 1932, e della corrispondenza con Freud, iniziata nel 1992 con il primo volume delle lettere, molti europei hanno iniziato ad apprezzare il lavoro dello psicoanalista ungherese che era rimasto, fino ad allora, marginale. Negli stessi anni, gli analisti che, invece, non avevano smesso di ispirarsi alle sue idee e ai suoi lavori hanno avviato le International Sándor Ferenczi Conferences, che dal 1991 si sono svolte con regolarità richiamando sempre maggior interesse sul suo pensiero e sulla sua produzione. Da allora numerose iniziative hanno sostenuto il loro recupero e la loro diffusione (The Ferenczi House project – campagne di raccolta fondi per preservare la casa di Ferenczi a Budapest, The International Sándor Ferenczi Foundation e la fondazione di molte associazioni locali affiliate.
[5] In occasione del suo 50° compleanno (1923), fu dedicato a Ferenczi un numero monografico della “Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse”, vol. 9 (3), di cui Freud scrisse l’introduzione mettendo in rilievo la poliedricità della sua produzione scientifica (Il dottor Sándor Ferenczi; per il cinquantesimo compleanno OSF vol. 9 pag. 580) e sempre Freud iniziò a curare la raccolta dei suoi articoli pubblicati in 4 volumi tra il 1927 e il 1939 con il titolo Fondamenti di psicoanalisi. Inoltre, fu chiesto a Ferenczi di scrivere a Freud gli auguri per il suo 70° compleanno il 6 maggio 1926
[6] Curatore con Egon Molinari della traduzione italiana di Fondamenti di Psicoanalisi in cinque volumi suddivisi per tematiche (Guaraldi, 1972-75) e della traduzione dal francese delle Opere complete curate da Balint, in quattro volumi suddivisi per periodi (Cortina, 2002-09).
[7] Dopo il passaggio avvenuto nel Congresso di Madrid del 1997, Franco Borgogno è rimasto il principale allievo di Ferenczi; ha fondato insieme a Carlo Bonomi l’Associazione Culturale Sándor Ferenczi www.ferenczi.it di cui è l’attuale Presidente, membro dell’International Sándor Ferenczi Network www.sandorferenczi.org ed è autore di numerosi articoli e saggi, oltre che curatore di libri collettanei dedicati all’analista ungherese.
Ferrari Armando Blanco

Ferrari Armando Blanco
Armando B. Ferrari
I maestri della psicoanalisi
A cura di Riccardo Lombardi
La vita
Armando Blanco Ferrari (1922-2006), nato in Canada da genitori italiani, è cresciuto in Italia sino all’adolescenza. Dopo aver partecipato da giovane al movimento antifascista e alla Resistenza finendo in carcere per la sua attività politica, è partito per il Brasile nel 1947, completando la sua formazione di antropologo e diventando professore di sociologia all’università di San Paolo del Brasile. La sua formazione analitica è stata segnata dall’incontro con analisti di diverse impostazioni, dalla sua prima analisi personale con Henrique Scholloman, freudiano formatosi a Vienna, poi con Virginia Bicudo, la prima analista brasiliana ad avere avuto una formazione Kleiniana a Londra e la prima autrice brasiliana a pubblicare sull’International Journal of Psychoanalysis, ed infine con Frank Philips, l’analista che portò l’approccio di Bion in Brasile e che invitò Bion stesso a tenere i suoi seminari brasiliani.
Ferrari è stato training analyst della Società Psicoanalitica di San Paulo, partecipando alla formazione dell’istituto di psicoanalisi a Brasilia. Come antropologo ha effettuato quattro spedizioni antropologiche solitarie presso le tribù amazoniche del Mato Grosso per studiarne i rituali di morte: dati poi rielaborati nel contesto della sua ricerca psicoanalitica sull’istinto di morte (Ferrari 1967, 1968).
Formato dall’insegnamento di Bion in Brasile, si è trasferito in Italia dalla seconda metà degli anni ’70 per un progetto di studio interdisciplinare sulla relazione analitica con il filosofo Emilio Garroni, decidendo, differentemente da un altro analista immigrato dal Sud America come Matte Blanco, di non diventare analista di training in Italia. In occasione delle Giornate di Studio sull’opera di W. R. Bion” della S.P.I. (Roma 27-28 marzo 1981), pubblicate in un numero speciale della Rivista di Psicoanalisi (1981, 27, 3-4), Ferrari non fu invitato, malgrado fosse all’epoca l’unico psicoanalista residente in Italia ad esser stato clinicamente formato a lavorare con il suo approccio.
Pur essendo, insieme con autori come Matte Blanco, Fornari e Gaddini, una delle personalità psicoanalitiche più rilevanti presenti in Italia negli ultimi cinquant’anni, il contributo di Ferrari appare ancora non integrato nel panorama scientifico della Società Psicoanalitica Italiana, essendo questo un contesto maggioritariamente condizionato dalla politica istituzionale, da cui Ferrari, dopo il suo arrivo in Italia, aveva deciso di restare fuori. Anche più recentemente si registra l’assenza di uno scritto firmato da Ferrari nel recente volume su ‘Readings Italian Psychoanalysis’ (Borgogno, Luchetti & Marino 2016), che ha l’intento di presentare la tradizione psicoanalitica italiana al lettore di lingua inglese, anche se alcuni suoi concetti inerenti la relazione corpo-mente sono ivi testimoniati attraverso il mio contributo ‘Primitive Mental States and the Body’ (Lombardi 2002).
Il contributo alla Psicoanalisi
– La Relazione Analitica
Collaborando con il filosofo Emilio Garroni, una delle figure chiave della filosofia italiana recente, Ferrari ha studiato le potenzialità di ricerca offerte dalla Relazione Analitica, valorizzando il contributo di entrambi i ‘co-autori’ di tale relazione, facendo perno sui suoi processi di significazione che passano nella comunicazione verbale in analisi e sugli elementi invariantivi che se ne possono ricavare (Ferrari & Garroni 1979). In un’epoca anteriore ai contributi di autori come Mitchell e Renik. la psicoanalisi è concepita negli scritti relazionali di Ferrari in un’ottica intersoggettiva, costruttivista e processuale: una nuova esperienza di andare dentro sé stessi, nella misura in cui si è capaci di andarci con l’altro (Ferrari 1981).
Costruttività delle singole relazioni analitiche ed invarianza degli elementi hanno portato più tardi Ferrari a formulare l’ipotesi de L’Eclissi del corpo (Ferrari 1992), o più precisamente eclissi dell’Oggetto Originale Concreto (O.O.C.): tale ipotesi si declina anche nei successivi due volumi italiani (1994, 1998), ma è stata poi raccolta in un unico volume nell’edizione inglese (Ferrari 2004). Per il nostro autore dalla messa in ombra degli incandescenti stimoli sensoriali del corpo deriva in modo determinante la possibilità di realizzare un’alba del pensiero: in questo modo egli offre un originale status metapsicologico al corpo nel contesto di una teoria psicoanalitica, dove tale status praticamente non esiste, perché il ruolo del corpo è concepito essenzialmente in funzione del suo successivo trasformarsi in pensiero e del suo ‘partecipare alla conversazione’ (Lombardi 2002).
– Il Corpo
Collocandosi ai margini di una concezione della psicoanalisi centrata sul mentale, Ferrari riscopre in una nuova chiave le rivoluzionarie intuizioni freudiane sulle ‘necessità di lavoro’ (‘Arbeitsanforderungen’) che legano il corpo e la mente (Freud 1915) e quelle che vedevano nell’autoerotismo una precondizione per uno sviluppo verso il narcisismo e le dinamiche oggettuali. Egli riformula le ipotesi di Bion (1957) di area psicotica e non psicotica nei termini di aree entropica e neghentropica, riferendo la tendenza alla disorganizzazione non ad elementi primariamente distruttivi, ma alla forza disorganizzante delle sensazioni originarie. Partendo da questo vertice il focus del lavoro clinico viene orientato sul livello sensoriale e sui cosiddetti ‘livelli mentali primitivi’, valorizzando l’esperienza di un corpo e di sensazioni che sono in attesa di trovare corrispondenza con le rappresentazioni mentali: la nascita della rappresentazione mentale è poi essenziale per permette il distanziamento e il contenimento del primordiale dilagare caotico delle sensazioni, altrimenti incontenibile.
Il passaggio dal corporeo al mentale è facilitato dalla presenza di una madre dotata di reverie, ma non si caratterizza per l’introiezione dell’oggetto materno, come nel modello di Melanie Klein (1952), perché le prime forme di contenimento restano essenzialmente un dato interno al bambino. Sembra che in questo modo Ferrari dia un’enfasi primariamente intra-personale al modello topologico della relazione contenitore-contenuto proposta da Bion (1970), lì dove altri autori post-bioniani hanno enfatizzato il valore di questo stesso concetto soprattutto sul versante relazionale esterno, identificandolo come controparte e modello inconscio del concetto di ‘attaccamento’ proposto da Bowlby e dalla psicologia cognitiva dello sviluppo infantile (cfr Grotstein, 2007, 154 e seg). Le ipotesi di Ferrari cercano di cogliere i fenomeni correlati alla nascita del pensiero nelle fasi più precoci, ma al tempo stesso fotografano una condizione interna che resta operativa per tutto il corso generale della vita, dal momento che la pressione etologica del corpo non perde mai la sua forza primitiva ed i processi di trasformazione delle sensazioni in pensiero non cessano mai di presentare connotati ardui e altamente drammatici.
– La rete di contatto corpo-mente
Il punto di confronto clinico elettivo di Ferrari è il cosiddetto ‘analizzando con difetto di pensiero’ (Bion) e i pazienti ‘difficili da raggiungere’ (Joseph), per cui egli propone strumenti come la rete di contatto e i registri di linguaggio, orientati a catalizzare i primi movimenti di autocoscienza, centrando sugli accadimenti che si realizzano all‘interno del paziente, anche se in parallelo con gli eventi relazionali (Ferrari e Stella 1998). In linea con il vertice inaugurato da Bion, egli inoltre guarda al problema dell’identità e dell’Edipo privilegiando il piano dell’organizzazione attuale degli scenari interni, piuttosto che il piano storico ricostruttivo.
Il livello interno che compete alla relazione corpo-mente viene chiamato da Ferrari relazione verticale, mentre il dato esterno inerente la reazione madre-bambino è denominato relazione orizzontale: queste relazioni sono parallele e complementari e si influenzano a vicenda. La relazione con il corpo resta in ogni caso la relazione primaria che fonda la soggettività ed il pensiero, mentre la funzione primaria della mente è quella di fornire contenimento a sensazioni ed emozioni, che, per loro natura, possono essere soltanto essere sperimentate.
In tal modo l’enfasi di Ferrari si pone proprio su quell’esperienza, che Bion (1962) aveva identificato come il motore centrale della crescita della mente. Se per quest’ultimo il fallimento ad usare l’esperienza emozionale ha conseguenze disastrose e paralizzanti per la mente, Ferrari radicalizza la posizione di Bion vedendo nella relazione con il corpo una componente stabilmente irrinunciabile per l’attivazione del pensiero. Questa prospettiva appare particolarmente funzionale ai cosiddetti pazienti gravi, in cui traspaiono evidenti i tratti del marasma sensoriale corporeo originario; al tempo stesso può esser utile all’approccio agli analizzandi che non trovano soddisfazione nella vita perché non si accorgono che mancano di un dialogo con il proprio corpo.
Il problema della relazione corpo-mente non è circoscritto da Ferrari al campo della cosiddetta ‘psicosomatica’, ma riflette i problemi basici del funzionamento mentale che si manifestano, con sfumature diverse, in tutti i campi di competenza psicoanalitica, in particolare in quelli ‘di frontiera’, in cui la funzione mentale è esposta a rischio di collasso ed agiti catastrofici. La necessità di una stretta continuità tra corpo e mente, chiamati significativamente da Ferrari Uno e Bino – in continuità con il ‘Pinocchio uno e bino’ di Emilio Garroni (1975) – implica elementi di novità sul piano della tecnica psicoanalitica e riserva rilevanti conseguenze in vari contesti, come accade nelle situazioni cliniche che mostrano una precaria attivazione dell’auto-coscienza.
– L’Adolescenza
Particolare oggetto di studio per Ferrari (1994) è l’adolescenza, concepita come la ‘seconda sfida’ – dopo la prima sfida della ‘nascita psicologica’: in entrambe queste sfide il corpo incontra in modo determinante la mente. Mentre nell’infanzia la mente si è presentata al corpo per operare il contenimento della spinta marasmatica delle sensazioni fisiche, durante l’adolescenza è il corpo che si presenta all’attenzione della mente, in virtù della pressione della spinta biologica e dei cambiamenti fisici. La pressione del corpo verso la crescita e l’assunzione dei nuovi connotati adulti può essere così forte tanto che il corpo diventa un estraneo e l’adolescente teme di non poter reggere l’impatto delle sue trasformazioni: il corpo si pone non a caso come carico di elementi sconosciuti e fonte fonte di disagio ed imbarazzo. L’adolescenza è allora concepita come il periodo della vita in cui il conflitto corpo-mente assume i connotati più acuti, sollecitando un’elaborazione che getta le basi per la maturità futura o, al contrario, per i successivi squilibri interni.
Ferrari preferisce non parlare di ‘patologia adolescenziale’, perché insiste sulla mobilità della fenomenologia di quest’età della vita e sulla necessità di non farsi sviare dalle abituali categorie psicopatologiche: egli è convinto che anche le forme più acute di disagio possano essere superate in analisi grazie alla mobilità caratteristica di questa età, offrendo un decisivo contributo alla costruzione dell’uomo adulto. Per l’analista l’adolescenza si pone come un campo difficile, perché gli richiede una particolare capacità di contenimento di fronte a modi comunicativi connotati dalla provocazione e dall’azione.
– La morte e il tempo della vita
L’ultimo libro di Armando Ferrari è ‘Il pulviscolo di Giotto’ (2006), dedicato al problema psicoanalitico del tempo e all’approccio clinico ai pazienti terminali confrontati con la morte, che sposta il punto di vista freudiano dell’istinto di morte, enfatizzando il problema della relazione con la vita in presenza della minaccia incombente della morte. Un orientamento mentale che valorizza il tempo attuale permetterebbe di creare condizioni di vivibilità anche nei pazienti che hanno consapevolezza di un termine prossimo della propria esistenza. Il valore del tempo viene quindi ‘assolutizzato’ nel suo’ essere presente’, piuttosto che una dimensione nutrita di speranze e di promesse future.
Conclusioni
Il contributo psicoanalitico di Armando Ferrari, pur essendo fortemente marcato dalla dimensione relazionale, mette l’accento sui problemi posti dall’organizzazione del pensiero – non diversamente da come accade nell’approccio di Matte Blanco (Lombardi 2000)- e sui conflitti interni alla relazione corpo-mente: un approccio atipico rispetto a una cultura psicoanalitica attuale centrata sulla relazione oggettuale e sulle peripezie dell’intersoggettività. Il suo contributo può essere recepito come disturbante perché chiede agli analisti di pensare da un vertice differente rispetto a quelli con cui si è abituati a pensare (Mancia 1995). Tale vertice può essere avvertito come disturbante per la sua tendenza a marginalizzare le interpretazioni di transfert, considerate in genere come ‘marchio di fabbrica’ dell’autenticità della psicoanalisi, e per la sua tendenza a ridimensionare il ruolo dell’introiezione dell’analista come ‘oggetto’ chiave nel funzionamento dell’Io: una introiezione che funziona come baluardo di istituzioni psicoanalitiche, il cui funzionamento è caratterizzato dal potere, dall’affiliazione e dal proselitismo (Renik 2006, Lombardi 2006). Le ipotesi di Armando Ferrari meritano, non di meno, di essere approfondite e studiate dall’analista praticante e dalle nuove generazioni: esse possono indirizzare la ricerca ed essere di grande aiuto nel trattamento dei cosiddetti casi gravi, come ho mostrato in alcuni miei libri (Lombardi 2016, 2017). Esse sono particolarmente attuali per il trattamento di quegli analizzandi incapaci a sentirsi vivi o di quelli connotati da forme di pensiero concreto: esse facilitano l’avvicinamento di condizioni spesso considerate ‘non analizzabili’ come le psicosi, le gravi inibizioni, i disturbi del comportamento alimentare e tutte quelle fenomenologie che vedono il corpo in primo piano.
Bibliografia
BION, W.R. (1957). Differentiation of psychotic from the non-psychotic personalities. In Second Thoughts. London: Karnac 1967.
_______ (1962). Learning from Experience. London: Karnac.
BORGOGNO.F, LUCHETTI, A, MARINO COE, L (2106). Reading Italian Psychoanalysis. London, Routledge.
FERRARI, AB
____________ (1967), Instinto de morte. Contribuição para uma sistematização de seu estudo, Revista Brasileira de Psicanálise, v. 1 nº 3, 1967 p. 324 a 350.
____________ (1968), Instinto de morte. Contribuição para uma sistematização de seu estudo / 2ª parte. Revista Brasileira de Psicanálise, v. 1 nº 4, 1968 p. 487 a 526.
____________ (1983). Relazione analitica: sistema o processo? Rivista Psicoanal., 29:476-496
____________ (1992). L’Eclissi del Corpo. Roma: Borla.
____________ (1994). Adolescenza. La seconda sfida. Roma: Borla.
____________ (2004). From the eclipse of the body to the dawn of thought. London: Free Association Books.
____________ (2005). Il pulviscolo di Giotto. Milano, Angeli.
FERRARI, AB & GARRONI, E (1979). Schema di progetto per uno studio della “relazione analitica”. Rivista di Psicoanalisi 25: 282-322.
FERRARI, AB & STELLA A. (1998). L’alba del pensiero. Roma: Borla.
FREUD, S (1915). Metapsicologia. Pulsioni e loro destini. OSF 7.
GARRONI, E (1975). Pinocchio uno e bino. Bari, Laterza.
GROTSTEIN, JS (2007). A beam of intense darkness. Wilfred Bion’s legacy to Psychoanalysis. London, Karnac.
KLEIN, M. (1952). Some theoretical conclusions regarding the emotional life of the infant. Envy and Gratitude and Other Works 1946-1963. London: Hogarth Press,1975.
LOMBARDI, R (2000). Corpo, affetti, pensieri. Riflessioni su alcune ipotesi di I.Matte Blanco e A.B.Ferrari. Rivista di Psicoanalisi 46, 4, 683-706.
________ (2002) Primitive mental states and the body. A personal view of Armando B. Ferrari’s Concrete Original Object. Int. J. Psychoanal, 83:363-381.
________ (2006). Passioni e conflittualità nelle istituzioni psicoanalitiche. Rivista di Psicoanalisi, 52, 1, 191-212.
_________ (2016). Metà prigioniero Metà alato. La dissociazione corpo-mente in psicoanalisi. Torino, Boringhieri.
_________ (2017). Body–Mind Dissociation in Psychoanalysis. Development after Bion. The Relational Perspective Book Series. New York, Routledge.
MANCIA, M. (1994). Recensione di “L’Eclissi del Corpo” di A.B. Ferrari. Int. J. Psychoanal. 75: 1283- 1286.
RENIK, O. (2006), “An analyst questions the self-perpetuating side of therapy”. Intervista di Benedict Carey. New York Times, 10 ottobre. http://www.nytimes.com/2006/10/10/health/psychology/10conv.html
Filiazione
A cura di Chiara Rosso
Potremmo definire la Filiazione, dal latino filius “esser figlio” come un termine che accomuna il diritto, l’antropologia e la psicoanalisi e designa le regole in virtù delle quali un individuo acquisisce la sua identità sociale iscrivendosi in un processo di trasmissione di tipo patrilineare o matrilineare. Nella sua accezione originaria, la filiazione riguarda i sistemi di parentela e si struttura sulla base della differenza dei sessi e delle generazioni.(Roudinesco,1997)
FILIAZIONE IN PSICOANALISI
La Filiazione si intreccia col processo identitario dell’individuo, legando insieme il piano biologico con quello simbolico. Allo psicoanalista francese Guyotat(1980) dobbiamo uno studio approfondito dei molteplici aspetti della Filiazione. La filiazione istituita (o giuridica) è socialmente e culturalmente costruita e rappresenta l’ articolazione simbolica in cui l’individuo si colloca nella catena generativa, rispetto agli ascendenti ed ai discendenti. La filiazione immaginaria e narcisistica invece ha a che vedere con una dimensione psichica e fantasmatica che coinvolge il vissuto personale dell’individuo e il suo inserimento nella rete di relazioni presente fin dalla nascita. Infine una terza dimensione è quella della filiazione da corpo a corpo che indica il legame corporeo tra il genitore e il figlio. Quest’ultima dimensione, rispetto alle logiche del legame di filiazione, si situa sul versante del legame con la madre mentre la filiazione istituita su quello del legame col padre inglobando l’area più generale del ‘principio paterno’. Con l’avvento delle nuove frontiere procreative che separano l’atto sessuale da quello fecondativo, si assiste alla diffrazione del processo di concepimento e la filiazione che ne deriva si costituisce come una “rappresentazione biomedica del legame tra parti del corpo e prodotti del corpo” (Zurlo, 2013,5). La fecondazione eterologa ad esempio pone un problema complesso che sfocia su di una situazione ibrida; il sistema di filiazione in questo caso non appartiene né interamente a quella istituita basata sul legame biologico, dal momento che uno dei due genitori biologici è esterno alla coppia, né si struttura come indipendente da essa (come nell’adozione ) poiché il legame biologico non può essere negato né affermato od ancora ignorato per entrambi i membri della coppia .In questo modo la filiazione istituita entra in crisi e ciò è testimoniato anche dalle oscillazioni delle sentenze e dei provvedimenti in campo giuridico (frequenti le cause di disconoscimento di paternità) dove spesso si delega al magistrato prima che al legislatore il compito di introdurre nuove normative onde regolamentare un campo in divenire. Quando la filiazione istituita dunque, non riesce a render conto di quella biologica si crea una situazione di rischio psicologico e come osservano diversi Autori, la presenza di anomalie a livello della filiazione istituita si ripercuote in quella fantasmatica ed immaginaria, accentuandone la dimensione narcisistica. Nota infatti Zurlo :“Il sistema simbolico della filiazione rende pensabile e dicibile ciò che riguardo le origini e la morte, costituisce l’indicibile. Alle situazioni di anomalia della filiazione istituita, quindi corrisponde un vuoto di pensiero e di simbolizzazione che trova espressione sia a livello collettivo che individuale” (ibid.,59). La problematicità che investe la filiazione a seguito delle nuove tecniche di procreazione assistita costituisce un campo in parte inesplorato, oggetto di studi e riflessioni. Per capire il lavoro di elaborazione richiesto a livello individuale, sottolinea ancora Zurlo : “ (…)è necessario interrogarsi sulle fantasie che precedono e sono sottese al concepimento con tale procedimento.”(61) E’ dunque utile dirigere l’attenzione sugli aspetti narcisistici della filiazione e sulla evoluzione della tematica del desiderio in cui la filiazione si iscrive. Come già sottolineava Freud (1914) relativamente al narcisismo del bambino inteso come prolungamento del narcisismo del genitore, possiamo osservare come il bambino si collochi nella catena generazionale come il frutto del desiderio dei genitori. L’investimento narcisistico nei confronti della prole costituisce le basi dell’ individualità e ne garantisce lo sviluppo armonioso. Questi aspetti rinviano al concetto di contratto narcisistico della psicoanalista francese P. Aulagnier (1975)
PSICOPATOLOGIA DEL LEGAME DI FILIAZIONE
Guyotat sottolinea come il disturbo del legame di filiazione si possa realizzare sia nei confronti degli ascendenti che in quello dei discendenti. Nel primo caso annoveriamo ad esempio il delirio di filiazione in cui la persona sostituisce i propri genitori reali con dei genitori immaginari illustri. Nel 1910 gli psichiatri francesi Serieux e Capgras dettero il nome di “interpretatori filiali” a questo tipo di pazienti. Freud si occupò dell’argomento a proposito del Romanzo famigliare dei nevrotici (1909) e nel Caso clinico del Presidente Schreber (1911). Le psicosi puerperali possono invece essere considerate come un delirio di filiazione proiettato sulla discendenza. La madre non si figura di partorire un bambino reale ma bensì un doppio di sé stessa, grandioso e pericoloso al tempo stesso e il bambino immaginario si sovrappone e si sostituisce a quello reale.
FILIAZIONI PSICOANALITICHE
Nella storiografia freudiana Il tema della Filiazione si inscrive nella trasmissione del sapere psicoanalitico dal maestro all’allievo attraverso l’analisi personale o didattica. La filiazione psicoanalitica ripropone una sorta di sistema di parentela poiché la comunità psicoanalitica è paragonabile ad una famiglia patriarcale. Nel 1927, Ferenczi fu il primo ad interessarsi all’analisi degli analisti affrontando la tematica della fine dell’analisi mentre Balint approfondì il processo di formazione degli analisti . Il termine specifico di Filiazione venne introdotto nel corso di un seminario aperto ( Filiations, l’avenir du complexe d’Oedipe 1974-1975) da Granoff , psicoanalista francese di origini russe, influenzato da Ferenczi. La Filiazione psicoanalitica che si sviluppa tra analista e candidato assume una dimensione particolare poiché implica la presenza sul piano transferale e controtransferale di processi consci ed inconsci di grande intensità che, a seconda del grado di elaborazione, influenzano sia il presente che il divenire del futuro analista. Ad un livello istituzionale invece, la natura esplosiva di questi processi qualora essi non siano stati sufficientemente analizzati , sfocia su attitudini di disaccordo, fratture o ancora di atteggiamenti caratterizzati da eccessive lealtà. La funzione dell’IPA ( Associazione Psicoanalitica Internazionale) esprime a tal proposito la necessità di esercitare un ruolo di sostegno e di mediazione tra i vari gruppi locali, all’interno della comunità psicoanalitica.(De Mijolla, 2002, Napolitano 1999)
BIBLIOGRAFIA
Aulagnier P. (1975). La violence de l’interprétation. Du pictogramme à l’énoncé. Paris, PUF.
Balint M.(1948) On The Psychoanalytic Training System. Int.J.Psycho-Anal., XXIX,p.163-173. Trad.it.: Il sistema didattico in psicoanalisi. In: L’Analisi didattica in psicoanalisi (a cura di Gino Zucchini). Rimini, Guaraldi, 1975,p.17-47.
De Mijolla A.(2002) Dictionnaire International de Psychanalyse. Paris, Calmann-lévy.
Ferenczi S. (1927)Il problema del termine dell’analisi. In: Opere vol.IV, Milano, Raffaello Cortina,2002, p.14-22.
Freud S.(1909) Il romanzo familiare dei nevrotici. O.S.F.,5.
Freud S.(1911) Caso clinico del presidente Schreber. O.S.F.,6.
Freud S.(1914) Introduzione al narcisismo.O.S.F.,7.
Granoff W(19759. Filiations. Paris, Minuit,1975.
Guyotat J. (1980) Mort, naissance et filiation. Etudes de psychopathologie sur le lien de filiation.Paris, Masson.
Napolitano F.(1999)La filiazione e la trasmissione nella psicoanalisi.Sulla consegna transgenerazionale del sapere.Roma, Franco Angeli.
Roudinesco E. Plon M. (1997) Dictionnaire de la Psychanalyse.Paris, Fayard.
Zurlo M.C (2013)La filiazione problematica. Saggi psicoanalitici (a cura di).Napoli, Liguori.
Ottobre 2014
Fobia scolare
A cura di Manuela Moriggia
La fobia scolare è un disturbo caratterizzato dalla paura, irrazionale e non controllabile, di andare e/o restare a scuola. I bambini e gli adolescenti che ne soffrono presentano un livello d’ansia tale da compromettere significativamente la regolare frequenza scolastica. Tale disturbo non ha una sua categoria nosologica specifica all’interno del DSM. La sua insorgenza sembra spesso immotivata in quanto si tratta, nella maggior parte dei casi, di ragazzi intelligenti e studiosi con buona resa scolastica. Il manifestarsi di tale fobia rappresenta solitamente un segnale d’allarme particolarmente rilevante, che non va mai sottovalutato, perché può essere il sintomo di una sottostante struttura psicopatologica in procinto di scompensarsi.
Molti ragazzi che non riescono a frequentare la scuola mostrano delle difficoltà anche nell’affrontare altre situazioni della propria vita; in particolare soffrono di un disturbo di tipo narcisistico, presentando un’idealizzazione del Sé e desiderando in generale alti rendimenti, a livello scolastico in primis ma anche in altre attività (ad es. sport e hobby). Ambiscono ad essere speciali, ad essere sempre “i primi”; hanno un atteggiamento competitivo verso gli altri e pensano che a scuola si debba rendere al meglio, vivendo con ansia ogni prova. Non riescono a vivere la scuola come un luogo in cui condividere delle esperienze con i compagni e dove si possa usufruire della solidarietà degli altri per affrontare situazioni difficili.
In tutti è presente un forte senso di vergogna, legato al timore di non essere percepiti come persone “ideali”, che non deludono mai; pensano infatti che se non saranno sempre “ideali”, “perfetti”, non avranno alcun valore. Proprio a causa di tali caratteristiche la vita scolastica è per loro molto faticosa; in ogni fase di apprendimento ritengono di dover imparare tutto il possibile immediatamente, non riuscendo ad accettare la gradualità nell’apprendimento stesso.
Il meccanismo scolastico, basato su regole, verifiche e confronti, sottopone questi ragazzi ad una costante frustrazione delle proprie aspettative, cioè ad una ferita narcisistica; quando ciò accade, sono pervasi da un’angoscia catastrofica, che impedisce loro di pensare e di agire; non solo non riescono ad andare a scuola ma, molto spesso, non riescono ad uscire da casa ed arrivano a patire anche un isolamento sociale, in quanto, temendone il giudizio, non vogliono più frequentare amici e conoscenti. La casa diventa quindi simbolo di protezione, luogo privilegiato in cui rifugiarsi, proprio perché la realtà esterna è diventata inaffrontabile e spaventosa.
Nella mente di tali ragazzi, quando non riescono più a frequentare la scuola ed a mantenere un contatto con il mondo reale, prende il sopravvento una realtà virtuale, falsificata (quella dei film e dei videogiochi), all’interno della quale essi si sentono gratificati e competenti. La realtà alternativa, utilizzata come rifugio contro l’angoscia, era certamente già presente anche prima che si manifestasse la fobia scolare, ma è solo quando i ragazzi non riescono più ad andare a scuola che tale mondo ritirato rischia di trasformarsi nell’unico mondo possibile; la fobia scolare infatti può evolvere, anche se raramente, in una psicosi con dissociazioni e deliri persecutori.
A livello di struttura familiare si tratta normalmente di famiglie in cui si crea un’innaturale riduzione della distanza intergenerazionale, genitori che perdono il loro ruolo presso i figli e figli che tendono a non riconoscere l’autorevolezza dei genitori. Madre e padre tendono a proiettare le proprie esigenze narcisistiche sui figli, diventando critici e, a volte, apertamente aggressivi, quando i figli non raggiungono più i risultati auspicati nelle varie attività intraprese, scuola compresa. L’atteggiamento ambivalente verso i figli, a volte adorati come bambini ideali ed a volte denigrati, non favorisce lo sviluppo di un’autonomia emotiva e di pensiero. Nella maggior parte dei casi i genitori inizialmente “esaltano” il proprio figlio, proprio perché, fin da piccolo, è sempre stato bravo, coscienzioso, educato e intelligente, prestandosi quindi ad essere considerato il “figlio ideale”; successivamente, con la comparsa della fobia scolastica, di bugie per nascondere le difficoltà e di accessi di rabbia, i genitori cadono in uno stato di panico e di confusione che altera completamente gli equilibri familiari.
Per quel che riguarda l’evoluzione del concetto di fobia scolare, notiamo che, mentre la teoria cognitivo-comportamentale ha cercato di approfondirlo e ha messo a punto alcune modalità per un assessment che permetta d’individuarne i fattori scatenanti, il pensiero psicoanalitico si è occupato solo marginalmente di tale disturbo.
Anna Freud è una delle autrici che ha trattato questo argomento (“L’Io e i meccanismi di difesa”, 1936 e “Scritti”, vol. II, 1957). L’autrice ritiene che le fobie siano generate dalla difficoltà a superare l’ambivalenza edipica (amore-odio verso il genitore dello stesso sesso) durante la fase genitale. Uno dei casi che possiamo prendere ad esempio di fobia scolare è quello del “bambino con il berretto” (1936), così definito perché non poteva separarsi da un berretto che gli ricordava il cappello del padre, verso il quale nutriva una grande gelosia: il piccolo paziente, durante una seduta, decide di smettere di colorare un album da disegno proprio quando il confronto con le capacità dell’analista, nell’eseguire il medesimo compito, gli fanno pensare di non avere eseguito una coloritura perfetta; il bambino resta frustrato dal confronto e decide di non competere più con l’analista in modo da evitare il ripetersi della spiacevole sensazione di fallimento. Ugualmente, quando comincia ad andare a scuola egli si rifiuta di partecipare a lezioni nelle quali non si sente sicuro di sé e si ritira dalle attività che possono procurargli quel tipo di dolore. A. Freud ritiene che il bambino soffra di un conflitto edipico irrisolto: ogni qualvolta una persona ha un successo maggiore del proprio, significa che tale persona ha degli organi genitali più grandi dei propri e che quindi gli fa sperimentare nuovamente la cocente gelosia edipica verso il padre. Il meccanismo di difesa della fobia scolare consisterebbe perciò nell’allontanamento del conflitto edipico dalla famiglia e dal suo “spostamento” sulla scuola, un sostituto più accettabile. Il continuo rifiuto delle attività in cui c’è un confronto che può procurare angoscia, limita sempre di più le funzioni dell’Io e ne compromette ampiamente lo sviluppo. L’autrice ritiene che quando l’Io diventa rigido, e utilizza in modo ossessivo la fuga come meccanismo di difesa, si generi un vero e proprio deficit di sviluppo dell’Io.
Più recentemente sono René Diatkine ed Eric Valentin (“Trattato di psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza”, 1985) ad approfondire tale concetto. Essi affermano che le fobie scolari della fine del periodo di latenza e dell’adolescenza pongono problemi di natura totalmente differente rispetto alle fobie infantili in genere; distinguono i ragazzi che ne soffrono da quelli perfettamente scolarizzati, che non sono intenzionati a studiare non avendo alcun interesse per le materie di studio e che per tale motivo disertano la scuola.
Nel caso dei ragazzi con fobia scolare il quadro è molto più complesso e gli autori ne descrivono quattro possibili evoluzioni focalizzando l’attenzione sul fatto che non si tratta mai di un sintomo “fugace o benigno”.
Il primo tipo di evoluzione, quella più grave ma fortunatamente numericamente poco consistente, evolve verso la schizofrenia, manifestando dissociazione e delirio paranoide.
Il secondo tipo di evoluzione analizza degli adolescenti che sembrano essere incapaci di qualsiasi compromesso con i propri desideri: tali ragazzi vengono considerati come psicotici (“caso limite”, “borderline”), ma non presentano dissociazioni o deliri. Gli autori mettono in evidenza una relazione familiare estremamente problematica, preesistente alla comparsa della fobia scolare e da questa esacerbata, caratterizzata da ambivalenza e da messaggi contraddittori sia da parte dei genitori che dei figli; viene evidenziato il fatto che l’adolescente non più capace di andare a scuola, in precedenza aveva solo apparentemente uno sviluppo armonico, ma che ad un esame più attento l’adattamento alla realtà era solo apparente ed erano già presenti angosce importanti. Concludendo il secondo tipo di evoluzione gli autori rimarcano che il ragazzo resta a casa, trovando una nuova organizzazione che non gli crea alcuna inquietudine, ma che diventa un nuovo modo di vivere in funzione del principio di piacere.
Il terzo tipo di evoluzione, quella più diffusa, ha un esordio simile a quella dei precedenti gruppi ma è caratterizzata da adolescenti che vivono un’atmosfera depressiva, esacerbata dal fatto che mal sopportano la propria incapacità di affrontare una vita normale, oltre ad un isolamento sociale parzialmente presente. Secondo Diatkine molti di loro non hanno sperimentato nell’infanzia il piacere del funzionamento mentale legato all’investimento del processo secondario.
Il quarto tipo di evoluzione riguarda un piccolo gruppo di ragazzi, nei quali si constatano fobie scolari organizzate come delle vere e proprie isterie di angoscia.
Bibliografia
Freud A.
1936 Das ich und die abwehrmechanismen, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Vienna (trad. it.: L’io e i meccanismi di difesa, Psycho di G. Martinelli & C., Firenze 1997)
1957 “Child observation and prediction of development: a memorial lecture in honor of Ernst Kris”, in The psychoanalytic study of the child, vol. 13 (trad. it. “Osservazione del bambino e previsione dello sviluppo: conferenza commemorativa in onore di Ernst Kris” in Opere 1945-1964, vol. II, Boringhieri, Torino 1991)
1965 Normality and pathology in childhood: assessments of development, International Universities Press, New York (trad. it. Normalità e patologia del bambino, Feltrinelli, Milano 1996)
Diatkine R., Valentin E.
1985 “Le phobies de l’enfant et quelques autres formes d’anxiété infantile”, in Lebovici S. Diatkine R. Soulé M.(a cura di) Traité de psychiatrie de l’enfant e de l’adolescent, vol. II, Presses Universitaires de France, Paris (trad. it. “Le fobie del bambino e altre forme di ansia infantile”, in Trattato di psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Borla, Roma 1990)
Novembre 2014
Fobie

G. Kieffe, La madre di tutte le fobie - 1923
A cura di Laura Contran
Definizione
Il termine fobia deriva dal greco phóbos – paura – e indica timore irrazionale e incontrollabile di un oggetto o di una situazione sentita come minacciosa in assenza di un reale pericolo.
Dal punto di vista etimologico la paura riferita a un particolare oggetto definisce il sintomo specifico: l’agorafobia significa paura degli spazi aperti, la claustrofobia paura dei luoghi chiusi, la zoofobia paura degli animali, l’eritrofobia paura di arrossire, la rupofobia paura dello sporco (per citarne solo alcune tra le più note). Le fobie hanno inoltre uno stretto legame con il sentimento dell’angoscia e con gli attacchi di panico.
Storia del concetto
La fobia è una nozione prettamente psicoanalitica. Freud ne parla per la prima volta nel 1894 tracciando peraltro una distinzione tra le normali paure, anche se accentuate (del buio, della morte, delle malattie, della solitudine), e le fobie intese come formazioni sintomatologiche.
Le fobie possono presentarsi in forma mutevole o fissa, essere transitorie (come accade di frequente nell’infanzia) o invece croniche, e condizionare in modo più o meno invalidante la vita di una persona a causa delle restrizioni che esse “impongono”.
Vari tipi di fobie o tratti fobici possono inoltre manifestarsi in quadri psicopatologici anche molto diversi tra loro (nevrosi, psicosi, stati limite).
Freud differenzia innanzi tutto le fobie dalle ossessioni (1894b) in quanto queste ultime hanno un carattere compulsivo assente nelle fobie e sono riconducibili a un pensiero o a un ricordo spiacevole o traumatico. Nell’ossessione, infatti, lo stato affettivo è giustificabile in quanto è possibile risalire “all’idea originaria” associata a una condizione emotiva (ansia, dubbio, timore, collera, colpa) ritenuta “intollerabile” per l’Io e che viene quindi sostituita difensivamente da un’altra più compatibile seppure incongrua. Tra le varie osservazioni cliniche riportate da Freud, un caso letterario famoso è quello di Lady Macbeth, celebre personaggio shakespeariano: il rimorso per la sua infedeltà coniugale e la “purezza morale” perduta la costringono a lavarsi continuamente le mani nel tentativo di scacciare il ricordo del suo tradimento.
Un altro elemento fondamentale che contraddistingue la fobia rispetto all’ossessione è il sentimento dell’angoscia.
Nella prima teorizzazione freudiana, infatti, la fobia è la manifestazione psichica più frequente che accompagna l’isteria d’angoscia (1894a) (contrapposta all’isteria di conversione in cui l’angoscia “libera” cioè slegata da una rappresentazione si trasforma in sintomi somatici). Nell’isteria d’angoscia un accumulo di eccitamento o di affetto (libido) legato a una rappresentazione angosciante (“idee incompatibili”) di natura sessuale si sposta su un oggetto o una situazione esterna dando così origine alla fobia che funge da “costruzione protettiva”. Così, ad esempio, l’agorafobia può rappresentare il tentativo di eludere avventure sessuali o “situazioni sessualizzate” nelle quali una persona può cedere ai propri desideri o impulsi. L’Io reagisce come se il pericolo provenisse dall’esterno mentre l’insorgenza dell’angoscia può essere in una certa misura controllata a condizione che vengano attuate le opportune strategie di inibizione e di evitamento.
Dal punto di vista terapeutico Freud sottolinea che può rivelarsi inutile, se non dannoso, tentare di dissuadere o sottrarre qualcuno alla propria fobia senza conoscerne il significato inconscio: la mancanza della funzione protettiva del sintomo lascerebbe la persona senza difese e quindi esposta all’angoscia e al panico.
Freud affronta più approfonditamente lo studio sulla fobia con il Caso del piccolo Hans (1908). Hans, un bambino di cinque anni figlio di Max Graf uno tra i primi allievi di Freud non esce di casa perché ha paura di essere attaccato e morso d un cavallo e teme inoltre che il cavallo possa cadere, farsi male e morire. Nel corso del lavoro analitico, condotto dal padre stesso di Hans con la guida di Freud, emergono i sentimenti di rivalità edipica del bambino “innamorato della madre” nei confronti del padre seppure amato e nel tentativo di “sciogliere questo conflitto”, connotato da sentimenti di ambivalenza, si sviluppa la fobia. Il moto pulsionale che soggiace alla rimozione e che provoca l’angoscia è dunque l’ostilità verso la figura paterna che viene sostituita dall’animale-cavallo, oggetto composito di cui Freud sottolinea la polivalenza semantica.
Con il procedere della sua ricerca meta psicologica, Freud giunge a sostenere che il fine ultimo della rimozione è quello di evitare il dispiacere e laddove questo fallisce, a causa di un eccesso dell’ammontare affettivo, si produce una “formazione sostituiva” atta a fronteggiare “il ritorno del rimosso” che si presta particolarmente a spiegare il meccanismo fobico. Nel 1925 nel suo scritto Inibizione sintomo e angoscia Freud rivede la sua teoria e proprio a partire dal caso del piccolo Hans riformula l’ipotesi iniziale: l’angoscia di castrazione-separazione è un’angoscia esterna che rende pericolosi i sentimenti interni che devono essere rimossi. La fobia di Hans, infatti, si era manifestata in concomitanza con le sue prime curiosità e impulsi sessuali (masturbazione) e con la nascita della sorellina di cui era geloso, eventi che lo ponevano a confronto con la differenza sessuale e con la paura di non essere più l’oggetto privilegiato dell’amore della madre.
Freud tuttavia fa un ulteriore passo nel dare al concetto di castrazione un significato più ampio che permette di risignificare i livelli dell’angoscia (di separazione, di perdita di mancanza) a stadi precedenti le vicende edipiche. Il primo distacco, ricorda Freud, è quello del lattante dal seno materno, vissuto come la perdita di una parte importante del proprio corpo (1908) considerata come propria e che in un secondo momento riguarderà la perdita di altri “oggetti” quali ad esempio le feci nel periodo dell’educazione degli sfinteri. Ma ancor prima, ricorda Freud, è la nascita stessa (il trauma della nascita), in quanto separazione dal corpo materno, il prototipo della castrazione.
Tra gli autori post freudiani, Melanie Klein, pur non avendo trattato in modo specifico il tema della fobia, ha tuttavia dato un contributo fondamentale per la comprensione delle nevrosi infantili e, a posteriori, della psicopatologia nell’età adulta. L’autrice colloca la fobia nell’adulto nel quadro più generale dell’angoscia, concetto centrale che percorre il suo pensiero teorico e che si sviluppa intorno alla teoria delle relazioni oggettuali. Secondo Melanie Klein le fobie sarebbero l’espressione nonché la riattualizzazione di angosce primitive che rimandano a meccanismi difensivi precoci risalenti ai primi stadi dello sviluppo dell’Io immaturo. Come già ricordava lo stesso Freud, l’essere umano alla sua nascita viene a trovarsi in una reale (biologica) condizione di impotenza fisiologica nella quale la sua sopravvivenza dipende dalle cure della madre.
Per Klein, dunque, l’angoscia è l’elemento primordiale che determina in senso anticipatorio le vicende edipiche. L’ambivalenza nei confronti dell’oggetto primario (seno-madre) attraversa le varie fasi dello sviluppo psichico dell’infans in cui si alternano pulsioni d’amore e aggressive a seguito delle gratificazioni-frustrazioni derivanti dal rapporto con l’oggetto. Per Klein la fobia può essere considerata un meccanismo difensivo la cui funzione è quella di evitare una situazione catastrofica per l’Io determinato dall’unione degli aspetti buoni, con quelli cattivi dell’oggetto quando le angosce persecutorie diventano particolarmente intense (Mehler, 1989 ). Alla base delle fobie vi sono sempre angosce persecutorie (che minacciano l’integrità dell’io) e angosce depressive (relative alla paura di danneggiare e quindi di perdere l’oggetto d’amore).
Possiamo affermare che sia per Freud sia per la Klein i processi di internalizzazione ed esternalizzazione costituiscono il punto centrale della fobia, ma mentre Freud evidenzia i meccanismi psichici della sostituzione, dello spostamento, e della deformazione, Klein mette in luce i meccanismo “proiettivi” (e di scissione) che stanno alla base della fobia. Resta comunque che la funzione della fobia è quella di stabilire un confine tra l’interno e l’esterno, di costruire una “barriera psichica” che fa da argine all’angoscia.
Sulla scia di Klein, H. Segal ritiene che lo scopo della fobia è quello di proiettare le fantasie persecutorie e di fissarle in situazioni esterne e quindi evitabili. In un suo lavoro del 1954, descrive il caso di una paziente la cui fobia nei confronti folla e del cibo si manifestava quale reazione a sentimenti di frustrazione nelle relazioni vissuti come vere e proprie minacce di morte e di frammentazione dell’Io.
A partire dalle angosce primitive numerosi autori, (tra cui A. Freud, Winnicott, Fairbain, M. Kahn, Bion, per citarne solo alcuni), seppure con accenti diversi, hanno centrato la loro attenzione sulle prime interazioni del bambino con la madre/ambiente in quanto esperienze fondanti l’organizzazione psichica.
In particolare Winnicott sostiene che un ambiente sufficientemente supportivo e responsivo, in grado di contenere le angosce del bambino, favorirà in lui quella graduale autonomia che gli consentirà, nel tempo, di affrontare le separazioni, di esplorare il mondo, e di creare nuovi legami affettivi. L’acquisizione di queste sicurezze di base permetterà la nascita di quella che Winnicott ha definito “la capacità di stare da soli” (che implica la capacità di simbolizzare l’assenza dell’altro), che si può consolidare grazie all’interiorizzazione delle funzioni genitoriali e al graduale sviluppo dei processi di mentalizzazione di esperienze e sensazioni corporee.
Seguendo questo filone di pensiero molte ricerche psicoanalitiche hanno dedicato studi approfonditi su due tipi particolari di fobie entrambe in rapporto allo spazio – l’agora-claustrofobia – che si caratterizzano per una compromissione delle sensazioni corporee di fronte allo spazio esterno. Tra i numerosi autori va segnalato lo psicoanalista E. Weiss (1966) il quale si è dedicato per cinquant’anni allo studio della sindrome agorafobica.
Rispetto al significato dato originariamente all’agorafobia, come abbiamo precedentemente visto, questi importanti contributi ne hanno ampliato la lettura in termini teorico-clinici. Occorre però sottolineare che già Freud, a proposito della complessità della realtà psichica, nel 1938 scrive che “lo spazio può essere la proiezione dell’estensione dell’apparato psichico […]. La psiche è estesa di ciò non sa nulla”.
La paura di affrontare gli spazi aperti o i luoghi chiusi può manifestarsi con crisi di panico accompagnate da sintomi somatici con sensazioni di vertigini o di svenimento, fino ad arrivare a sentimenti di depersonalizzazione. Ne conseguono una serie in inibizioni motorie, di misurazioni degli spazi percorribili, di tragitti e mezzi di trasporto consentiti o la necessità, per fronteggiare la forte angoscia, di non essere soli, di avere accanto “un compagno fidato”, così definito dalla psicoanalista Helen Deutsch, che verrebbe a compensare il senso del vuoto d’essere o la labilità dei confini dell’Io.
Le fobie dello spazio assumono forme e gravità diverse in base alle angosce sottostanti, a seconda che esse siano più primitive (angosce di sopravvivenza) o invece più evolute quando riguardano la conflittualità nelle relazioni investite affettivamente: desiderio/incapacità di separazione oppure, nel caso di reazioni claustrofobiche, fuga dai rapporti vissuti come soffocanti o pericolosi.
BIBLIOGRAFIA
Amati Mehler J. (1989), Fobie in Trattato di psicoanalisi a cura di A. Semi – Vol. II. Raffaello Cortina Editore.
Deutsch H. Alcune forme di disturbo emozionale e la loro relazione con la schizofrenia. In AA.VV. Il sentimento assente, Boringhieri, 1992.
Freud S. (1894a), Le neuro psicosi di difesa, OSF, 2, Boringhieri.
Freud S. (1894b), Ossessioni e fobie, OSF, 2, Boringhieri.
Freud S. (1908), Analisi della fobia di un bambino di cinque anni. (Caso del piccolo Hans), OSF., 5, Boringhieri.
Freud S. (1915), Metapsicologia, OSF, 8. Boringhieri.
Freud S. (1925), Inibizione, sintomo, angoscia, OSF, 10. Boringhieri.
Freud S. (1938). Risultati, idee, problemi, O.S.F., 11. Boringhieri.
Klein M. (1952), Scritti 1921-1958, Boringhieri.
Segal H. (1954), I meccanismi schizoidi che sottostanno alla formazione delle fobie in Scritti psicoanalitici, Astrolabio 1984.
Ewiss E. (1966), La formulazione psicodinamica dell’agorafobia, in Riv. Psicoanalisi, 12.
Winnicott (1960), Sviluppo affettivo e ambiente. Studi sulla teoria dello sviluppo affettivo, Armando, 2004.
Fobie infantili
A cura di Laura Colombi
Definizione
Possiamo definire in senso generale le fobie come paure divoranti nei riguardi di oggetti o situazioni che non motivano razionalmente tale paura.
Per quanto possano sembrare imparentate con le normali paure, le fobie sono di natura differente perché, a differenza di queste ultime, non scompaiono di fronte a una verifica della realtà. Le fobie sono manifestazioni – transitorie o radicate più profondamente- di uno stato di angosciabilità che fa sì che la fantasia carichi di pericolosità oggetti/situazioni che di per sé non dovrebbero provocare timore. L’adulto che soffre di fobie, ancor più del bambino, è consapevole dell’irrazionalità dei suoi timori, che tuttavia non riesce a risolvere.
Da questa premessa possiamo capire perché occupandoci di come vengono inquadrate le fobie infantili nella teoria psicoanalitica, sia necessario ancorare l’argomento al carattere dinamico dello sviluppo. Infatti, poiché nel bambino l’Io (struttura deputata al contatto e ai rapporti con la realtà interna-soggettiva ed esterna-oggettiva) non è ancora consolidato e la fantasia infantile ha una sua specifica qualità (fluida, fervida e potente), paure e angosce sono stati emotivi frequenti nell’infanzia, e ciò rende sottile la linea di demarcazione tra le ‘normali’ paure del bambino e quelle che si connotano come fobie.
Paure marcate per animali, insetti, rumori improvvisi e violenti, il buio, gli estranei, sono esperienze diffuse e fisiologicamente compatibili con lo sviluppo psicologico, ma nella maggioranza dei casi esse tendono a risolversi spontaneamente con la crescita, ripresentandosi –se mai- solo in brevi momenti collegabili a specifici fattori di per sé traumatici o a eventi che si verificano in fasi critiche dello sviluppo.
In certe situazioni tuttavia queste paure possono configurarsi, sia per durata nel tempo, che per intensità, complessità e/o connessione con uno stato d’angoscia marcato e diffuso, come un vero e proprio segnale di una sofferenza psicologica che può pregiudicare la qualità della vita emotiva e relazionale del bambino, interferendo con il fisiologico sviluppo psichico. Di questo parliamo quando parliamo di fobie infantili.
L’approccio psicoanalitico al quadro fobico nell’infanzia.
Pur all’interno di un comune riferimento teorico legato al carattere inconscio di dinamiche psichiche fondanti la personalità, in psicoanalisi si sono sviluppati modelli differenti che, partendo da quadri clinici diversi, hanno arricchito la teoria di prospettive e approcci terapeutici differenti.
Un punto che accomuna i diversi approcci è l’origine infantile della sofferenza psichica e, per questo, la psicoanalisi attribuisce molta importanza alla messa a fuoco dei fattori che possono favorire o interferire con lo sviluppo psicologico del bambino .
Pur dando un peso diverso ai fattori soggettivi e/o ambientali nel determinare lo sviluppo (nella direzione di una sempre maggior riconoscimento del peso dell’ambiente sullo sviluppo), tutti i modelli considerano l’eccesso di angoscia come fattore centrale del disagio psichico e, poiché le fobie sono manifestazioni dell’angoscia, è dunque importante focalizzare l’argomento collegandolo alla specificità dei diversi concetti di sviluppo e di angoscia a cui si riferiscono i principali modelli teorici.
Freud.
La prima descrizione psicoanalitica di fobia infantile è dello stesso Freud che, pur non essendosi mai occupato direttamente di clinica infantile, ebbe modo di conoscere, attraverso il resoconto dettagliato del padre, un caso di fobia per i cavalli sviluppatasi improvvisamente in un bambino di 5 anni. Questo caso fu di grande rilevanza per Freud, poiché gli consentiva di “vedere” dal vivo le teorie sullo sviluppo, sulla sessualità infantile, sulle fantasie inconsce, sull’Edipo e sull’angoscia che erano state, fino allora, inferite dalle analisi degli adulti.
In “Analisi di una fobia in un bambino di 5 anni”, meglio conosciuto come “Caso Clinico del piccolo Hans” (1908), Freud ha l’occasione di osservare da vicino le dinamiche sottostanti allo scatenarsi delle fobie nel bambino e ciò gli consente di specificare meglio la genesi e il significato di quella che chiamerà “nevrosi fobica” che inquadra come un possibile esito dell’isteria d’angoscia (da lui considerata la “nevrosi dell’età infantile), poiché rappresenta un tentativo che il bambino fa di liberarsi dall’angoscia “legandola” ad un oggetto specifico. Il caso di Hans permise a Freud di osservare come la fobia segnalava una difficoltà nel fisiologico superamento del complesso edipico ed era un sistema difensivo dall’angoscia di castrazione che deriva dagli impulsi e le fantasie edipiche che si attivano nella fase genitale (3/5 anni). Queste fantasie, per il loro carattere aggressivo e/o sessuale (odio-ostilità per il genitore dello stesso sesso e amore per quello di sesso opposto), sono incompatibili con la coscienza infantile, attivano un “conflitto” e vengono per ciò rimosse, proiettate all’esterno e – nel caso della nevrosi fobica- spostate su un oggetto più controllabile (sistema difensivo).
Freud ricostruì come, apparentemente, il bambino non voleva uscire da casa per il timore di essere morso da un cavallo, ma, in realtà, questa paura sottintendeva un conflitto inconscio tra le sue pulsioni ostili nei confronti del padre e le esigenze dell’Io che disapprovavano sia questa ostilità che le pretese istintuali nei confronti della madre. In sostanza: il conflitto edipico irrisolto di Hans gli faceva vivere un’intensa angoscia di castrazione che non si manifestava come tale, ma, appunto, per effetto della rimozione della sua psicodinamica interna, come fobia di essere morso dai cavalli.
Freud fu il primo a intuire l’importanza delle dinamiche infantili nello sviluppo normale o patologico ma è con Anna Freud e Melanie Klein che nasce la psicoanalisi infantile e il conseguente studio sistematico dei diversi quadri clinici nell’infanzia.
Anna Freud attribuisce particolare risalto all’importanza per lo sviluppo psicologico dell’ equilibrio che l’Io, nelle varie fasi della crescita, riesce a raggiungere tra le differenti esigenze dell’ambiente, dell’Es (istanza istintuale) e del Superio ( istanza morale). Anche nel normale sviluppo il bambino ha, infatti, a che fare continuamente con conflitti e il buon uso dei meccanismi di difesa psicologici più idonei a quella “fase evolutiva”, insieme al ruolo dei genitori reali, è essenziale a mitigare la violenza dell’angoscia e a superare le varie tappe (1936). Dall’infanzia all’adolescenza A. Freud individua 8 fasi evolutive e colloca nella quinta fase (edipica) la matrice di un possibile sviluppo di carattere fobico. Come per il padre anche per lei le fobie appartengono a un disturbo della fase genitale, quando il bambino non è più piccolissimo e hanno le loro radici nella difficoltà a superare l’ambivalenza edipica (attorno ai 4/6 anni) caratteristica di questa fase. Sono il tentativo di controllare l’angoscia attraverso uno spostamento del conflitto in un terreno più ‘neutro’. A. Freud individua per esempio la fobia della scuola – non rara nei bambini – come collegabile ad un conflitto edipico irrisolto che trova una sua ‘soluzione’ nel venir allontanato e trasferito dalla famiglia alla scuola, dove l’angoscia può meglio essere più decantata e razionalizzata spostandosi su compagni, insegnanti e prove scolastiche (1957).
Melanie Klein
Pur partendo dal modello freudiano sviluppò in seguito un proprio approccio di grande rilievo per la comprensione dell’origine di quegli stati di sofferenza psichica che derivavano dalle primissime fasi dello sviluppo.
Lavorando con bambini piccoli introdusse nella tecnica analitica materiale di gioco che le permise di osservare le dinamiche psicologiche interne più precoci in azione. L’esperienza clinica la portò ad affermare la presenza di un Io presente fin dalla nascita, capace di percepire angoscia e di difendersi (contrariamente all’ipotesi freudiana di un costituirsi dell’Io nel corso della crescita). In questo modello l’angoscia diviene un fatto “primario”, che s’innesca fin dagli albori della vita. Tra le angosce primarie la più terribile è l’angoscia di “annientamento”-morte , da cui il bambino si difende attraverso la proiezione di propri impulsi aggressivi su un oggetto esterno (il primo: il seno), oggetto che si tinge di minacciosità. Queste prime dinamiche di proiezioni/introiezioni, legate ai cicli vitali di soddisfacimento-mancanza/dolore, sono connotate da una violenta persecutorietà che caratterizza quell’ insieme di angosce e difese che Klein chiama “posizione schizoparanoide”. Solo quando l’intensità dell’angoscia diminuisce l’Io, più maturo, riesce a percepire e riconoscere che l’ “oggetto”(seno) che soddisfa (oggetto buono) e quello che lo fa attendere (oggetto cattivo) sono un’unica cosa. Nello sviluppo si ha allora accesso alla “posizione depressiva”, in cui al senso di minaccia per l’Io subentra il senso di minaccia/preoccupazione per l’oggetto d’amore (madre-seno) che proviene dai persecutori interni: angoscia depressiva. Il successo di un buon sviluppo è quindi concepito dalla Klein come legato alla possibilità di superare la violenza delle angosce schizoparanoidi e la colpa/struggimento per la perdita/ separazione dall’oggetto buono esterno. Da questa necessaria premessa, si comprende che per la Klein le fobie sono manifestazioni di problematiche molto precoci legate ad angosce persecutorie e depressive.
Nelle sue parole: “ Una caratteristica della nevrosi infantile è costituita delle prime fobie, che appaiono inizialmente nel corso del primo anno di vita e, cambiando forma e contenuto, si presentano e ripresentano durante tutti gli anni dell’infanzia. Alla base delle prime fobie, che comportano difficoltà di alimentazione, pavor nocturnus, angoscia per l’assenza della madre, paura degli estranei, disturbo del rapporto con i genitori e delle relazioni oggettuali in genere, vi sono sempre angosce persecutorie e depressive. Il bisogno di esteriorizzare gli oggetti persecutori costituisce un elemento intrinseco del meccanismo delle fobie e questo bisogno nasce sia dall’angoscia persecutoria (relativa all’Io) sia da quella depressiva relativa alla minaccia dei pericoli per gli oggetti interni che provengono dai persecutori interni”(1952).
D.W. Winnicott
Come la Klein, anche Winnicott sposta l’attenzione della sua ricerca sulle angosce più precoci e primitive, ponendo però maggiormente l’accento sul ruolo cruciale della risposta dell’ambiente. Pediatra e in seguito psicoanalista ha l’opportunità di riflettere a fondo sullo sviluppo nei primi mesi di vita del bambino e sul rapporto speciale che lo lega alla madre in un percorso caratterizzato dal progressivo incontro con la realtà in modo autonomo e indipendente. In questo graduale percorso compito della madre è quello di offrire gli strumenti necessari per supportare la naturale progressione all’autonomia e allo sviluppo del Sé personale del bimbo. Per Winnicott alla nascita il bambino non esiste come individuo, ma all’interno di una diade madre-bambino e il corretto sviluppo deriva da una madre/ambiente capace di holding (sostegno), cioè di offrire quelle specifiche cure fisiche ed emotive necessarie al bambino per progredire da stati di non integrazione a esperienze di sempre maggiore senso di “unità” ed integrità della propria personale continuità dell’essere. Le fobie del bambino mettono dunque in scena primissime angosce derivate dall’assenza di holding, di contenimento e si realizzano in diverse fenomenologie tra cui la paura di precipitare (fobia del vuoto) o di andare a pezzi ( fobie di animali o altro che si tingono di persecutorietà)(1958).
Bibliografia
Freud Anna (1936) “L’Io e i meccanismi di difesa”Giunti Editore, 2012.
Freud Anna (1957). “Osservazione del bambino e previsione dello sviluppo”.in Anna Freud, Opere, Vol. 2,Boringhieri,1979.
Freud Sigmund (1908) “Analisi della fobia di un bambino di cinque anni (Caso del Piccolo Hans)”, in Freud, Opere,Boringhieri, 1972.
Klein Melanie (1952) “Alcune conclusioni teoriche sulla vita emotiva del Bambino nella prima infanzia” in Scritti,Bollati Boringhieri,1978.
Winnicott Donald W. (1958) Dalla pediatria alla Psicoanalisi, Martinelli 1975.
Fornari Franco

Franco Fornari
Maestri della Psicoanalisi
Fornari Franco
A cura di Lidia Leonelli Langer
Foto d’archivio
…io amo la vita proprio come i suoi significati.
… ciò che mi appassiona
è scoprire gli inesauribili significati della vita. (1)
Franco Fornari (Niviano di Rivergaro, 1921-Milano, 1985)
Verso una nuova psicoanalisi.
NOTE INTRODUTTIVE
Medico, neuropsichiatra, psicoanalista con funzioni di training della SPI e dell’IPA, Presidente della Società Psicoanalitica Italiana (1974-78), ricercatore, scrittore e divulgatore, Franco Fornari ha vissuto immerso nella storia, nella piccola storia personale, relazionale, familiare, in quella culturale, sociale, politica, e nella grande storia mondiale, e su di essa si è costantemente interrogato.
Considerava la psicoanalisi una scienza riparativa (2), dotata di modalità scientifiche di comprensione della drammaticità della vita, ed era convinto che essa potesse costituire uno strumento potente per comprendere la natura umana in tutte le sue manifestazioni e per favorire lo sviluppo della convivenza e il superamento dei conflitti.
La sua teorizzazione è tesa ad una psicoanalisi oltre le contrapposizioni, in funzione della ricomposizione dei contrari. Corpo-mente, biologico-psichico, ragione-affetti, innato-appreso, mondo interno-mondo esterno, istinto di vita-istinto di morte, natura-cultura risultano intrecciati in un continuum inscindibile.
Il suo stile di fare clinica è segnato dalla convinzione che fare l’analisi rappresenti un’esperienza privilegiata di libertà (2) e di conoscenza per l’analista e per l’analizzando, entrambi affettivamente coinvolti nel dispiegarsi del transfert e del controtransfert.
Il suo contributo originale alla ricerca psicoanalitica, radicato nel clima del dopoguerra, è nato e si è sviluppato anche come risposta al trauma inferto all’umanità intera dalla seconda guerra mondiale e dall’esplosione atomica, che lo ha posto di fronte alla pressante domanda sulla natura dell’uomo e sull’origine del male. A partire da lì, il suo pensiero si è sviluppato in varie direzioni e in teorizzazioni complesse e articolate, esposte in numerosi libri e numerosissimi lavori. E, proprio perché radicato nel fluire dell’esperienza storica, è stato un pensiero in continuo divenire, pronto a trasformarsi e a concretizzarsi nell’azione.
Nei suoi scritti, dal primo del 1955 a quelli cui stava lavorando al momento della sua morte nel 1985, pubblicati postumi nel 2005 sulla Rivista di Psicoanalisi (3), si vede come i temi siano in fondo sempre gli stessi e come siano andati sviluppandosi nell’arco di trenta anni, in una continua riflessione sull’origine della vita psichica, sulla psicosi e sulla guerra.
E’ però l’ultima teorizzazione, punto d’arrivo di un’intera vita di ricerca, che dà un senso nuovo e unitario a tutte le precedenti. In essa Fornari individua la vita intrauterina ed il parto-nascita come fantasmi originari e chiave di lettura per accostarsi alla comprensione dei vari aspetti della vita psichica individuale e collettiva.
LA VITA E L’OPERA
Poiché Fornari traeva spunto di riflessione dagli eventi, nei suoi scritti troviamo tracce della sua vita, usate come esempi e metafore. Attraverso le sue opere quindi, conosciamo l’autore e apprendiamo qualcosa della sua vita. In esse troviamo infatti l’infanzia come nono di dieci figli, la campagna e la natura , la vita e la cultura contadina, il lavoro dei campi, la buona cucina, l’affresco di San Giorgio e il drago. Troviamo anche le discussioni con insegnanti e studenti, l’istituzione psicoanalitica, i nervosismi nel traffico, l’affetto di nonno.
Dal racconto della figlia Gigliola Fornari Spoto (4), possiamo avere anche qualche quadro della vita nella famiglia fondata con Bianca.
Bianca Fornari, psicoanalista SPI e IPA, è stata moglie, compagna di tutta la vita e madre dei suoi cinque figli, tra i quali Gigliola e Silvia, a loro volta psicoanaliste. Bianca ha sempre condiviso e discusso con Franco, fin da quando erano ragazzi, i pensieri che gli si affacciavano, e ha letto e corretto i suoi scritti, fino agli ultimi giorni. Le opere di Fornari portano traccia della presenza e del pensiero di Bianca, ma una in particolare, “Psicoanalisi e Ricerca letteraria” (1974) è frutto della loro feconda collaborazione e del reciproco innesto. In essa si coglie dal vivo la comune passione per la letteratura, per l’insegnamento e per la trasmissione dell’amore per il bello, oltre alla convinzione condivisa della necessità di trasformare l’educazione sessuale in educazione agli affetti. Ritroveremo l’evoluzione dell’interesse di Fornari per la letteratura, la musica e l’arte in “Coinema e icona” (1979), “Psicoanalisi della musica” (1984), “Carmen adorata” (1985).
Tra la prima e la seconda parte della vita di Fornari, sta la guerra con l’esplosione atomica.
Il romanzo giovanile “Angelo a capofitto”, pubblicato solo nel 1969, che contiene in nuce il suo pensiero e la sua teorizzazione futura, è una riflessione sui mali del mondo, visti attraverso il disperato tentativo di un giovane di riparare individualmente i disastri compiuti dalla follia collettiva.
Da quando Franco Fornari, portandosi nel cuore il suo paese, si spostò dal piacentino a Milano per gli studi universitari, fu sempre legato a Milano e alla sua Università, in cui rimase fino alla morte. Fu il primo allievo di Cesare Musatti , del quale , studente di medicina, seguì nel 1946 il primo corso di psicologia tenuto presso l’Università degli Sudi di Milano. Con lui discusse la tesi di laurea nel 1947 e da lui fu poi analizzato, divenendo membro della SPI e dell’IPA.
Nel 1962 ottenne la libera docenza in psicologia dell’età evolutiva ed insegnò nelle scuole di Specializzazione in Psicologia e in Psichiatria. Fu assistente di Musatti presso l’Istituto di Psicologia della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Statale da lui diretto e nel 1972 gli subentrò nella direzione di quello stesso Istituto.
Nel 1968, ebbe l’incarico di Psicologia Generale e Dinamica presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento, dove venne anche contestato in modo molto acceso dagli studenti, come del resto successe anche quando, dopo questo breve ed intenso intermezzo, tornò all’Università di Milano. Qui la contestazione era in parte innescata dalle sue posizioni sulla sessualità, poi illustrate in “Genitalità e cultura” (1975), che additavano il superamento della pregenitalità in funzione di una sessualità genitale, basata sul reciproco riconoscimento.
Alla scuola rigorosamente freudiana di Musatti, da cui aveva ereditato la convinzione della necessità di inserire formalmente la psicoanalisi nell’insegnamento universitario, Fornari aveva imparato ad avvicinare la psicoanalisi anche con la mentalità del filosofo e dello sperimentalista oltre che del clinico e ad applicarne il metodo nello studio dei fenomeni sociali e politici. Aveva imparato a confrontarsi con le altre discipline, a pensare liberamente e ad esprimere con coerenza e coraggio le proprie convinzioni, anche quando controcorrente.
Fornari era convinto che fosse necessario e possibile insegnare in Università i fondamenti della psicoanalisi. Come Presidente della SPI, cercava di convincere di questo i suoi colleghi psicoanalisti. Pensava ad un Polipsichico, un centro clinico un po’ sul modello del Policlinico, all’interno del quale fosse possibile per gli studenti interessati, imparare a mettere in pratica la competenza psicoanalitica. Non sappiamo se ce l’avrebbe fatta a realizzare questo sogno, non sempre compreso, se fosse rimasto più a lungo tra noi.
A PARTIRE DAL PENSIERO DI FREUD E DELLA KLEIN (1955-1970)
Fornari introdusse in Italia il pensiero di Melanie Klein, partendo dal quale portò avanti la sua prima ricerca sull’origine della vita psichica, sulla psicosi e sul fenomeno guerra.
In un confronto continuo e serrato con il pensiero freudiano e con il dibattito innescato dalle discussioni controverse con Anna Freud, contribuì alla diffusione della cultura psicoanalitica in Italia e all’estero, attraverso numerosi articoli e libri tradotti in varie lingue, in cui si preannuncia già lo sviluppo del suo pensiero originale.
Ne “La vita affettiva originaria del bambino” (1963), Fornari ipotizza che nel bambino ci sia da subito intenzionalità relazionale, tesa a “presentificare” nel mondo esterno, attraverso l’incontro con la madre, “la presenza buona originaria”. Da qui arriverà alla teorizzazione della vita intrauterina come fantasma originario.
Nel libro “Nuovi orientamenti della psicoanalisi” (1966), tra i molti altri argomenti, afferma che l’essere umano è fin da subito “soggetto” non “oggetto” di tendenze contrastanti e generatrici di angoscia, e ipotizza la presenza fin da subito di un Io che necessita della capacità di identificazione da parte della madre, per sviluppare la conoscenza e la capacità di vivere.
Sono quindi prefigurati il superamento della teoria degli istinti di vita e di morte, la presenza alla nascita di una competenza innata relazionale, affettiva e cognitiva tesa alla vita, la necessità della risposta relazionale perché questa competenza si sviluppi.
E’ soprattutto la riflessione sul fenomeno guerra nel periodo dell’era atomica, contenuta in alcuni libri, tra cui “Psicoanalisi della guerra atomica” del 1964 e “Psicoanalisi della guerra” del 1966 che, in questo periodo, fa conoscere Fornari in Europa e nel mondo (5).
Con le sue ricerche Fornari contribuì alla nascita in Italia di un vero e proprio movimento di impegno per la pace che si concretizzò nel 1965 nel Gruppo anti-H e nell’1967 nell’Istituto italiano di polemologia. Il suo impegno lo portò anche, alla fine degli anni sessanta, a partecipare alla conferenza dell’ONU sulla pace a New York e a diventare membro del comitato mondiale di ricerca sulla pace. La visione della guerra, qui vista come esportazione paranoica del lutto, evolverà attraverso l’introduzione della teoria dei codici affettivi e della paranoia primaria (6).
DA UNA NUOVA VISIONE DELL’INCONSCIO A UNA NUOVA PSICOANALISI (1970-1985)
A partire dagli anni settanta, Fornari diede impulso ad una intensa attività di ricerca scientifica in ambito clinico, istituzionale e sociale, che lo portò a sviluppare il suo pensiero originale, attraverso lo studio sui sogni in gravidanza, sulla simbolizzazione, sul linguaggio, sulle scelte decisionali, sull’ideologia. Attraverso tappe successive quali quella della teoria psicoanalitica del linguaggio, della teoria coinemica, della teoria dei codici affettivi, ha così preso forma una visione innovativa dell’inconscio, illustrata in “La lezione freudiana” (1983).
Si tratta di un inconscio funzionale alla vita, dotato di competenza conoscitiva e decisionale innata, dominato dalla tensione a conoscere e a dare significato al mondo, per abitarlo. E’ un inconscio sempre presente e all’opera, che sottende e motiva ogni manifestazione umana in funzione della sopravvivenza. Questa visione pone le basi per una teoria psicoanalitica del processo decisionale, attraverso la quale è possibile leggere il declinarsi delle scelte di vita individuali, istituzionali, sociali e politiche come tentativi di garantire la sopravvivenza del singolo e della specie. Fornari la applicò nelle istituzioni, come descrisse ne “Il Minotauro” (1977) e in “Psicoanalisi in ospedale” (1985) e, poco prima della morte, contribuì a fondare il Minotauro, Istituto di Analisi dei Codici Affettivi, il cui primo obiettivo era proprio quello di applicare lo strumento dell’analisi di codice in ambito istituzionale.
Sulla base di questa nuova teorizzazione vengono letti in modo nuovo anche i conflitti e le vicende che portano alla guerra, come radicalizzazioni ideologiche di scelte, che diventano pericolose nel loro porsi come assolute. Le ipotesi sull’origine del male e della guerra mutano infatti con l’introduzione della teoria di codice, secondo la quale il male può originare da un eccesso di bene, dall’ assolutizzazione a fin di bene di una posizione, dal desiderio di difendere a qualsiasi costo il proprio ideale vissuto come bambino indifeso. E raggiungono la forma più complessa e compiuta attraverso l’ultima formulazione teorica, quella sul parto-nascita come fulcro della vita psichica.
NASCITA E VITA INTRAUTERINA
DALL’ELABORAZIONE PARANOICA DEL LUTTO ALLA PARANOIA PRIMARIA
Proseguendo nella ricerca iniziata molti anni prima sui sogni delle madri in gravidanza e sulle vicissitudini legate al parto, e portandola alle estreme conseguenze, Fornari arriva a formulare, negli ultimi anni di vita, la parte del suo pensiero che diventerà il fulcro di tutta la sua teorizzazione precedente. Si tratta dell’individuazione della vita intrauterina e della nascita come fantasmi originari, da cui prende avvio, attraverso un continuo movimento di transfert, ogni conoscenza e ogni azione nel mondo (7).
Sulla scena del parto nascita incontriamo la violenza originaria e la cesura originaria, di cui la funzione paterna separante e simbolizzante si fa carico, dandole un senso e additandola come necessaria e funzionale alla vita stessa. E’ questa la paranoia primaria, figura esplicativa originale di grande portata, solo attraverso il cui buon funzionamento, può venire accettata la morte insita nella vita stessa, fin dal suo inizio, e può quindi essere superato il bisogno di esportarla all’esterno(8).
Da questa nuova prospettiva, unita al nuovo modo di intendere l’inconscio ipotizzato dalle teorie coinemica e dei codici affettivi, deriva una revisione radicale della teoria psicoanalitica, che Fornari stava sistematizzando nel “Trattato di Psicoanalisi”, a cui stava lavorando al momento della morte e di cui sono stati pubblicati due capitoli (3).
OLTRE LA STANZA D’ANALISI
Franco Fornari è stato fin da subito presente ed attivo come psicoanalista anche nelle istituzioni, di cui ha studiato la dimensione affettiva, traendone le sue teorizzazioni. Nelle istituzioni non ha mai lavorato da solo, ma ha sempre contato sull’aiuto di collaboratori, compagni di strada nel suo fare ricerca. Ha svolto, nella società civile, un intenso lavoro di divulgazione fatto di conferenze, dibattiti pubblici, articoli e interventi su riviste e quotidiani, e ha partecipato attivamente, come abbiamo visto, al movimento per la pace.
Nel corso della sua vita ha teorizzato e praticato
– una psicoanalisi clinica intesa come esperienza radicale e privilegiata di conoscenza e di libertà, che si dispiega tra analista e analizzando attraverso il coinvolgimento affettivo del transfert e del controtransfert
– una psicoanalisi delle decisioni affettive individuali, particolarmente adatta nei momenti di passaggio
– una psicoanalisi delle decisioni affettive collettive, che favorisca una convivenza di pace
– una psicoanalisi capace di usare molteplici strumenti di contatto e di comunicazione per risvegliare il buon funzionamento gruppale e istituzionale
– una psicoanalisi in continuo dialogo con le altre scienze, con la cultura e con ogni componente sociale
– una psicoanalisi “pedagogica” tesa ad innescare momenti trasformativi in molti ambiti, dai più quotidiani e vicini, ai più lontani, fino alle Nazioni Unite
– una psicoanalisi “oltre il divano”, usata anche per comprendere la vita e la cultura umana nel suo vario manifestarsi, attraverso la lettura delle ideologie che ispirano i fenomeni culturali, istituzionali, sociali e politici, i conflitti e le guerre.
Le sue intuizioni sullo sviluppo della vita psichica sono confermate dagli studi più recenti.
La sua lettura della vita istituzionale è oggi particolarmente attuale e utile.
Il suo impegno civile costituisce un esempio.
Autore di moltissimi scritti, ha pubblicato i seguenti libri:
La vita affettiva originaria del bambino (Feltrinelli, 1963); Psicoanalisi della guerra atomica (Feltrinelli, 1964); Psicoanalisi della guerra (Feltrinelli, 1966), Nuovi orientamenti nella psicoanalisi (Feltrinelli, 1966); Angelo a capofitto (Rizzoli,1969), Psicoanalisi e ricerca letteraria (Principato, 1973, scritto con la moglie Bianca Fornari), Genitalità e cultura (Feltrinelli, 1975), Simbolo e codice (Feltrinelli, 1976), Il Minotauro (Rizzoli,1977); I fondamenti di una teoria psicoanalitica del linguaggio (Boringhieri,1979), Coinema e icona (Il Saggiatore, 1979), Il codice vivente (Boringhieri,1981), La malattia dell’Europa (Feltrinelli, 1981), La lezione freudiana (Feltrinelli,1983), La Riscoperta dell’anima (Laterza,1984) , Psicoanalisi della musica (Longanesi, 1984), Psicoanalisi in ospedale (Raffaello Cortina,1985, in coll. con L.Frontori e C.Riva Crugnola), Carmen adorata (Longanesi,1985), Affetti e cancro (Raffaello Cortina,1985).
Inoltre:
F.Fornari (1985) La nascita psichica. In Rivista di Psicoanalisi, 2005, LI,1,pp 181-190
F. Fornari, (1985) Il sogno durante la poppata e il transfert onirico. In Rivista di Psicoanalisi, 2005, LI,1 190-199
La bibliografia estesa si può trovare in Rivista di Psicoanalisi, 1986, XXXII,1, pp. 59-71
Note.
1.Faccia a faccia con uno psicoanalista. Intervista a F. Fornari di G.Minoli. In AAVV. La vicenda uomo tra coscienza e computer. Cittadella, Assisi, 1984
2.Cfr. F. Fornari, (1966) Nuovi Orientamenti della Psicoanalisi. Introduzione alla 2° edizione, Feltrinelli, Milano, 1970
3.Si tratta di due capitoli del Trattato di Psicoanalisi cui stava lavorando nel 1985: F.Fornari, La nascita psichica; F. Fornari, Il sogno durante la poppata e il transfert onirico pubblicati sulla Rivista di Psicoanalisi, 2005, LI,1 pp.181-190 e190-199
4.G. Fornari Spoto. Affetti e pensieri. In Conflitti affetti, cultura Franco Fornari 2005. Quaderni del Centro Milanese di Psicoanalisi, Milano 2007
5.Cfr. F.Fornari (1964) La psicoanalisi della guerra. Riduzione all’inconscio del fenomeno guerra e responsabilità individuali della guerra. Rivista di Psicoanalisi, 2005, LI,1 pp. 99-178
6.Cfr. L. Leonelli Langer Note per una rilettura del pensiero di F.Fornari sulla guerra. In Dossier Guerra. Spiweb, 2014
7.Cfr. F. Fornari La riscoperta dell’anima. Laterza, Bari, 1984
8.Cfr. F. Fornari. (1981) Il codice vivente. Bollati Boringhieri, Torino 2001
Funzione paterna
A cura di Giuseppe Pellizzari
In estrema sintesi la funzione paterna consiste nell’interdizione dell’incesto e nell’introduzione della legge che, ponendo un limite all’anarchia delle pulsioni, consente loro di acquistare una forma evolutiva e di accedere al pensiero. Per incesto è da intendersi qui una con-fusione indifferenziata tra sessi e generazioni alla quale si contrappone la legge paterna come limite generativo.
L’interdizione dell’incesto, ma anche contemporaneamente la protezione dall’incesto come rischio di una regressione mortifera, instaura la struttura edipica, cioè fonda la conflittualità tra sessi e generazioni secondo un vettore di sviluppo che consente una evoluzione, una crescita, un apprendimento dall’esperienza altrimenti impossibile. La funzione paterna è dunque garante della civiltà, sia nel microcosmo familiare, sia nella società.
La parola “allevamento” indica il gesto col quale il padre sollevava il piccolo nato verso il cielo staccandolo dalla terra. In molti miti dell’origine in principio vi è uno stato caotico, dove tutto è indifferenziato, privo di forma. L’atto che dà inizio al “cosmo”, contrapposto al “caos”, consiste in una separazione: la luce dalle tenebre, la terra dal cielo, le acque dalla terraferma, via via fino alle diverse specie viventi, al maschile e al femminile. Il principio generativo è dunque rappresentato dalla rottura di una continuità. La proibizione dell’incesto è da intendersi come l’introduzione di tale discontinuità, che separa il bambino dalla madre, che rompe la loro fusione e in questo modo fa sì che la madre sia madre e il bambino sia bambino e non un’unica cosa. Dà inizio alla relazione. Perché ci sia relazione infatti occorre ci siano due reciprocamente “altri”.
La funzione paterna è ciò che rende fecondo il materno proprio attraverso il limite che separa. Il fallo maschile è divenuto il simbolo di tale funzione generatrice e ordinatrice. Lo ritroviamo nello scettro dei re, nel bastone dei profeti, nelle chiavi che conferiscono al Papa il potere di sciogliere e di legare. Diviene cioè simbolo del potere legislativo del padre, che gli conferisce il diritto di giudicare e di punire, l’”auctoritas”. La piramide del potere parte dal padre capo della famiglia, arriva al sovrano come capo del popolo e giunge fino a Dio come capo dell’universo. Ciò che li unisce è l’”axis mundi”, l’asse attorno al quale si organizza la realtà che diviene mondo, cosmo, vale a dire realtà stabilita, ordinata e non caotica e indifferenziata.
Occorre però notare che con l’inizio della modernità questa organizzazione semantica incentrata sulla figura del padre è entrata sempre più in crisi. Le grandi concezioni del mondo, politiche, religiose, ideologiche, che la fondavano sono progressivamente tramontate. Oggi la funzione paterna conosce una crisi profonda ed inedita. Ciò è dovuto a molteplici fattori. L’avvento della democrazia ha fatto decadere l’idea di un potere assoluto, di origine divina, e introdotto l’idea di un potere laico, condiviso e in perenne discussione. L’emancipazione femminile ha portato all’uguaglianza dei sessi e alla fine dell’istituzione del “capofamiglia” con tutte le conseguenze sul piano pratico e simbolico che ancora non si sono completamente delineate.
Tutto ciò, se da un lato rappresenta una conquista di civiltà, dal momento che nel nome del padre, sia esso identificato con Dio, con un Idea, con l’Autorità sono state commesse le peggiori efferatezze (anche oggi purtroppo), dall’altro comporta, come tutti i grandi cambiamenti socioculturali, confusione, ansia e disorientamento.
E’ significativo che tutti i dittatori si siano sempre fregiati del titolo di “padre” e fatti ritrarre, sorridenti e benevoli, circondati da un popolo di facce felici e devote, a sottolineare che la loro autorità era una autorità naturale, come quella del padre appunto, e non poteva dipendere da nessuna delega elettiva reversibile.
Un tempo il padre era percepito come rappresentante di un potere che andava oltre lui come persona particolare. Poteva anche essere un individuo debole e insignificante, ma era il padre e come tale detentore di un potere indiscutibile. Così i sovrani e gli imperatori. Oggi non più. Ogni padre deve conquistarsi credibilità e rispetto per così dire “sul campo”, senza che nulla venga dato per scontato. Lo stesso vale per i governanti eletti dal popolo, sempre pronto a voltar loro le spalle. Non vi è più un potere certo, stabile e sicuro. Una simile situazione determina fenomeni regressivi mossi dalla nostalgia di padri ideali che diano sicurezza e certezze. Le varie forme di fondamentalismo lo testimoniano quotidianamente.
Franco Fornari, distinguendo tra “codice materno”, che interpreta sulla base dell’affetto e della comprensione, e “codice paterno”, che interpreta invece sulla base del rigore e della frustrazione, ha espresso l’idea che la nostra società soffra di un eccesso di codice materno a discapito di quello paterno. Ciò comporta una stagnazione evolutiva, una difficoltà a crescere per impreparazione ad affrontare le durezze della vita adulta. Se questo è ampiamente condiviso, resta tuttavia difficile immaginare una rifondazione del codice paterno in una società non più sorretta da orizzonti simbolici in grado di giustificarlo e renderlo attendibile e riconoscibile.
Se la funzione paterna resta sempre la medesima nel suo compito di introdurre una separazione fondante, senza la quale vi sarebbe un caos informe ed infecondo, un trionfo della pulsione di morte, come possiamo osservare in tante patologie legate alle varie forme di dipendenza, tuttavia il suo esercizio non può più essere appannaggio dei soli padri reali, deve diventare una tensione condivisa, sia in ambito familiare che sociale.
La funzione paterna è oggi una funzione che astrae dalla concretezza sessuale del maschile, che pur ne rappresenta la testimonianza simbolica, per diventare un compito culturale che interessa l’intera società alla ricerca di nuovi parametri di senso che sappiano conferire un ordine semantico ed etico non più riconducibile a dogmi assunti come assoluti.
Novembre 2014
Dibattito su: “la funzione paterna ieri e oggi: analogie e differenze” a cura di G. Bambini
Gaburri Eugenio

Eugenio Gaburri
Maestri della psicoanalisi
A cura di Noemi Pepe
Foto d’archivio
Gaburri, Eugenio (Soresina, 1934 – Milano, 2012)
La vita
Nato a Soresina, in provincia di Cremona, il 26 Febbraio 1934, figlio di Gilberto, cancelliere di tribunale, e di Alda Lanzi docente di storia dell’arte. Fin da piccolo coltivò la passione per la vela ed il violino, passioni che lo accompagnarono per tutta la vita.
Dopo aver frequentato il Liceo Scientifico, si laureò in Medicina a Parma, specializzandosi poi in neuropsichiatria. Nel 1962 si trasferì a Milano per lavorare nei centri di base e nel 1967 venne chiamato a dirigere l’ospedale psichiatrico di Varese, dove elaborò un modello di ristrutturazione dei manicomi; la sua idea era di non abbandonare i pazienti a se stessi e alle loro famiglie ma di creare una rete di servizi territoriali. Fu tra i primi a introdurre in Italia il pensiero di Bion.
Da sempre appassionato e sensibile alle tematiche di gruppo, nel 1975 fondò “Il Pollaiolo”, bottega di ricerca sulla teoria e la clinica dei gruppi, con Francesco Corrao, Claudio Neri, Nando Riolo ed altri. Nel 1995 si trasformò nell’Iipg (Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo).
Dopo la legge Basaglia si trasferì a Milano per insegnare alla SPI.
Dalla sua prima moglie, anch’ella psicoanalista, Gilda De Simone, ebbe due figli: Luca e Stefano. Fu nel 1992 che conobbe la sua seconda moglie, Laura Ambrosiano, in occasione di un congresso a Parigi sulla femminilità. Iniziò così anche una feconda collaborazione che esitò in diversi scritti a quattro mani (Ululare coi lupi, La spinta ad esistere, Il futuro sul lettino).
Fu segretario scientifico del Centro Milanese di Psicoanalisi “Cesare Musatti” e della SPI, redattore della Rivista di Psicoanalisi e presidente del CMP.
E’ scomparso il 6 Dicembre 2012, all’età di 78 anni, in seguito ad una lunga malattia, vissuta fino alla fine con grande coraggio e passione.
Il contributo alla psicoanalisi

Uomo e pensatore estremamente generoso, contribuì in modo creativo a far avanzare il pensiero psicoanalitico. “Battitore libero”, come lo definisce Massimo Recalcati, insofferente alle teorizzazioni scolastiche responsabili di irrigidire i concetti separandoli dall’esperienza clinica, era un vero navigatore, capace di navigare a vista nella realtà clinica, perdendosi nella confusione e nell’incertezza, da cui riusciva sempre a produrre un pensiero non convenzionale.
La sua grande passione per il mare e per la vela si rispecchiava, infatti, nel suo modo di pensare sempre originale, seguendo la direzione imprevedibile del vento, rotte nuove, non ancora note.
Gaburri imbeve i concetti freudiani del pensiero di Bion dando origine ad un pensiero innovativo, stimolante e coraggioso che propone una concezione della mente dialogica e relazionale, non timorosa di esplorazioni affettive. Come Spinoza, non si propone, infatti, di allontanare e controllare le passioni, ma di comprenderle, avendo il coraggio di soffermarsi su temi nuovi e complessi.
E’ proprio la disponibilità a lasciarsi “infettare” che permette la conoscenza profonda dell’altro, intesa come capacità di non tenere a distanza le emozioni e di avvicinarsi in una reciproca condivisione e coinvolgimento.
Ecco che lo spazio dell’interazione psicoanalitica si connota come un bagno denso di contagi dove “i processi di personificazione indicano la presenza di una disponibilità a perdere l’ancoraggio alla propria identità consolidata, a lasciarsi turbare e contagiare dall’impatto emotivo dell’incontro con l’altro” (Gaburri & Ambrosiano, 2003). Il ruolo dell’analista è quello di co-protagonista in grado di tollerare uno sostare spaesato, aiutato dalla corrente di tenerezza che lo lega al paziente. Fondamentale è la capacità negativa dell’analista, che “apre la mente ad un pensiero liberamente associativo che sigla una prospettiva etica della psicoanalisi” (Gaburri & Ambrosiano, 2008), e che caratterizza un analista con la mente libera, “senza memoria e senza desiderio” direbbe Bion, ma anche libera dal pensiero del gruppo di riferimento, capace di fare spazio dentro di sé al paziente, per poter rilanciare la bioniana spinta ad esistere. È solo dalla capacità negativa che può emergere la rêverie “un pensiero sognante e non lineare che si muove come unità funzionale tra associazioni libere e attenzione fluttuante. E’ un atteggiamento mentale senza memoria e senza desiderio, vale a dire (relativamente) libero di vagare fuori dal senso comune e dai significati condivisi” (Gaburri & Ambrosiano, 2003). L’incapacità negativa, di converso, è legata al socialismo (termine che indica l’identificazione a massa e usato da Bion come radice pulsionale delle organizzazioni che provvedono alle aggregazioni gruppali) in cui non è possibile ascoltare ciò che è diverso rispetto alle attese consegnate dagli assunti del gruppo.
E’ come un abbraccio il movimento della mente dell’analista verso l’altro, verso elementi inediti e non ancora pensati dell’incontro con il paziente. Quello che Romain Rolland chiama sentimento oceanico e che descrive una tensione a immergersi nell’universo condiviso, a sentire con l’altro, ad accorgersi delle implicazioni degli eventi e di avvertire la propria responsabilità rispetto ad essi e che permette la realizzazione della rêverie, in quanto “esperienza emotiva che consente di avvicinare intuitivamente, prima che razionalmente, gli aspetti di contiguità tra realtà interna ed esterna” (Gaburri & Ambrosiano, 2003).
Entrambe le dimensioni, consensuale, tipica dell’uomo oceanico, ed edipica, caratteristica dell’uomo terrestre, strutturano la mente.
Un altro tema centrale e trasversale del pensiero di Gaburri è proprio il conflitto tra identità e appartenenza, già presente in Freud (1921) e ripreso da Bion (1992) in termini di oscillazione tra narcisismo e socialismo, funzionale a rendere conto della trasformazione da individuo-massa a individuo autonomo. Gaburri avverte del pericolo insito nella spinta socialistica che “diffonde la speranza delirante di poter essere tutti ugualmente amati, di poter essere trattati secondo una giustizia uguale per tutti, di poter essere immortali […] essere ugualmente amati […] organizza una fantasia delirante fruita come tanto benefica e protettiva da ostacolare l’individuazione” (Gaburri & Ambrosiano, 2003). Il conflitto tra narcisismo e socialismo è centrale nell’Edipo in quanto è la dimensione edipica ed il ruolo terzo del padre ad aprire a possibili trasformazioni, promuovendo disidentificazioni e movimenti di allontanamento rispetto alla seduzione del socialismo e dell’indifferenziato, incoraggiando ad avventurarsi nella vita e a vivere le passioni.
Around the end
Se si nasce si muore eppure quanto è difficile far entrare nella realtà della vita l’idea della morte
(Freud, 1915)
Tematica che spaventa e riguarda tutti e terreno fondamentale d’indagine in psicoanalisi, la morte, è sempre stata un tema molto caro e presente nel pensiero di Gaburri. La morte è intesa come ciò che spinge a fare spazio all’inedito, al non ancora pensato; come qualcosa che apre a possibilità nuove. La morte, e in particolare la preconcezione della morte, non affrontata come contrapposizione alla vita ma come condizione dell’esistere.
Scrive Gaburri nel 2011, a malattia già inoltrata, in occasione del 1° colloquio italo-spagnolo :“la passione dei geni creativi (i mistici di Bion) che per tutta la vita si sono dedicati a ricerche scientifiche o artistiche, non si spegne con l’avvicinarsi della morte. Un caso esemplare di questa evenienza è l’opera di Michelangelo che, animato dalla passione, riuscì a lavorare fino agli ultimi giorni di vita rappresentando se stesso come un Cristo Morto sostenuto da un fantasma materno nell’ineguagliabile “pietà Rondanini”. In quest’opera artistica esemplare […] affiora la potenza della passione che travalica la morte”.(Leggi la Relazione )

La sublimazione diventa il prototipo di ogni possibile processo di soggettivazione e di umanizzazione della vita, allargando il proprio mondo alla creatività e al pensiero.
Nonostante la morte sia il limite inevitabile dell’esistenza umana, “il fatto di tenere così lontano il pensiero della morte e le paure connesse, finisce per conferire al vivere un andamento affannoso e affannato le cui espressioni estreme non sono tanto la perenne mancanza di tempo, ma l’illusione di poter fare a meno del tempo” (Rustad, 2001). Ecco che la mentalità di gruppo, l’identificazione a massa, il socialismo, diventa tanto più seducente per l’individuo in quanto prospetta un mondo senza tempo, in cui la caducità ed il terrore della morte sono allucinatoriamente assenti.
Nel 2009, il Professor Gaburri venne invitato all’Università Cattolica di Milano a partecipare ad una tavola rotonda dal titolo “Around the end, intorno alla morte”.

La tavola rotonda, organizzata dal Professor Osmano Oasi vede dialogare intorno al tema della morte il Prof. Gaburri, il Prof. Marco Sarno e il Prof. Marco Riva a partire da un filmato (prodotto dal Dr. Riva) in cui Freud, Jung, Bion, Lacan e Musatti parlano della morte.
Freud, nel 1938, prossimo ormai alla morte, parla delle pulsioni di vita, vero e proprio motore per l’inconscio.
Jung, nel 1959, descrive il distacco della psiche con le direttive di spazio e tempo, sancendone una sorta di immortalità della stessa e facendo della morte un traguardo per un inconscio minacciato.
Lacan definisce la morte come territorio della fede e afferma anche che la consapevolezza della sua non esistenza renderebbe la vita insopportabile.
E’, guarda a caso, Wilfred Bion che si addentra verso il nocciolo della questione, toccando la tematica principe dell’angoscia di morte in un malato terminale. Bion ritiene ingiusto definire una malattia o una persona come “terminale”, poiché bisogna considerare la prospettiva di morte in funzione del tempo che ancora deve venire e che deve essere vissuto al meglio. Ed è proprio su questo periodo che è ancora da vivere che la psicoanalisi deve spremere le sue forze, levando quell’angoscia che lega l’uomo al tema della morte.
«La morte non è una malattia, non prevede una cura, eppure durante la nostra esistenza ne siamo angosciati – spiegava Eugenio Gaburri-, ma la spiegazione è da cercare dentro Bion, quando ci suggerisce che ciò deriva dall’accanimento delle cose che non sappiamo spiegarci come affrontare. La paura della morte attiva quindi la psicoanalisi proprio perché la morte è irreversibile».
Gaburri sollecita ad affrontare questo limite per giungere alla rielaborazione del lutto e riuscire a sconfiggere l’atteggiamento “ipocrita” dell’uomo.
Il lutto è l’angoscia che si produce nell’emergere dalla condizione mentale indifferenziata. Ecco che “il lavoro psichico è innanzitutto il lavoro del lutto, che non riguarda solo gli aspetti di mancanza ambientale traumatica, ma anche il dolore e la paura di emanciparsi dai legami a massa” (Gaburri & Ambrosiano, 2003).
A Gaburri si deve la trasmissione di un pensiero libero e autonomo, caratterizzato da risposte non saturanti e suscettibili di colonizzare il pensiero dell’altro, ricordando sempre il pericolo di illusori passepartout. Essere psicoanalisti comporta un’assunzione di responsabilità e la costante riflessione sui nostri disagi personali e collettivi.
La passione per la ricerca del Professor Gaburri, per il gusto di pensare insieme, sono rinvenibili nelle pagine, nei testi che ha lasciato, come giacimento culturale per le nuove generazioni con l’auspicio che le sue idee percorrono il tempo a venire rimanendo feconde e aperte alla creatività di chi le incontra.
D’altronde una citazione tanto cara a Freud, dal Faust di Goethe, sembra racchiudere questo auspicio e l’invito ai futuri analisti a prendere le distanze dal socialismo, dall’identificazione a massa , dagli “abiti usati” e a mantenere viva la tensione conoscitiva della disciplina psicoanalitica:
Was du ererbt von deinen Vatern hast,
Erwirb es, um es zu besitzen.
[Ciò che hai ereditato dai padri,
Riconquistalo, se vuoi possederlo davvero.]
Tenere la rotta nel mare della psicoanalisi
Il 25 Gennaio 2014 si è tenuta presso la Casa della Cultura di Milano una giornata di lavoro in memoria del Prof. Gaburri, occasione per ricordarlo come persona e per ricordare gli importanti contributi del suo pensiero per la psicoanalisi.
La giornata si è aperta con un breve filmato del Dr. Marco Riva intitolato “Around Bion” e poi risoprannominato “Around Gaburri”.
Il pensiero di Gaburri può essere interpretato come un’opera musicale che lascia ad ognuno libertà di interpretazione e che proprio per questo permette l’incontro tra persone, pensieri diversi.
Il ricordo del Professore è andato articolandosi mano a mano grazie agli apporti dei relatori che hanno saputo intrecciare aspetti della persona, dell’uomo e del pensatore attraverso il racconto di esperienze che sono state generate dall’incontro con lui.
Durante la mattinata, ognuno dei relatori ha sottolineato un aspetto del pensiero e della persona di Eugenio Gaburri: la tenerezza, l’irrequietezza e la dimensione sociale.
Il primo a parlare è stato il Prof. Claudio Neri che ha presentato una relazione su “La tenerezza e la capacità di relazione” in cui la tenerezza emerge come un costrutto psicoanalitico ben preciso, con nuovi significati rispetto a quelli legati al senso comune, e come caratteristica dell’uomo Gaburri, dotato di una capacità di relazionalità interpersonale e interna in grado di rigenerare continuamente l’interesse per l’altro, di fargli spazio e di fungere da calco per il suo sviluppo.
La relazione del Dott. Jaffè, “Il campo gruppale. Eugenio Gaburri lungo il filo dei suoi personaggi: Conrad, Kurosawa, Velasquez … e altri ancora” ci mostra un affresco gruppale, fatto di personaggi cari e discussi dal Professore, che ne hanno costituito l’animo.

Ecco allora prendere vita il personaggio del bambino zoppo, dalla favola de “Il pifferaio magico” dei fratelli Grimm, unico bambino, che proprio grazie a questa sua specificità si salva dall’indifferenziato della comunità in cui vive; di Dersu Uzala, del regista Kurosawa, personaggio semi selvaggio dalla conoscenza magico-intuitiva che permette la buona riuscita del viaggio grazie alla sua grande intelligenza, al suo istinto e all’acuto senso di osservazione; de “Il coinquilino segreto” di Conrad, che esemplifica il continuo lavoro tra Sè e il doppio per poter lavorare nell’incontro col paziente; “Las Meninas” di Velazquez e le successive reinterpretazioni, trasformazioni, di Picasso che parlano di un analista che non solo entra nel campo, come Velazquez, ma che anche, all’interno del campo, non si sottrae al dialogo con l’altra parte di Sè e mostra come da questo dialogo interno si può creare un campo allargato con personaggi multiformi collegati tra loro.
Il Dott. Marco Sarno, parte da una caratteristica del pensiero scientifico del Prof. Gaburri, il coraggio di non fermarsi di fronte a temi complessi e nuovi. E sceglie come parola guida il “degrado”, concetto presente nel libro Ululare coi lupi e che trova uno sviluppo nel lavoro del 2005 “Paranoia primaria e degradazione” e nel lavoro del 2007 “La promessa delirante e i pifferai magici”. Sottolineando la passione del Prof. Gaburri per la ricerca, la sua competenza gruppale, sviluppata proprio a partire dal concetto di “degrado”, e ricordando che indagare lo spirito dei tempi e dei luoghi è fin da Freud una frontiera in continua espansione per la psicoanalisi, il Dott. Sarno ci propone una ricerca di psicoanalisi allargata sugli aspetti intrapsichici e intersoggettivi che caratterizzano le culture criminali in Italia.
Il Dr. Conforto, nella sua relazione, ricorda Gaburri anche attraverso questa citazione di Freud: “ La vita si impoverisce e perde interesse se non è lecito rischiare quella che, nel gioco dell’esistenza, è la massima posta cioè la vita stessa”. Ed è proprio la preconcezione della morte a permetterci di non evacuare l’angoscia per la caducità dell’esistenza e ad avventurarci nei legami affettivi, nelle passioni, nella sessualità … nella vita.
ll pomeriggio ha visto riuniti in una tavola rotonda i Prof. Antonino Ferro, Martin Cabrè, Fausto Petrella e Massimo Recalcati che hanno continuato a ricordare il Professor Gaburri, fornendone una presentazione tridimensionale a completamento del quadro iniziato nella mattina.
Bibliografia
Gaburri E. (1971). Rapporti diadici e traidici all’interno dei gruppi istituzionali psichiatrici. Rivista di Psicoanalisi, vol. 17, pp. 145-162.
Gaburri E. (1973). Il silenzio in analisi. Studio clinico sul rapporto tra silenzio, interpretazione e narcisismo. Rivista di Psicoanalisi, vol. 19, pp. 225-227.
Gaburri E. (1976). Realtà psichica e setting psicoanalitico. Rivista di Psicoanalisi, vol. 22, pp. 191-205.
Gaburri E. (1979). Enzo Funari. La struttura e il desiderio. Rivista di Psicoanalisi, vol. 25, pp. 473-474.
Gaburri E. (1980). Protocomunicazione e comunicazione nel rapporto analitico. Rivista di Psicoanalisi, vol. 26, pp. 1-22.
Gaburri E. (1981). Ipotesi teoriche sulla genesi della perversione del transfert. Rivista di Psicoanalisi, vol. 27, pp. 229-236.
Gaburri E. (1982). Una ipotesi di relazione tra trasgressione e pensiero. Rivista di Psicoanalisi, vol. 28 (4), pp. 511-25.
Gaburri E. (1983). Idealizzazione e narcisismo nella relazione tra il Sè e gli oggetti. Con De Simone G. Rivista di Psicoanalisi, vol. 29 (2), pp. 243-262.
Gaburri E. (1986). Dal gemello immaginario al compagno segreto. Rivista di Psicoanalisi, vol. 32 (4), pp. 509 – 520.
Gaburri E. (1987). Letture bioniane. Rivista di Psicoanalisi, vol. 33, pp. 449-451.
Gaburri E. (1988). La scuola di Melanie Klein. Con Ferro A. Rivista di Psicoanalisi, vol. 34, pp. 546-550.
Gaburri E. (1988). Gli sviluppi kleiniani e Bion. Con Ferro A. In Semi.
Gaburri E. (1990). L’ultimo Freud e le premesse della psicoanalisi attuale. Rivista di Psicoanalisi, vol. 36 (4), pp. 831 – 61.
Gaburri E. (1992). La tecnica nella psicoanalisi infantile. Con Ferro A. Rivista di Psicoanalisi, vol. 38, pp. 842-862.
Gaburri E. (1992). Emozioni, affetti, personificazioni. Rivista di Psicoanalisi, vol. 38 (2), pp. 325-352.
Gaburri E. (1994). Etica, civiltà e psicoanalisi. Con R. Contardi. Rivista di Psicoanalisi, vol.40 pp. 620-643.
Gaburri E. (1997) (a cura di). Emozione e interpretazione. Psicoanalisi del campo emotivo. Bollati Boringhieri, Torino.
Gaburri E. (1998). Il campo gruppale e la “non cosa”. In Rugi e Gaburri.
Gaburri E. (1999). Psicoanalisi: per un’etica profana. In Preta
Gaburri E. (1999). Enigmi della cultura e disagio nella civiltà. Con Contardi R. Bollati Boringhieri, Torino.
Gaburri E. (2002). Pensiero associativo e lutto: tra attenzione fluttuante e senso comune. Rivista di Psicoanalisi, vol. 48 (2), pp. 345-364.
Gaburri E. (2003). Ululare con i lupi. Conformismo e rêverie. Con Ambrosiano L. Bollati Boringhieri, Torino.
Gaburri E. (2006). La promessa delirante e i pifferai magici. Psiche, 2, pp. 13-29.
Gaburri E. (2008). La spinta a esistere. Note cliniche sulla sessualità oggi. Con Ambrosiano L. Borla, Roma
Gaburri E. (2013). Pensare con Freud. Con Ambrosiano L. Raffaello Cortina, Milano.
Gaddini Eugenio

Eugenio Gaddini
Maestri della psicoanalisi
A cura di Darwin Mervoglino
Gaddini Eugenio (Cerignola, 1916 – Roma, 1985)
Presentazione
Eugenio Gaddini è stato uno psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana e della International Psychoanalytical Association. Ha dato un contributo fondamentale alla formazione di molti analisti italiani e all’ingresso della psicoanalisi italiana nella comunità psicoanalitica internazionale.
Gli interrogativi fondamentali cui Gaddini ha tentato di rispondere riguardano la nascita psicologica del soggetto e l’azione terapeutica della psicoanalisi. La sua ricerca si è incentrata sui modi in cui si organizza l’attività mentale nei primissimi tempi della vita, sul rapporto fra mente e corpo, sui processi evolutivi grazie ai quali si forma psicologicamente un individuo e sullo sviluppo della sua capacità di mettersi in rapporto con la realtà e con l’altro. Si è inoltre molto occupato del metodo psicoanalitico nel continuo collegamento fra teoria e clinica, fornendo un importante contributo sia all’approccio psicoanalitico alle patologie non-nevrotiche che all’individuazione delle aree non-nevrotiche nei pazienti nevrotici.
 Eugenio Gaddini was a psychoanalist of the Italian Psychoanalytic Society and of the International Psychoanalytic Association. He gave a very important contribution to the training of many Italian analists and to the admission of Italian psychoanalysis in the International psychoanalytic community.
Eugenio Gaddini was a psychoanalist of the Italian Psychoanalytic Society and of the International Psychoanalytic Association. He gave a very important contribution to the training of many Italian analists and to the admission of Italian psychoanalysis in the International psychoanalytic community.
The fundamental questions Gaddini tried to answer concern the psychological birth of the subject and how psychoanalysis operates. His research focused on the ways in which mental activity organizes itself in the earliest times of life, on the relationship between mind and body, on the developmental processes thanks to which an individual psychologically forms himself and on the development of his ability to take in the relation with the reality and the other. He was very concerned as well to psychoanalytic method in its continuous connection between theory and clinic, giving an important contribution both for the psychoanalytic approach to non-neurotic pathologies and for the attention to non-neurotic areas in any patients.
La vita
 Eugenio Gaddini nasce il 18 gennaio del 1916 a Cerignola, in provincia di Foggia. La sua famiglia d’origine si costituisce fin dall’inizio in una situazione conflittuale, che ne caratterizzerà gli sviluppi. Il padre, Guglielmo Gaddini, proveniva da una famiglia riminese di intellettuali antifascisti e aveva tentato, senza fortuna, un’attività imprenditoriale nei pressi di Cerignola. La madre, Palmira Strafile, molto più giovane di lui, proveniva da una famiglia pugliese di origini modeste e legata alla terra, le cui attività imprenditoriali durante il primo conflitto mondiale avevano però avuto molta fortuna. I due, pur di sposarsi, avevano inizialmente organizzato una “fuga”, usanza del tempo per quelle coppie che volevano sposarsi senza il consenso dei genitori. Il conflitto tra il nonno materno e il padre di Eugenio caratterizzerà le dinamiche della famiglia esitando nella rottura definitiva tra i due.
Eugenio Gaddini nasce il 18 gennaio del 1916 a Cerignola, in provincia di Foggia. La sua famiglia d’origine si costituisce fin dall’inizio in una situazione conflittuale, che ne caratterizzerà gli sviluppi. Il padre, Guglielmo Gaddini, proveniva da una famiglia riminese di intellettuali antifascisti e aveva tentato, senza fortuna, un’attività imprenditoriale nei pressi di Cerignola. La madre, Palmira Strafile, molto più giovane di lui, proveniva da una famiglia pugliese di origini modeste e legata alla terra, le cui attività imprenditoriali durante il primo conflitto mondiale avevano però avuto molta fortuna. I due, pur di sposarsi, avevano inizialmente organizzato una “fuga”, usanza del tempo per quelle coppie che volevano sposarsi senza il consenso dei genitori. Il conflitto tra il nonno materno e il padre di Eugenio caratterizzerà le dinamiche della famiglia esitando nella rottura definitiva tra i due.
Gaddini, sesto di nove figli, ultimo maschio, fu molto presto allontanato dalla famiglia insieme con la sorella Ester e affidato ad alcuni amici di Foggia. Contribuì a questo allontanamento, oltre alla situazione familiare conflittuale, la malattia della sorella Rosaria, più grande di lui di soli tredici mesi, che la condurrà alla morte a soli 14 anni. Egli rievoca la drammaticità della vicenda nel racconto Ragazzi (1936).
In seguito alla chiusura dell’attività paterna, il nonno decide il trasferimento della famiglia a Napoli. Gaddini rimane a Napoli fino all’età di 17 anni, in una situazione familiare in cui al padre era impedito di vivere con la famiglia. La madre di Eugenio era presente, ma emotivamente distante, mentre il legame con la nonna materna fu, fin dall’inizio, di profonda vicinanza.
Nel 1933 Gaddini si trasferisce a Roma per volere del nonno. Qui termina gli studi classici e partecipa alla vita intellettuale dell’epoca, fondando insieme a due intellettuali d’avanguardia, Ventruoli e Stradone, una rivista letteraria: Accademia.
Nel 1936 si iscrive alla Facoltà di Medicina e si laurea il 15 Luglio 1942, discutendo una tesi su un trattamento specifico delle leucemie. Sono gli anni del Secondo Conflitto Mondiale e Gaddini viene destinato all’Ospedale militare di Mirano Veneto come Allievo Ufficiale di Marina. Dopo l’Armistizio, nel Settembre del 1943, lascia la Marina e fa ritorno a Roma.
Il 1945 è un anno caratterizzato dalla conquista di stabilità. Anzitutto si sposa con Renata De Benedetti, con cui avrà due figli, Silvia e Andrea. Con Renata condividerà per il resto della vita, oltre agli interessi personali, anche quelli scientifici e professionali. Nello stesso anno diviene Primario dell’Ospedale della Croce Rossa di Forte Aurelio, a Roma, mantenendo l’incarico fino al 1956.
Fin da subito Gaddini si era interessato agli aspetti psicologici dei suoi pazienti ed alle malattie che egli considerava di origine psicofisica. Nel 1946 inizia un’analisi personale con Emilio Servadio e successivamente la formazione psicoanalitica. Nel 1953 diventa Socio della Società Psicoanalitica Italiana e negli anni successivi contribuisce in modo fondamentale a riorganizzare la SPI, tentando nel contempo di fornirle un respiro internazionale. Dal 1967 al 1969 è Vice presidente della SPI; nel 1970 diviene didatta; è Presidente dal 1978 al 1982. Collabora attivamente con l’International Psychoanalytical Association dal 1963, come membro di molti comitati di programma dei congressi dell’IPA e di commissioni per lo sviluppo delle società psicoanalitiche di altri Paesi. Nel 1983 è Chairman della Conferenza sull’analisi di training di Madrid; nel 1985 è Co-Chairman alla Conferenza sull’analisi di training di Amburgo.
Eugenio Gaddini avrebbe dovuto far parte del comitato scientifico del Congresso Internazionale di Montreal del 1987. Purtroppo non gli fu possibile a causa di una embolia polmonare che ne causò la prematura scomparsa, il 27 Settembre del 1985.
 Il contributo alla psicoanalisi
Il contributo alla psicoanalisi
Il contributo di Gaddini alla psicoanalisi è vasto ed articolato. Qui si tenterà di fornire alcune linee guida del pensiero dell’autore, rimandando il lettore interessato all’ampia bibliografia disponibile. Per avere un’idea del contesto teorico in cui si colloca il suo pensiero è importante tenere presente che Gaddini fu particolarmente vicino alla psicoanalisi anglofona. Due punti di riferimento del suo pensiero psicoanalitico sono stati Donald W. Winnicott e Phyllis Greenacre, con i quali ebbe occasione di intrattenere anche rapporti personali.
La questione mente-corpo e i processi imitativi
Secondo Gaddini la psicoanalisi considera il corpo e la mente sotto l’aspetto di un continuum funzionale in cui l’elemento fondamentale è un processo di differenziazione del funzionamento mentale dal funzionamento fisiologico. Esso avviene attraverso l’apprendimento mentale del funzionamento fisiologico, che si realizza attraverso manovre protettive (precursori delle difese) fondate sulle percezioni imitative (1969a). Il primo modello, secondo Gaddini, è quello dell’imitare per percepire, il cui significato risiede nel fatto che l’infante inizialmente non percepisce lo stimolo reale ma la modificazione avvenuta nel proprio corpo. In questo senso l’identità di percezione acquista un significato nuovo: percepire costituisce inizialmente la garanzia della propria esistenza, dell’esistenza di sé. E’ questo il modello dell’imitare per essere, che si instaura gradualmente con lo scopo di ristabilire la fusione. L’imitazione ha dunque una funzione omeostatica perché, se essere l’oggetto vuol dire “essere tout court”, questo comporta contemporaneamente la strenua difesa dalla minaccia dell’alterità dell’oggetto.
Questa concezione induce Gaddini a distinguere un’area psico-sensoriale, legata a fenomeni primari di tipo imitativo, da un’ area psico-orale, connessa cioè alla possibilità dell’investimento d’oggetto. Vi è dunque, in questo modello, l’ipotesi di fondo di un’attività mentale che si differenzia dal somatico attraverso un processo di elaborazione del funzionamento fisico. Ne consegue che, nei primissimi tempi di vita dell’infante, il funzionamento psichico sia embricato con quello fisiologico e dipenda in gran parte da esso.
E’ in questo contesto teorico che Gaddini sviluppa le sue concezioni sulle sindromi psicofisiche (termine che egli preferiva a quello di “psicosomatiche”) ed in particolare sulle sindromi datate (1980c): le sindromi psicofisiche dei primi diciotto mesi di vita, la cui caratteristica fondamentale è che non si presenterebbero prima di un determinato tempo dalla nascita. E’ in questo senso che Gaddini le definisce datate. Esse sono il mericismo (o ruminazione), che comparirebbe a partire dal terzo mese; la dermatite atopica, a partire dal sesto mese; l’asma, che non comparirebbe prima della fine del primo anno. Tali sindromi si riferiscono ad una patologia della mente relativa al distacco e alla separatezza e si sviluppano, come soluzioni difensive, in un momento dello sviluppo psichico in cui il problema della separatezza emerge pressante.
L’aspetto fondamentale di questa concezione sta nel fatto che non vi sarebbe un ritorno al somatico per inaccessibilità del mentale, ma una trasformazione da parte del mentale del funzionamento somatico. La patologia psicofisica sarebbe il risultato di un’attività creativa della psiche e, pertanto, la fantasia non sarebbe assente in essa, ma espressa attraverso il corpo. A tale riguardo Gaddini parla di protofantasie nel corpo, distinguendole dalle più evolute fantasie sul corpo(1981a).
La costruzione del senso di sé
Nel modello teorico proposto da Gaddini, sulla linea di Winnicott, il soggetto si costituisce attraverso un processo di costruzione di un senso di continuità di sé. A partire da una condizione iniziale di non distinzione fra sé e non-sé prende le mosse, come abbiamo visto, un graduale processo di differenziazione che, sulla base dei processi imitativi dell’area psicosensoriale, conduce ad una Organizzazione Mentale di Base (OMB). La OMB (1980c) è dunque una prima forma di organizzazione psichica. Essa ha carattere autarchico e magico, e il suo scopo è di ristabilire in modo onnipotente la fusione del Sé con l’oggetto. In tal senso tale organizzazione è qualcosa di diverso dalla struttura psichica descritta da Freud. La OMB rappresenta dunque il primo nucleo psichico operativo formatosi allo scopo di fronteggiare la graduale esperienza della separatezza.
Proprio l’esperienza graduale di separatezza determina, secondo Gaddini, lo sviluppo di meccanismi introiettivi. I processi dell’introiezione sono successivi ai primissimi tempi della vita e cominciano ad instaurarsi nel momento in cui si istituisce una differenza tra dentro e fuori. Il modello psicofisico sulla base del quale si sviluppa l’introiezione è quello dell’incorporazione, cioè il meccanismo del “mettere dentro”. L’integrazione di processi imitativi e processi introiettivi, infine, dà luogo alle identificazioni.
Con i processi dell’identificazione siamo nell’area di una soggettività che può rapportarsi all’oggetto percepito come esterno. E’ molto importante rimarcare come, per Gaddini, tutti questi processi appartengano ad aree di funzionamento psichico, seppure primitive, e non ad aree di funzionamento puramente fisiologico.
Si può dunque sostenere che il modello gaddiniano si occupa prevalentemente del protomentale e della sua evoluzione in ciò che diverrà la struttura psichica descritta da Freud. Una struttura, quest’ultima, che tende allo sviluppo dell’autonomia attraverso il riconoscimento della realtà e il rapporto con un oggetto distinto da sé. La questione della relazione oggettuale, strettamente connessa a tutto questo, incrocia quindi in modo pressante il rapporto del modello di Gaddini con la teoria strutturale e la teoria pulsionale freudiane.
La relazione oggettuale
La relazione oggettuale – intesa come la possibilità del soggetto di entrare in rapporto con un oggetto distinto da sé – è in stretta connessione con la possibilità dell’investimento oggettuale e, quindi, con la dimensione pulsionale.
Come abbiamo detto sopra, nel modello gaddiniano la OMB rappresenta la prima organizzazione psichica risultante dall’esperienza della separatezza, che attua delle manovre difensive di tipo imitativo volte a negare l’alterità dell’oggetto. La natura paradossale di un tale processo risiede nel fatto che la prima esperienza di un Sé separato è un’esperienza di angoscia, che Gaddini definisce come angoscia di integrazione (o angoscia di perdita di sé). L’evento più straordinario che si verifica nel Sé sopravvissuto alla separazione è l’emergenza delle pulsioni istintuali (1984c). L’autore sostiene infatti una ipotesi di emergenza delle pulsioni nel momento di costituzione del Sé.
Le pulsioni istintuali esisterebbero fin dalla nascita, in ossequio alla teoria freudiana, ma sarebbero inattive. Emergerebbero, cioè entrerebbero in funzione, nel momento in cui si forma un sé separato che può entrare in rapporto con un oggetto percepito come altro da sé. (Va rimarcato che Gaddini, pur sottolineando la differenza fra pulsioni e istinti, usa spesso, confusivamente, i due termini come sinonimi). Nel modello gaddiniano sembra prevalere l’idea che non sia possibile parlare di primato della pulsione. Il primato riguarda la costituzione dell’unità di sé, cioè del soggetto, e la pulsione ne rappresenta una funzione in direzione dell’oggetto. E’ inoltre possibile osservare come egli consideri in primo piano il ruolo dell’aggressività in questo processo. Gaddini sostiene infatti che, all’inizio, le cariche aggressive sarebbero rivolte all’esterno, mentre le cariche libidiche all’interno. Solo gradualmente la libido verrebbe portata all’esterno (poi verso l’oggetto) proprio attraverso le cariche aggressive.
Un altro elemento fondamentale che istituisce la possibilità della relazione oggettuale è il processo di scena primaria e formazione del padre (1974a). All’interno della relazione fusionale con la madre, in cui l’infante va gradualmente differenziandosi, si sviluppa un ulteriore processo di trasformazione della madre in una figura che è percepita prima come estranea, aliena. Solo in un secondo momento, gradualmente, ella è percepita come esterna. In questo processo il padre è percepito inizialmente dall’infante come la madre estranea che attacca la fusione imitativa. Solo gradualmente il padre sarà prima percepito in quanto aspetto dicotomico della madre estranea e successivamente, gradualmente, come oggetto differenziato e separato dalla madre.
Si comprende come il processo della scena primaria e l’emersione del padre dalla madre rappresentino l’elemento fondamentale di uscita del bambino dall’illusione magica dell’identità imitativa fusionale. Inoltre, questa concezione di processo della scena primaria può fornire una lettura alternativa al concetto di fantasma originario di scena primaria, di derivazione filogenetica. In questo senso, infatti, essendo il processo di separazione ed il vissuto di separatezza delle esperienze universali, la scena primaria può essere considerata come derivato di una esperienza esclusivamente ontogenetica.
Rappresentazione e simbolizzazione
Il modello teorico di Gaddini, come abbiamo visto, è fondato sullo studio dei processi attraverso i quali si costituisce un senso della continuità di sé, a partire dalle primissime esperienze di vita dell’infante. Si tratta, utilizzando una terminologia diversa da quella strettamente gaddiniana, del processo di costruzione del soggetto (o soggettivazione).
Se il concetto di apprendimento mentale del funzionamento fisiologico nel continuum corpo-mente può far pensare ad una visione lineare-genetica dello sviluppo psichico, ad uno sguardo più approfondito si coglie chiaramente l’impegno di Gaddini nel mostrare la creatività dell’attività psichica, già a partire dai primi modelli di funzionamento mentale. Di fatto, egli sottolinea la drammaticità del processo di costruzione di sé. Un processo che richiede la capacità di sostenere un’angoscia profonda, l’angoscia di perdita di sé (integrazione) e che consente l’invenzione dello spazio e del tempo (1978), inizialmente non presenti. Tutto questo è alla base dello sviluppo dei processi rappresentazionali che, come l’angoscia, sono strettamente connessi all’emersione pulsionale e all’investimento oggettuale.
Il processo di costruzione del soggetto è, dunque, un processo attraverso il quale l’attività psichica, agli albori embricata con il corpo, si emancipa dai funzionamenti fisiologici assumendo un senso suo proprio che non ha più a che fare col funzionamento fisico. La costruzione della soggettività diviene la costruzione della rappresentazione di sé, di un soggetto che continuamente crea se stesso.
In questo senso l’attività presimbolica della mente infantile (1984c), teorizzata da Gaddini, rappresenta anche il motore continuo di quei processi elaborativi che determinano l’attività psichica di simbolizzazione.
Aspetti della clinica
Nel continuo rimando dalla teoria alla clinica e dalla clinica alla teoria, che caratterizza la psicoanalisi, il contributo del pensiero di Gaddini risiede nella continua attenzione che egli poneva nel cercare di distinguere, in analisi, quei funzionamenti che appartengono all’area psico-sensoriale da quelli che appartengono all’area psico-orale. In altri termini, il suo impegno è sul come comprendere quando, con il paziente, ci si trovi nell’area del conflitto pulsionale e della relazione oggettuale e quando, invece, ci si trovi nell’ambito della relazione basata sul funzionamento primario imitativo.
Risulta necessaria, a questo proposito, una precisazione. E’ chiaro che una tale distinzione di funzionamenti ha un ottimo valore in termini esplicativi, ma va declinata in maniera non radicale nella clinica. In tal senso Gaddini è attento a mostrare modalità di funzionamento prevalenti, a volte in dati i momenti, in tutti i soggetti, e non ad incasellare certi funzionamenti in determinate patologie.
L’attenzione ai processi imitativi che possono attivarsi in ogni analisi si condensa nel concetto di transfert imitativo. Il transfert imitativo è una difesa dal riconoscimento dell’alterità dell’analista e, quindi, della propria separatezza. Esso può attivarsi ad un livello diverso rispetto al transfert oggettuale, come una sorta di “spinta a fare uno”, difendendosi dall’angoscia. Per comprendere meglio la portata di questo concetto occorre sottolineare che se è vero che in ogni transfert vi è una tendenza all’evitamento della separatezza, è altrettanto vero che qualcosa dell’analizzando viene trasferito sull’analista in quanto altro. Nel transfert imitativo, invece, non vi sarebbe trasferimento bensì imitazione. E’, questa, la dimensione del bisogno prevalente su quella del desiderio, e diventa fondamentale che l’analista sia in grado di riconoscerla.
E’ importante rimarcare che, essendo stato Gaddini anche un formatore di analisti, la sua attenzione al problema delle analisi imitative (1985d) era anche molto legata al problema delle analisi di training dei candidati.
Bibliografia
1936 Ragazzi. Il pensiero dei giovani – La gazzetta, 20 luglio 1936. In Sergio Palumbo, L’impetuosa giovinezza di antiborghesi senza rimedio, EDAS, Messina 1999, pp.224.
1953 Introduzione al Frammento di un’analisi d’isteria di Sigmund Freud. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano 1989, p.1
1955 Un caso di disturbi del carattere con sintomi di conversione pregenitale. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano 1989, p.9
1956 (1) Psicoanalisi; (2) Biografie di psicoanalisti. Inedito. Doveva apparire sulla Enciclopedia Domus, che non vide mai la luce. Note: (2) Biografie di: Abraham Karl, Aichorn August, Alexander Franz, Bergler Edmund, Brill A.A., Federn Paul, Ferenczi Sandor, Jones Ernest, Musatti Cesare, Rorschach Hermann, Servadio Emilio, Weiss Edoardo.
1959a La ruminazione nell’infanzia. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano 1989, p.27
1959b Immagine corporea primaria e periodo fallico: considerazioni sulla genesi dei simboli di forma rotonda. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.48
1960 Psicoanalisi e arte. Tre conferenze. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano 1989, p.59
1961 Psicoanalisi e fattori socioculturali. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano 1989, p.89
1962 Sui fenomeni costitutivi del controtransfert. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano 1989, p.94
1963 Oggettività e certezza. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano 1989, p.116
1964 Interventi nell’ambito del “First International Congress of Direct Psychoanalysis”. Proceedings of the I Internat. Congr. of Direct Psychoanalysis. The Doylestown Foundation. Doylestown, Pa., 1965. Congresso tenutosi a Roma, 11-12 settembre 1964.
1965a Contributo allo studio dell’ “effetto PES” nella situazione analitica. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano 1989, p.118 1965b L’arte come espressione clinica. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano 1989, p.142
1966 Lo sviluppo della sessualità femminile (4 seminari). Programma Insegnamento Ist. Psicoanal.: Centro Psicoanal. di Roma. Inedito.
1967 Il controtransfert nel caso di Dora. Commento a “Rileggendo il caso di Dora” del dottor Lopez. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.150
1968a Imitazione e mistificazione. Lavoro presentato al Convegno su “Psicoanalisi e Cultura”, Trieste, 11-13 ottobre 1968. Inedito. Note: Bollettino del convegno apparso su Rivista di Psicoanalisi, XIV, n.3, set-dic., 1968.
1968b Trad. e cura del volume di Hanna Segal, Introduzione all’opera di Melanie Klein. Martinelli Editore, Firenze 1968.
1968c La controversia e l’eredità kleiniana. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.155
1968d Nota biografica su Melanie Klein. In Introduzione all’opera di Melanie Klein di Hanna Segal. Martinelli Editore, Firenze 1968.
1968e Rapporto sul Training in Italia. Boll. Soc. Svizzera di Psicoanalisi, n. 8, 1968-69. Letto alla Conf. delle Commissioni Europee del Training (Zurigo apr. 68).
1969a Sulla imitazione. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.159
1969b Linguaggio e psicoanalisi. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.190
1969c La nevrosi e i conflitti psichici. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano,1989, p.194
1969d Fenomeni PSI, fattori PSI, e processo creativo. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p. 203
1969e Prefazione all’edizione italiana del volume di Edward Glover “La nascita dell’io”. In: La nascita dell’io di E. Glover (Vol.). Casa Editrice Astrolabio, Roma 1970. E’ stata anche rivista la traduzione.
1969f Trad. e cura: Charles Rycroft: Dizionario critico di psicoanalisi. Volume. Casa Editrice Astrolabio, Roma, 1969.
1970a Prefazione al Dizionario critico di psicoanalisi di Charles Rycroft. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano 1989, p.219
1970b Oggetti transizionali e processo di individuazione: una ricerca in tre differenti gruppi sociali. In: Scritti 1953-1985. Cortina, Milano 1989, p.223
1970c Intervista sugli spazi architettonici. Moebius. Architettura, Urbanistica, Arte. Anno III, 1970, n.3, Edizioni O.M.G. s.a. Geneve, Paris, Rome.
1971a Trad.: D.W.Winnicott: L’uso di un oggetto (con R. Gaddini). “Psiche”, anno VIII n.1, gen.-apr. 1971. Edizioni dell’Ateneo, Roma 1971.
1971b Il movimento psicoanalitico in Italia. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.240
1972a L’aggressività. Nota introduttiva. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.263
1972b Aggressività e principio del piacere. Verso una teoria psicoanalitica dell’aggressività. In: Scritti 1953-1985 Milano, Cortina, 1989, p.266
1972c Oltre l’istinto di morte. In: Scritti 1953-1985 Milano, Cortina, 1989, p.282
1972d Trad.: H. Rosenfeld: L’accostamento clinico alla teoria psicoanalitica degli istinti di vita e di morte. (Una ricerca sugli aspetti aggressivi del narcisismo). Rivista di psicoanalisi, XVIII, fasc. unico 1972. Giunti Barbera, Firenze.
1972e La terapia psicoanalitica. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.299
1973 Discussione del lavoro di Henry Edelheit “Crucifixion Fantasies and their Relation to the primal Scene” In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.319
1974a Formazione del padre e scena primaria. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.326
1974b I settanta di Emilio Servadio. Un tributo. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.351
1974c L’interpretazione. Nota introduttiva. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.360
1975a La formazione del padre nel primo processo infantile. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.362
1975b Una nota sui processi creativi. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.370
1975c Ricerca, controversie ed evoluzione della tecnica terapeutica in psicoanalisi. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.375
1978 L’invenzione dello spazio in psicoanalisi. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.387
1976 Note su alcuni fenomeni del processo analitico. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.405
1977 Seminario sul dolore mentale. Rivista di psicoanalisi, XXIV, 3, sett.dic.1978. Il Pensiero Scientifico Editore, Roma. Tenuto al XV Convegno Scientifico della S.P.I. Bologna, 22-23 ottobre 1977.
1978a Dialogue on “Different Types of Anxiety and their Handling in the Psychoanalytic Situation” (Dialogue Report). Int.J.Psycho-Anal., (1978) 59, 237. Baillière Tindall for the Institute of Psycho-Analysis, London. Reported by Eugenio Gaddini, Rome and Albrecht Kuchenbuch
1978b Sessualità (voce della Enciclopedia italiana). Lessico Universale Italiano Treccani. Ist. della Enciclopedia Italiana (G. Treccani), Roma 1978.
1978c Stadi nell’organizzazione del sé e dell’angoscia. Inedito. Presentato a Firenze il 12 ottobre 1978.
1979a Intervista in Argentina. Boletìn de Candidatos, anno IV, n.9, giugno 1979.
1979b Il tempo di un anniversario. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.427
1979c Sigmund Freud a Lavarone. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.430
1979d Seminari Argentini In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.433
1980a Relazione introduttiva al 4° Congresso nazionale della Società psicoanalitica italiana In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.462
1980b Preghiera e onnipotenza. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, Appendice III, p. 827
1980c Note sul problema mente-corpo. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.470
1980d Discussione del lavoro presentato dal dottor Feldman. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.502
1981a Fantasie difensive precoci e processo psicoanalitico. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.508
1981b Itinerari nella creatività di Bion. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.521
1981c Acting out nella situazione analitica. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.535
1982a Il problema mente-corpo e la psicoanalisi. In Cervello e Sogno. Neurobiologia e Psicologia. Feltrinelli Editore, Milano 1982
1982b Discorso di apertura al V Congresso Nazionale della S.P.I. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.547
1982c Terapia e conoscenza in psicoanalisi. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.551
1982d Trad.: D.W.Winnicott: Piggle. Una bambina (con R.Gaddini). Boringhieri Editore, Torino, 1982
1982e Il Sé in psicoanalisi. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.559
1982f La preistoria dell’individuo torna a galla nel sonno. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.570
1983a Gli stati di non-integrazione nell’esperienza gruppale. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.576
1983b Sulla traduzione italiana del lavoro di Melanie Klein Der Familienroman in statu nascendi. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 198, p.590
1984a Trauma della nascita e memoria della nascita. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.592
1984b La frustrazione come fattore della crescita normale e patologica. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.603
1984c L’attività presimbolica della mente infantile In: Scritti 1953-1989 Cortina, Milano, 1989, p.618
1984d Psicologia in Orwell. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.633
1984e Se e come sono cambiati i nostri pazienti fino ai nostri giorni. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.644
1984f L’ultimo Bion. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.663
1984g Il processo analitico (seminari). Inedito. Seminari tenuti presso il C.P.R. dal 5 novembre 1983 al 2 giugno 1984.
1984h La discontinuità come unica dimensione possibile della continuità nella crescita individuale. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, Appendice III, p.836
1985a Genesi della creazione in arte. Dipinti di Ennio Calabria. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.669
1985b La nascita, la crescita. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989, p.702
1985c La maschera e il cerchio. In: Scritti 1953-1985 Cortina, Milano, 1989 , p.731
1985d Il Candidato-paziente e l’istituzione. Inedito. Nota: Relazione presentata alla Riunione scientifica dl Comitato Generale del training della S.P.I. “Presenza del paziente e del candidato nei reciproci rapporti con l’analista e con l’istituzione psicoanalitica”. Firenze, 26-27 gennaio 1985.
1986b Creatività tra fantasia a immaginazione. Atti Convegno sull’immaginario. Venezia, 23.24 marzo, 1985
Bibliografia su Gaddini
Volumi
Genovese C. (a cura di) Corpo-mente e relazione, Dunod, Milano 1998.
Lambertucci-Mann S. Eugenio Gaddini, Psychanalystes d’aujourd’hui, Presses Universitaires de France (PUF), Parigi, 1999.
Mascagni M.L. (a cura di) Studi sul pensiero di Eugenio Gaddini, Soteria, Editore Metis, Chieti, 1994.
Articoli
Carratelli T.I., Eugenio Gaddini, Ricercatore di frontiera in psicoanalisi. Psicoanalisi, 1,2,1997,
Ferretti Levi Montalcini A., Sulla imitazione di Eugenio Gaddini: elementi per una discussione. Psicoanalisi, 1,2,1997.
Manfredi Turillazzi S., Ricordo di Eugenio Gaddini, maestro di psicoanalisi. Rivista di Psicoanalisi, 32, 1986.
Genovese C., Aggressività: istinto o pulsione?. Psicoterapia Psicoanalitica, 12, 2, 2005.
Genovese C., Organizzazione mentale di base: Eugenio Gaddini e il percorso circolare Freud-Winnicott-Freud. Rivista di Psicoanalisi, 55, 2009.
Riferimenti in rete
Generali Clements Lina
I maestri della Psicoanalisi
Lina Generali Clements
A cura di Riccardo Brunacci, Renata Rizzitelli e M.Angiola VignaTaglianti
Profilo di Lina Generali Clements
La dottoressa Lina Generali Clements nasce nel 1923 in provincia di Cremona; laureata in medicina, si specializza in neurologia e pediatria. Già in questo periodo scopre la passione per il lavoro con i bambini. Citando dall’ Intervista a Lina Clements, “Sulla storia della psicoanalisi infantile in Italia”, a cura di Maria Luisa Algini, Borla editore:
“L’idea di lavorare nel campo dei disturbi psicologici infantili è nata dall’esperienza fatta in clinica pediatrica come studente, prima, e come specializzando in Pediatria, poi. Mi aveva colpito allora la sofferenza a cui i bambini andavano incontro quando erano lontani dai genitori, sofferenza che niente poteva alleviare, nemmeno l’ambiente accogliente, caldo e pieno di affetto quale era il Reparto in cui a quel tempo lavoravo.
Se ci ripenso, devo dire che la mia successiva scelta non è stata mossa da sollecitazioni culturali o ambientali: la verità è che non avrei potuto fare altro”.
Come psicoanalista, la sua formazione avviene a Milano: ella infatti effettua la propria analisi didattica con Musatti, facendo poi un secondo training a Londra, nel gruppo kleiniano.
A Milano la dottoressa opera come libera docente in neuropsichiatria infantile e professore incaricato di psicoterapia all’Università fino al trasferimento a Londra, dove approfondisce la sua competenza sia per quanto riguarda il lavoro con gli adulti, sia per quello con i bambini, divenendo esperta anche di osservazione del bambino nel rapporto con la madre e l’ambiente familiare, l’ “Infant observation”. Le sue maestre sono Martha Harris e Esther Bick. Ai maestri, italiani e londinesi, che l’hanno accompagnata nel suo percorso di formazione, la dottoressa Generali, nella medesima intervista, mostra la propria riconoscenza:
“La mia grande fortuna son stati i miei compagni di viaggio, dai docenti dell’Università e della Scuola Psicoanalitica ai miei compagni di corso, agli assistenti di sala. Penso che anche loro avessero ascoltato e che per questo siano stati i miei migliori alleati, sempre disposti ad aiutarmi, e a tollerarmi senza farmelo pesare.
I loro nomi? È un elenco molto lungo; il prof. Musatti, e i suoi allievi; non ultima Vanna Giaconia, che è stata come una sorella per me.
Più tardi, dei miei compagni di viaggio citerò soltanto alcuni nomi: Ruth Riesemberg, Martha Harris, Hanna Segal, Betty Joseph, Nuscia Bick, tutte persone indimenticabili, e col passare del tempo a me sempre più care”.
E ancora:
“A un certo punto è arrivato per me il momento di pagare il mio debito verso chi mi aveva aiutato: in primo luogo verso la Società Italiana di Psicoanalisi, che mi ha dato l’incarico di insegnamento. E da qui si è ancora allargato il gruppo dei miei compagni di viaggio: Dina Vallino, Annalisa Ferretti, Alessandra Piontelli, Marinella Lia e tanti altri… è un lungo ponte verso il futuro”.
Il lavoro pionieristico di Lina Generali Clements consiste soprattutto nell’aver introdotto l’osservazione del neonato in Italia e di aver stimolato una direzione di ricerca a partire da esso. Ella portò, infatti, l’Infant Observation dapprima (intorno agli anni 70) nell’ambito della formazione dei neuropsichiatri infantili dell’Università Statale di Milano e quindi in ambito più squisitamente psicoanalitico, dal 1978 al1984, sia privatamente che al Centro Milanese di Psicoanalisi con un gruppo di candidati e di psicoanalisti provenienti da diverse città italiane ( fra cui Dina Vallino, Gina e Franco Mori, Giusi Tirelli, Giuliana Boccardi, Antonino Ferro, Franco Borgogno, Barbara Serrati…), gruppo in cui si lavorava sulla comparazione della relazione madre-bambino dell’Infant Observation e l’osservazione della relazione analista-paziente nella situazione analitica. Frutto del fervente lavoro di quegli anni furono la relazione “Correlazioni fra la relazione analitica e la relazione madre- bambina ” presentata da Lina Generali e da Gina Mori al IV Congresso Nazionale della Società Psicoanalitica Italiana (Taormina, 1980) ed il Pane “Dall’osservazione all’interpretazione: un vecchio metodo sempre più attuale” al V Congresso della Società Psicoanalitica Italiana (Roma, 1982), con relazioni di Ferro, Borgogna, Girelli, Serrati e Boccardo.
Nel 1990 Lina Generali si trasferisce a Ruta di Camogli, proseguendo da lì il suo impegno formativo di nuove leve di psicoanalisti; negli ultimi anni 90 rientra definitivamente a Londra, pur ritornando periodicamente in Italia per tenere seminari di psicoanalisi infantile, soprattutto a Firenze e Cremona. Rispetto ai contesti dell’esperienza italiana ed alle sollecitazioni che l’hanno sostenuta, la dottoressa ricorda:
“Durante la mia Specializzazione in Malattie Nervose presso l’Università di Milano la Prof.ssa Adriana Guareschi ha avviato un Ambulatorio di neuropsichiatria Infantile, in cui ho mosso i primi passi.
Le mie difficoltà erano la scarsa preparazione: il sostegno mi è venuto dalla stessa professoressa Guareschi, a cui sarò sempre grata. Con il suo incoraggiamento ho proseguito il cammino, a Londra nel Bethlem Hospital, negli Stati Uniti presso l’Università di Harvard, e successivamente ancora a Londra nella Tavistock Clinic”
“Attorno agli anni ’70 e ’80 vi era la tendenza a richiedere e a volte ad attuare un trattamento psicoanalitico per un ampio spettro di disturbi psicologici e psichiatrici, tendenza che si è successivamente attenuata.
Il mio primo paziente è stato un bambino di otto anni con difficoltà di apprendimento, che si esprimeva soprattutto con il disegno.
L’aiuto migliore mi è venuto dalla pratica dell’Osservazione, di cui già Freud era stato fautore. Per molti anni, direi per tutto il periodo del mio lavoro, ho condotto Seminari di Osservazione del neonato (Osservazione madre-bambino) condotta secondo il metodo di Esther Bick.
Penso che il saper osservare secondo questo metodo sia alla base del lavoro analitico; non per niente i Seminari di Infant Observation fanno parte del training della Società Psicoanalitica Britannica, oltre ad essere alla base dell’insegnamento alla Tavistock di Londra”.
Si tratta di un lavoro faticoso, emotivamente impegnativo per chi lo attua e chi lo conduce; per cui non fa meraviglia che susciti delle resistenze […] .
Che cosa ho imparato dal mio lavoro, o meglio, cosa valuto di più di quello che ho imparato?
Non ho dubbi: il rispetto, l’apprezzamento, la gratitudine per tutti i genitori, fortunati o sfortunati; con il loro coraggio e la loro determinazione sono parte della vita – e sono loro che.
Cosa ho imparato su di noi esseri umani? Mah, potrebbe essere meglio.
Ma potrebbe anche essere peggio!”.
Vasta è stata l’attività della dottoressa in termini di formazione nel campo degli adulti e dei bambini e nell’osservazione dei neonati, piuttosto che in termini di pubblicazioni. Lina Generali è stata, infatti, psicanalista didatta e analista di bambini, adolescenti ed adulti.
Tra le pubblicazioni della dottoressa, in ogni caso, troviamo due lavori importanti:
“L’osservazione del neonato come metodo di studio in psichiatria infantile”, del 1971, sulla “Rivista di psicoanalisi” (XVII);
“Correlazioni tra la relazione analitica e la relazione madre – bambino”, del 1980 (Generali L., Ferrara Mori G., Quaderni di Psicoterapia Infantile, n. 55, 2007).
Genitorialità
A cura di Marta Badoni
Se nella parola genitore è iscritto l’atto del generare, nella parola genitorialità dovremmo trovare, seppure in maniera condensata, quello che la società si aspetta dagli adulti in quanto genitori; di conseguenza quello che lo Stato fa per sostenere la funzione genitoriale.
Siamo subito in un rapporto dialettico tra privato e pubblico, tra quella che è una spinta creativa largamente sostenuta da un bisogno di portare a compimento una propria visione di sé e del mondo, di buttare uno sguardo oltre il limite delle proprie esistenze e, d’altra parte, un compito pubblico che la società assegna che è quello di educare.
Sul generare la questione è oggi assai complessa: si genera sempre più tardi rispetto al periodo naturalmente fertile della donna, si genera per procura, la coppia genitoriale non ha più confini stabili e ristretti, ma si estende alle coppie omosessuali, alle famiglie allargate che devono affrontare equilibri delicati tra figli di genitori diversi, nei casi di fecondazione eterologa la coppia genitoriale è caricata dalla fantasia di un terzo, il donatore, presente nei pensieri anche se sconosciuto. Pensieri che conoscono bene i genitori adottivi, con l’aggiunta del compito di lenire una ferita all’origine.
Inutile aggiungere che in un quadro di tale complessità l’intervento pubblico, che in Italia è da sempre carente, rischia di naufragare o di essere manipolato a seconda delle scelte politiche o delle regole religiose.
Eppure i genitori sono, tra gli umani, gli esseri più esposti a quello che (a partire dal saggio di Freud del 1914) chiamiamo il lavoro del lutto. Tale lavoro, che significa la capacità di trattare con i sentimenti di delusione che inevitabilmente gli “oggetti” ci infliggono, è, nel caso dei genitori, diretto a una costante ricerca di equilibrio tra la necessità di investire i propri figli, sui propri figli, di tifare per loro, e una continua, vigile attenzione a che le aspettative nei loro confronti non costituiscano una cappa soffocante e le inevitabili delusioni non scardinino, magari silenziosamente, la fiducia e la speranza. Fiducia anche nel proprio ruolo di genitori, speranza nelle rispettive risorse.
E’ lavoro di lutto quello che accompagna la nascita e che confronta i genitori allo scarto inevitabile tra bambino immaginato e bambino reale; è lavoro di lutto l’inserimento al nido, alla scuola materna, alla scuola elementare, ampliato dai primi non sempre incoraggianti confronti con altri modi di essere bambini, di essere genitori, di essere educatori; è lavoro di lutto quello che si presenta di fronte al figlio adolescente, in quanto esso mette al vivo, più degli altri momenti citati, assieme al tifo per il successo dei figli, il problema del succedersi delle generazioni e quindi il problema della propria morte.
Come resiste la coppia a questo tipo di pressioni? Come si distribuiscono compiti e ruoli tra i due o più genitori, quando le famiglie si allargano? Come lo Stato e le Istituzioni intervengono o potrebbero intervenire a rendere il lavoro dei genitori meno impossibile? E infine che cosa può dire, suggerire e fare la ricerca psicoanalitica al riguardo?
APPROFONDIMENTI
Nascita della genitorialità
A cura di Sandra Maestro
Da sempre la psicoanalisi si è interessata della costruzione dei primi legami tra il neonato e le sue figure di attaccamento, la madre e il padre, per offrire dei modelli interpretativi sulle fasi iniziali dello sviluppo psicoaffettivo e dare al tempo stesso delle chiavi di lettura della sofferenza e del disagio.
Winnicott sosteneva che, “non esiste un bambino senza la madre”. Questa affermazione, apparentemente paradossale, sta a significare che per comprendere il comportamento di un bebè, il filtro che l’osservatore deve utilizzare è quello dato dalle “rappresentazioni”, consce e inconsce che i genitori hanno di lui.
Ma da dove scaturiscono queste rappresentazioni? Secondo Palacio Espasa ogni individuo nel diventare adulto sedimenta nel proprio inconscio delle immagini di se stesso bambino e dei propri genitori che vanno a costituire delle “identificazioni”. Tali identificazioni si riattivano con la nascita del bambino nel complesso processo trasformativo che l’autore definisce “lutto evolutivo”. La nascita del bambino comporta, infatti, l’inclusione di una “neoformazione” nella personalità del genitore, il “bambino reale”, per natura diverso da quello immaginato, e la perdita dello statuto esclusivo di figlio, che normalmente tende a risolversi con l’identificazione da parte del neo-genitore con i propri genitori. Ma il bambino reale non è mai solo “il bambino”, ma è anche il “bambino che i genitori avrebbero voluto essere…” e specularmente i genitori si identificano con “i genitori che avrebbero voluto avere…” Questa “gioco “di identificazioni incrociate è cruciale per la formazione dei primi legami ed è una delle chiavi di lettura per comprendere le interazioni tra genitori e figli.
Quindi per capire qualcosa di un bambino dobbiamo anche vedere ed ascoltare le persone che si prendono cura di lui. Dal punto di vista di Winnicot la “cura” prevede:
1) la “preoccupazione materna primaria” ovvero una condizione mentale della madre di intensa e totale dedizione al neonato capace di alimentare in lui l’illusione di essere tutt’uno con lei;
2) l’holding ovvero la capacità della madre di fungere da contenitore delle angosce del bambino, intervenendo per soddisfare i suoi bisogni emotivi e riuscendo a mettersi da parte nel momento in cui il bambino non ha bisogno di lei;
3) la “madre sufficientemente buona” cioè una madre che attivamente si adatta alle necessità del bambino, un adattamento attivo che a poco a poco diminuisce a seconda della capacità del bambino che cresce, di tollerare la “disillusione” e la frustrazione, conseguente al venir meno della totale corresponsione materna ai suoi bisogni emotivi.
Per Bion un’altra dimensione della cura materna è data dalla funzione di rêverie, ovvero uno stato mentale aperto alla ricezione di tutti gli stimoli provenienti dal bambino e in particolare alle “identificazioni proiettive” legate alle intense angosce di morte, elicitate nel neonato dalla condizione di assoluta dipendenza. Attraverso la sua “funzione alfa”, ovvero attraverso la sua capacità di pensiero, la madre metabolizza le ansie del bambino e gliele restituisce in un modo per lui più tollerabile.
Indipendentemente dalla declinazione che il concetto di cura ha per la psicoanalisi, il ruolo del padre è centrale, inizialmente per il sostegno dato alla madre, successivamente per la sua funzione di modulatore della separazione all’interno della coppia madre-bambino e per consentire passaggio da legami di tipo diadico a legami di tipo triadico.
Quindi per la psicoanalisi una dimensione centrale dell’ “l’ambiente” di crescita del bambino è rappresentata dall’assetto emotivo e dall’intrapsichico dei genitori, per la cui comprensione ed esplorazione servono contesti e strumenti specifici.
Ma il bambino come interagisce con tutto ciò?
La psicoanalisi oggi è molto interessata ad integrare le nuove conoscenze derivate dalla psicologia dello sviluppo e dall’infant research che hanno rivoluzionato l’immagine del neonato, non più rappresentato in una condizione di “autismo fisiologico” o di “ritiro narcisistico primario” ma al contrario, “orientato” con tutto il suo apparato sensoriale, fin dalle prime ore di vita, verso il contatto con madre.
Questa innata predisposizione del neonato all’interazione sociale con gli altri esseri umani, nonché all’interazione con altre “menti”, come suggerito da tutti quegli esperimenti che dimostrano la presenza fin dalle prime ore di vita dell'”intersoggettività primaria”, (Trevartheen) non esclude tuttavia la necessità di poter disporre di teorie relative allo sviluppo emotivo e psicoaffettivo, che forniscano delle ipotesi sulle “premesse della vita psichica”.
Nella storia della psicoanalisi alcuni autori hanno sviluppato le loro teorie a partire da osservazioni comportamentali empiriche dei neonati, seguendone lo sviluppo longitudinale nell’arco dei primi due anni di vita.
R.Spitz ha introdotto il concetto di “organizzatore” per descrivere alcune tappe evolutive fondamentali , coincidenti con salti evolutivi nel comportamento del bambino e della qualità delle sue relazioni con l’ambiente. Il primo organizzatore è la risposta del sorriso e si colloca al terzo mese di vita; il secondo organizzatore è “l’angoscia per l’estraneo” e coincide con l’VIII mese, l’ultimo organizzatore è “la risposta del no”, attorno al 18° mese.
L’interesse di queste intuizioni empiriche è stato confermato dall’evidenza che in questi periodi il SNC del neonato subisce dei cambiamenti strutturali maturativi che ne rendono il comportamento sempre più più finalizzato ed organizzato.
M. Malher ha concettualizzato lo sviluppo psico affettivo del bambino nel periodo che va dai quattro-cinque mesi di vita fino circa al trentesimo-trentaseiesimo mese denominandolo come “processo di separazione ed individuazione”: Separazione e individuazione rappresentano due sviluppi complementari: la separazione consiste nell’emergenza del bambino da una fusione simbiotica con la madre e l’individuazione consiste nella progressiva assunzione da parte del bambino delle proprie caratteristiche individuali.
Più recentemente Daniel Stern si è impegnato attraverso un’attenta e approfondita ricapitolazione di tutte le conoscenze derivate dall’infant research, nella costruzione di ponti teorici tra il bambino della psicoanalisi e quello della psicologia dello sviluppo, proponendo una teoria dello sviluppo psico-emotivo, basata sullo sviluppo del Sé e della soggettività.
Si potrebbe concludere che uno dei punti di forza dell’approccio psicoanalitico sta nel fornire delle teorie esplicative dello sviluppo infantile strettamente connesse con lo sviluppo del suo sistema relazionale, offrendo quindi delle chiavi di lettura per comprendere le turbolenze emotive e i conflitti che accompagnano i processi di crescita del bambino. A questo proposito Anna Freud, in “Normalità e patologia” descrive la fisiologica fluttuazione dello sviluppo del bambino nelle diverse “linee evolutive”, per cui nel processo di maturazione ci si può aspettare una certa disarmonia, con momenti di regressione. Parallelamente i processi della genitorialità vanno incontro a periodi critici che possono essere legati a snodi specifici della crescita del bambino, o della vita familiare, o della storia personale… ma nella maggior parte dei casi i genitori si rivelano “sufficientemente buoni”, ovvero, sufficientemente permeabili e recettivi al cambiamento e capaci di maturare nel rapporto con il loro bambino quelle competenze necessarie a favorirne la crescita armonica.
Ma quando al contrario, nel processo di accudimento si re-iterano micro-fallimenti (“non riesco a farlo dormire”, “non riesco a calmarlo”, “non riesco a farlo mangiare”) il genitore non percepisce “il rinforzo del sentimento di competenza e fiducia nella propria funzione genitoriale” (Abidin) e il rischio è che gradualmente si strutturi una rappresentazione negativa speculare, ovvero quella di un “cattivo bambino con un cattivo genitore”…In questi casi è importante farsi aiutare!
Bibliografia
Abidin, R. R. (1983). Parenting stress and the utilization of pediatric services. Children’s Health Care, 11(2), 70-3.
Bion W. (1962). Apprendere dall’esperienza. Roma, Armando, 1996 .
Cramer B., Palacio-Espasa F. (1995). Le psicoterapie madre-bambino, Milano, Masson.
Freud A (1965) .Normalità e patologia del bambino: Valutazione dello sviluppo . Milano Feltrinelli,1974 .
Mahler S.M., Pine F., Bergman A. (1975). La nascita psicologica del bambino. Torino Boringhieri, 1978 .
Manzano J, Palacio Espasa F., Zilkha N. (2001). Scenari della genitorialità. La consultazione genitori-bambino, Ed Cortina.
R. Spitz: (1962). Il primo anno di vita del bambino. Firenze Giunti.
Daniel Stern. (1985). Il mondo interpersonale del bambino. Torino, Bollati Boringhieri, 1987.
Trevarthen C. (1998). Empatia e Biologia. Psicologia, cultura e neuroscienze. Milano, Raffaello Cortina Editore.
Winnicott D,(1971). Gioco e realtà. trad. Giorgio Adamo e Renata Gaddini, prefazione di Renata Gaddini. Roma, Armando, 1974.
Winnicot D (1974). Sviluppo affettivo e ambiente: studi sulla teoria dello sviluppo affettivo. Roma, Armando, 1974.
Genitori si nasce o si diventa?
A cura di Barbara Piovano
Esiste una preistoria infantile del desiderio adulto di paternità e maternità.
Le fantasie infantili di procreazione che risalgono all’infanzia e l’ipotesi di una pulsione universale a essere genitori costituiscono il substrato fantasmatico e biologico del desiderio di avere un figlio.
Il figlio, fin dal momento della programmazione e del concepimento promuove un cambiamento nei genitori. Un’intensa produzione di fantasie si attiva durante il processo di riorganizzazione della identità personale e di genere cui vanno incontro i genitori nelle fasi del concepimento, della gravidanza, parto, post-partum, allattamento. Il desiderio del bambino (e quindi il progetto cosciente) crea nella mente del genitore uno spazio virtuale atto a contenere l’idea del bambino e di se stessi come genitori. E’ il nuovo nato, diverso dall’irrappresentabile bambino immaginario, il bambino reale che sollecita i genitori a creare uno spazio psichico effettivo e non solo virtuale per il figlio .
La genitorialità è considerata nella teoria classica come uno stadio di sviluppo nella vita di un adulto (J. and K. Novick, 1998).
In termini più attuali la genitorialità va intesa non tanto e non solo come una fase dello sviluppo che viene raggiunta sotto la spinta biologica e fantasmatica a procreare, ma come un processo trasformativo che evolve nel corso della vita e attraverso il quale viene sviluppata una costellazione di capacità affettive e psichiche. Questo processo viene attivato dal progetto di avere un figlio e dalle interazioni con lui e richiede un tipo di funzionamento mentale e di disposizione affettiva in ciascun genitore ed un tipo di relazione coniugale – la genitorialità è quindi funzione della coppia nella sua totalità e non del singolo – che promuovono crescita e cambiamento psichico.
La creazione di uno spazio per l’investimento emotivo e la rappresentazione del figlio e di uno spazio di riflessione sulla relazione con il figlio, presuppone:
1— una triangolazione nella relazione di coppia.
Se si deve creare uno spazio per il figlio non può essere mantenuta l’illusione di una relazione fusionale simbiotica. Il passaggio da una relazione a due – che nell’innamoramento era per molti versi una relazione ad uno – ad una relazione a tre, comporta una serie di modifiche dell’assetto di coppia e un fondamentale processo di ri-distribuzione di energie e di investimenti affettivi.
2 — una triangolazione introdotta dal bambino reale.
3 —lo sviluppo di funzioni genitoriali sufficientemente buone.
Le funzioni genitoriali vanno considerate non come competenze innate o da acquisire, ma come funzioni psichiche che condensano la capacita di pensare, in contrapposizione all’agire o all’aderire all’altro, e quella di sostenere emotivamente ed affettivamente la crescita del figlio.
Ciascun genitore può svolgere adeguate funzioni genitoriali, intese come funzioni della mente, se può fare riferimento a un duplice referente materno e paterno, che gli consente di svolgere funzioni paterne e funzioni materne in armonica interazione.
La funzione materna di contenimento e rispecchiamento consente al bambino di sperimentare una continuità del sé e di raggiungere uno stato di coesione del sé.
La funzione paterna, introduce separatezza, profondità e processualità (senso del tempo) nella relazione con il figlio, favorendo in quest’ultimo l’accettazione del diverso da sé, la costruzione di un sé separato, la conquista di uno spazio psichico e di un’attività psichica (capacità di provare emozioni, di immaginare, di sognare).
La disposizione genitoriale affettiva include la capacità di generare amore, di sostenere la speranza, di contenere la sofferenza, oltre a quella di pensare ( Meltzer, 1986).
Essa presuppone che siano di continuo elaborati gli aspetti conflittuali delle relazioni dei genitori con gli oggetti del passato e con gli altri significativi del presente e che nel figlio possa essere proiettato il proprio sé infantile investito narcisisticamente (come dire una buona dose di autostima) ( Freud, 1914).
L’esperienza clinica insegna che in situazioni favorevoli, che non necessariamente conseguono al desiderio e al progetto cosciente di avere un figlio, quest’ultimo, per il fatto stesso di esistere, e per il suo potenziale di sviluppo può rappresentare un momento di crescita per i genitori nel senso che sollecita una serie di aggiustamenti che vanno dalla creazione di uno spazio psichico per il figlio, all’elaborazione di traumi e conflitti con figure significative del passato, alla revisione del legame di coppia, all’elaborazione del lutto dei genitori rispetto a superati valori, ad una maggiore apertura e confronto dialettico con l’ambiente sociale. E’ quello che si può definire come il contributo del figlio alla genitorialità (Piovano, 1998,2004). Se succede che i sintomi del bambino non siano più gestibili all’interno del nucleo familiare i genitori sono allora sollecitati a chiedere interventi specialistici dei quali essi stessi possono usufruire. E’ in questo senso che il sintomo del figlio rappresenta una speranza anche per i genitori. L’analista interviene a riparare dove il disagio e la sofferenza del figlio non è riuscita aprire spazi di riflessione su quello che non ha funzionato o non sta funzionando, nella speranza di saperne un po’ di più su ‘come fare crescere i bambini di qualunque età’ (Bion, 1975).
Bibliografia
Bion, W.R (1975). Memorie del futuro. Trad.it. Raffaello Cortina, Milano
Freud.S (1914). Introduzione al narcisismo.OSF vol.7
Meltzer, D.Harris M. (1968).Il ruolo educativo della famiglia: un modello psicoanalitico dei processi di apprendimento. Centro Scientifico Torinese.
NovickK.K., Novick,J.(2009).Il lavoro con i genitori. Franco Angeli Milano
Piovano.B. (2004).Parenthood and Parental Functions as a Result of the Experience of Parallel Psychotherapy with Children an Parents. Int.ForumPsychoanal 13: (187-2004)
Piovano, B (1994) Le esperienze parallele: percorsi psicanalitici dal bambino al genitore. BorlaRoma-Trad. Ingl. Parallel Psychotherapy with Children and Parent, NY Jason Aronson 1998.
Interrogativi sull’oggi della maternità-genitorialità
A cura di Carla Busato Barbaglio
Riflettere sull’oggi della maternità- genitorialità è un invito a ripensare ad un ‘gioiello’ di possibilità che abbiamo come psicoanalisti, psicologi, psichiatri, ginecologi, pediatri, operatori dei servizi, insegnanti: possibilità attinenti alla cura e alla prevenzione, e più precisamente perché la prevenzione si attivi prima della cura. Il “gioiello” è costituito sia dalle acquisizioni teoriche sulla crescita e lo sviluppo di un bambino, che ormai sono patrimonio comune, sia dalle possibilità di lavoro a contatto con la nascita e la crescita della maternità quale genitorialità. Infatti, non c’è solo la nascita del bambino ma nel concepimento viene avviata quella maternità in fieri, data dalla possibilità di farlo crescere, che è la genitorialità e poi la “nonnità”.
La maternità oggi sembra collocarsi in una linea di frontiera complessa. Ci sono, infatti, ricerche sempre più raffinate, frutto del lavoro di osservazione della relazione madre bambino che si estende all’indietro fin dal tempo del concepimento, (da segnalare il bel lavoro a cura di Gina Ferrara Mori sulla maternità interiore ) tese ad approfondire il difficile compito della costruzione del’grembo materno’. Anche le ricerche accuratissime dell’Infant Research, vedi per esempio Tronick, presentano un modello di regolazione reciproca secondo il quale madre bambino sono legati da un sistema di mutuo adattamento,in cui il bambino costruisce le proprie capacità di regolazione emotiva. Gli studi stessi delle neuroscienze sembrano supportare tali ricerche. Rizzolati afferma che il possesso dei neuroni specchio e la selettività delle loro risposte determinano uno spazio di azione condiviso, all’interno del quale ogni atto e ogni catena di atti, nostri o altrui, appaiono immediatamente iscritti e compresi, senza che ciò richieda alcuna esplicita o deliberata “operazione conoscitiva”. Lettura questa interessante, perché dà consistenza agli studi sull’identificazione proiettiva, sottolineando un movimento riflesso tra i partners della relazione che non passa immediatamente e sempre per una struttura rappresentativa, eppure è presente. E questo riguarda l’essere l’uno di fronte all’altro, l’uno con l’altro. Possiamo perciò ipotizzare che ci sia fin dal concepimento l’iscrizione nel corpo non solo di un programma genetico, ma anche di un alfabeto relazionale che si tradurrà poi nell’esistere in un determinato modo e con una certa qualità di reciprocità.
Si sa inoltre che la depressione, l’ansia, la rabbia, perfino l’ottimismo/pessimismo vissuti dalla donna incinta possono avere effetti stressanti sul feto. Lo stress materno è sempre più associato allo stress del feto e in particolare l’ansia, collegata ad alti livelli di cortisolo (“l’ormone dello stress”) e presente soprattutto negli ultimi mesi di gravidanza, si ritiene possa essere un fattore predittivo di un ritardo mentale e motorio ai 3 mesi del neonato e soprattutto di un ritardo motorio agli 8 mesi.( Tiffany Field). Ogden afferma che “l’esperienza sensoriale è il bambino”, e ogni brusca discontinuità di forma, simmetria, ritmo, pressione epidermica e così via, segna il “non-essere” del bambino.
Gli studi sull’allattamento confermano tutto ciò. Nell’andamento della relazione tra il bambino e la madre, dal modo di essere tenuto in braccio, al rispetto delle pause, dei tempi e alla risposta ad essi, non solo viene favorita l’alimentazione, ma sono poste le basi della comunicazione vera e propria.
Tutte queste ricerche sembrano andare in controtendenza rispetto ai ritmi di una società il cui comun denominatore è la fretta, il consumo, il guadagno. La debolezza, la fragilità, le angosce e tutti i fantasmi legati alla maternità sembrano in essa trovare ancora più difficoltà di radicamento e accoglienza. Quale posto trovano la solitudine e l’angoscia a diventare madre, e quale contenimento viene dato al nuovo rapporto che si va creando quando i ritmi di lavoro poco tutelano la crescita di un bambino? Interessante poi come la proposta che viene dal mondo che si occupa della nascita di un bambino solleciti una risposta materna di azione, più che di pensiero e di interiorità. Pensiamo alle diete cui si sottopongono le madri in gravidanza o alle visite mediche che sembrano essersi moltiplicate su un crinale molto difficile da reggere, tra il vivere un evento che fa parte della vita e una medicalizzazione troppo forte che sposta l’ottica di ciò che sta avvenendo. Si moltiplicano studi sulla vita intrauterina, studi sulla placenta… e poi la donna è lasciata sola, assolutamente non aiutata, anzi spesso si infierisce su di lei in momenti delicatissimi. Quante donne prese da mille visite si sottraggono all’ascoltare il proprio corpo e a costruire l’alfabeto relazionale che come il codice genetico nasce già in utero? Non accadono continuamente espropri? Barbara Duden segnalava il problema del corpo della donna come luogo pubblico, quanto continuamente ancora ciò accade?
Nuovi problemi vengono anche posti dalla grande offerta di possibilità di andare oltre l’infertilità. Possibilità bellissime e inedite, difficili a volte da coniugare nell’esistenza senza che si traducano in un attacco al corpo, alla vita di coppia nella non accettazione di un limite che a volte la vita pone. E che spazio c’è per pensare alla fecondazione eterologa e a ciò che mette in atto prima che ci siano problemi seri per il bambino? Un bambino che uno dei genitori guarderà sempre per scrutarvi un oltre. Non segnalo tutto ciò per chiudere alla ricerca e alla scienza ma per continuare incessantemente a pensare sul fatto che ogni scelta mette in atto meccanismi di cui è meglio sapere prima, per quanto possibile. Così come per le fecondazioni nelle coppie lesbiche, o per i bambini adottati da coppie omosessuali. Quale spazio viene dato, fuori dalle ideologie, al riflettere seriamente su come viene costruita una ‘maternità interiore’, una genitorialità? Questo vale anche per le adozioni. Quale la domanda sottesa alla ricerca di un bambino, e quale spazio c’è perché genitori e bambino crescano assieme?
Vedo poi sempre più adolescenti nati da coppie miste. Altre culture, sradicamenti forti che non hanno trovato accoglienza e comprensione e che rendono difficilissimo il passaggio adolescenziale nel figlio. Interessante a questo proposito il bel testo ‘Maternità in esilio’ di Marie Rose Moro, Dominique Neuman e Isabelle Réal ).
Tutto ciò pone interrogativi sull’eccessiva medicalizzazione della prevenzione, gestita esclusivamente sul fronte degli accertamenti diagnostici strumentali ed ematochimici, che pure debbono avere un loro posto, ma non possono saturare il campo e lo spazio tra madre-feto-bambino-padre-ambiente.E come integrare il lato medico, le ricerche con un tempo di contatto profondo al proprio interno con ciò che sta avvenendo dandosi anche tempi per sognarlo? Questo vale anche per altri percorsi nei quali la richiesta istituzionale non veglia a sufficienza sulla buona riuscita dell’incontro. A questo proposito ci sono interessanti sperimentazioni in Italia. Alcune si collegano al metodo osservativo di Ester Bick, e propongono una formazione agli operatori che si occupano del farsi della vita, aiutandoli ad essere attenti ai loro stessi vissuti per poter accogliere al meglio e sostenere ciò che sta avvenendo.
La costruzione della maternità-genitorialità è un cantiere aperto che non si esaurisce con il concepimento e la nascita ma richiede un continuo lavoro di integrazione tra ciò che la vita propone, a volte anche crudelmente ( aborti, lutti in famiglia, malattie, difficoltà nella coppia stessa, figlio diverso dal sogno, propria storia personale) e la possibilità di mantenere viva e vitale, ricca di interrogativi, curiosità e capacità di pensare e ripensare, la ‘camera gestazionale’ .
Bibliografia
Busato Barbaglio C., Mondello Ml., Tra femminile e materno: l’invenzione della madre. Milano Franco Angeli, 2008.
Busato Barbaglio C., Maternità: fortezza da due debolezze? In N.Neri e C.Rogora., Desideri di maternità. Roma Borla 2010
Duden B., (1991) Il corpo della donna come luogo pubblico Torino, Bollati Boringhieri 1994
Ferrara Mori G., a cura di Un tempo per la maternità interiore Roma, Borla 2008
Field T., 2007, “Being a fetus (Prenatal Growth and Development)” in “The Amazing Infant”, Blackwell Publishing.
Moro MR., Neuman D., I Réal., Maternità in esilio.Milano, Raffaello Cortina Editore, 2010
Ogden T. H., (1989). Il limite primigenio dell’esperienza. Roma, Astrolabio 1992.
Rizzolati G., Sinigaglia C., So quel che fai. Milano, Raffaello Cortina Editore, 2006.
Soubieux M-J.,Soulé M.,La psichiatria fetale. Milano, Franco Angeli, 2007
Tronick E., Regolazione emotiva. Milano, Raffaello Cortina Editore, 2008.
Attualità della figura paterna nello sviluppo psichico dei bambini
A cura di Mario Priori
Nella famiglia della cultura occidentale le figure genitoriali hanno subito profonde trasformazioni negli ultimi decenni. La madre, da “angelo del focolare” totalmente assorbita dalla cura dei figli, si è trasformata in una figura orientata verso nuove realizzazioni che la vedono superare i confini della famiglia, protesa verso nuove mete di lavoro e di impegno sociale. Ancor più radicale è stata la trasformazione della figura paterna. Erede di una tradizione che lo ha visto in una posizione a dir poco marginale rispetto al compito dell’allevamento della prole, il padre ha comunque rappresentato nella famiglia la massima espressione dell’autorità. Con il crollo dei grandi totalitarismi che dell’autorità paterna erano l’espressione simbolica, ha preso avvio un processo che nel periodo delle contestazioni giovanili del sessantotto ha definitivamente messo in discussione il principio di autorità paterna.
Tutti questi cambiamenti sembrano aver restituito una figura paterna rinnovata: siamo ormai quasi abituati alle immagini patinate di questi nuovi padri in atteggiamenti di tenerezza verso i loro figli neonati, coinvolti nelle mansioni di un quotidiano che la tradizione aveva esclusivamente attribuito alle figure femminili. La figura del padre sembra essere sopravvissuta ai mutamenti degli ultimi decenni proprio enfatizzando quei tratti di partecipazione alla cura dei figli che nella tradizione gli erano valsi, invece, la denominazione di “padre assente”. Messo in discussione nei suoi ruoli tradizionali, il padre è stato infine convocato ad una partecipazione, meno istituzionale e più esplicitamente affettiva, nella crescita dei figli.
Il pater familias ha rappresentato per secoli la funzione del padre all’interno della famiglia. In una rigida ripartizione di funzioni con il ruolo materno, preposto all’educazione più che alla cura dei figli, il padre ha rappresentato in seno alla famiglia la legge e l’ordine, la continuità della tradizione ed ha avviato la prole alla vita sociale. Una figura, quindi, che interviene nella vita dei figli in un secondo tempo. Sarà con la psicoanalisi freudiana che il ruolo paterno verrà riconsiderato in modo più completo e ne saranno poi mostrate le profonde funzioni rispetto allo sviluppo psichico dei figli, fin dalle epoche precoci della loro vita.
Molti termini psicoanalitici fanno ormai parte del linguaggio comune ed hanno finito per sostituire in modo approssimativo parole di uso corrente. Così come “rimuovere” è spesso usato come sinonimo di “dimenticare”, in maniera analoga, il “complesso di Edipo” è usato più che altro per indicare un eccessivo attaccamento alla figura materna. Seguendo queste brevi considerazioni sulla funzione del padre, è il caso di chiarire che per la psicoanalisi il “complesso di Edipo” sottende un elemento di novità che irrompe nella scena, un passaggio dal “due” del rapporto madre-bambino al “tre” che si realizza, appunto, con l’entrata in scena della figura paterna. Se nelle origini mitologiche di questo concetto psicoanalitico la comparsa del padre è riferita alla proibizione dell’incesto (S.Freud, 1913), secondo un’ottica riferita allo sviluppo psichico del bambino la funzione della figura paterna che rompe il sodalizio madre-bambino è più che altro rivolta ad un passaggio evolutivo che si realizza nel distogliere il bambino da un vissuto di totale e continua disponibilità della figura materna. Uno stato mentale che prende origine dall’allattamento e che se non trovasse nel “terzo incomodo” paterno un’esperienza di limite renderebbe un figlio poco adatto a vivere in una realtà che prevede inevitabilmente rinunce, attese e frustrazioni. Un padre che contende l’esclusivo possesso della madre e che fa tramontare la fantasia del bambino di essere un tutt’uno con la madre svolge una funzione separativa, permettendo l’instaurarsi di una realistica distanza che crea i presupposti per le future identificazioni. Bisogna pensare a questa funzione paterna non soltanto come esercitata da un padre in carne ed ossa ma anche come una funzione presente nella mente di una madre che, orientata verso un progetto evolutivo, vede nell’esperienza della separazione un passaggio importante e necessario nella vita di suo figlio, qualcosa che le consentirà di tollerare con maggiore serenità le proprie inevitabili indisponibilità alle richieste del figlio. Ma la funzione del padre inizia ancor prima della nascita di un figlio. Già durante la gravidanza egli è chiamato a svolgere una funzione contenitiva, condividendo con la sua compagna le ansie e le preoccupazioni che le trasformazioni corporee della gestazione possono generare, così come sarà chiamato, alla nascita del figlio, a svolgere una funzione protettiva per la delicata esperienza della coppia madre-bambino.
Questa nuova esperienza di vicinanza può sprigionare vissuti spesso difficili da conciliare con i tratti di una identità maschile ancora venata dai lasciti della tradizione. L’avvicinamento dei padri all’intimità dell’esperienza della maternità può far balzare in primo piano più espliciti sentimenti di tenerezza o di esclusione, se non di gelosia o di invidia, sentimenti a cui è spesso difficile dare una collocazione. Quella del divenire padri è diventata quindi un’esperienza complessa che investe livelli profondi dell’identità maschile.
Se la figura materna è impegnata in una più intensa partecipazione alla vita sociale che la costringe ad esitare meno a lungo nelle cure primarie della prole, il padre si allontana dagli antichi fantasmi dell’autoritarismo diventando spesso una figura amicale per i figli. Da queste nuove figure genitoriali crescono nuovi figli modellati da precoci richieste materne sul piano dell’autonomia e delle prestazioni, figli assai poco conformati in relazione ad un principio di autorità, sicuramente poco inclini ad accettare le norme costituite, le opinioni e l’operato stesso dei genitori. Tutto ciò produce una contrapposizione generazionale più esplicita ma espone anche le nuove generazioni ad un bisogno di protezione che si traduce molto spesso in una ricerca di rassicurazione attraverso il successo economico e nel perseguimento di obiettivi socialmente riconosciuti.
In definitiva, il contraccolpo delle trasformazioni socio-culturali della figura paterna da un lato espone l’uomo ad una rivisitazione profonda dei canoni della propria identità e dall’altro rischia di imporgli un radicale allontanamento dai fantasmi dell’autoritarismo degli antichi padri attraverso la totale rinuncia a qualsiasi tratto di autorevolezza. Sembra che il padre debba trovare un nuovo modo di svolgere il proprio ruolo attraverso la possibilità di rappresentare anche quella funzione di limite che, senza risvegliare le ombre del padre-tiranno, possa costituirsi come elemento che orienti e protegga la crescita dei figli.
Bibliografia
Freud S. (1913), Totem e Tabù in O.S.F., vol.7, Boringhieri Ed. 1974.
Guerriera C., Il padre nella mente, Idelson-Gnocchi Ed., Napoli, 1999.
Quagliata E. (a cura), Essere Genitori, Casa Editrice Astrolabio, Roma, 2010.
Quilici M., Storia della paternità, Fazi Editore, Roma 2010.
Ugarte U., Un padre (romanzo)- Zero91 Ed., Milano, 2009.
Genitorialità (Nuove)

Joaquín Lavado, in arte Quino, Mafalda
A cura di Carla Busato Barbaglio
Nuove forme sociali, nuove identità relazionali
‘Le persone usano il linguaggio non solo per segnalare stati emotivi o confini territoriali ma anche per influenzare la mente altrui. Il linguaggio è uno strumento squisitamente adatto per descrivere luoghi, persone, altri oggetti, eventi e perfino pensieri ed emozioni. Lo usiamo per descrivere il passato e anticipare il futuro, per raccontare storie immaginarie, per lusingare ed ingannare’ (M.C. Corballis). Una delle caratteristiche del linguaggio come afferma Whitehead è la ‘generatività’. Le nuove forme sociali, almeno nella loro consolidata prassi quotidiana, sono generative di nuovi linguaggi che attivano la necessità di ascolto e di studio: ‘nuovi fatti’ nella complessità relazionale.
Riporto di seguito alcune affermazioni che in modo plastico rendono le novità della vita dell’oggi.
Mamma, ma lui è mio fratello? No, risponde la mamma, che cosa ti viene in mente mica è nato da me. E allora che cosa è per me? Mah, risponde la mamma un po’ confusa, è un ‘semi cugino’. Dopo poche ore Matteo, 7 anni, si ritrova con degli amichetti e con molta fierezza presenta il nuovo arrivato dicendo: E’ il mio semi- cugino. Con molta serietà tutti si salutano e si rimettono a giocare.
Federica 9 anni viene portata in consultazione perché aveva sempre creduto che Roberta fosse sua sorella e invece realizza improvvisamente che è figlia sì del padre, ma non della mamma. E’ molto turbata, si sente tradita e non sa più bene lei di chi sia figlia.
Roberta 26 anni racconta tra le lacrime che a sette anni mamma e papà si sono separati e mamma è andata a vivere con una signora da lei chiamata zia. Papà aveva un’altra moglie. Tra le lacrime dice ma si figuri dottoressa come a Natale potevo fare il presepe?
Dottoressa, racconta con aria tra il malizioso e il turbato Roberto di 8 anni, sono andato a dormire da papà e sotto al cuscino ho trovato una camicia da notte che non avevo mai visto. E sono sicuro: assolutamente non era di mamma.
Non so più chi sono, dice una ragazza adottata, mi hanno presa e poi ognuno si è rifatto una vita, ma io di chi sono? Per giunta sono di colore, mi guardo allo specchio e rimango male mi vorrei bianca.
E ancora Roberta 16 anni. Mio padre mi mette a parte della sua nuova vita compresi i particolari dei suoi rapporti fisici….Mi ha anche confidato che la sua bella ha avuto un aborto spontaneo e che sta tanto soffrendo, ma chi se ne frega. La odio, li odio…
I miei genitori sono schegge impazzite, dice Donatella 14 anni: una non mangia, l’altro mi chiede aiuto per coprirlo e farlo uscire con la fidanzata. Io ho tutti i miei casini: che faccio?
Flash che in positivo o in negativo interrogano comunque il mondo degli adulti e interrogano il nostro pensare situazioni che sono diventate molto più complesse e che richiedono forse nuove riflessioni, studi, proposte.
Questi piccoli flash e molti altri che potrei aggiungere parlano di nuove configurazioni familiari e di diverse espressioni di genitorialità. Linguaggi che, se pur per certi aspetti indicano situazioni conflittuali che potevano clandestinamente esserci anche nel passato, ora immettono in narrazioni e linguaggi che realmente sono dicibili.
Tra genitorialità e coniugalità
Si è passati da un sistema familiare nel quale la funzione coniugale e quella genitoriale coincidono, ad una serie di ‘discontinuità rispetto al passato che vertono sulla non coincidenza tra genitorialità e coniugalità (la funzione genitoriale può essere esercitata in assenza della relazione coniugale); sulla non sovrapponibilità tra nucleo familiare e famiglia (famiglie allargate e ricostituite); sulla non omogeneità tra cultura famigliare e cultura della comunità sociale di appartenenza (coppie miste); sulla non consequenzialità tra genitorialità biologica e universo affettivo (case famiglia, comunità per minori); sulla non coincidenza tra ruoli familiari e ruoli di genere (coppie omosessuali). (P.Bastianoni e A Taurino).
Tutto questo è espresso in una pluralità e molteplicità di forme nuove e particolari. Troviamo ad esempio famiglie omosessuali accanto a famiglie etero, famiglie d’immigrati o miste con figli adottati con i canali internazionali…Oppure famiglie di diverse provenienze geografiche con figli di diversi nuclei familiari.
L’ultima legge che sancisce l’uguaglianza di tutti i figli, anche se nati fuori dal matrimonio firma in modo irrevocabile a livello istituzionale molti di questi cambiamenti e in qualche modo sancisce nuove narrazioni genitoriali rendendo il luogo della crescita più fluido. E in questa fluidità può esserci sia una maggior ricchezza sia un minor contenimento, sicuramente una difficoltà maggiore a concepire limiti e debolezze.
Una pluralità di forme nelle quali si declina il vivere, forme che cambiano la tessitura sociale, il modo di relazionarsi, di comunicare, di appartenere di crescere. Una tessitura più composita e più complessa. La genitorialità in questa prospettiva sempre più sembra non essere legata all’avere direttamente figli, ma al saperli crescere (bello a questo proposito il titolo di un libro di un nostro collega Marco Mastella: Crescere i figli degli altri), al proteggerli, all’entrare in sintonia con loro al sapere porre dei limiti accompagnarli nelle tappe evolutive che via via percorrono.
Dice Music nel suo bel libro ‘Nature Culturali’: ‘Noi tendiamo a usare parole come ‘veri e naturali’ per descrivere i genitori biologici e il confronto tra varie culture può essere utile per mettere in discussione i preconcetti riguardo all’inviolabilità del legame di sangue. Per esempio i Baatombu del Benin settentrionale non hanno una parola per definire i genitori biologici, e sia per i genitori adottivi che per quelli biologici usano il termine che equivale al concetto di dare alla luce.
Mi avvalgo solo di questa ricerca anche se ce ne sono molte altre interessantissime che ci parlano di crescite diverse in culture diverse. Certamente la nostra cultura occidentale propone e studia le relazioni di attaccamento madre bambino in modo sempre più puntuale nell’essenzialità del crescere nella relazione e nella comunicazione. Direi che proprio partendo dall’essenzialità di ciò che serve per crescere si possono aprire interrogativi al declinarsi delle nuove forme del dare alla luce o crescere i figli anche degli altri.
Gli ultimi studi sulla competenza dei neonati ci dicono che i bambini cercano sguardi fin dai primi momenti della vita, proprio per suscitare risposte positive che garantiscano la sopravvivenza…poi diventano bravi, crescendo, a capire chi può fornire loro cure e sostegno.
In questa prospettiva anche una coppia omosessuale può garantire quanto detto prima. Rimane, da tenere saldamente in considerazione, che un eventuale figlio è molto esposto a pregiudizi e discriminazioni anche a volte per primo nella struttura mentale della coppia stessa. Alice Miller nel suo libro ‘La rivolta del corpo’ mette in luce, aggiungendo un dato in più riguardante l’ambiente, il conflitto tra i sentimenti che proviamo (che il nostro corpo ha registrato) e quelli che vorremmo provare per vivere in armonia con le norme morali interiorizzate….’La madre costretta a riconoscersi incapace, nonostante ogni sforzo, di amare il suo bambino a causa della carenza affettiva vissuta nella propria infanzia, deve fare i conti con il rimprovero di essere ‘immorale’ se vuole articolare quella sua verità. Tuttavia, a mio parere, il fatto stesso di riconoscere i propri veri sentimenti, indipendentemente da ciò che pretenderebbe la morale, la metterà in grado di sostenere se stessa e il bambino, spezzando la catena dell’autoinganno’.
Non solo c’è lo sguardo della madre verso il bambino sin dal concepimento, o si potrebbe dire ancora meglio la qualità, la tonalità emotiva dello sguardo, ma a questo si aggiunge e a volte si sovrappone come una cappa difficilmente scrollabile lo sguardo dell’ambiente, un manto culturale, che avvolge e permea la vita. Sguardo che però ha perso il contatto con la vita stessa, con i bisogni centrali dell’essere e che spesso funziona su norme e regole a cui attenersi più che ad uno scambio profondo ed intimo. E tutto questo vale logicamente per ogni bambino, collocato nei più diversi ambienti, ma tocca maggiormente tutto ciò che si scosta dal conosciuto, dal vissuto dall’ esperimentato.
Diversi per sempre?
Per esempio tutto questo si evidenzia per i bambini di colore adottati. Come stare in una società per la quale il colore della pelle è ancora e troppo la rappresentazione di un figlio di un Dio minore? Ciò che è capitato in Italia in questi ultimi mesi da notizia a grandi lettere della qualità razzista che ancora alberga tra noi e che poi serpeggia nella quotidianità in una infinità di comunicazioni a vari livelli. Il bambino adottato anche quando è visto quale frutto di ‘un’opera buona: come sono bravi i genitori, nel tipo di comunicazione viene veicolato il marchio della diversità.
E questo introduce appunto il tema della diversità e delle diversità. Un ragazzo eritreo figlio di una coppia di eritrei che come lavoro facevano servizi nelle famiglie è stato da me seguito in terapia. Per questo ragazzo sradicato dalla sua terra, dai riti, dalle sue tradizioni e inserito in una cultura che pur facendo lui l’università era comunque stigmatizzante, il darsi un’identità appariva molto complesso e la sua crescita all’interno di un contesto genitoriale, pure impastato di sradicamenti e senza punti di riferimento contenenti, passava per angosce e vissuti persecutori paralizzanti.
Come essere genitori e figli sradicati dalla propria terra di origine? Come radicarsi in un ambiente che possa costituirsi come ‘patria sostitutiva’ così chiamata dal gruppo di comunità africane che si riuniscono a Roma?
Pensavo anche ad una mia esperienza di osservazione in un ospedale in sala travaglio dove stavano per partorire donne di culture estremamente diverse. Signore cinesi che vivevano il tutto nel silenzio più assoluto e senza battere ciglio, signore rom che con le loro urla strazianti accompagnavano i movimenti del corpo. Bambini il cui arrivo al mondo avviene con modalità assolutamente diverse in ritualità lontane e per certi aspetti incomprensibili agli stessi operatori.
Ora tutto questo accade ed è tra di noi. Nella nostra vita, nella vita dei nostri figli e nipoti.
Se la genitorialità come ci dicono alcuni studi è legata a narrazioni nel senso di patrimonio interiorizzato di eventi emozioni, schemi mentali, sistemi comportamentali, culture diverse; l’esperienza vissuta dall’individuo immagazzinata nella memoria diventa parte di un sistema comportamentale di essere che contribuisce alla costituzione dell’identità.
Ora i nuovi linguaggi, le nuove modalità narrative della genitorialità, la pluralità delle forme: la monogenitorialità, la bigenitorialità, la plurigenitorialità sia per chi li vive in una dimensione piuttosto che nell’altra costituiscono un nuovo habitat narrativo e comunicativo estremamente diverso dal passato.
A me sembra che quello che sta avvenendo ci immette in situazioni di maggior precarietà di limiti, confini contenitori e ci chiama ad un riflettere continuamente in quella che viene definita ‘l’incertezza costante’ nel senso che tutto sta dentro una continua negoziazione. Una capacità, una funzione riflessiva a vegliare sulla crescita in tempi nei quali non c’è spazio -tempo al costituirsi saldamente di questa funzione.
In questo momento storico di grandi cambiamenti, o meglio nel nostro mondo liquido-moderno sempre citando Bauman, viviamo un’epoca in cui ‘attendere’ è diventata una parola oscena Abbiamo gradualmente sradicato, per quanto possibile, la necessità dell’attesa, la parola che preferiamo è ormai l’aggettivo ‘istantaneo’. Non abbiamo più dodici miseri minuti da dedicare a cuocere il riso nella pentola, e allora per farci risparmiare tempo è stata realizzata una versione di riso che si prepara nel forno a microonde in soli due minuti….Viviamo una vita costantemente a corto di tempo…. Ho ripreso questo stralcio simpatico dal volume ‘L’arte della vita’ in cui c’è un’analisi interessante dei meccanismi economici e di potere che guidano la nostra vita e che danno importanza sempre di più a delle necessità di consumo rispetto a valori sedimentazione e comprensione di comportamenti. Questo testo mi ha dato da pensare sul tempo per eccellenza di attesa che è la maternità. Come mettere insieme il tempo dell’attesa, normalmente di 9 mesi con il ritmo frenetico che viviamo? Come costruire grembo materno o costituire genitorialità nel vortice delle cose da fare, alle prese con i problemi lavorativi, con le analisi mediche che sembrano moltiplicarsi a dismisura con le diete che spesso si sente vengono suggerite… come se la maternità al posto di un tempo di contatto con sé, uno spazio di ridefinizione di sé, diventasse luogo di produzione di nuovi bisogni che portano lontano dall’interiorità e dalla possibilità di pensarsi. E questo per l’inizio della vita.
Nella disamina della molteplicità delle forme genitoriali non va tralasciato un piccolo accenno all’inseminazione eterologa. E’ questo un tema complesso che richiederebbe un tempo di approfondimento. Vorrei però segnalare, da quanto appreso dalla mia esperienza clinica, che il dare nascita a questo bambino e per nascita non intendo solo la gravidanza e il parto, ma maternità e paternità, può funzionare meglio a patto che i fantasmi ulteriori che questa esperienza immette nella coppia siano il più possibile presi seriamente in carico. E’ una partenza di vita in cui lo sguardo del genitore si appoggia spesso alla ricerca di un altro, un oltre la coppia, un qualcosa di misterioso che però è sempre presente. Lo sguardo non si ferma a ricercare nei tratti la continuazione di una storia, ma si corre il rischio di guardare oltre. Questo non facilita la vita di coppia, ma introduce elementi spesso non contenibili. Tra le varie storie che ho frequentato, interessante a questo proposito la vicenda di un paziente che più che trentenne viene a sapere di non essere figlio biologico di suo padre. Già tutti i suoi sogni prima della comunicazione ricevuta parlavano di questo, come se fosse inscritto nel suo DNA psicologico. Ma questa inscrizione non poteva essere avvenuta se non in quello che era circolato nella famiglia nelle sensazioni, percezioni emozioni e sentimenti. Tutte le strade sono percorribili purché si sappia il più possibile ciò che si sta facendo e quali ripercussioni può avere la gestione più o meno buona delle scelte. Inoltre rimane un interrogativo se queste inseminazioni non trasmettano delle difficoltà a cui ci troveremo di fronte nel futuro.
Inoltre ci si potrebbe chiedere se difficoltà di concentrazione e di apprendimento di moltissimi adolescenti abbiano un qualche tipo di collegamento tra l’inizio delle cure non materne e l’apprendimento scolastico. Ci sono delle ricerche del 2006 di Hungerford e Cox e anche di altri che segnalano una maggiore difficoltà a concentrarsi per i bambini inviati prima al nido rispetto a quelli che entrano più tardi. Ci sono anche studi rispetto alle cure non materne correlati alla distrazione più avanti nel percorso scolastico.
Un altro dato riguarda l’accudimento dei bambini secondo cure- non genitoriali molto in aumento per motivi di lavoro: asili, baby-sitter… Questo tipo di assistenza danneggia o cura i bambini? Certamente le ore che i bambini stanno al nido o con baby sitter spesso e sempre di più sono moltissime. A volte la maggior parte della giornata. Mio figlio di tre anni, mi raccontava una madre in analisi, parla con accento rumeno essendo la sua baby sitter di quella nazione. Anche su questo tema ci sono molti studi che prendono in esame vari aspetti…per esempio lo stress dei bambini nell’andare al nido. Sembra dimostrato che i bambini piccoli che vanno al nido hanno livelli di cortisolo dal 75% fino al 100% più alti di quando stavano a casa…indipendentemente sembra dal tipo di attaccamento. Certamente avere una figura di accudimento di scarsa qualità sia a casa che al nido peggiora di molto la situazione. Il problema riguarda la qualità stessa del nido che, come dice Music, è caratterizzata spesso dalla mancanza di mind-mindedness che invece potrebbe essere un elemento fondamentale al funzionamento di un contesto istituzionale di questo tipo tanto quanto lo sono le capacità psicologiche degli operatori.
Costruire la ‘noità’ tra io e tu
Vorrei tornare ora a ciò che mi sembra l’essenziale per la crescita di un bambino, fondamento anche del dare alla luce o crescere i figli degli altri.
La relazione non è solo la somma dell’io e del tu, ma una nuova comunicazione, inedita che promuove un modo di essere in fieri e sempre in movimento su un ‘noi’ da creare. Stern parlava non solo della nascita del bambino, ma della nascita della mente della madre per quel bambino. E’ un apprendere a sintonizzarsi, a capirsi, a intendere gli stati mentali gli uni degli altri, che avviene in modo complesso sia con passi sbagliati sia nelle modalità che consentono crescite migliori. Molte sono le ricerche attuali su quelle che Tronick (2008) chiama danze interattive, come una sorta di modello di regolazione reciproca, durante le quali entrambe le parti sono attive. E’ la costruzione di un ‘noi due’ che rende esistenti l’io e il tu. Ora è evidente che tutto questo in qualche modo permane. Lo stesso concetto di mente oggi, infatti, è cambiato. L’antica dicotomia cognizione- affetto è scomparsa e si va verso una lettura (simbolicamente rappresentata dal nastro di Moebius) in cui componente psichica e componenti biologiche sono una l’interfaccia dell’altra: quello che un bambino sperimenta di positivo o negativo resterà registrato, lascerà tracce. Alcune potranno essere richiamate, altre rimarranno non evocabili eppure attive nel creare nuove tracce. Si sa ora che esperienze positive aiutano la plasticità neuronale e facilitano le introiezioni. Si sa anche che cosa scatenano esperienze negative. C’è un profondo arricchimento nello studio integrato dei processi relazionali e correlati neurobiologici. Frans de Wall zoologo ed etologo, nel suo interessante libro l’Età dell’empatia, afferma appoggiandosi alla neuroscienziata Beatrice de Gelder, che ‘reagiamo agli atteggiamenti corporei con la stessa velocità con cui reagiamo alle espressioni facciali. Interpretiamo il corpo senza sforzo, cogliamo subito un atteggiamento di spavento… o uno di rabbia… Apparentemente ci fidiamo più degli atteggiamenti corporei che delle espressioni facciali. Però, continua l’autore, le esatte modalità con cui le emozioni sortiscono un certo effetto sulle nostre non sono state ancora completamente chiarite. E per questo chiama una sua idea ‘teoria della priorità del corpo’ cioè vuole che sia il corpo a dare il via al processo e che le emozioni si accodino. Il linguaggio corporeo degli altri ha un effetto sul nostro corpo, seguito da un’eco emotiva che ci fa provare le emozioni conseguenti. Più in là però sostiene che la faccia rimane la via maestra delle emozioni: offre la connessione più rapida con l’altro. C’è anche un interessante libro di Michael Corballis Dalla mano alla bocca in cui l’autore passando dall’antropologia, all’etologia alle neuroscienze alla linguistica e alla psicologia dello sviluppo ci dimostra come il linguaggio sia nato dal gesto…e come prima del linguaggio la comunicazione sia avvenuta in modo fattuale. Parlo quindi di danza relazionale quale metafora di un linguaggio psicofisico.
Riporto ora perché mi sembra serva alla riflessione che vado facendo un esempio che propone la Fraiberg in un lavoro degli anni 70 con i figli non vedenti di madri vedenti. Alcuni bambini si sviluppavano normalmente mentre altri apparivano isolati e asociali. La Fraiberg notò che alcune madri si staccavano dai figli e interagivano meno perché non comprendevano che con questi figli era necessario un linguaggio diverso e come effetto i bambini utilizzavano strategie di coping quali ritirarsi e concentrarsi più su sé stessi. Le madri si sentivano impotenti e interagivano sempre meno e così si instaurava un circolo vizioso. Quando le madri comprendevano il loro distanziarsi e riprendevano ad interagire con il corpo dei bambini, rinunciando al contatto oculare che è specificamente umano, i bambini ritornavano in relazione. Questo esempio mi sembra utile per introdurre alcune riflessioni su come noi terapeuti, insegnanti, giudici, pediatri e tutte le figure che hanno a che fare con la protezione e la crescita possono darsi da fare per ‘dare alla luce’ migliore qualità di vita.
Aggiungo a questo esempio un altro che ha a che fare con il difficile incontro adottivo che pone di fronte ad un limite, una mancanza, che comunque non è di per sé garanzia sufficiente per farsi madri per questa altra strada. E’ questo un doppio salto mortale; il tentativo di rendere familiare ciò che inesorabilmente nasce come estraneo…nei colori, negli odori nella gestualità…In un altro scritto parlavo di una madre che solo dopo anni si era accorta che non sentiva più l’estraneità della sua piccola figlia che dal momento dell’adozione aveva avvertito pesantemente come un odore che non apparteneva alla famiglia e non apparteneva alla casa. Con questa comprensione dava notizia che l’adozione per lei non era più solo una maternità della mente, ma era diventata una ‘maternità fisica’ una familiarità.
In un’altra situazione Sole, singhiozzando tra l’arrabbiato e il deluso, ripeteva che se avesse saputo che l’adozione era questo non l’avrebbe mai fatta e glielo sentivo ripetere anche di fronte al figlio sedicenne. Provavo dolore per lei e il ragazzo come se mi trovassi di fronte un’orfanità insolubile. E mi chiedevo quanto nella valutazione della domanda si era stati capaci di intravvedere le reali possibilità di questa famiglia di accogliere una storia in partenza così difficile. Già in un altro scritto mi sono occupata di questo. Segnalavo che l’abbinamento adottivo non parte dal corpo, dalla pancia che cresce nonostante tutto e costruisce al di là dei pensieri, ma si articola in un altro alfabeto relazionale che ha come componente all’inizio addirittura il rapporto tra la coppia e l’istituzione. Il linguaggio dell’intimità si avvia in modo assolutamente diverso. E’ un alfabeto che si costruisce, per certi aspetti, con poco ’luogo del dentro’ e il cui spazio include, a volte, anche pesantemente, ma inevitabilmente il fuori: altri contenitori, altre madri, orfanatrofi, psicologi, assistenti sociali, tribunale, ecc.: realtà non facile da reggere anche nelle situazioni più solide.
Quanto in ogni relazione per quanto complessa e diversa essa sia si ha nella mente il bisogno dell’altro, il suo momento evolutivo ciò che gli serve per la crescita e ciò che al contrario contribuisce a bloccarlo a tenerlo in una comunicazione, o meglio in una sintonizzazione negativa perché pur vedente non risponde comunque alle nostre aspettative o ai nostri bisogni. Questa sintonizzazione poi sarà foriera se continuamente ripetuta di difficoltà relazionali nella futura coppia e con i figli di altre sintonizzazioni malate. Lo stesso Bollas (1987) parla di pazienti che descrive come non nati dal punto di vista psicologico, che sono spesso cresciuti in famiglie dove i loro sé reali non sono stati rispecchiati o facilitati, con genitori poco sensibili alla realtà interna dei loro bambini. Definisce questi pazienti ‘normotici’ e sono pazienti che hanno una scarsa capacità di introiettare un oggetto, di identificarsi con l’altro o di entrare in empatia. Bollas dice che tali pazienti possono essere stranamente privi di oggetto. E piuttosto che proiettare un senso di morte, potremmo dire che sono psicologicamente insensibili, cosicché le parole piene di significato da noi espresse con vitalità ed energia possono diventare in un attimo private di significato. Tali pazienti non attaccano tanto il legame, in quanto non hanno ancora sviluppato sufficienti legami psicologici, cosa che pare vada di pari passo con la mancanza di connessioni sinaptiche, in particolare tra gli emisferi destro e sinistro del cervello (Siegel 1999). Per rimanere nella complessità ripeto anche l’affermazione della Blaffer quando sostiene che “affidare un bambino ad una allomadre non ha ripercussioni dannose, ne ha invece l’incapacità di convincerlo che la madre non lo abbandonerà mai”. Anche questo elemento del puzzle, con le dovute cautele è da tenere a mente nei vari percorsi sia adottivi che di nuove composizioni.
La ricerca e i progressi della competenza psicologica e psicoanalitica sembrano dirigersi sempre più al cuore di ciò che serve alla crescita, di ciò che la nutre. In questo senso più che alle forme che la vita familiare prende nelle diverse società, ai modi in cui si declinano funzioni che storicamente abbiamo definito materne e paterne, ciò che sempre più è da prendere in considerazione e ritenere fondamentale per la crescita umana è la costruzione di sintonizzazioni il più possibile sane sostenute da affetti caldi e profondi, germinativi di vita.
Bibliografia
Bastianoni P., Taurino A., Famiglie e genitorialità oggi. Nuovi significati e prospettive, Unicopli, Milano, 2007.
Blaffer S. Hrdy, Istinto materno, Sperling & Kupfer, Milano 2001, pag.399.
Bollas C., 1987. The Shadow of the Object: Psychoanalysis of the Unthought Known, Free Association Books.
Busato Barbaglio C., Mondello Ml., Tra femminile e materno: l’invenzione della madre. Milano Franco Angeli, 2008
Busato Barbaglio C., “Maternità fortezza da due debolezze?” In Desideri di maternità, Neri N., Rogora. C., Roma Borla, 2010.
Corballis M., Dalla mano alla bocca, Raffaello Cortina Editore, Milano 2008
De Gelder B (2006) Towards the neurobiology of emotional body language, Nature review of neuroscienze, n. 7 pp 242- 249.
De Wall F., L’età dell’empatia, Garzanti, Milano 2011 pp. 112-114.
Fraiberg S. (1982) Difese patologiche nell’infanzia, in Il sostegno allo sviluppo, Raffaello Cortina Editore, Milano 1999.
Hungerford, A., & Cox, MJ (2006).Family factors in child care research. Evaluation Rewiew, 30 (5), 631-635.
Miller A., La rivolta del corpo, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2005, p.12.
Music G., Nature culturali. Attaccamento e sviluppo socioculturale, emozionale, cerebrale del bambino Roma, Borla 2013
Siegel D. J., 1999. La mente relazionale, Raffaello Cortina, Milano, 2001
Tronick E., Regolazione emotiva, Raffaello Cortina Editore, Milano 2008.
Settembre 2014
Group Relations

David Hockney, Dancers VIII, 2014
A cura di Mario Perini
Il termine Group Relations (Relazioni di Gruppo) descrive il paradigma teorico e l’approccio operativo su cui si basa il metodo di ricerca, formazione e consulenza elaborato dal Tavistock Institute di Londra, noto anche come “psicodinamico-sistemico”. E’ un metodo centrato sull’esplorazione del funzionamento dei gruppi e dei sistemi organizzativi e sulla comprensione del comportamento degli individui al loro interno. Alla base delle Group Relations stanno assunti teorici provenienti dalla psicoanalisi, dalla teoria generale dei sistemi e da altre scienze sociali, e in particolare l’evidenza che i gruppi di lavoro oscillano costantemente tra l’orientamento a svolgere il proprio compito e quello a soddisfare i propri bisogni emotivi inconsci.
Tali assunti si possono riassumere nei termini seguenti:
1.Il gruppo nel suo insieme ha una propria vita psichica, che include desideri, ansie e strategie difensive.
2.Il gruppo usa inconsciamente i suoi membri per esprimere i propri bisogni emotivi e per mettere in atto le proprie difese.
3.I membri di un gruppo perciò di solito non sono padroni del proprio destino come credono, ma diventano in qualche misura strumenti del gruppo.
4.Il comportamento dell’individuo in gruppo è quindi sempre la risultante di due forze, i suoi bisogni personali e le pressioni generate dal gruppo.
5.Di qualunque cosa il gruppo stia parlando, in un certo senso sta anche parlando di sé, e ciò permette di comprenderne il funzionamento esplicito e implicito e di aiutare i membri a diventarne consapevoli.
6.Nei sistemi organizzativi i gruppi di lavoro vanno incontro ad ansie collettive e a fenomeni regressivi, in relazione al loro compito, ai rapporti tra individuo e gruppo o tra la persona e il ruolo che svolge, alle tensioni connesse con l’autorità, il potere, la leadership, i processi di confine e le situazioni di cambiamento.
7.Le forze inconsce che influenzano il comportamento organizzativo, la loro tipologia, intensità e frequenza, dipendono da variabili quali la dimensione del gruppo, le caratteristiche dei membri, i modelli di leadership, il compito specifico, la cultura dell’organizzazione e il contesto sociale, politico ed economico in cui opera.
La metodologia delle Group Relations permette di portare alla luce questi processi, di acquisirne maggiore consapevolezza e di sviluppare la capacità di gestirli nell’interesse dell’individuo e dell’organizzazione. L’apprendimento implicito in questo metodo – nelle sue applicazioni formative come in quelle consulenziali – non è primariamente di tipo cognitivo e razionale, ma si basa soprattutto sull’esperienza diretta e sulla comprensione emotiva dei processi gruppali e organizzativi vissuti dai partecipanti o dai clienti nel “qui-e-ora”, cioè nel momento stesso in cui si manifestano.
L’esempio più noto di questa metodologia formativa esperienziale è rappresentato dai seminari residenziali sulle relazioni di gruppo o Group Relations Conferences – come le “Leicester Conferences” in Inghilterra o in Italia i Seminari su Autorità Leadership e Innovazione (ALI), in passato conosciuti come “Seminari di Arona”.
Che cos’è una Group Relations Conference?
Le Group Relations Conferences sono “organizzazioni formative temporanee create per esplorare o studiare le tensioni inerenti alla vita di gruppo con l’impiego di un metodo di apprendimento di tipo esperienziale” (Armstrong 2002)
Come molti altri eventi seminariali le GRC hanno un programma, uno staff, sessioni plenarie e piccoli gruppi, ma per altri aspetti ne differiscono profondamente:
- La GRC è un laboratorio formativo “in tempo reale”, dove i partecipanti insieme con lo staff possono esaminare criticamente differenti modelli di funzionamento gruppale e organizzativo, diverse esperienze e comportamenti lavorativi, ed il proprio modo di assumere ed interpretare ruoli di leader o di follower all’interno del seminario.
- La Conference va considerata come una vera “organizzazione temporanea”, il suo staff opera anche come management e le sessioni in cui si articola sono progettate per rispecchiare contesti organizzativi reali e per promuovere consapevolezza e apprendimento dall’esperienza. Perciò non prevede lezioni o presentazioni teoriche, e i membri dello staff offrono ai partecipanti delle ipotesi di lavoro a partire dalla loro esperienza e comprensione di ciò che sta accadendo durante i vari eventi.
- Come ogni altra organizzazione ha un compito primario (primary task), che è quello di fornire opportunità di comprendere la natura delle organizzazioni attraverso la partecipazione alle varie sessioni e l’interazione con gli altri partecipanti e i membri dello staff in una sequenza di gruppi di lavoro e di riflessione sia separatamente sia nel contesto complessivo della Conference. L’assunto di fondo è che attraverso l’esame e l’interpretazione della loro esperienza nella Conference i partecipanti possano ampliare e approfondire la comprensione delle proprie organizzazioni di provenienza e dei ruoli formali e informali che svolgono al loro interno.
- La maggior parte delle GRC sono centrate sui temi dell’autorità, della leadership, della followership e dei processi organizzativi, ma altre si indirizzano ai più rilevanti problemi sociali contemporanei, come la sostenibilità dello sviluppo, la diversità, l’insicurezza sociale, le tensioni internazionali, la crisi del welfare.
- La GRC è un contesto volutamente interculturale: i partecipanti e i membri dello staff provengono da un ampio ventaglio di retroterra professionali e organizzativi (imprese, servizi sociali e sanitari, scuola e università, pubbliche amministrazioni, società di consulenza, volontariato e terzo settore, istituzioni politiche e religiose) e di solito anche da differenti Paesi.
- Alcune Conference di breve durata sono non-residenziali, ma la residenzialità è un elemento caratteristico e cruciale delle GRC: vivere e lavorare insieme per un certo tempo offre una preziosa opportunità di esplorare problemi personali e collettivi, e anche processi gruppali, istituzionali e culturali, nel momento stesso in cui nascono e si sviluppano, permettendo l’emergere di nuove idee e la possibilità di metterle alla prova prima nel contesto della Conference e poi al ritorno nel proprio contesto lavorativo e di vita.
- Il focus di una GRC non è sulla personalità individuale bensì sulle connessioni tra il comportamento dell’individuo e i processi psicosociali e sistemici in cui è coinvolto. Tuttavia parte dell’apprendimento sarà personale e potrà riguardare aspetti del funzionamento individuale, ad esempio il modo in cui precoci esperienze con l’autorità (dei genitori, degli insegnanti) possono aver influenzato il comportamento di una persona nel ruolo di leader o di follower all’interno di un’organizzazione o della società in generale.
Holding

Gustav Klimt Mother and Child
A cura di Maria Antoncecchi
Definizione
La parola holding (che deriva dal verbo to hold=tenere) è stata tradotta in italiano con il termine “sostenere” e si riferisce ad una funzione materna primaria necessaria allo sviluppo psichico del bambino. Il suo significato va da un senso strettamente fisico, come tenere in braccio l’infante, all’insieme delle cure ambientali volte a rispondere ai bisogni del bambino (per Winnicott i due significati si sovrappongono ).
Il concetto
Il concetto è inserito all’interno della teoria dello sviluppo emotivo di Donald W. Winnicott.
Egli parte dall’idea che c’è una fase in cui il bambino, o meglio l’infante (la parola infante si riferisce al periodo che precede la comparsa del linguaggio), dipende completamente dalle cure materne. La coppia madre-figlio costituisce un sistema unico, tanto che le cure materne e l’infante non possono essere considerati disgiunti. Questa condizione si crea nelle prime fasi del rapporto madre-bambino, quando non esiste un Sé separato dalle cure materne e l’infante si trova in una condizione di dipendenza assoluta .
Le cure materne si basano sulla sensibilità e sulla capacità empatica della madre che, grazie a uno stato mentale definito da Winnicott “preoccupazione materna primaria”, è in grado di identificarsi con l’infante e di rispondere ai suoi bisogni.
Winnicott parte dall’idea che le cure genitoriali soddisfacenti permettono al potenziale ereditario del bambino di accrescersi e svilupparsi e le suddivide in tre stadi che si sovrappongono:
a) il sostenere
b) la madre e l’infante che vivono insieme
c) padre, madre e infante che vivono tutti e tre insieme
Al primo stadio, quello del sostenere, sono collegati eventi complessi dello sviluppo psicologico.
Si tratta di esperienze che danno al bambino la possibilità di cominciare a esistere e di strutturare un Io personale. Le cure ambientali hanno sia la funzione di rispondere ai bisogni fisiologici del bambino (nei primi mesi di vita fisiologia e psicologia non sono ancora differenziate), sia quella di proteggere il bambino dalle pressioni del mondo esterno.
Quando le cose vanno abbastanza bene si costruisce nell’infante la “continuità dell’essere” che è il fondamento dell’Io che passerà da un iniziale stato non integrato ad un sentimento di unità nello spazio e nel tempo (integrazione).
Un ambiente emotivamente solido e sicuro protegge il bambino dalle interferenze interne ed esterne (impingments) che, secondo Winnicott, possono, se eccessive o troppo precoci, disturbare il processo di sviluppo.
Questo “isolamento protettivo” è importante in quanto permetterà all’Io dell’infante di crescere e rafforzarsi e di affrontare gli “urti” della realtà con gradualità.
Se la funzione di protezione non è svolta adeguatamente si determinerà una frammentazione del senso di esistenza personale che può generare una minaccia di annichilimento (angoscia di disintegrazione).
Per questo la madre deve saper cogliere l’evolversi dei bisogni fisici e psichici del bambino e sapersi adattare a tutte le piccole modificazioni che avvengono nell’infante a causa del suo sviluppo psico-fisico.
L’adattamento quasi totale della madre offre la possibilità al bambino di vivere un’esperienza di onnipotenza durante la quale crede di avere un potere magico sulla realtà.
In questa fase di sviluppo il bambino è esposto ad angosce impensabili come: andare a pezzi, cadere per sempre, essere senza alcuna relazione con il corpo, essere senza orientamento ed isolato.
Pertanto, se il bambino sperimenta un deficit nell’accudimento materno, può andare incontro a:
– distorsioni dell’organizzazione dell’Io.
– lo sviluppo di un autocontenimento difensivo (self-holding), cioè la costruzione di un falso Sé compiacente verso le richieste dell’ambiente. In alcuni casi il falso Sé può funzionare da involucro per nascondere e tenere segregato il vero Sé, la parte più autentica e vitale, consentendogli di continuare a vivere; in altri casi prevale una modalità imitativa che può costituire una minaccia per il vero Sé.
La capacità della madre di tenere in braccio il bambino (holding), la sua capacità di manipolarlo e maneggiarlo (handling, la fase successiva) consentono l’elaborazione immaginativa delle esperienze sensoriali e motorie che andranno a costituire il tessuto del vero Sé e il raggiungimento della coesione psiche-soma .
La pelle diventerà una membrana che delimita il confine tra “me” e “non-me”, tra esterno e interno. Il bambino sarà in grado di percepire se stesso e la madre come persone separate e avrà luogo quel processo che Winnicott chiama “personalizzazione”.
La qualità dell’ambiente e delle prime cure materne determinano dunque lo sviluppo e la qualità di un Sé autentico che, se ben sostenuto, sarà capace di essere creativo e di sentirsi reale.
In seguito il bambino potrà passare da uno stato di dipendenza assoluta ad uno stato di dipendenza relativa e, infine, allo stato d’indipendenza.
I tre stadi evolutivi elencati sopra corrispondono, per Winnicott, a tre importanti fenomeni psichici: l’integrazione (tenere in braccio), la personalizzazione (manipolare) e la relazione oggettuale, che corrisponde alla presentazione degli oggetti (object presenting) .
Il concetto di “holding” è stato di primaria importanza per definire quanto sia determinante la funzione della madre-ambiente per lo sviluppo dei processi primari nell’infante.
Bibliografia
Jan Abram”Il linguaggio di Winnicott” Franco Angeli Ed,Milano,2013
Donald W. Winnicott “Sviluppo affettivo e ambiente”, Armando Ed, Roma, 1970
Donald W. Winnicott “Dalla pediatria alla psicoanalisi”, Martinelli Ed, Firenze, 1975
Donald W. Winnicott “Sulla natura umana”, Cortina Ed, Milano, 1989
Ideale dell’Io

MASSIMO PULINI
Parole chiave: Ideale dell’io, Freud S., Chasseguet Smirgel J., Narcisismo
Ideale dell’Io e Io ideale
R. Musella
L’ideale dell’Io è un’istanza psichica che va differenziata dall’Io ideale e dal Super Io. Se l’Io ideale è erede del narcisismo assoluto, ovvero di quella condizione pre-oggettuale che precede qualsivoglia separazione tra soggetto e oggetto, l’ideale dell’Io poggia invece il suo desiderio sulla rappresentazione ideale dell’Io. Rappresentazione che, nella sua ambizione, restituirebbe al soggetto la soddisfazione narcisistica secondaria che, in fantasia, gli consentirebbe di lenire la sofferenza derivante dalla perdita del paradiso perduto. L’ideale dell’Io è posto quindi sul piano della rappresentazione dell’Io mentre l’Io ideale su quello dell’affetto.
Ritegno quindi necessario differenziare una dimensione affettiva da una rappresentazionale e considerare che l’ideale dell’Io, attraversa l’Io per investire una rappresentazione ideale di se stesso e, contiene, in nuce, un progetto di identificazione: – Solo se fossi un re, un campione, un miliardario (mio padre) ecc. potrei sentirmi appagato. In questo passaggio c’è già il riconoscimento della perdita, – non sono un re (mio padre) ecc.-, e della rinuncia, oltre quello della frustrazione e del limite.
Lo scarto tra l’Io e l’ideale dell’Io è sempre giudicato e messo in discussione dal Super Io, come misura dell’ambizione da raggiungere e come monito di quanto non è stato ancora fatto. Il rapporto tra l’Io e l’ideale mediato dal Super Io funziona come la carota e il bastone per l’asino, spingendo sempre in avanti la realizzazione del progetto da raggiungere e comunque, ad un certo livello, sostenendo il narcisismo di vita. Come afferma J. Chasseguet Smirgel (1975) dietro l’ideale dell’Io c’è sempre un progetto.
Freud afferma: “ciò che egli (l’uomo) proietta avanti a sé come proprio ideale è il sostituto del narcisismo perduto dell’infanzia, di quell’epoca, cioè, in cui egli stesso era il proprio ideale” (Freud OSF 7, 464). Lo stesso Freud non ha mai tracciato una differenza tra Io ideale e Ideale dell’Io (in verità in Freud neanche i confini tra ideale dell’Io e Super Io sono del tutto delineati), cosa su cui invece si sono confrontati diversi autori postfreudiani (su tutti D. Lagache, 1955)
É lecito domandarsi se l’ideale dell’Io sia un’istanza che deriva dalla differenziazione del soggetto psichico da una condizione di iniziale indifferenziazione o se l’ideale dell’Io è un derivato dell’Io inteso come istanza.
La questione incrocia a vari livelli la teoria del narcisismo, il quale è esso stesso spesso vittima di un’ambiguità concettuale che lo vede diviso tra l’essere il derivato originario della differenziazione primaria tra soggetto e oggetto e l’essere l’effetto dell’investimento libidico dell’Io (Das Ich) inteso come istanza.
L’alternativa teorica si potrebbe risolvere rispolverando la differenziazione tra narcisismo originario e narcisismo secondario. Di qui se ne evince che l’Io ideale sembra essere l’erede del narcisismo originario: una traccia precoce, espressione della condizione di indifferenziazione primaria che non prevede separazione tra soggetto e oggetto, e rimanda ad una esperienza primitiva che lascia un’iscrizione nello psichismo e un anelito a recuperare l’affetto del paradiso perduto.
L’ideale dell’Io sembra invece una formazione più matura e organizzata, derivata dal narcisismo secondario, una sotto istanza psichica al confine tra l’Io e il Super-Io che propone una direzione al primo per essere amato dal secondo.
Come già ho avuto modo di rilevare in un precedente contributo (Musella, 2017) è necessario chiarire nel contesto della teoria del narcisismo, da cui deriva l’investimento di una istanza ideale dell’Io, quale direzione dare alla definizione stessa dell’Io. Come afferma giustamente Hartmann (1956), c’è una certa ambiguità concettuale riguardo la definizione dell’Io nell’opera freudiana. Per quanto la distinzione possa sembrare elementare, l’attenzione che pone Hartmann nel distinguere l’investimento dell’Io, inteso come istanza, dall’investimento dell’Io inteso come individuo, come soggetto distinto dall’oggetto, risulta dirimente per comprendere l’impianto metapsicologico rivisitato dalla teoria del narcisismo. Sembrerà chiaro che trattare degli investimenti libidici rivolti su di sé contrapponendoli agli investimenti rivolti agli oggetti, sarà ben diverso dall’affrontare economicamente l’investimento dell’Io inteso come istanza intrapsichica oggettualizzata.
Troveremo dunque una differenza sostanziale tra la rappresentazione ideale dell’Io inteso come istanza psichica e l’idealizzazione di un affetto soggettivo indifferenziato che non conosce separazione dall’oggetto. L’aporia di risolverà nel delineare due istanze del tutto differenti ma indubbiamente correlate che definiamo ideale dell’Io e Io ideale. La prima figlia dell’idealizzazione dell’istanza psichica differenziata dall’Es e dal Super Io e la seconda espressione dell’investimento ideale di un Io pre-oggettuale, beato nella sua condizione narcisistica originaria ed oceanica.
Nel mito di Narciso, narrato da Ovidio, l’altro non esiste, è una mera proiezione del soggetto sull’oggetto. L’ideale dell’indifferenziazione soggetto-oggetto piega Narciso alla sua illusione, la ninfa Eco non può che essere il suo riflesso, strozzata nella logica del desiderio di annullare l’oggetto. Quando Eco si palesa nella sua sostanza e non solo nella sua voce, Narciso, incapace di accedere alla relazione d’oggetto, la rifiuta. Se lo splendido ragazzo muore consumato per l’amore della sua immagine è perché la presunta libido che ha investito il suo Io ideale non è altro che un concentrato di pulsione di morte. Freud (1914) premette che il complesso di castrazione rompe il narcisismo originario del bambino e si domanda del destino della libido che investiva l’Io infantile narcisistico. Non tutto, dice Freud, può essere spiegato con gli investimenti d’oggetto e ipotizza che un’istanza psichica, l’ideale dell’Io appunto, sarà il depositario degli investimenti abbandonati e costituirà per l’apparato psichico l’erede del narcisismo perduto, il luogo cui l’Io ambirà per sempre ritornare: «L’uomo si è dimostrato ancora una volta, come sempre nell’ambito della libido, incapace di rinunciare a un soddisfacimento di cui ha goduto nel passato» (ibid., 464).
Ne risulta, in ultima analisi, che l’ideale dell’Io è ideale dell’istanza, con una sua rappresentazione e un progetto di identificazione, mentre l’Io ideale è traccia ideale della soggettività indifferenziata.
Chasseguet Smirgel J. (1975) L’ideale dell’Io, Raffaello Cortina, Milano, 1991
Freud S. (1914) Introduzione al narcisismo, OSF 7
Hartmann H. (1956). Evoluzione del concetto dell’Io nell’opera di Freud. In: Saggi sulla psicologia dell’Io. Torino, Boringhieri, 1976.
Lagache D. (1955) La Psychanalyse, Presses Universitaires de France
Musella R. (2017) Il problema economico del narcisismo, Rivista di Psicoanalisi, 2017, LXIII, 2
Identificazione
Identificazione
A cura di Gemma Zontini
L’identificazione si può definire come un processo psichico mediante il quale un soggetto acquisisce una qualità, un tratto, una funzione che appartengono ad un’altra persona trasformando sé stesso, totalmente o parzialmente, sul modello di quest’ultima. E’ un meccanismo psichico centrale per la costituzione ci quella che comunemente viene chiamata identità personale.
L’identificazione, anche nell’uso comune del termine, ha una valenza attiva (si identifica una classe di oggetti, si identifica una persona per esempio attraverso un suo documento personale, etc.) e una valenza passiva che più strettamente corrisponde al meccanismo psicologico sopra definito (Lalande 1971).
A ciò va aggiunta l’opportunità di distinguere l’identificazione secondo il senso, il verso, cui essa si conforma. Così, esistono identificazioni centrifughe, in cui un soggetto identifica l’altro alla propria persona e identificazioni centripete in cui il soggetto identifica sé stesso con un’altra persona. Talvolta nello stesso meccanismo identificatorio sono presenti entrambi i vettori: questo sembrerebbe essere ciò che accade nelle identificazioni presenti nei gruppi e nelle masse umane.
Il concetto di identificazione, già a partire dalla riflessione freudiana (Freud 1921, comporta alcune problematiche ad esso strutturalmente inerenti.
Relativamente a tali problematiche, è da sottolineare in primis il legame tra identificazione e investimento oggettuale.
Infatti, l’identificazione può 1) rappresentare una forma originaria di legame affettivo con l’oggetto. Si tratterebbe qui di un’identificazione primaria, preedipica che si compie in presenza dell’oggetto (Freud 1921). Oppure può 2) rappresentare un sostituto costituito nell’Io (e in questo senso narcisistico) di un legame oggettuale abbandonato. In tal caso, si parla di identificazioni secondarie conseguenti al tramonto del complesso edipico che si compiono in assenza dell’oggetto (Freud 1922). Possono, poi, 3) esistere identificazioni che non hanno a che fare con l’investimento libidico dell’oggetto, ma con la presenza di uno o più elementi comuni tra soggetti, come accade nei casi di “contagio” isterico Freud 1921, Gaddini 1969). Infine, l’identificazione può 4) avere a che fare con l’acquisizione di aspetti ideali in cui tratti dell’oggetto possono concorrere alla costituzione dell’Ideale dell’Io o l’oggetto in sé può essere messo al posto dell’Ideale dell’Io (tipo di identificazione maggiormente visibile nei gruppi e nelle masse). Anche in quest’ultimo caso, l’elemento di investimento libidico dell’oggetto sembra essere in secondo piano nel processo identificatorio (Freud 1921), riguardo al quale sarebbe piuttosto in primo piano la problematica sublimatoria.
A titolo di esempio di questo tipo problematicità inerente il rapporto tra identificazione e relazione oggettuale, propongo qualche spunto di riflessione sul concetto identificazione primaria. Essa viene descritta da Freud (1921) come una forma arcaica di relazione con l’oggetto che avvia e addirittura precede la scelta dell’oggetto da investire libidicamente. La problematicità di un simile concetto sta, ad esempio, nel concepire che ci possa essere un rapporto identificatorio con oggetti che appartengono all’ordine della filogenesi e non dell’ontogenesi, oggetti che, dunque, appartengono al passato della specie e non dell’individuo e che funzionano non come oggetti di piacere/dispiacere ma come modelli del percorso di ominazione. Questo problema è particolarmente presente nel concetto di identificazione al padre della propria personale preistoria (Freud 1922). Sempre a titolo di esempio, un’altra problematica concernente il rapporto tra identificazione e investimento oggettuale si ritrova nel concetto di identificazione proiettiva (Klein 1946). In essa il presupposto per la messa in atto dell’identificazione è il riconoscimento precoce di un oggetto percepito come altro da sé. In altri termini, l’oggetto come altro separato e diverso viene posto all’inizio della vita psichica e non al termine di un percorso evolutivo che culmina con il complesso edipico. Quest’ultimo, piuttosto, viene conseguentemente antedatato. Va infine anche notato che questo elemento di posizionamento in epoche più o meno precoci dello sviluppo psichico del riconoscimento della separatezza dell’oggetto condiziona a sua volta il vettore centripeto (qualcosa dell’oggetto viene portata nell’Io) o centrifugo (qualcosa dell’Io, del soggetto, viene esportato nell’oggetto), che è consustanziale al processo identificatorio.
Un altro tipo di problematicità intrinseca al concetto di identificazione è quella concernente il rapporto che intercorre tra l’identificazione e altri meccanismi difensivi e/o costitutivi dello psichico: che tipo di rapporto l’identificazione contrae con l’incorporazione, che sembra rappresentarne in un certo senso la controparte, il modello somatico (Freud 1912, Abraham 1924)? E con l’introiezione, che, a sua volta, sembra costituire la controparte psichica dell’incorporazione, il modello psichico rappresentativo del modello somatico incorporativo? Quindi, dove può risiedere o cosa può stabilire una differenza tra incorporazione, introiezione e identificazione? Freud, del resto, per molti riguardi usa i termini introiezione e identificazione in maniera piuttosto intercambiabile, mentre Ferenczi (1909) e Abraham (1924) ignorano quasi totalmente il termine identificazione a favore quasi esclusiva dell’uso del termine introiezione.
Per chiarire questo livello di problematicità, può essere utile approfondire il rapporto che l’identificazione contrae con l’interiorizzazione. L’interiorizzazione è un meccanismo generale che si attiva ogniqualvolta una relazione interpsichica si trasforma in una relazione intrapsichica, sussumendo nella sua processualità tutti i meccanismi che ruotano intorno ad essa (incorporazione, imitazione identificazione)? Oppure l’interiorizzazione è un meccanismo che si attiva come premessa, processo preliminare, dell’identificazione, poiché per mettere a segno un’identificazione è necessario che un oggetto esterno, cioè presente in una relazione esterna, sia stato almeno parzialmente interiorizzato?
Un altro aspetto problematico, poi, è il rapporto imitazione-identificazione (già sopra di sfuggita accennato). L’imitazione sembra essere un meccanismo identificatorio che si attiva molto precocemente, all’alba della vita psichica (Gaddini 1969). Il suo scopo è quello di veicolare il desiderio di tenere in vita un frammento di scena percettiva incluso nella relazione pulsionale con l’oggetto. In assenza dell’oggetto e all’apice della spinta pulsionale, l’imitazione recluta gli stessi schemi senso-motori che furono attivati nell’esperienza pregressa di soddisfacimento ottenuto grazie alla presenza dell’oggetto. E, tuttavia, l’imitazione è presente come dinamica identificatoria anche nella nevrosi isterica ed è evidenziata da Freud (1899) come meccanismo identificatorio costituente il III tipo di identificazione, quello concernente l’identificazione all’altro compiuta attraverso la percezione di un tratto, una situazione, uno stato emotivo comune al soggetto e all’altro/altri. Si tratterebbe in questo caso di una forma identificativa secondaria. Dunque, l’initazione è una forma primaria e arcaica di identificazione, è una forma secondaria ed evoluta di essa, è un meccanismo totalmente diverso, è una componente di un più generale meccanismo identificatorio?
Accenno, infine, al problema concernente la relazione tra identificazioni e strutture psichiche. Un primo problema riguarda l’istanza psichica in cui si compie l’identificazione. Per lo più il processo prende le mosse dall’Es, o meglio dalla sua parte che costituisce il rimosso, poiché l’identificazione si compie secondo una processualità prevalentemente inconscia e poiché essa costituisce un meccanismo difensivo attivato contro la perdita degli antichi oggetti d’amore che, proprio attraverso l’identificazione vengono per sempre conservati. Un punto per certi versi problematico riguarda proprio la struttura in cui il prodotto finale dell’identificazione si deposita, influendo in tal modo sul funzionamento della struttura stessa. Le identificazioni edipiche, ad esempio, secondo la teoria strutturale si depositano nell’Io. Ma contemporaneamente il loro compimento finale trova il suo luogo elettivo nel Super Io (Freud 1922). Ne deriva un rischio di collasso delle due strutture tale da obliterare la loro discernibilità. Per garantire quest’ultima Freud (1922) assegna un certo regime di passività alle identificazioni che si depositano nel Super Io e un regime a maggiore prevalenza di attività a quelle che si depositano nell’Io. Ancora più complesso appare poi il rapporto tra forme arcaiche di identificazione quali quelle che hanno a che fare la filogenesi come l’identificazione al padre della propria personale preistoria (cui ho già accennato in precedenza) e la struttura psichica nella quale esse portano a compimento il loro processo. Esse, infatti, paiono piuttosto identificazioni garanti di un modello su cui strutturare le istanze psichiche piuttosto che identificazioni garantite dalla presenza di una struttura psichica che possa, a sua volta, garantire a tali identificazioni di compiere il loro lavoro psichico.
Certamente, queste note non intendono rappresentare una disamina esaustiva e completa del concetto di identificazione e delle problematiche ad esso connesse. Esse cercano solamente di proporre dei punti di partenza per una riflessione sull’identificazione, la sua complessità concettuale, le criticità più o meno implicite più o meno esplicite che l’uso di un tale concetto comporta.
Bibliografia
Abraham K. (1924). The influence of oral eroticism on character-formation. In Selected papers of Karl Abraham. New York. Basic Books. 1953.
Ferenczi S. (1909). Introiezione e transfert. In Opere. Milano. Cortina. 1989.
Freud S. (1899). L’intepretazione dei sogni. O.S.F. 3.
Freud S. (1912). Totem e tabù: alcune concordanze nella vita psichica dei selvaggi e dei nevrotici. O.S.F. 7.
Freud S. (1921). Psicologia delle masse e analisi dell’Io. O.S.F. 9:
Freud S. (1922). L’Io e l’Es. O.S.F. 9.
Gaddini E. (1969). Sull’imitazione. In Scritti. Milano. Cortina. 1989.
Klein M. (1946). Note su alcuni meccanismi schizoidi. In Scritti 1921-1958. Torino. Boringhieri. 1978.
Lalande A. (1971). Dizionario critico di filosofia. Milano. Isedi.
Luglio 2016
Identificazione con l’aggressore
A cura di Cristiano Rocchi
Identificazione con l’aggressore in Sándor Ferenczi
Il concetto ferencziano di identificazione con l’aggressore, elaborato fra il 1932 e il 1933 nel suo “Diario Clinico” ( giornata 10 maggio) e in “Confusione di lingue tra gli adulti e il bambino” (1932) è decisamente più complesso di quello, forse più conosciuto, delineato successivamente (1936) da Anna Freud, in cui, detto in sintesi estrema, la vittima introietta l’aggressore, “assimilando l’esperienza angosciante”, e così, identificandosi, assume “il ruolo dell’aggressore e i suoi attributi” e “si trasforma da minacciato in minacciante”.
Per Ferenczi la reazione della vittima non consiste tanto nell’assumere, linearmente, il ruolo dell’aggressore per via identificatoria ed assumere quindi i suoi medesimi comportamenti. L’analisi ferencziana di ciò che accade alla vittima del trauma è fenomenologicamente profonda e dettagliata, è soprattutto, ed è questa la sua grandiosità, una descrizione “dall’interno”, generalizzabile ben oltre la tematica dell’abuso sessuale:‘I bambini si sentono indifesi fisicamente e moralmente, la loro personalità è ancora troppo debole per poter protestare, sia pure solo mentalmente; la forza prepotente e l’autorità degli adulti li ammutolisce, spesso toglie loro la capacità di pensare. Ma questa stessa paura, quando raggiunge il culmine, li costringe automaticamente a sottomettersi alla volontà dell’aggressore, a indovinarne tutti i desideri, a obbedirgli ciecamente, a identificarsi completamente con lui.’ (Confusione delle lingue tra adulti e bambini, 96).
La paura è tale che le reazioni di disgusto, odio, energica difesa, vengono inibite. Il bambino violato, terrorizzato dalla paura, anziché reagire e difendersi, tenderà a sottomettersi automaticamente. La vittima, sovrastata da un potere schiacciante e fuori controllo, non attiva una reazione di rifiuto o difesa, ma, soggiogata da una paura impotente, si sottomette alla volontà dell’aggressore. Come unica possibilità di sopravvivenza, la vittima abdica, rinuncia alla propria persona, consegnandosi all’aggressore ed identificandosi esattamente con ciò che egli si aspetta. Tende a sentire da un lato ciò che l’aggressore stesso sente, dall’altro ciò che l’aggressore vuole che la vittima senta. Può arrivare così ad anticiparne le mosse, per minimizzare il danno ed avere maggiori possibilità di sopravvivenza. Pare qui evocarsi l’Orpha che, secondo Nancy Smith (1999) è per Ferenczi “pura intelligenza che preserva la vita”; una sorta di “angelo custode” modellato sulle parti della personalità del soggetto, in sostanza, “una intelligenza inconscia priva di affetti” (135). Assistiamo quindi ad un processo di dissociazione, caratterizzato da uno svuotamento della mente della vittima per far posto alle percezioni dell’aggressore, cosicché l’esperienza è vissuta in stato oniroide, o come se l’evento dell’abuso venisse visto dall’esterno, fino alla totale negazione della realtà (G. Ceragioli, 2013).
Ed oltre alla fenomenologia dissociativa Ferenczi ne individua anche una di tipo “scissionale” che si manifesta nella personalità del bambino abusato: ‘Non c’è trauma né spavento che non abbia come conseguenza un accenno di scissione della personalità’ (ibid, 98). Tale scissione riguarda il suo (del bambino) sentirsi al tempo stesso innocente e colpevole finendo per perdere così fiducia in ciò che gli dicono i suoi sensi. Ciò pare favorito anche da una regressione a uno stato precedente: ‘Nessun psicoanalista si stupirà che la personalità del traumatizzato regredisca allo stato di beatitudine precedente all’evento traumatico e cerchi di fare come se quest’ultimo non si fosse mai verificato’ (ibid.); distanziare e dimenticare ciò che è accaduto ha lo scopo ovviamente di mantenere un buon rapporto con l’adulto (che continua ad essere amato nonostante sia stato origine di sofferenza). E’ il “terrorismo della sofferenza”: per mantenere un rapporto tale da ricevere tenerezza e sicurezza, il bambino è disposto ad assumersi le colpe degli adulti e divenire compiacente nei confronti dei loro desideri. In questo modo viene mantenuta una (buona) relazione, anche se l’adulto è disturbato. Possiamo così vederlo mettere in atto comportamenti come lo scomparire, il mimetizzarsi, usare il linguaggio della seduzione. La vittima sviluppa anche attitudini alla ipervigilanza ed alla estrema attenzione percettiva, emotiva, intuitiva che le suggeriscono i comportamenti per lei meno pericolosi. Su piano psicodinamico potremmo osservare che, introiettati, sia l’evento traumatico che il traumatizzante, scompaiono come realtà esterna e da extrapsichici divengono intrapsichici e inconsci, sottoposti così al processo primario “vale a dire ciò che è intrapsichico può essere, in base al principio di piacere, plasmato e trasformato in modo allucinatorio, positivo o negativo. In ogni caso l’aggressione cessa di esistere […] ed il bambino riesce a mantenere in vita la precedente sensazione di tenerezza” (ibid., 96). Il bambino però si sentirà enormemente confuso da tutto ciò; anche perché finirà così anche per introiettare il senso di colpa dell’adulto, che tende a far apparire come un’azione colpevole un gioco ritenuto fino a quel momento innocente. Difatti il partner adulto, tormentato dai suoi rimorsi di coscienza, ci dice Ferenczi, sarà freddo e brusco col bambino, gli dirà di non parlare a nessuno di ciò che è accaduto -perché deve rimanere un segreto tra loro due- cosa che acuirà la vergogna e la colpa nell’abusato, o addirittura l’adulto tenterà di convincere la vittima che nulla è avvenuto, negando la realtà e gettandola così nella confusione: il risultato di ciò sono “l’abbandono emozionale” e la “solitudine traumatica” (Diario clinico, giornata dell’8 agosto), in cui la vittima è gettata dal disconoscimento del suo vissuto e dalla dissociazione. Più strano, ci dice Ferenczi, è invece vedere all’opera il meccanismo di ‘progressione traumatica (patologica) o di precocità (patologica)’ (Confusione delle lingue tra adulti e bambini, 98) che implica che una parte della personalità si sviluppi in modo precoce, acquisendo caratteristiche dell’adulto sul piano emotivo ed intellettuale: ‘Viene da pensare a quei frutti che la beccata di un uccello ha fatto maturare troppo in fretta e reso troppo dolci…’ (ibid.); con questa stupenda metafora Ferenczi ci descrive con brevi tratti quello che aveva chiamato anche il ‘poppante saggio’ (1923), in cui “Il trauma può consentire a una parte della personalità di maturare improvvisamente, non solo a livello emozionale ma anche intellettuale” (ibid., 98.). Molti bambini, infatti, sviluppano una particolare capacità a riconoscere e assecondare i bisogni degli altri e arrivano ad occuparsene come se fossero degli infermieri o dei terapeuti, prendendosi cura dei loro adulti, prevenendo e cercando di lenire il disagio del genitore, anche per così tentare di mantenere una condizione di relativa tranquillità nella quale non si verifichino altri traumi.
Bibliografia
Ceragioli, G. (2013)L’odio nella relazione transfert-controtransfert come reciproca identificazione con l’aggressore in situazioni di grave abuso sessuale, Comunicazione presentata al Congresso dell’Associazione culturale Sándor Ferenczi “Il Diario Clinico oggi”, Firenze, 17-19 maggio 2013.
Ferenczi, S. (1923) Il sogno del poppante saggio, p. 184, vol. III, Opere, Cortina Editore, 1992.
Ferenczi S. (1932) Confusione di lingue tra gli adulti e il bambino, p. 91-100, vol. IV, Opere, Cortina Editore, 1992.
Ferenczi S. (1933) Diario Clinico, Cortina Editore, 1988.
Freud, A. (1936) L’Io e i meccanismi di difesa, Giunti Editore, 2012.
Smith, N. (1999) From Oedipus to Orpha: Revisiting Ferenczi and Severn’s Landmark Case, The American Journal of Psychoanalysis, vol. 59, Issue 4, pp.345-366.
Gennaio 2014
Identificazione Patologica

N.Samori, 2015
IDENTIFICAZIONE PATOLOGICA
(nella Struttura Narcisistica del Carattere)
A cura di Anna Oliva De Cesarei
I processi di Identificazione, nei differenti livelli di sviluppo, sono basilari per la strutturazione dello psichismo, costituiscono le basi dell’ identità e del senso di Sé, partecipano alla formazione del carattere, portano mattoni alla costruzione dell’Io, Super-Io, Ideale dell’Io e organizzano le funzioni della mente attraverso le primitive relazioni d’oggetto.
Delle diverse modalità della Identificazione, tenendo conto delle caratteristiche teoriche e cliniche (identificazione isterica, identificazione melanconica, identificazioni nella psicosi…), mi soffermerò su qualche nota introduttiva alla problematica specifica nelle identificazioni patologiche nella struttura narcisistica del carattere.
Identificazione primaria e secondaria
L’identificazione primaria costituisce per Freud (1921) la forma più originaria di legame emotivo con un oggetto,qualcosa di diretto, di immediato, di più antico di qualsivoglia investimento oggettuale (1922), e presuppone un livello psichico di indifferenziazione che fonda l’esperienza di “essere” nel bambino. L’attenzione della psicoanalisi contemporanea è centrata sulla interazione dello psichismo dei caregivers nell’holding; il lattante è a contatto fin dall’inizio con il modo di essere della madre sia nell’accudimento ma anche col suo alito vitale, lo psichismo della madre influenza le cure nell’holding. La possibilità di costituirsi di un ambiente interno è in stretta correlazione con un incontro sufficientemente buono con lo spazio psichico materno (l’impianto che la madre può dare al bisogno e al desiderio del bambino, come maneggia l’ansietà, il grado di costanza, come infonde la vita…); il bambino “pesca” nell’inconscio materno attraverso voce, contatto, movimenti corporei, sguardo, cercando la luce-vita. Il lattante recepisce il senso dato dalla madre (messaggi metabolizzati) ma anche come “è” la madre.
La struttura psichica si costituisce attraverso l’interiorizzazione dell’holding in uno spazio interno le cui caratteristiche sono molto legate a quanto spazio e risonanza hanno trovato bisogni, affetti, attività del bambino.
Se l’oggetto è sufficientemente buono e libero, accoglie i bisogni primari, favorisce lo sviluppo del desiderio e permette differenziazione e separazione, promuove lo sviluppo del pensiero con la possibilità di costruire rappresentazioni, aiuta il passaggio dalla relazione arcaica indifferenziata ad un uso mobile della identificazione secondaria, fondata sulla capacità di riconoscere e accettare l’alterità nella relazione; si avvia così una sufficiente libertà di essere, la possibilità di fruire di una fonte creativa, e la capacità di avviare nuovi e versatili investimenti oggettuali.
Vi è un continuum di sviluppo tra identificazione primaria e secondaria, in rapporto alla formazione o difetti di formazione dello spazio psichico interno, inteso come indice di che ricezione, ascolto e investimento abbia o meno avuto il bambino per il nascente Sé.
Ogni analisi esplora le complesse interazioni del senso di esistere con il desiderio e fantasmi dei genitori; come dice Kaës, siamo costituiti dal desiderio di un altro prima di noi e questo desiderio alimenta, a mio parere, la vitalità profonda dell’essere, la linfa che anima il respiro di base.
Identificazione patologica.
Freud (1914) aveva sottolineato come l’amore parentale non è altro che il narcisismo dei genitori tornato a nuova vita. Si instaura una coazione ad attribuire al bambino ogni sorta di perfezioni; egli deve appagare i sogni e i desideri irrealizzati dei suoi genitori.
Nelle fasi precoci dello sviluppo, quando non vi è differenziazione soggetto-oggetto, il bambino deve confrontarsi con un mondo strutturato di significati e di attese per lui incomprensibile. Quale incontro avrà “sua maestà il bambino” con le attese dei genitori?
Molti Autori Ferenczi, Aulagnier, Bonaminio e AA si sono soffermati successivamente sulla asimmetria dell’incontro primario, punto cardine di innesto della patologia narcisistica nell’incontro tra la competenza aperta del neonato e l’influenza delle proiezioni narcisistiche o impingement o mancate proiezioni dei suoi genitori: l’equilibrio o meno dell’incontro condizionerà in modo determinante il processo di differenziazione tra Sé e non-Sé, la possibilità di apertura alla percezione dell’ “altro” nell’oggetto della relazione narcisistica.
La stabilizzazione di una fiducia di base fonda un pavimento psichico, uno sfondo su cui possono poi appoggiarsi nuovi stimoli, immagini, sensazioni, ricordi ecc. ; abbiamo la struttura “spaziale” per l’iscrizione di una scena psichica in un registro rappresentativo. La metafora del notes magico, con una superficie-sfondo su cui vengono registrate le tracce, rende bene la mobilità necessaria al sistema per poter essere aperto a successive ricezioni e acquisizioni.
Se vi è un grave intoppo o mancanze nella funzione di schermo, sotto la pressione dell’urto, “impingement”, la caduta è rovinosa, vi è blocco della temporalità e immobilizzazione, un’invasione di angoscia o di diffidenza opera un arresto totale, mentre la coazione a ripetere testimonia un impatto violento che frattura la ritmicità, “in un’area sospesa tra la vita e la morte” (Freud 1919). Si creano buchi nella trama della rimozione primaria; una irruzione precoce di qualcosa che sia “non-Sé” causa una lacerazione insostenibile, sanabile solo attraverso dissociazioni e stati di deafferentazione sensoriale (sordità e cecità psichica ).
Nel blackout, nello squarcio sullo sfondo, vi è uno sradicamento di ricordi con una memoria bianca su delle pagine importanti, come dice A. Green (1992), non esiste lo schermo per quel trauma specifico e non ci sono quindi le premesse per istituire una scena psichica.
La frattura del pavimento psichico, con irruzione dell’altro e frattura precoce Sé non-Sé, porta a constatare, come dice A.Green (2004), l’assenza di formazioni intermedie, ossia di formazioni dell’inconscio propriamente detto, domina l’Es.
Di fatto, si apre la porta agli automatismi, a “memorie” nel soma, agli agiti, al sonno come valvola che chiude tutto.
Gli effetti di un disturbo di questo primo incontro appaiono rilevanti nelle identificazioni narcisistiche, che inibiscono o bloccano del tutto la capacità di sviluppo necessaria per losviluppo di una identità personale. H. Faimberg (1995) ha descritto le identificazioni inconsce alienanti, non c’è spazio psichico affinché il bambino possa sviluppare la propria identità, libero dal potere alienante del narcisismo dei suoi genitori.
Per J. Badaracco, in fasi molto precoci dello sviluppo, con poca differenziazione soggetto-oggetto, si stabiliscono identificazioni patologiche invadenti o totalmente intrusive nei confronti di un Io fragile e immaturo, il quale – non potendo difendersi – deve mimetizzarsi, trasformarsi nell’altro perdendo completamente le proprie caratteristiche personali. Una tale identificazione diventa alienante perché l’Io, perdendo completamente le proprie possibilità, viene sostituito da un oggetto estraneo invadente che se ne impadronisce, come in una possessione demoniaca.
Sviluppi. Una prospettiva.
In un mio scritto (Oliva De Cesarei A., 2010), ho pensato di suddividere i pazienti con una struttura narcisistica del carattere che ho avuto in analisi, in due gruppi; il problema centrale è quale grado di estraneità, di alter, è sopportabile per il bambino, in relazione al budget di esperienza di rapporto di cui dispone, nel momento e nel modo in cui incontra nella sua storia l’oggetto traumatico.
Un primo gruppo comprende nella struttura identificazioni bidimensionali, è caratterizzato da identificazioni fuse del Sé e dell’oggetto, “vittima” e “aggressore” sono un tuttuno; l’analista è catturato in una amalgama indifferenziata con le identificazioni del paziente, è l’oggetto arcaico gelato, instabile, che espelle…
Nel secondo gruppo, l’oggetto rifiutante o maltrattante…con cui il paziente è identificato, è interiorizzato; vi sono parecchie differenze nelle caratteristiche dei pazienti, gradi e sfumature diverse nella patologia; nel corso della terapia, l’analista funziona da schermo di proiezione per le identificazioni del paziente.
La divisione in due gruppi è un punto di riferimento per descriverne caratteristiche specifiche, vi è un continuum di situazioni intermedie, là dove vi sono tratti indifferenziati conservati in ‘nicchie’ o in tratti del carattere non totalizzanti o nel soma…, accanto ad aree che possono evolvere in identificazioni patologiche del secondo gruppo.
Nei due gruppi, nella traslazione viene denegata l’esistenza dell’analista come individuo separato e differenziato.
La differenza fondamentale è nella presenza, o nella assenza o schiacciamento, dello spazio interno; disporre di uno spazio interno, significa essere almeno in parte a contatto con la sofferenza vissuta nell’infanzia. I pazienti del secondo gruppo, spesso non vogliono figli, oppure pensano all’adozione, poiché con un figlio loro, “dentro”, temono di ripetere nel ruolo capovolto le sofferenze subite, di avere un figlio che sia la loro copia, mentre un figlio “fuori”, che viene da lontano, introduce uno iato, un aiuto per differenziare, per stabilire una separazione anziché duplicare il genitore patologico. Nei pazienti del primo gruppo, proprio perché sono fusi e confusi con il genitore rifiutante o maltrattante…, immersi in una nebbia di indifferenziazione, è frequente la ripetizione inconscia di un uguale destino con i figli.
Identificazioni bidimensionali.
Ci si riferisce a situazioni cliniche che hanno come elemento comune una frattura, nei primissimi mesi di vita, di una situazione di unità della coppia madre-bambino, con l’esperienza di un apparire improvviso e prematuro di un non-Sé che, per vari motivi, fa precocemente cadere e lascia da soli a gestire dosi di angoscia intollerabile. Il punto di rottura avviene in quella delicata fase in cui sono dominanti le esperienze sensoriali in una primitiva organizzazione presimbolica e preoggettuale.
Nel descrivere la Bipolarità narcisismo-autismo, Autori di riferimento per me fondamentali sono S. Klein (1980) e F. Tustin (1990) che hanno scritto, rispettivamente, su “Fenomeni autistici” e “Barriere autistiche” in pazienti nevrotici; nella descrizione dei pazienti a cui fanno riferimento, è molto marcata la struttura narcisistica insieme a un muro autistico, che taglia fuori questi pazienti dal resto della loro personalità e dall’analista.
In questi pazienti, memorie arcaiche sensoriali sono depositate immobili, immutabili, e totalizzanti negli aspetti formali del carattere, negli automatismi rigidi, a senso unico, delle loro relazioni e nella ripetizione, con effetti spesso drammatici, del loro buco di esperienza nel rapporto con i figli. I segnali sensoriali sono assimilati e assorbiti nella pelle-corazza, nel tono di voce, nel tipo di sguardo, nella mimica fissata in una maschera statuaria… memorie che raccolgono la sensazione, assolutizzandola (la parte per il tutto), della qualità traumatica delle cure materne. Il paziente è, nel suo modo di essere, un Replicante senza memoria di sensazioni e percezioni antiche che costituiscono l’essenza della memoria implicita. Questi aspetti del carattere così rigidi e fissati impediscono la possibilità di “apprendere dall’esperienza” successiva, essendo il sistema impegnato a mantenere una identità e immutabilità di stato.
Identificazioni narcisistiche con un oggetto interiorizzato.
Mi riferisco a una vasta gamma di identificazioni rigide e serrate con un oggetto patologico, maltrattante, intermittente e contraddittorio, espulsivo verso il bisogno del bambino; c’è nella storia una esperienza di investimento, con rilevanti aspetti narcisistici del genitore nelle proiezioni sul figlio, tale da poter costituire uno spazio interno, una anche parziale dimensione interna, e da lasciare un residuo più o meno celato dell’esperienza positiva (pur non essendoci la struttura per uno spazio transizionale). L’esperienza di esserci, esistere, ha trovato uno spazio concreto nel genitore, spesso con una personalità narcisistica, seppure al prezzo di deformazioni per non rischiare di perdere tale spazio.
Sui bisogni denegati nell’oscurità dei visceri, sulla disperazione e sull’annichilimento del mancato incontro con i bisogni del bambino, si è costruita la potenza del bastone fecale, che, nel suo luccichio, deve raccogliere i bagliori di una età dell’oro violentemente crollata, disillusa, espulsa (spesso anche dalle intermittenze di corrente alternata del genitore). L’affettività tenuta a bada è qualcosa di esplosivo, bruciante, non c’è un freno al dilagare della affettività (una ipereccitazione esposta a sguardi che non solo non contengono, ma sono sprezzanti e umilianti). Lo sfintere è un baluardo di una situazione o aperta e totalmente esposta, di inconsistenza e dispersione o completamente chiusa e blindata.
E’ un’area segreta dove viene protetto e conservato qualcosa di prezioso per il bambino.
Per descriverne alcune caratteristiche strutturali, A. Green (2005) introduce il termine di analità primaria per descrivere una fissazione segnata in modo prevalente dal narcisismo, descritto come un narcisismo contuso, a pezzi…sembra intrattabile, poiché ogni approccio troppo diretto provoca un acuto dolore psichico; sono scorticati vivi…con una ossatura rigida fatta di ostinazione e testardaggine sopra un derma esposto a tutte le aggressioni.
Secondo Green, la proiezione del paziente attribuisce all’analista una potenza e una onnipotenza che non lascia altra possibilità all’analizzando che quella di lottare contro il transfert… mentre il potere è sempre limitato, fallibile, contestabile… in questa ottica, la potenza conferisce a colui che la possiede una forza assoluta agli occhi dell’altro, è sempre più o meno divina (o diabolica).
Aspetti simili di personalità sono descritti da H. Rosenfeld per le strutture di carattere narcisistico-onnipotente: nella struttura onnipotente è nascosto un Super-Io molto primitivo, che sminuisce e attacca le capacità del paziente, e soprattutto il suo tentativo di accettare il bisogno di oggetti reali…spesso questo Super-Io distruttivo è dissimulato sotto forma di figure benevole, un buon amico o guru che usa potenti suggestioni per preservare lo status quo.
Bibliografia
Aulagnier, P. (1994). La violenza dell’interpretazione. Borla.
Badaracco, J. (2000). Difficoltà nei processi di disidentificazione dalle identificazioni patogene. In: E. Levis (a cura di), Forme di vita, forme di conoscenza. Bollati Boringhieri.
Bonaminio, V. Carratelli, T. Giannotti, A. (1991). Equilibrio e rottura dell’equilibrio nella relazione tra fantasie inconsce dei genitori e sviluppo normale e patologico nel bambino. In: Società di neuropsichiatria infantile (a cura di), Fantasie dei genitori e psicopatologia dei figli. Borla.
Faimberg, H. (1995). All’ascolto del télescopage delle generazioni. In: R. Kaës, H. Faimberg, M. Enriquez, J. Baranes: Trasmissione della vita psichica tra generazioni. Borla.
Ferenczi, S. (1932) Diario clinico. Cortina.
Freud, S. (1914) Introduzione al narcisismo O.S.F. 7
Freud, S. (1919) Il perturbante O.S.F. 9
Freud, S. (1921) Psicologia delle masse e analisi dell’Io 9
Freud, S. (1922) L’Io e l’Es O.S.F. 9
Green, A. (1985). Narcisismo di vita narcisismo di morte. Borla.
Green, A. (1992) La psicosi bianca. Borla.
Green, A. (2004) Idee per una psicanalisi contemporanea. Cortina Editore.
Green, A. (2005). L’analità primaria nella relazione anale. In: E. Mangini (a cura di), Nevrosi Ossessiva. Borla.
Kaës, R (1995). Introduzione al concetto di trasmissione psichica nel pensiero di Freud. In: R. Kaës, H. Faimberg, M. Enriquez, J. Baranes: Trasmissione della vita psichica tra generazioni. Borla.
Klein, S. (1980). Autistic phenomena in neurotic patients. Int. J. Psycho- Anal., 61: 395-401.
Oliva De Cesarei A. (2010). Alla ricerca del filo con la vita. Identificazioni primitive e struttura narcisistica del carattere. Franco Angeli Ed.
Rosenfeld, H. (1987). Comunicazione e interpretazione. Boringhieri.
Tustin, F. (1990). Barriere autistiche nei pazienti nevrotici. Borla.
Identificazione Proiettiva
A cura di Maria Laura Zuccarino
“Sappiamo che l’identificazione è la più primitiva e originaria forma di legame emotivo” scriveva Freud nel 1921, in “Psicologia delle masse ed analisi dell’Io”, descrivendo le forme dell’identificazione primaria, basata sull’acquisizione delle caratteristiche dell’oggetto amato, attraverso un processo di introiezione, sul modello degli istinti cannibalici originari del neonato: un legame emotivo precoce, precedente all’instaurarsi della relazione anaclitica. A partire da questa considerazione, è possibile affermare che l’identificazione originaria a cui Freud si riferisce costituisce una sorte di matrice teorica di cruciale importanza, che solo nel tempo verrà ripresa e sviluppata dagli psicoanalisti post-freudiani, anche grazie al progressivo maggior riconoscimento dei meccanismi di funzionamento della mente primitiva, e della precocità delle relazioni oggettuali. Sarà il caso dell’”identificazione proiettiva”.
Il concetto di “identificazione proiettiva”, pur essendo comparso già in precedenza nella letteratura psicoanalitica (Weiss, 1925; Brierley, 1945) non suscitò molto interesse negli psicoanalisti, finché non venne descritto nel 1946, da M. Klein, in “Note su alcuni meccanismi schizoidi”. Concordando con le osservazioni di Fairbain (1944) sull’esistenza di una “posizione schizoide” normale nei primissimi tempi dello sviluppo, M.Klein descrive una particolare fantasia attraverso la quale il neonato – per difendersi dall’angoscia – scinde, e proietta parti di sé intollerabili all’interno della madre, con il fine di prenderne possesso e controllarle/la: “ poiché e in quanto, con tale proiezione dentro, la madre viene a contenere le parti cattive del Sé, essa non è sentita come un individuo separato ma come il Sé cattivo […]. Ciò determina una particolare forma di identificazione che costituisce il prototipo delle relazioni oggettuali aggressive” (ed anche, aggiungerei, delle identificazioni narcisistiche). Nella revisione di quello stesso articolo, nel 1952, aggiungerà: “Proporrei di denominare questa forma di processo di identificazione ”identificazione proiettiva”.
Si tratta di un concetto complesso, che “illustra la connessione tra istinti, fantasia e i meccanismi di difesa. E’ una fantasia di solito molto elaborata e dettagliata; è un’espressione degli istinti perché sia i desideri libidici che quelli aggressivi sono sentiti essere onnipotentemente soddisfatti dalla fantasia; è comunque anche un meccanismo di difesa nello stesso modo in cui è la proiezione, cioè sbarazza il Sé delle parti non desiderate” (H. Segal, 1967), tenendole al tempo stesso sotto controllo. Ciò permette, inoltre, di evitare ogni consapevolezza di separazione, di dipendenza e di invidia.
L’uso eccessivo dei meccanismi proiettivi produce l’insorgere di angosce paranoidi, poiché gli oggetti contenenti le parti cattive del sé diventano persecutori, oltre ad un senso di svuotamento e indebolimento dell’Io, fino a stati di depersonalizzazione, per la perdita delle parti scisse e proiettate del sé. Questa dinamica verrà descritta da M. Klein con molta chiarezza nel suo articolo “Sulla identificazione” (1955), attraverso le trasformazioni identitarie di Fabien, il protagonista della novella di J. Green, “Se fossi in te”.
Bisogna ricordare che M. Klein si era parzialmente dissociata dalla teoria pulsionale di Freud, ritenendo che la relazione oggettuale esistesse fin dall’inizio della vita neonatale, e che ogni spinta pulsionale fosse sempre fissata ad un oggetto, il primo dei quali è il seno materno precocemente interiorizzato, che costituisce “un organizzatore fondamentale dell’Io e ne garantisce la coesione”. All’epoca in cui ha descritto l’Identificazione Proiettiva, stava cercando di approfondire la qualità degli stati d’angoscia primitivi, ed i meccanismi attraverso i quali l’Io immaturo del neonato – privo di una stabile coesione ma presente ed attivo fin dalla nascita, – cerca di difendersene. L’angoscia conseguente all’entrata in azione della pulsione di morte nell’organismo, viene “avvertita inizialmente come paura di annientamento (morte), e… si configura pressoché immediatamente come paura di persecuzione” da parte di oggetti che minacciano il neonato dall’interno. Ciò lo espone ad intense angosce di frammentazione, per difendersi dalle quali, scinde attivamente ed espelle dentro all’oggetto esterno, il seno materno, parti dell’Io e degli oggetti interni minacciosi, gli oggetti cattivi. Questo stato della mente, caratteristico dei primi 3-4 mesi di vita, fu denominato dalla Klein “ posizione schizoparanoide”.
Klein, tuttavia, sottolinea che, non solo parti “cattive” del sé vengono proiettate nell’oggetto esterno, ma anche parti “buone” – perché sentite come immeritate, o per proteggerle dai cattivi persecutori interni. Tale proiezione “è fondamentale affinché il bambino sviluppi buone relazioni oggettuali e le integri nel proprio Io”, e diventa la base dell’empatia. Se eccessiva, anche in questo caso, “può derivarne una troppo forte dipendenza da questi rappresentanti esterni delle parti buone del sé e la paura che la propria capacità di amare vada perduta” (Klein, 1946)
W. Bion (1959, 1962) sarà il primo ad introdurre una distinzione tra una forma di Identificazione Proiettiva “normale”, ed una “patologica”, mettendo in luce, accanto alla primitiva funzione evacuativa descritta inizialmente da M. Klein, la dimensione interpersonale, comunicativa, che l’identificazione proiettiva contiene.
Con Bion, l’identificazione proiettiva “normale” diventa un’importante modalità di comunicazione non verbale, attraverso la quale l’organismo immaturo riesce a trasmettere sentimenti ed emozioni non ancora nominabili ad un oggetto recettivo. L’effetto che essa produce sull’oggetto che riceve la proiezione, ed il ruolo che esso ha nell’accoglierla e nel modificarla diventano parte fondamentale del fenomeno descritto, ponendo le basi della sua teoria del pensiero.
Con la formulazione del concetto di “rêverie” materna, Bion descrive una relazione in cui la madre accoglie “dentro” di sé, attraverso l’identificazione proiettiva del neonato, esperienze sensoriali, emozioni, disagi fisici disorganizzanti e inelaborabili, e glieli restituisce arricchiti di senso, tramite ciò che Bion definisce ”funzione alfa”, la capacità della mamma di elaborare l’esperienza emotiva per trasformarla in elementi utilizzabili per il pensiero ed il sogno (elementi alfa). In tal caso, non c’è perdita di parti del sé. Al contrario, ciò che il neonato reintroietta, non sarà solo la propria originaria esperienza “digerita” dalla mente materna, ma l’esperienza della relazione amorevole creativa con un oggetto recettivo, e capace di elaborazione emotiva: è identificandosi in questa esperienza interpersonale creativa che il neonato apprende, a propria volta, a pensare (Bion, 1962)
Da questo legame tra la mamma e il bambino, W. Bion elaborerà il modello “contenitore-contenuto”, che diverrà anche il modello della funzione dell’analista nella relazione terapeutica, e delle “trasformazioni” dell’esperienza emotiva che si producono all’interno di tale relazione.
L’Identificazione Proiettiva “patologica”, osservata da Bion attraverso le caratteristiche del transfer di pazienti schizofrenici, si distingue invece per la sua qualità onnipotente ed il grado di violenza con cui la proiezione viene messa in atto. Nonostante egli attribuisca in molti casi, alla particolare intensità dell’invidia del neonato, o ad una sua innata intolleranza alla frustrazione, la violenza di tale proiezione, essa viene per lo più ricondotta alla qualità della risposta dell’oggetto. Pazienti che – a livello di relazione primaria – hanno avuto l’esperienza di un oggetto chiuso alla comprensione e non recettivo rispetto alle proiezioni della propria sofferenza, ricorrono all’uso ipertrofico dell’identificazione proiettiva, per negare la realtà e l’angoscia (Bion, 1959).
La valenza euristica del concetto di identificazione proiettiva venne immediatamente colto dalla comunità psicoanalitica, e servì a dare fondamento concettuale ad aspetti molteplici della clinica psicoanalitica, in particolare relativi alla comprensione e alla cura delle patologie gravi, ad aspetti importanti della teoria della tecnica e alla teoria della formazione del simbolo (Segal, 1957) L’ampio uso che ne è stato fatto, anche da autori con orientamenti diversi rispetto al modello kleiniano da cui il concetto è nato, ha talora causato una certa confusione sul suo significato, e in parte la perdita della sua specificità originaria. Al tempo stesso, rappresentando un ponte tra dimensione intrapsichica e intersoggettiva, ha dato vita a un ricco dialogo tra modelli psicoanalitici della mente spesso distanti tra loro (E. Spillius, E. O’Shaughnessy, 2012.)
Differenza tra Identificazione Proiettiva e Proiezione
H. Segal afferma che la proiezione è il meccanismo mentale, mentre l’I.P. è la fantasia che la sottende, ma gli analisti kleiniani, per lo più, non ritengono utile una differenza nel lavoro clinico tra proiezione e identificazione proiettiva. L’argomento è discusso tra gli analisti americani, la cui opinione diffusa è che, nella proiezione, venga perso il contatto con quanto proiettato, mentre nell’I.P. il contatto venga mantenuto, e si rispecchi nella relazione identificatoria con l’oggetto che accoglie la proiezione (Odgen, 1979.)
Identificazione Proiettiva e situazione psicoanalitica: transfert e controtransfert
La dimensione comunicativa, interpersonale, dell’identificazione proiettiva, verrà associata molto presto alla comprensione dei fenomeni di transfert e di controtransfert che si attivano nella situazione psicoanalitica (Malin e Grotstein, 1966). Fu P. Heimann (1950) a valorizzare i sentimenti che il paziente suscitava nell’analista, non più come un ostacolo alla comprensione del paziente (Freud 1910, 1937), ma come uno strumento prezioso per esplorarne l’inconscio, tuttavia non considerò mai che l’identificazione proiettiva fosse implicata in quel processo. Fu il modello descritto da Bion – attraverso cui il paziente può trasferire parti disturbanti del sé e del proprio mondo interno dentro l’oggetto (prima la madre, ora l’analista), ed esercitare una pressione perché vengano accolte e restituite in qualche forma più tollerabile – ad offrire una comprensione più profonda all’esperienza transfert-controtransfert, e alla sua funzione nella relazione terapeutica e nella crescita psichica del paziente. Money-Kyrle (1956) ha sottolineato, tuttavia, quanto sia delicato, talora, differenziare il contributo del paziente dal proprio, ed ha messo in guardia sulle condizioni psicologiche dell’analista che possono ostacolare questo processo.
Racker (1957), L. Grinberg (1985) hanno descritto come l’analista possa identificarsi troppo massivamente con la rappresentazione di sé e dell’oggetto nelle fantasie inconsce del paziente, con il rischio di agire i suoi stessi sentimenti e difese, fallendo la sua funzione di contenimento delle proiezioni del paziente, e di trasformazione della sua esperienza emotiva. Il concetto di “controidentificazione proiettiva” introdotto da Grinberg, si riferisce alla risposta dell’analista ad un uso eccessivo dell’identificazione proiettiva, spesso da parte di pazienti che, da bambini, sono stati oggetto di pesanti proiezioni genitoriali. Al contrario, nell’”identificazione complementare” descritta da Racker, sono proprio i residui nevrotici dell’analista, attivati dai conflitti del paziente, ad ostacolare la recettività dell’analista verso i contenuti emotivi del paziente.
Identificazione proiettiva e clinica psicoanalitica
H. Segal, H.Rosenfeld, B. Joseph, D. Meltzer, e molti altri, hanno riproposto la distinzione formulata da Bion tra Identificazione Proiettiva normale e patologica, mettendo in rilievo l’utilità di quest’ultima per la comprensione e la cura della schizofrenia, delle angosce psicotiche, claustrofobiche, dei gravi stati borderline.
Rosenfeld, già nel 1947, partendo dagli studi di M. Klein sui meccanismi schizoidi e l’identificazione proiettiva, pubblicò il primo caso di analisi di un paziente schizofrenico, evidenziando, in particolare, l’esperienza di depersonalizzazione, e gli stati confusionali (1950), a cui tali processi davano origine. Approfondì inoltre il contributo che l’identificazione proiettiva ha dato alla comprensione degli stati psicotici (1971), e la sua influenza sul lavoro dell’analista (1987.)
Bion, nel 1957 descrive, nella personalità psicotica, una forma estrema di identificazione proiettiva osservata nei pazienti schizofrenici, in cui, sotto la pressione dell’angoscia e dell’odio per la realtà, l’apparato percettivo stesso viene frantumato in piccolissimi frammenti, che si proiettano sugli oggetti esterni, inglobandoli o penetrandoli. Il paziente si trova così in una realtà popolata di “oggetti bizzarri” la cui crescente persecutorietà produce l’intensificarsi dell’identificazione proiettiva, fino alla distruzione dei primitivi processi di pensiero, e di tutti i legami tra gli oggetti, in grado di generare simboli.
Un originale contributo all’analisi delle diverse forme di ’identificazione proiettiva’ che aprono nuove prospettive alla comprensione dell’esperienza clinica viene da D. Meltzer (1965, 1982), in particolare, con la teorizzazione del suo concetto di Claustrum (1992). Il Claustrum, è il risultato di un’identificazione proiettiva “intrusiva”, accompagnata da una fantasia onnipotente masturbatoria, dentro ad un oggetto interno. Quest’oggetto è il corpo materno, nei suoi vari compartimenti geografici (testa-seno, genitali, retto), ognuno dei quali colora diversamente la qualità delle angosce di chi vive al suo interno: un nuovo sguardo sulla qualità delle angosce claustrofobiche, e su vari aspetti dell’esperienza perversa e degli stati borderline.
Identificazione Proiettiva, intersoggettività, infant research
Per alcuni autori, il riconoscimento delle funzioni dell’I.P., così come descritta da W. Bion nella dinamica della reciproca interazione mamma-neonato, e della funzione di “rêverie” materna che promuove nel piccolo umano l’accesso al pensiero, e la profondità delle complesse relazioni tra la dimensione intrapsichica ed il campo transfert-controtransferale che si attiva nella relazione psicoanalitica, rappresentano una preziosa area di contatto con i modelli intersoggettivi ed i rilievi dell’infant Research (Seligman 1999; Silverman & Lieberman, 1999). I commenti ai loro scritti, di A.Alvarez, (1999) e J. Grostein (1999) suggeriscono interessanti spunti di riflessione.
Bibliografia
Alvarez, A. (1999). “Widening the Bridge”. Psychoanal. Dial., 9, 2
Bion, W. R. (1957). “ Differentiation of the psychotic from the non –psychotic personalities », IJP, 38. (Trad. It. in Analisi degli Schizofrenici e metodo psicoanalitico, Armando, 1970)
Bion, W. R. (1959). “ Attacks on linking” International Journal of Psychoanalysis, 40. (Trad. it. in Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico, cit.)
Bion W.R. (1962). “Learning from experience”. Heinemann. (Trad. it Apprendere dall’esperienza, Armando 1962 )
Brierley (1945). “Further notes on the implications of psychoanalysis: metapsychology and Personology” IJP, 26 ( trad. it. in “Orientamenti teorici in psicoanalisi”. Borla,1990)
Freud S. (1910). “Le prospettive future della psicoterapia psicoanalitica”, in OSF, vol. 6, Boringhieri 1974
Freud S. (1921). “Psicologia delle masse e analisi dell’Io”, in OSF, vol. 9, Boringhieri 1977
Freud S. (1937). “Analisi terminabile e interminabile”, in OSF, vol. 11, Boringhieri, 1979
Grinberg, L. (1979). Countertransference and Projective Counteridentification. Contemp. Psychoanal. 15 (trad. it in « Il controtransfert », Liguori, 1986
Grotstein, J.S. (1999). Projective Identification Reassessed. Psychoanal. Dial., 9:187-203
Joseph, B. (1984), Projective identification: Some clinical aspects. In: Psychic Equilibrium and Psychic Change: Selected Papers of Betty Joseph, ed, E. B. Spillius & M. Feldman. London: Tavistock/Routledge, 1989,
Klein M. (1946) “Notes on Some Schizoid Mechanisms”, International Journal of Psychoanalysis, vol.27, 1946, con alcune note ed un paragrafo aggiunte in “Notes on Some Schizoid Mechanisms” in M. Klein, P. Heimann, S. Isaac, J. Rivière – Development in Psychoanalysis, Hogarth Press, London, 1952. (Trad. it. in: “Note su alcuni meccanismi schizoidi” in Scritti: 1921-1958 – Boringhieri, 1978)
Malin A, Grotstein J.S. (1966) « Projecting identification in the therapeutic process » IJP, 47 (trad. it. in : Spillius E, O’Shaughnessy E. “Il concetto di identificazione proiettiva. La sua nascita e la sua evoluzione”, Astrolabio, 2014)
Meltzer D. (1966). « The relation of anal masturbation to projective identification » IJP, 47. (Trad. it. in : La comprensione della bellezza, Loescher, 1981)
Meltzer D. et coll. (1982), The Conceptual Distinction between Projective Identification (Klein) and Container-Contained (Bion). The Journal of Child Psychotherapy, 8. (Trad. it : La distinzione concettuale tra identificazione proiettiva (Klein) e contenitore-contenuto (Bion). Studi di Metapsicologia allargata. Cortina, 1987)
Meltzer D. (1992). “Claustrum”, The Roland Harris Education Trust (trad. It. « Claustrum », Cortina, 1993)
Money-Kyrle (1956). ‘Normal contertransference and some of its deviations »IJP, 37 (trad. It. « Scritti 1927-1977 », Loescher, 1985
Ogden, T.H. (1979). On Projective Identification. Int. J. Psycho-Anal., 60:357-373
Racker H.(1957). « The meaning and uses of countertransference ». Psychoanal. Quart. 26 (trad. It in : Studi sulla tecnica psicoanalitica, Armando 1970)
Rosenfeld, H. A. (1947). “Analysis of a schizophrenic state with depersonalization » IJP, 28. (Trad. It. In : Stati Psicotici. Armando 1973)
Rosenfeld, H. A. (1950) “Notes on the psychopatology of confusional states in chronic schizophrenias » IJP, 31 (Trad. It. In : “Stati Psicotici” cit.)
Rosenfeld, H. A. (1971). “Problems of psychosis”, The Hague. Excerpta Medica. (Trad. It. In « Melanie Klein e il suo impatto sulla psicoanalisi oggi », vol. 1°, Astrolabio, 1995)
Rosenfeld, H. A. (1987). « Impasse and Interpretation », Tavistock Publications. (Trad. It : « Comunicazione e Interpretazione. Bollati Boringhieri, 1989)
Segal H. (1967) – “Melanie Klein’s technique”, in B. B. Wolman (a cura di), Psychoanalitic Techniques, Basic Book, New York, 1967 (Trad. It “La tecnica di Melanie Klein” in Scritti Psicoanalitici, Astrolabio, Roma, 1981)
Segal H. (1957) “Notes on symbol formation” IJP, 38. (Trad. It : Scritti psicoanalitici, Astrolabio, 1984)
Seligman, S. (1999). Integrating Kleinian Theory and Intersubjective Infant Research. Psychoanal. Dial., 9, 2
Silverman, R.C. and Alicia F. Lieberman,A. F. ( 1999). Negative Maternal Attributions, Projective Identification, and the Intergenerational Transmission of Violent Relational Patterns. Psychoanal. Dial., 9, 2
Spillius E, O’Shaughnessy E. (2012) « Projecting Identification. The fate of a concept » Routledge, Taylor & Francis Book. (Trad. It : Il concetto di Identificazione Proiettiva. La sua nascita e la sua evoluzione, cit.)
Weiss, E. (1925) – « Ube reine noch nicht beschriebene Phase der Entwicklung zur heterosexuellen Liebe » Internationale Journal of Psychoanalyse, 11
Luglio 2015
Identità

Francesca Woodman, 1978
IDENTITA’
A cura di Alfredo Lombardozzi
Il termine identità in generale è considerato un concetto non appartenente alla teorizzazione psicoanalitica, in quanto trattato marginalmente nelle opere di Freud, che in poche occasioni si riferisce direttamente ad esso. Le diverse scuole psicoanalitiche, in seguito, non hanno considerato l’identità come un problema di cui valesse la pena occuparsi preferendo, al contrario, concentrarsi sull’analisi dei complessi processi di identificazione nella formazione della personalità, oppure delle diverse istanze e strutture psichiche centrate sull’Io oppure sul Sé.
In realtà Freud (1926) cita esplicitamente il termine identità, riferendolo al suo sentimento di appartenenza alla cultura ebraica, nel Discorso ai membri della Associazione B’nai B’ rith di cui faceva parte, in cui riconduce la sua qualità di ebreo non tanto alla fede e all’orgoglio nazionale, quanto a quello che si potrebbe definire un suo stile di pensiero. Processo questo che prende forma nella correlazione tra le ‘oscure forze del sentimento’ e la consapevolezza di un’interiore identità nel contesto di una medesima costruzione psichica. L’essere ebreo pone Freud nella posizione di essere svincolato dai limiti del pregiudizio e disposto ad opporsi a quella che definisce la ‘maggioranza compatta’.
E’ chiaro che per Freud l’essere ebreo e avere acquisito un’identità di ebreo rappresenta un’esperienza di interiorità che gli consente di attribuire una ‘presunta’ ‘ebraicità’ ad alcuni tratti del suo ‘carattere’, che sono quelli che gli hanno consentito di essere lo ‘scopritore’ della psicoanalisi e di lottare per il suo riconoscimento nel mondo scientifico del suo tempo. Il termine identità attiene ad una struttura della personalità che contiene i ‘caratteri’ culturali più significativi di un popolo e che, allo stesso tempo, viene interiorizzata in termini intrapsichici. Né in questo breve scritto, né in altri contesti Freud, però, descrive o definisce il modo in cui accade questo processo. Piuttosto, nel corso dello sviluppo del suo pensiero, ha analizzato le modalità in cui le diverse forme dell’identificazione, che si ritrovano sia a livello individuale che nei gruppi e nella società, contribuiscono alla formazione delle strutture psichiche relative alle istanze del modello strutturale (Io, Es, Super-Io), senza passare attraverso il concetto di identità.
L’acuta e sentita riflessione nel suo discorso all’associazione ebraica sembra introdurre e anticipare, anche se solo con un breve accenno, un possibile uso del concetto di Identità sul piano psicoanalitico. L’identità in questi termini può essere vista come una ‘struttura’ della personalità che fa da ponte tra l’esterno (in termini generali il mondo della cultura) e l’esperienza dell’interiorità.
Il discorso sull’identità verrà approfondito, tra gli psicoanalisti, da Erik Erikson nel noto e significativo testo Gioventù e crisi dell’identità (1968), dove, prendendo spunto proprio dal discorso di Freud, ne mette in evidenza la caratteristica ‘etnica’, cioè l’attribuzione sociale di appartenenza al senso dell’identità. Questo lavoro di Erikson rappresenta un contributo originale che, traendo spunto dalla tradizione della psicologia dell’Io, tende ad un superamento del concetto di adattamento, dando maggiore rilievo alla dimensione storico-culturale e al carattere ‘comunitario’ dell’esistenza umana, rispetto ai processi di formazione dell’Io,
Secondo Erikson c’è una stretta correlazione tra l’identità personale, che definisce Identità dell’ego e il contesto sociale in cui questa si forma. In questi termini l’identità dell’ego costituisce un fattore sintetizzante per quanto riguarda il rapporto tra lo stile della propria individualità e l’identificazione del senso di continuità, correlato al significato che questo acquisisce nella comunità di appartenenza. L’autore descrive un processo che rende ragione del bisogno di continuità dell’ego che, però, non può prendere forma se non attraverso il rispecchiamento e il riconoscimento dell’altro e nell’altro, facendo riferimento alla sua ampia formazione antropologica.
Erikson aveva, infatti, svolto importanti ricerche sull’infanzia presso le culture dei nativi d’America, accompagnato dal grande antropologo statunitense Alfred Kroeber. Successivamente sceglierà, come campo elettivo di analisi sull’identità, l’adolescenza nella forma più compiuta della ‘gioventù’, in quanto momento della vita più significativo a rappresentare le forme rituali di passaggio in relazione ai cambiamenti del ciclo della vita. Qui Erikson (1968) definirà senso d’identità interiore la completezza raggiunta in questo stadio, che comprende la percezione di una continuità progressiva tra le esperienze che lo hanno formato negli anni dell’infanzia, ciò che promette di diventare in avvenire e le aspettative degli altri appartenenti al mondo circostante
Riprendendo a suo modo Hartman (1958), Erikson distingue i processi relativi all‘identità dell’ego da quelli attinenti all’identità del Sé. Mentre la prima avrebbe a che fare con una tendenza ad una strutturazione dell’esistenza, la seconda riguarderebbe tensioni ideali in trasformazione. L’identità dell’ego (1968) è il risultato di una funzione sintetizzante dell’ambiente, in quanto realtà sociale trasmessa al bambino attraverso le successive crisi infantili e l’identità del Sé allude alle immagini del Sé e dei ruoli dell’individuo.
Mentre la prima avrebbe a che fare con una tendenza ad una strutturazione dell’esistenza, la seconda riguarderebbe tensioni ideali in trasformazione. L’ego, parzialmente inconscio, come ‘agente organizzativo centrale’ fa sempre i conti con un Sé in cambiamento, che si esprime in una continua articolazione tra il Sé ideale e il Sé corporeo. Di conseguenza si potrebbe dire che, l’identità del Sé ha origine da esperienze nelle quali vari Sé temporaneamente confusi si reintegrano con successo in un insieme di ruoli che comporteranno anche un riconoscimento sociale.
Mi sono soffermato sul lavoro di Erikson in quanto è uno dei pochi psicoanalisti che abbia tentato un’analisi particolareggiata del concetto di identità e anche in quanto, pur muovendosi nella cornice del modello psicoanalitico strutturale della psicologia dell’Io, ha anticipato sviluppi interessanti, che prenderanno corpo successivamente nella psicoanalisi del Sé. Ha, inoltre, sempre avuto uno sguardo da un lato orientato alla realtà intrapsichica e, dall’altro, ai fattori sociali che interagivano con essa.
Mi sposterei ora su un altro versante degli studi psicoanalitici sull’identità, che ha come rappresentante il lavoro di Leòn e Rebeca Grinberg (1975) Identità e cambiamento e che si ispira alla tradizione kleiniana-bioniana o, più in generale, alla psicoanalisi delle relazioni oggettuali. Gli autori riprendono, per alcuni aspetti, l’analisi di Erikson e le formulazioni riguardanti la relazione tra il Sé e l’Io, propendendo, dal loro punto di vista, a dare preminenza al Sé e al processo di formazione dell’identità, che attiene alla percezione di continuità dell’esistenza in relazione ai fattori di cambiamento. Questo processo ha a che fare, a loro avviso, con quello che definiscono un sentimento d’identità, che è alla base di uno sviluppo ‘sano’ della persona e che, al contrario, quando è deficitario, espone a patologie confusive dell’identità. Il sentimento d’identità si fonderebbe sulla integrazione di spazio, tempo e dimensione del gruppo. Si tratta di rapporti d’integrazione che consentono la differenziazione tra Sé e non Sé, la percezione di un senso di continuità del Sé e la relazione tra aspetti di sé e oggetti esterni. Questo avviene attraverso la messa in campo delle dinamiche intrapsichiche, nella loro relazione con gli oggetti esterni e interni in termini di identificazioni introiettive e proiettive.
L’individuo, che accede al sentimento di identità, sa di essere se stesso nel succedersi dei cambiamenti nella misura in cui il suo Io contiene una chiara rappresentazione del suo Sé e dei cambiamenti che sta sperimentando nel corso del tempo, per cui la sua unità è preservata.
I Grinberg (1975) sottolineano, inoltre, l’importanza dello schema corporeo nel processo di costruzione del sentimento d’identità; schema corporeo che, oltre a rappresentare l’integrazione di esperienze primarie sensoriali inconsce, è anche espressione di un fenomeno sociale. La percezione del corpo altrui è una condizione necessaria per la percezione del proprio corpo e della sua espressione emozionale, che si costruisce nella relazione reciproca in cui non ci si può rappresentare senza un altro. Di conseguenza un corpo è sempre l’espressione di un Io e di una personalità situati in un mondo. Ribadiscono, inoltre, l’importanza della crisi, nel processo di formazione dell’identità, come ‘cambiamento catastrofico’, in senso bioniano, che è condizione necessaria per una crescita trasformativa. In questo si avvicinano allo spirito di Erikson, che sottolineava l’aspetto ‘positivo’ e ‘creativo’ della crisi. A partire, poi, dall’analisi delle dinamiche psichiche che intervengono nell’esperienza della ‘migrazione’ , pongono al centro del cambiamento il processo di elaborazione del lutto che, se non elaborato, diviene resistenza al cambiamento. Lo stabilirsi del sentimento d’identità comporta il fatto che l’individuo reagisca con angoscia per la nuova situazione e con sentimenti depressivi relativi al lutto per l’oggetto perduto e anche alla perdita di aspetti del proprio Sé (lutto per il Sé).
Come abbiamo visto sia Erikson che i Grinberg, tra i pochi psicoanalisti che hanno approfondito il tema dell’identità tra gli anni Sessanta e Settanta, hanno messo in evidenza la stretta correlazione tra i processi di formazione dell’identità e quelli relativi all’Io e al Sé. E’ ovvio che il concetto di Sé non coincide con quello di identità, ma in molti aspetti troviamo motivi di assimilazione e sovrapposizione.
Già Winnicott (1971) aveva riportato la capacità del bambino di esistere e percepirsi vivo nel rapporto con una madre ‘sufficientemente buona’, che gli avrebbe consentito, attraverso l’esperienza dei fenomeni transizionali, di acquisire un senso di Sé separato, in modo da trovare il ‘seno’ proprio lì dove l’aveva ‘pensato’, creandolo .
Bion, dal canto suo, raramente cita il termine identità, mentre in un dialogo riportato nel testo di Memoria del futuro, L’alba dell’oblio (1979) fa dialogare diverse istanze psichiche, che si riconoscono in sé molteplici, relativi a varie stratificazioni dell’esperienza. Le diverse articolazioni dei sé che siano ‘ittici’, o ‘arcaici’ o più ‘evoluti’, ripropongono l’oscillazione PS-D tra coesione e frammentazione, oppure il tema delle invarianti che permangono nei processi di trasformazione. Temi tipici che ripropongono, con un altro linguaggio, la possibilità di un soggetto di rappresentarsi in un identità che risulta da un processo che consente una dinamica e un’oscillazione tra continuità e discontinuità.
Per altri versi Bollas (1989) colloca la dinamica continuità/discontinuità del senso di esistere nella formulazione del concetto di ‘idioma’, che riguarda quel nucleo unico del Sé che è come un germe che, in circostanze favorevoli, nell’incontro con l’ambiente e nelle esperienze con le figure di base di riferimento, può svilupparsi e articolarsi.
L’attenzione all’identità ha acquisito una maggiore centralità anche grazie allo sviluppo della psicoanalisi del Sé nelle sue varie articolazioni. Heinz Kohut (1984), ad esempio, pur riferendosi raramente al concetto di identità, propone una visione del Sé come una ‘struttura’, che si costituisce attraverso l’interiorizzazione degli oggetti-Sé nelle loro funzioni di rispecchiamento, gemellarità e idealizzazione e che garantiscono, non tanto la spinta all’autonomia, quanto la percezione del senso della continuità dell’esistenza del soggetto, perennemente esposto a vissuti ed esperienze di frammentazione e dispersione. L’oggetto-sé ha per Kohut (1985) anche una’ valenza’ culturale e, in questo, è in stretta relazione con le componenti ambientali e sociali che costruiscono, attorno ai processi che costituiscono il Sé nucleare, quello che i Grinberg hanno denominato il ‘sentimento dell’identità’.
Stephen Mitchel (1993), insieme ad altri esponenti della corrente relazionale in psicoanalisi, ha sottolineato l’importanza dei sé multipli nella costruzione del soggetto individuale e sociale, non sottovalutando, però, il bisogno di una ‘relativa’ coesione del Sé per garantire un ragionevole equilibrio psichico, formulato in termini di ‘identità interiore’. Abbiamo, perciò, bisogno di un senso del Sé costante e immutabile nel tempo per poter dare priorità ai nostri obbiettivi, motivazioni e impulsi e sentire di avere un ‘identità interiore‘. Quella che all’inizio era un’illusione diviene una guida alla vita in virtù della nostra necessaria fede in essa.
Una serie di valutazioni ci porta, infine, a riflettere sui limiti e le strettoie del concetto di identità e anche sull’opportunità di mantenerlo come focus fondamentale di riflessione. Virginia De Micco (2014), ad esempio, propone un punto di vista che coglie tutti i limiti dell’identità, quando questa viene concepita nei termini di una spinta all’unitarietà del soggetto, ‘impoverendo’ la forza del discorso psicoanalitico basato sull’assetto pulsionale della psiche inconscia con le sue molteplici istanze. La funzione dell’identità viene in qualche modo riguadagnata nel momento in cui è ricondotta al più ampio concetto di ‘cultura’ in quanto dimensione di una psiche incarnata nell’inconscio.
La riflessione di De Micco si distingue dalle formulazioni dell’antropologo Francesco Remotti (2019), che da anni porta avanti una riflessione critica sul concetto di identità, fino a giungere recentemente a sostenere la maggiore flessibilità e aderenza alla complessità della condizione umana sul piano sociale, ma anche psichico, del concetto di somiglianza. Il concetto di identità pone dei confini troppo rigidi al soggetto, radicalizzando l’opposizione identità/alterità, piuttosto che favorendo l’immersione creativa e generativa nell’intrigo/intreccio di somiglianze e differenze. Remotti si pone in una posizione molto articolata per cui l’identità viene posta sul lato estremo della ricerca di una coerenza assoluta e sostanziale per giungere, nel lato opposto del processo, ad una mancanza di coerenza che pone a rischio di sentimenti frammentazione e dispersione gli individui e i gruppi sociali. La soluzione migliore sembra trovarsi ‘nel mezzo’ in un gioco di somiglianze e differenze in cui l’altro può essere concepito come un altro che è anche, e soprattutto, simile a sé. Remotti propone una visione per molti versi condivisibile, anche secondo alcune ottiche psicoanalitiche. Bisogna, però considerare che, se una formulazione troppo rigida dell’identità espone a gravi rischi di reificazione e fondamentalismo, esiste un bisogno di coerenza e di continuità a cui, anche solo sul piano ‘illusorio’, può rispondere, a condizione che sia esplicitato il suo carattere imperfetto e non necessariamente corrispondente al riferimento etimologico che ne riduce il senso alla identicità (Lombardozzi A., 2015). Allo stesso tempo, sembra difficile considerare il rapporto differenza/somiglianza immune rispetto alla dimensione del conflitto, per come è stato descritto in termini sia socio-antropologici che psicoanalitici, nella relazione identità/alterità.
Bibliografia
Bion W.R., (1979), Memoria del futuro, L’alba dell’oblio, Cortina, Milano, 2007.
Bollas C., (1989), Forze del destino, Psicoanalisi e idioma umano, Borla, Roma, 1991.
De Micco V., Le identità nomadi. Identità, migrazioni, fratture narcisistiche, in (a cura di Paolo Cutrufo e Rossella Pozzi) Identità e processi di identificazione, FrancoAngeli, Milano, 2014.
Erikson E., (1968), Gioventù e crisi d’identità, Armando, Roma, 1974.
Freud S., (1926), Discorso ai membri dell’Associazione B’nai B’rith, in OSF Vol 10, Boringhieri, Torino, 1978.
Grinberg L e Grinberg R., (1975), Identità e cambiamento, Armando, Roma, 1976.
Kohut H. (1984), La cura psicoanalitica, Bollati Boringhieri, Torino, 1986.
Kohut H., (1985), Potere coraggio e narcisismo, Psicologia e scienze umane, Astrolabio, Roma, 1986.
Hartman H., (1958), Psicologia dell’Io e problema dell’adattamento, Bollati Boringhieri, Torino, 1978.
Lombardozzi A., L’imperfezione dell’identità. Riflessioni tra psicoanalisi e antropologia. AlpesItalia, Roma, 2015.
Mitchel S.A., (1993), Speranza e timore in psicoanalisi, Bollati Boringhieri, Torino, 1995.
Remotti F., Somiglianze. Una via per la convivenza, Laterza, Bari, 2019.
Winnicott D.W., (1971), Gioco e realtà, Armando, Roma, 1974.
Illusione
A cura di Almatea Kluzer Usuelli
“Illusione” (dal latino illudere : deridere, farsi beffe, scherzare), é “ogni errore dei sensi o della mente che falsi la realtà” (Lessico Universale Italiano).
Nella letteratura psicoanalitica il termine illusione ha mantenuto fino ad un certo punto la medesima connotazione e il valore eminentemente negativo che gli é attribuito nel linguaggio comune, in contrapposizione con ‘realtà’ ‘verità’ e simili.
Nel saggio “L’avvenire di un’Illusione” Freud esamina il fenomeno religioso in rapporto all’impotenza infantile. L’illusione, che costituisce il fondamento delle credenze religiose, permetterebbe di soddisfare il bisogno di protezione da parte di una figura paterna. Il suo perdurare nell’età adulta è visto come un segno di infantilismo . Anche se “la voce dell’intelletto é fioca, essa non ha pace finché non ottiene udienza.. E questo é uno dei pochi punti che consentano un certo ottimismo per l’avvenire dell’umanità. . . a lungo andare nulla può resistere alla ragione ” (L’avvenire di un’illusione,p.482)
Winnicott ha dato una connotazione nuova al termine illusione, promuovendolo a concetto fondamentale nella teoria e nella pratica psicanalitica. Secondo questo Autore il soggetto e l’oggetto nascono, differenziandosi progressivamente, dalla coppia madre-bambino, nell’ambito dell’area transizionale, attraverso la creazione di una serie di oggetti: transizionali, appunto, in quanto si collocano in una zona di passaggio tra bambino e mamma, tra quello che diventerà l’Io e il non io, il Soggetto e l’Oggetto, il mondo interno e il mondo esterno ecc.
Immaginiamo quest’area all’inizio come un’impercettibile fessura: mamma e bambino costituiscono un’unità, le cure materne si adeguano ai bisogni del bambino in modo tale da creare in lui un’illusione di completezza, di onnipotenza magica.
Le inevitabili imperfezioni delle cure materne, fatte di ritardi, di inadeguatezza, di distrazioni, confluiscono nell’esperienza della separazione e provocano in lui una graduale percezione dei propri limiti, dei propri confini.
Quest’evoluzione può avvenire in modo non traumatico, quando l’impercettibile fessura dell’inizio si allarga, diventando uno spazio sempre più vasto, popolato di oggetti transizionali, rappresentanti simbolici dell’unità primitiva, intermediari tra io e non io.
In questi oggetti si materializza l’illusione (fondata sull’esperienza del rapporto con la “madre sufficientemente buona”) della congruenza tra sé e mondo esterno. In quest’area perdura la fiducia, l’illusione che l’oggetto, l’Altro, pur separato dal soggetto, corrisponda ai suoi bisogni,alle sue aspettative, sia predisposto a ciò, e che tutto quanto ci circonda si disponga intorno a noi con una certa coerenza o addirittura in bell’ordine provvidenziale.
Le delusioni inevitabili, i vissuti di frustrazione, mancanza, assenza, impotenza, introducono il soggetto nella dimensione del limite, nella “realtà” della propria finitezza; ma in condizioni ottimali questa consapevolezza acquisita si costituisce come un sapere che non intacca la capacità di illusione, così come del resto la capacità di illusione non oscura la visione chiara e distinta della “realtà” dei propri limiti.
C’é evidentemente qualcosa di paradossale in questa doppia visione, che non porta all’esclusione di uno dei due atteggiamenti tra loro contradditori.
Si potrebbe pensare ad un’organizzazione psichica, dove le diverse aree di funzionamento non sono tra loro integrate, senza tuttavia entrare in conflitto l’una con l’altra.
Se questo schema può corrispondere ad una struttura primitiva della mente, sorge tuttavia l’interrogativo di come possano coesistere nella vita adulta la capacità di illusione con il riconoscimento del limite che impone il “reale”. Nel suo percorso maturativo, l’Io tende verso una sempre maggiore integrazione e, nello sforzo di costituirsi come un’unità, riduce la sua tolleranza nei confronti del paradosso e delle contraddizioni. Debbono quindi intervenire particolari “accorgimenti” per permettere all’Io di accogliere e di sopportare la compresenza di ambiti di esperienza contradditori.
Possiamo identificare questi “accorgimenti” con i meccanismi di difesa costituiti dal diniego e dalla scissione dell’io? Forse. In questo caso essi non sarebbero più soltanto i segni della psicosi e della perversione, ma verrebbero promossi a meccanismi fondamentali della psiche, in quanto permetterebbero all’Io di sospendere il giudizio, e di mantenersi in un’ area di relativa ambiguità, necessaria alla sua sopravvivenza.
Tuttavia vorrei precisare alcune differenze fondamentali relative alla funzione del diniego e della scissione nella costituzione dell’oggetto transizionale e rispettivamente del feticcio: mentre il feticcio si costituisce a partire dal diniego dell’assenza, l’oggetto transizionale é per così dire un prodotto della presenza materna e nasce in un ambito di indifferenziazione tra io e non io, tra quello che diventerà il mondo interno e il mondo esterno. In questo caso il diniego si instaurerebbe secondariamente, a protezione dell’area transazionale, contro un eccesso di “alterità”, di “realtà” inassimilabile.
Il termine illusione dunque, nell’opera di Winnicott, ha assunto una connotazione e un valore nuovo: non più sinonimo di errore, bensì fondamento ontologico del soggetto. In questo contesto la realtà non si contrappone all’illusione, ma é invece definibile come illusione condivisa.
Un approccio del soggetto al mondo esterno non sufficientemente sostenuto dall’illusione, produrrebbe un’incapacità di dare un senso all’esperienza.
Bibliografia
Freud,S.(1927).L’avvenire di un’ illusione.O.S.F.,10.
Kluzer Usuelli,A. (1992) The Significance of Illusion In The Work of Freud and Winnicott: a Controversial Issue. Int J. Psycho-Anal. 19,179
Winnicott,D.W.1971. Playing and Reality. New York, Basic Books.
Winnicott,D.W.1987. Lettres vives. Editions Gallimard,Paris.
Inconscio
A cura di Francesco Conrotto
L’inconscio (Unbewußte) è il concetto centrale della psicoanalisi.
Già nella filosofia e nella cultura a cavallo tra il 18° e il 19° secolo, specialmente nel pensiero romantico, si riteneva che ci fossero “rappresentazioni” o “idee” non immediatamente accessibili alla coscienza e le pratiche terapeutiche fondate sulla suggestione post-ipnotica, derivanti dal sonnambulismo mesmeriano e operative ancora nella seconda metà dell’ottocento, si fondavano sulla convinzione della esistenza di idee collocate al di fuori della coscienza.
Ma è stato con Freud che la concezione della esistenza di rappresentazioni (Vorstellungen) alle quali non era consentito l’accesso alla coscienza o dalla quale venivano espulse, ha determinato la nascita di una nuova disciplina della quale rappresenta il nucleo. Pertanto, il concetto di inconscio è strettamente connesso con quello di rimozione (Verdrängung) e, a lungo, l’inconscio è stato identificato con il “rimosso”.
Da un punto di vista descrittivo, nella prima topica freudiana, bisogna distinguere un inconscio formato da contenuti mentali che, benché non presenti alla coscienza, sono ad essa volontariamente e immediatamente richiamabili, è il cosiddetto “preconscio”, e un inconscio dinamico che non è accessibile alla coscienza e i cui contenuti si appalesano sotto forma di sintomi, lapsus, azioni sintomatiche. I contenuti inconsci, inoltre, si rivelano nei sogni, benché deformati ad opera della censura onirica. Pertanto, l’inconscio è uno dei tre sistemi psichici descritti da Freud nella Prima Topica. Gli altri due sono, rispettivamente, il preconscio e il sistema percezione-coscienza. Il tratto caratterizzante il funzionamento dell’inconscio è il cosiddetto “processo primario”, vale a dire che esso opera in un regime economico-dinamico di “energia libera”, quindi, con una mobilità degli investimenti e con i meccanismi della condensazione, dello spostamento e della assenza sia di contraddizione che della dimensione della temporalità.
A proposito dei contenuti dell’inconscio, partire dal 1905, con l’introduzione del concetto di “pulsione” (Trieb) si determina un progressivo spostamento dalla centralità delle “rappresentazioni” (Vorstellungen) a quella del “moto pulsionale” (Trieb), benché ancora nel saggio “L’inconscio” (1915b), Freud affermi che una pulsione per dimorare nell’inconscio deve essere legata ad una rappresentazione.
Ben presto, Freud riconobbe che l’inconscio ha un’estensione più ampia del solo rimosso (1915b pag. 49). In primo luogo, infatti, dovette ammettere che anche una parte dell’Io è inconscia, nella fattispecie, lo sono i cosiddetti suoi “meccanismi di difesa” e, prima tra tutti, lo è la rimozione stessa, definita anche difesa “primaria” che, come rimozione “primaria” o “originaria”, è addirittura costitutiva dell’inconscio stesso. In “Pulsioni e loro destino” (1915a pag. 22), oltre alla rimozione, anche la trasformazione nel contrario, il volgersi sulla persona stessa del soggetto e la sublimazione sono definiti “destini pulsionali”, oltre che “meccanismi di difesa”. Più tardi, tutti i meccanismi di difesa dell’Io, messi in evidenza anche ad opera di A. Freud (1936), sono stati considerati aspetti del funzionamento inconscio dell’Io.
Con la svolta della Seconda Topica, l’inconscio smette di essere considerato uno dei sistemi psichici per limitarsi a designare una qualità del funzionamento psichico che appartiene ad una parte dell’Io, al Super-Io e all’Es (Freud 1922). Sarà quest’ultimo ad ereditare le caratteristiche più specifiche dell’inconscio della Prima Topica. Il termine Es, pronome neutro di terza persona (das Es), deriva da Groddeck che, a sua volta, lo usa citando Nietzsche. Nella prospettiva freudiana, costituisce il “serbatoio delle pulsioni”, sia di quelle di vita (Eros) che di quella di morte (Thanatos). Inoltre, l’Es non è nettamente separato dall’Io e neanche dal soma (1932 pag. 189). Laplanche (1993) afferma che con la Seconda Topica si è determinato uno “fuorviamento biologistico” della psicoanalisi, nel senso che il riferimento biologico ha acquistato un’importanza maggiore di quello che aveva nella Prima Topica. In realtà, tale scivolamento verso il fondamento biologico dello psichismo, era iniziato con l’introduzione del concetto di pulsione, di cui si diceva che avesse una “fonte” somatica e che, quindi, fosse una “rappresentanza psichica di una fonte di stimolo in continuo flusso, endosomatica” e “un concetto al limite tra lo psichico e il corporeo” (1905 pag. 479).
Nella psicoanalisi post-freudiana il concetto di inconscio ha subito alcune modificazioni.
La Psicologia dell’Io si è limitata a sviluppare la concettualizzazione dei meccanismi di difesa dell’Io, introducendo anche quello dell’ “adattamento” (Hartmann 1937), mentre le Teorie delle Relazioni Oggettuali, segnatamente quella kleiniana, si sono allontanate dalla concezione energetista, quindi economica, dell’inconscio, sviluppando il concetto di “ fantasia inconscia”, intesa come scenario di relazioni tra l’Io e gli oggetti interni.
W. R. Bion, apparentemente, ha condiviso l’impostazione kleiniana ma, con la sua “teoria delle funzioni” e delle “trasformazioni” (1962, 1963, 1965), ha introdotto una differente visione dell’inconscio. Il prototipo delle funzioni, per Bion, è la “funzione alfa” che consiste nella trasformazione delle sensazioni, “elementi beta”, in “elementi alfa” che sono i costituenti dei “pensieri del sogno”. Gli “elementi beta” sarebbero sensazioni non digerite e incapaci di diventare pensieri onirici. Esse, quindi, determinano l’attivazione dei meccanismi dell’identificazione proiettiva, della evacuazione delle emozioni e dell’acting. La “funzione alfa” sarebbe ciò che determina la rimozione e quindi forma l’inconscio rimosso. Dal suo punto di vista, si può dire che, in mancanza della “funzione alfa”, non vi è un vero inconscio rimosso. Le trasformazioni sono di vario tipo, non soltanto quella degli “elementi beta” in “elementi alfa” e viceversa, la cosiddetta “inversione della funzione alfa”.Tutti i processi della dinamica psichica sono determinati dall’azione dei differenti “legami” che sono: Amore (L), Odio (H), e Conoscenza (K). Tra le trasformazioni va segnalata la “Trasformazione in allucinosi”, caratteristica del funzionamento psicotico, in cui il soggetto, non potendo tollerare la frustrazione di non avere ciò che desidera, lo allucina.
Un approccio radicalmente differente all’inconscio è stato quello di Lacan. Egli ha abbandonato i referenti biologici e psicologici della metapsicologia freudiana e ha adottato gli assunti dello strutturalismo linguistico che fa capo a F. de Saussure (Lacan 1966). In questa prospettiva, ha affermato l’egemonia del significante sul significato e ha identificato i meccanismi specifici dell’inconscio, cioè la condensazione e lo spostamento, con le figure retoriche della metafora e della metonimia. Da ciò è derivata l’affermazione che “l’inconscio è strutturato come un linguaggio”. Pertanto, l’inconscio non è considerato qualcosa di profondo che occorre riportare alla superficie della coscienza ma è l’altro lato del linguaggio, ciò che si nasconde nelle pieghe del linguaggio stesso. Da questa teorizzazione ne sono conseguite delle ricadute sulla tecnica psicoanalitica e sulla pratica della cura in cui, all’analista, spetta il compito di essere lo spettatore, pressoché muto, del discorso dell’analizzando e dove, spesso, l’interpretazione verbale è sostituita dalla interruzione della seduta, nella aspettativa che questo favorisca, nell’analizzando, la rielaborazione a posteriori (après-coup) di ciò che, a sua insaputa, sarebbe emerso nella seduta, perché “l’inconscio parla” (ça parle).
Non possiamo concludere questa breve illustrazione del concetto di inconscio senza menzionare alcuni contributi di autori, prevalentemente di cultura francese, che, a suo tempo influenzati da Lacan, se ne sono poi allontanati.
Mi riferisco principalmente a D. Anzieu, a G. Rosolato e a J. Kristeva. Costoro, ciascuno secondo una personale prospettiva, hanno enormemente ampliato il concetto di “significante” facendogli trascendere la sola dimensione linguistica per coinvolgere aspetti percettivi e sensoriali, come quelli visivi, tattili, uditivi, kinesici e kinestetici, gettando così le basi di una nuova concezione dell’inconscio. Si può, infatti, immaginare che, in un regime di economia psichica egemonizzato dal principio di piacere, i differenti stimoli sensoriali diventano “significanti” e quindi “segni”. Questi, attraverso un processo generativo-ricorsivo, geneticamente condizionato e legato all’evoluzione della specie, producono degli schemi interpretativi di tali stimoli il cui punto di arrivo è la formazione dei cosiddetti “Fantasmi Originari” e quindi, delle Teorie Sessuali Infantili e la strutturazione del Complesso Edipico. Pertanto, si può giungere a considerare l’inconscio un sistema semiotico e semantico in perenne rielaborazione (Conrotto 2014).
Bibliografia
Bion W.R. ( 1962) Apprendere dall’esperienza. Armando, Roma, 1972.
Bion W. R. (1963) Gli elementi della psicoanalisi. Armando, Roma, 1973.
Bion W. R. (1965) Trasformazioni, il passaggio dall’apprendimento alla crescita.
Conrotto F. (2014) Ripensare l’inconscio. FrancoAngeli, Milano.
Freud A. (1936) L’Io e i meccanismi di difesa. Martinelli, Firenze, 1967.
Freud S. (1905) Tre saggi sulla teoria sessuale. O.S.F., 4.
Freud S. (1915a) Pulsioni e loro destino. O.S.F., 8.
Freud S. (1915b) L’inconscio. O.S.F., 8.
Freud S. (1922) L’Io e l’Es. O.S.F., 9.
Freud S. (1932) Introduzione alla psicoanalisi, Nuova serie di lezioni. O.S.F., 11.
Hartmann H. (1937) Psicologia dell’Io e problema dell’adattamento. Boringhieri,Torino, 1966.
Lacan J. (1966) Scritti. Einaudi, Torino, 1974.
Laplanche (1993) Le fuorviement biologisant de la sexualité chez Freud.Les Empècheurs de penser en ronde.
Luglio 2014
Inconscio non rimosso

ZAO WOU-KI, 1983
INCONSCIO NON RIMOSSO
A cura di Gabriella Giustino
Storia e definizione del concetto
Il concetto di inconscio non rimosso deriva da un insieme di contributi psicoanalitici e dall’apporto di discipline contigue come l’attaccamento[1], l’infant research e le moderne neuroscienze.
Freud in l’Io e l’Es (1922), aveva accennato all’esistenza di un inconscio non rimosso, forse riferibile ad una parte dell’apparato psichico più primitiva dell’inconscio, che sembrava avere a che fare con l’esperienza sensoriale associata alla percezione della realtà esterna.
Diversi autori psicoanalitici contemporanei (Storolow e Atwood,1992; Stern, 1999), che guardano a un modello di sviluppo della psiche infantile centrato prevalentemente sull’importanza delle interazioni precoci madre-bambino, hanno posto l’accento sulla dimensione che potremmo definire intersoggettiva dell’inconscio. Questi autori fanno riferimento a una dimensione pre-simbolica dell’inconscio e distinguono una componente implicita ed una componente esplicita dell’esperienza psichica.
Nel 1992, Storolow e Atwood hanno descritto la dimensione intersoggettiva dell’ inconscio inteso come deposito di affetti pre-verbali non convalidati da risposte ambientali sufficientemente responsive. Tali stati affettivi non integrati diventano fonte di conflitti, difese dissociative e resistenze. La mancata sintonizzazione affettiva tra genitore e bambino nello scambio intersoggettivo è, dunque, il fulcro della loro ipotesi; le emozioni non simbolizzate del bambino possono essere esperite attraverso il corpo e la memoria corporea. Essi affermano pertanto che l’inconscio dinamico di Freud non è niente affatto incompatibile con quelle concettualizzazioni sull’inconscio che, nel loro insieme, potrebbero andare sotto la denominazione di “inconscio non rimosso” e che sembra essere il risultato di un’ archiviazione, nella memoria implicita, di esperienze, fantasie e difese che appartengono ad un’epoca preverbale dello sviluppo e, pertanto, non possono essere ricordate, pur condizionando la vita affettiva e emozionale dell’adulto.
Nucleo inconscio del Sé (non rimosso)
Mauro Mancia (2006) definisce la natura dell’inconscio non rimosso come intrinsecamente relazionale, poiché i suoi contenuti sono il precipitato rappresentazionale prelinguistico delle vicende legate alla relazione primaria. Per l’autore, il bambino, attraverso l’incontro denso di scambi corporei e sensoriali inscritti nella relazione emotiva con la madre, crea le sue prime proto-rappresentazioni dando loro una collocazione nel tempo e nello spazio, organizzando intorno ad esse il proprio mondo interno. L’inconscio non rimosso riguarda dunque alcune esperienze di relazione precoce con gli oggetti primari che restano dissociate dalla memoria esplicita autobiografica e si mantengono invece nella memoria implicita preverbale. Queste esperienze non possono essere sottoposte al meccanismo della rimozione dal momento che le strutture ippocampali dedicate alla conservazione della memoria autobiografica ed esplicita non maturano prima dei due anni di vita (Siegel,1999); non sono suscettibili di ricordo cosciente non perché rimosse, ma in quanto non verbalizzate e non verbalizzabili. Esse costituiscono la struttura portante di un inconscio precoce non rimosso che condizionerà la vita affettiva, emozionale e cognitiva dell’individuo anche da adulto e per il corso della sua intera vita.
Il lavoro creativo del bambino, immerso nella dimensione precoce corporea e sensoriale con l’ambiente, permette l’organizzazione e lo sviluppo del Sé depositato nella memoria emotiva e va a costituire un nucleo inconscio del Sé non rimosso (Mancia, 2006).
Memoria emotiva nel sogno
Il sogno, in questa prospettiva, può corrispondere a un evento già registrato dalla mente inconsapevolmente e può intendersi come religione della mente (Mancia, 1988) nel senso di re-ligare cioè di legare insieme varie funzioni mentali: la memoria emotiva, la conoscenza, l’esperienza precoce corporea con l’oggetto primario. Talora il lavoro sul sogno trasforma in pensabile il non-rappresentabile rendendo possibile la raffigurabilità di contenuti altrimenti non accessibili all’analisi (Botella 2001).
Le memorie corporee sensoriali possono riemergere nei sogni di quei pazienti che, in età precocissima, hanno avuto gravi malattie o disabilità. Il corpo, con il suo statuto di generatore di sensazioni (e di memorie di sensazioni), sembra capace di sostare nel sogno riproducendo il trauma e permettendone l’elaborazione e la comprensione nel processo psicoanalitico (Leuzinger-Bolheber, 2015). Sogni molto vividi, con una particolare componente fenomenologica sensoriale visiva (concreta e quasi allucinatoria)[2] che persiste anche al risveglio e che cattura attoniti i pazienti, possono essere espressione del contenuto di un trauma emotivo precoce dissociato e accessibile all’ analisi solo attraverso l’emergere di una “memoria nel sogno” (Giustino 2009).
Questa particolare prospettiva sul lavoro del sogno che valorizza gli aspetti precoci del trauma emotivo depositati nella memoria implicita, non mette in discussione la potenza del rimosso Freudiano, della censura onirica e del sogno come espressione di un desiderio inconscio rimosso, ma si affianca ad essa, soprattutto nella clinica dei pazienti più difficili.
Molte tipologie di sogni e diversi tipi d’inconscio sembrano dunque stratificarsi nella comprensione del funzionamento della mente umana.
Le proto-rappresentazioni precoci nella mente infantile potrebbero forse essere paragonate alle pre-concezioni che Bion (1962) e Money- Kyrle (1927-1977) avevano ipotizzato come istanze inconsce emozionali che forniscono l’equipaggiamento interno al bambino per trasformarsi nell’incontro con la realtà e con l’oggetto, predisposizioni naturali e imprescindibili per la conoscenza soggettiva/oggettiva delle relazioni umane e del Sé.
Il nucleo inconscio non rimosso del Sé può a mio avviso rappresentare molto bene la dimensione intersoggettiva dell’inconscio poiché è composto da affetti, difese e fantasie nell’incontro con la mente dell’altro ed è in diretto rapporto con quanto percepito dal soggetto nelle relazioni primarie, cioè la memoria delle esperienze sensoriali precoci.
Il nucleo del Sé inconscio è, a mio parere, il deposito di una conoscenza preriflessiva che è in stretto rapporto con quanto il corpo ha memorizzato di ciò che è stato percepito della realtà; è popolato di contenuti emotivo-sensoriali , fantasie sensoriali nel corpo e memorie del funzionamento corporeo (Gaddini, 1987; Giustino, 2017) o di percetti conosciuti non pensati (Bollas,1987) legati all’esperienza personale e corporea del mondo interno ed esterno.
Sé corporeo e intersoggettività: alcuni contributi neuroscientifici [3]
L’intuizione formidabile di Winnicott (1971) sul rispecchiamento del bambino nel volto della madre, è ancora oggi fonte di grande ricchezza.
La celebre frase dell’Autore per cui il bambino vede se stesso nel volto della madre, è uno dei numerosi esempi di come la nostra disciplina sia spesso capace di anticipare, con il pensiero intuitivo che deriva dalla nostra esperienza teorico-clinica, ciò che altre discipline confermano poi più tardi .
Dobbiamo al gruppo di Gallese e Rizzolatti dell’Università di Parma la scoperta dei neuroni –specchio e dei vari funzionamenti corporei/ mentali in cui essi si attivano.
Collocati prevalentemente (ma non solo) nella porzione anteriore delle aree pre-motorie ventrali (area F5), sono neuroni motori che hanno la caratteristica di attivarsi durante l’esecuzione di movimenti volti al conseguimento di scopi molto precisi. Questi neuroni integrano anche informazioni sensoriali, cioè rispondono anche a stimoli tattili, acustici e visivi (Rizzolatti e Gallese, 2006); infatti anche il suono prodotto dall’azione è sufficiente a evocare la risposta dei neuroni-specchio.
Il meccanismo specchio presente nel cervello umano si attiva non solo in presenza di azioni dirette su oggetti, ma anche di azioni comunicative (es. la danza) e si attiva non solo durante l’esecuzione dell’atto motorio intenzionale, ma anche durante l’osservazione di un analogo atto motorio compiuto da qualcun altro, anche quando è possibile immaginare (non solo vedere) questo atto. Nel cervello umano, i neuroni specchio si trovano in alcune aree cerebrali legate funzionalmente ai processi della memoria (regioni para-ippocampali). Il rispecchiamento motorio di ognuno di noi è dunque potenzialmente diverso da quello degli altri perché la storia individuale e relazionale di ognuno di noi è diversa.
Gallese ipotizza che i neuroni specchio siano prelinguistici ma abbiano una sorta di “contenuto concettuale”. L’Autore (2014) parla di meccanismo di “simulazione incarnata” laddove il comportamento intenzionale dell’altro attiva un meccanismo funzionale di base pervasivo nel nostro cervello che è del dominio delle azioni, delle emozioni e della sensibilità/ sensorialità; un meccanismo legato alle dinamiche interpersonali non linguistiche delle interazioni precoci madre-bambino (pre e post- natali) e, verosimilmente, della comunicazione non verbale dell’interazione terapeutica.
La simulazione incarnata[4], sostiene Gallese, sembra essere del dominio motorio, emotivo e percettivo (sensazioni), è un meccanismo implicito automatico e preriflessivo ma fortemente influenzato dalle relazioni interpersonali che genera “intentional attunement” consentendo di capire le modalità esperienziali altrui. Sono in gioco gli aspetti precoci e non consapevoli delle relazioni intersoggettive così importanti per lo sviluppo del Sé e del mondo interno del bambino e poi dell’adulto.
Vedere l’oggetto, come sottolinea ancora Gallese, significa simulare un’azione potenziale interattiva con quell’oggetto; le stesse potenzialità motorie che ci rendono consapevoli del nostro Sé corporeo ci rendono consapevoli del Sé corporeo altrui che, attraverso il sistema specchio, viene mappato sul nostro. In condizioni normali, secondo l’autore, la relazione specifica tra Sé e mondo è un elemento organizzativo di base che prevede un’esperienza soggettiva del proprio corpo come corpo vivo in relazione col mondo e in relazione con le intenzionalità operative degli altri Sé.
Interessante, a questo proposito, anche il contributo di un altro neuroscienziato, Georg Northoff (2019). L’Autore sostiene che la sintonizzazione col nostro corpo e il senso di noi stessi come soggetti in relazione con gli stimoli provenienti dal mondo è un’ esperienza fondamentale; se si determina un disordine di tale sintonizzazione, c’è una rottura col mondo e c’è la perdita della consapevolezza preriflessiva del Sé. Northoff concepisce il Sé come un sistema dinamico, in interazione costante con il mondo interno e quello esterno, con un aspetto inconscio che interagisce e incorpora (embodiment) l’ambiente, ed un aspetto di consapevolezza conscia, che gli conferisce il senso di identità e la sensazione di stabilità nel tempo, comportando la possibilità di ripensare a se stessi nel passato e progettarsi nel futuro. In questo modello il corpo è l’ interfaccia tra mente e mondo esterno e il suo funzionamento modella la mente ad un livello inconsapevole, involontario, che precede la nostra consapevolezza. Quindi per Northoff, è l’esperienza soggettiva in prima persona di spazio e tempo, corpo, ambiente interno ed esterno e Sé, a costituire le basi della nostra struttura psichica, della nostra personalità e delle eventuali alterazioni in caso di disturbi psichici.
Conclusioni
La nostra disciplina, grazie a Freud, vanta il primato del riconoscimento dell’esistenza dell’inconscio. Tuttavia le declinazioni della “materia dell’inconscio” avanzano e si ampliano all’interno della psicoanalisi stessa. Basti pensare al concetto Bioniano di inconscio come funzione inconsapevole della mente, metabolizzatore psichico che permette di trasformare le esperienze sensoriali (elementi beta) in contenuti psichici (elementi alfa) (1962 ); oppure a quello di Matté Blanco (1975 ) sull’inconscio simmetrico che spersonalizza e generalizza e quello asimmetrico che particolarizza e personalizza. L’autore tra l’altro scrive di un inconscio non rimosso che ha caratteri primitivi (esclusivo dell’Es) e irrazionali e di un inconscio rimosso caratteristico dell’Io e del Super-Io.
Credo sia molto importante, dal punto di vista clinico, la distinzione tra il concetto d’inconscio dinamico, in cui opera la rimozione e di inconscio emotivo-ricettivo (De Masi, 2012 ) che elabora le emozioni garantendo il contatto con la realtà psichica e che sembra particolarmente compromesso nelle condizioni psicopatologiche più gravi. Le emozioni non simbolizzate non possono essere mentalizzate, ma solo essere esperite nel corpo dal bambino; le relazioni traumatiche precoci incidono negativamente sullo sviluppo della capacità di simbolizzazione e compromettono le sfere dell’affettività, della cognizione e delle relazioni sociali.
Per crescere e sviluppare la nostra mente abbiamo bisogno della mente di un altro e, soprattutto nei pazienti più difficili, la psicoanalisi ha il compito di co-costruire nella relazione analitica le capacità di simbolizzazione lavorando sulle funzioni emotivo-intuitive inconsapevoli della psiche che sono danneggiate.
L’interrelazione tra corpo, inconscio non rimosso, sviluppo del Sé e intersoggettività nello sviluppo mentale infantile a mio parere conferma l’importanza dell’empatia incarnata che noi tutti possiamo riscontrare nel processo terapeutico e che influisce sulla nostra abilità , come psicoanalisti, di sintonizzarci affettivamente con gli stati inconsci precoci del Sé del paziente (verbalizzati e non).
Il sistema specchio, tra numerosi altri riscontri delle neuroscienze, potrebbe rappresentare un arricchimento interdisciplinare importante aggiungendo un altro tassello alla comprensione dei processi diadici precoci intersoggettivi. E’ possibile dunque che la psicoanalisi utilizzi il proprio enorme patrimonio di conoscenze sulla soggettività per suggerire alle neuroscienze e ad altre discipline affini possibili terreni di ricerca sperimentale e che, di ritorno, i dati emergenti stimolino la nostra ricerca contribuendo a promuovere la valutazione dei concetti teorici e interrogando la psicoanalisi sulle proprie teorie evolutive, del trauma o dell’ azione terapeutica.
Note
1 Numerosi studi della teoria dell’attaccamento (Bowlby, 1988), i cui fruttosi e ampi sviluppi non mi dilungherò a ricordare in questa sede, descrivono i Modelli Operativi Interni come disposizioni e memorie implicite che derivano dagli stili precoci di accudimento e di interazione col caregiver e che si mantengono per tutto l’arco della vita in una matrice di rappresentazioni sub-simboliche.
2 La qualità fenomenica prevalentemente visiva di questa tipologia di sogni sembra essere espressione di scene oniriche collegate a memorie infantili precoci in quanto le rappresentazioni mentali infantili sono prevalentemente visive (Lewin 1968).
3 Così come avevano intuito gli psicoanalisti, numerosi contributi neuroscientifici hanno evidenziato che fin dalla nascita gli stimoli a cui il bambino è esposto innescano e rinforzano schemi specifici di attività neuronale (Edelman e Tononi, 2001). Gli stimoli sensoriali , ad esempio, tendono a regolare l’organizzazione anatomica e cellulare del sistema nervoso in via di sviluppo (Schore, 1994) e, nei casi in cui il bambino ha ricevuto stimoli sensoriali insufficienti o non ha avuto la sintonizzazione emotiva durante il periodo critico per la formazione dei legami di attaccamento, insorgono comportamenti che rimarranno anomali o disadattivi per il resto della vita.
4 Diversi studi mostrano che sia l’osservazione sia l’imitazione dell’espressione facciale delle cosiddette emozioni di base determina l’attivazione dell’area pre-motoria primaria (neuroni specchio), dell’amigdala e dell’insula.
Bibliografia
Ammaniti M., GalleseV. (2014). La nascita della intersoggettività. Lo sviluppo del Sé tra psicodinamica e neurobiologia. Milano: Cortina.
Bion W. R. (1962). Apprendere dall’esperienza. Roma: Armando
Bollas C. (1987). L’ombra dell’oggetto. Roma: Borla 1989.
Botella C., Botella S. (2001). La raffigurabilità psichica. Borla: Roma 2004.
De Masi F. (2012). Lavorare con i pazienti difficili. Torino: Bollati Boringhieri.
Freud S. (1922). L’Io e l’Es. In Opere Vol. 9 Torino: Bollati Boringhieri 1977.
Freud S. (1927). Il problema dell’analisi condotta da non medici. Conversazione con un interlocutore imparziale. Poscritto. Opere, 10: 416-423. Torino: Boringhieri1978.
Gaddini E. (1982). Early Defensive Fantasies and the Psychoanalytical Process. International Journal of Psychoanalysis, 63:379-388.
Giustino G. (2009) “Memory in dreams” International Journal of Psychoanalysis 90: 5 pp1057-1073 .
Giustino G. (2017). Further developments on the concept of fantasy. International Journal of Psychoanalysis 98 (3):831-839.
Giustino G. (2019). Inconscio non rimosso e intersoggettività.
Una possibile convergenza tra psicoanalisi e neuroscienze. Interazioni n.2/2019 , Roma .
M. Leuzinger-Bolheber (2015) Finding the body in the mind. Karnac books London.
Lewin B. D. (1968). The image and the past. New York, NY: International Universities Press.
Mancia, M. (1988). The Dream as Religion of the Mind. Int. J. Psycho-Anal., 69:419-426
Mancia M. (2006). Implicit memory and early unrepressed unconscious (how the neurosciences can contribute to psychoanalysis).
International Journal of Psychoanalysis, 87,pp 83-103.
Matte Blanco I. (1975). L’inconscio come insiemi infiniti. Saggio sulla bi-logica. Torino: Einaudi 1981
Money-Kyrle R.(1927-1977). Scritti. Torino: Loescher 1985.
Northoff G. (2019). La neurofilosofia e la mente sana. Imparare dal cervello malato. Milano: Cortina.
Rizzolatti G., Gallese V.(2006 ). So quel che fai .Milano: Cortina.
Siegel D. (1999). La mente relazionale. Milano: Cortina 2013
Stern (1999). Il mondo interpersonale del bambino. Torino: Bollati Boringhieri
Storolow R.D., Atwood G.E. (1992). I contesti dell’essere. Le basi intersoggettive della vita psichica. Torino: Bollati Boringhieri, 1995
Winnicott D. W. (1971). Gioco e realtà. Roma: Armando, 1974
Incorporazione
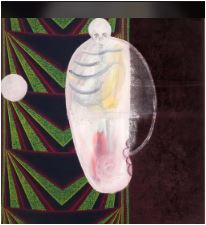
Sigmar Polke 1974
Parole chiave: Identificazione; Introiezione; Cannibalico; Abraham
INCORPORAZIONE
A cura di Maria Moscara
Incorporazione è una parola composta derivata dal latino tardo in – corporare che indica, in senso proprio e figurato, sia l’atto dell’immettere qualcosa in un corpo, sia lo stato di due o più cose incorporate, fuse insieme.
In psicoanalisi, il termine di incorporazione è andato incontro a vicissitudini, che durano fino ai nostri giorni poiché spesso il termine è stato usato come equivalente di introiezione e talora di identificazione (Knight 1940; Hartmann e Loewenstein 1961, p 169; Rapaport 1957, p 447; Gaddini 1968, p 160).
In queste note si cercherà di mettere a fuoco il concetto di incorporazione nel corpus freudiano e in alcuni degli psicoanalisti che si sono occupati di questo tema.
Col concetto di incorporazione si intende un processo psichico primitivo alla base dei processi introiettivi e identificativi che accompagnano le vicissitudini di sviluppo di ciascun individuo. L’incorporazione rappresenta una delle modalità più arcaiche di rapporto con l’oggetto (Fenichel 1945, p 168), un processo strettamente connesso alla fase orale (Hartmann e Lowenstein 1961, p 170) e alla pulsione orale parziale, pur senza coincidere, in quanto inizia ma non si esaurisce con essa.
Altre zone erogene possono fungere da supporto all’incorporazione per es. la funzione respiratoria e la cute. Hendrick (1951) descrive l’incorporazione anale e visiva e Fenichel (1945) menziona l’incorporazione attraverso lo sguardo e l’ascolto.
Secondo Greenson (1954) l’incorporazione è un’attività istintuale orale che ha come obiettivo di prendere nella bocca una parte esterna del mondo che in questo modo entra a far parte del mondo interno e per questa via entra nel sé fisico; l’obiettivo dell’incorporazione per questo Autore sarebbe la soddisfazione istintuale, senza tenere in considerazione il destino dell’oggetto, in questo senso l’incorporazione non è indicativa né di odio né di amore verso l’oggetto.
Freud utilizza il termine di incorporazione nei Tre Saggi sulla teoria sessuale (1905, p 506), aggiunge il termine nel secondo Saggio: “La sessualità infantile” nel 1920; facendo esplicito riferimento ai saggi di Abraham (1912) in cui si occupava del trattamento psicoanalitico della follia maniaco-depressiva; in una nota successiva del 1924, Freud fa riferimento al saggio di Abraham del 1916 in cui approfondiva l’evoluzione della libido. Sempre nei Tre Saggi sulla teoria sessuale (1905 p 506) segnala l’intreccio inestricabile tra attività sessuale e assunzione di cibo e sottolinea l’indifferenziazione tra le due attività e la comunanza della meta che consiste “nell’incorporazione dell’oggetto”.
Freud riprende il tema dell’incorporazione più volte; in Pulsioni e loro destini (1915) sottolinea come nell’incorporazione si intreccino diverse mete pulsionali e ri-sottolinea l’incontro tra pulsione sessuale e orale. Inoltre usa il concetto di incorporazione per descrivere il passaggio evolutivo dall’Io-piacere all’Io-realtà (p 31) e chiarisce che quando l’oggetto è fonte di sensazioni piacevoli si produce una tendenza motoria, mirante ad avvicinare l’oggetto all’Io, ad incorporarlo in esso (p 32). Nello stesso saggio, cita il lavoro di Ferenczi del 1909 che si occupava della connessione tra introiezione e transfert, affermando che l’Io assume in sé gli oggetti che costituiscono fonti di piacere, li introietta (secondo l’espressione di Ferenczi) e caccia fuori di sé ciò che nel suo interno diventa occasione di dispiacere (Freud 1915, p 31).
In Lutto e melanconia (1915) tornerà sull’incorporazione nella disamina della complessa relazione tra l’Io e l’oggetto perduto in relazione alla regressione che il lutto comporta. L’Io vorrebbe incorporare in sé tale oggetto e, data la fase orale o cannibalica della propria evoluzione libidica vorrebbe incorporarlo divorandolo (p 109), anche in questo saggio Freud cita Abraham, uno dei suoi interlocutori privilegiati, che già da alcuni anni lavorava sul tema della melanconia a partire dal trattamento psicoanalitico di casi di “Follia maniaco-depressiva” (1912). Freud (1932) riprende il tema dell’incorporazione nella Lezione 31 dove si occupa della formazione del Super-io; paragona l’identificazione con l’incorporazione orale cannibalesca e individua nell’identificazione il fondamento del processo per la formazione del Super-io.
Abraham (1916; 1924), anche per la consuetudine nella cura di pazienti psichiatrici gravi, si interessò allo sviluppo della libido pregenitale. A partire dalla teorizzazione freudiana propone una sottodivisione degli stadi dell’organizzazione della libido correlandola con gli stadi evolutivi dell’amore oggettuale (1924 p 349). Nel suo lavoro suddivide ciascuna delle fasi dell’organizzazione della libido, individuate da Freud, in due diverse sotto-fasi: stadio orale primissimo, della suzione; stadio orale più tardo o cannibalico; stadio anale primissimo; stadio anale più tardo; stadio genitale precoce o fallico; stadio genitale definitivo. Nel correlare gli stadi dello sviluppo libidico con gli stadi dell’evoluzione dell’amore oggettuale definisce l’incorporazione totale dell’oggetto come propria dello stadio orale più tardo o cannibalesco, dove corrisponderebbe una fase d’amore narcisistica; allo stadio sadico-anale primissimo fa corrispondere un’incorporazione con amore parziale (1924, p 349).
Abraham riprendendo la teorizzazione di Freud enunciata in Lutto e Melanconia avanza l’ipotesi che la Melanconia derivi da un processo di regressione della libido del malato “a quel primissimo stadio orale..”; l’Autore sottolinea l’importanza di due processi contestuali: da un lato vi è una regressione della libido alla fase orale, dall’altro un processo d’introiezione dell’oggetto d’amore; poiché nella malinconia vi è una regressione della libido allo stadio cannibalesco, l’introiezione dell’oggetto d’amore avviene, di fatto, tramite un processo di incorporazione.
M. Klein (1946; 1952) postula la possibilità di incorporare oggetti parziali come conseguenza della scissione dell’oggetto che avviene per proiezione dell’angoscia primaria sull’esterno, proiezione che in parte torna all’interno dell’Io precoce, avendo come risultato l’incorporazione di un oggetto parziale persecutore. Klein (1946) ipotizza che l’incorporazione dell’oggetto nella sua totalità sia il risultato di un processo di maturazione dell’Io che consente di sperimentare la posizione depressiva, caratterizzata dalla spinta a riparare o salvaguardare l’oggetto danneggiato; i processi riparativi permetterebbero di incrementare i processi di sintesi e integrazione dell’Io (Klein 1946, p 423; 1952, p 538).
Da parte sua Fenichel (1945, p 99) sottolinea come il primo comportamento istintivo positivo, nei confronti di un oggetto desiderato sia quello di diminuirne la distanza e di inghiottirlo. L’atteggiamento opposto è quello di sputarlo e rappresenta il primo istinto negativo nei confronti di un oggetto non desiderato, aumentandone così la distanza; con il progredire dello sviluppo l’atteggiamento è volto ad eliminarlo, come succede nella defecazione. Fenichel ribadisce come la prima incorporazione cerchi di distruggere l’oggetto, in questo senso l’oralità rappresenta la base per ogni incorporazione. La prima incorporazione rappresenta la radice comune dell’amore e dell’odio, con il procedere dello sviluppo l’oggetto è conservato anche per poterlo usare quando ce ne sarà ancora bisogno.
Autori come Rapaport (1957), Hartmann e Loewenstein (1961) e Gaddini (1968) teorizzano una visione genetica che dall’incorporazione porterebbe all’introiezione, all’identificazione e all’imitazione, ritenendo l’incorporazione “un precursore genetico dell’identificazione”. In qualche modo l’ipotesi genetica si ritrova in primis in Freud quando correla la meta sessuale all’incorporazione dell’oggetto e lo definisce “il modello” di quello che più tardi sarà la “identificazione” (1905, p 506).
Hinshelwood (1990) sottolinea come il termine di incorporazione si riferisca alla fantasia di prendere un oggetto dentro il proprio corpo, dove mantiene un proprio spazio e rimane attivo.
Laplanche e Pontalis (1993) individuano tre significati nell’incorporazione: quello del procurarsi un piacere facendo penetrare un oggetto in sé stessi, quello del distruggere questo oggetto e quello di assimilare le qualità dell’oggetto conservandole dentro di sé. Questa ultima accezione sarebbe la matrice dell’introiezione e dell’identificazione.
Gaddini (1968), a partire dall’interesse per i processi psichici primitivi, si occupa dell’incorporazione in riferimento all’imitazione che correla strettamente ai processi identificativi; anche nella sua teorizzazione si può rintracciare una visione genetica tra incorporazione, introiezione, imitazione ed identificazione; citando Greenson (1954, p 76) ritiene che l’introiezione sia il modello psichico parallelo al modello fisico del “mettere in bocca” proprio dell’incorporazione (Gaddini 1968, p 163). Nella sua teorizzazione l’incorporazione orale viene correlata alle fantasie di fusione nell’accezione di avere e possedere l’oggetto; in modo concorde con l’ipotesi kleiniana il modello incorporativo-introiettivo rappresenterebbe la base per lo sviluppo dell’invidia per ciò che si vorrebbe possedere (ibidem p 164).
Bibliografia
Abraham K.: (1912) Note per l’indagine e il trattamento psicoanalitici della follia maniaco-depressiva e di stati affini, Bollati Boringhieri, To, 1975
Abraham K. (1916): Ricerche sul primissimo stadio evolutivo pregenitale della libido in: Opere, I, Bollati Boringhieri, To, 1997
Abraham K. (1924): Tentativo di una storia evolutiva della libido sulla base della psicoanalisi dei disturbi psichici in: Opere, I, Bollati Boringhieri, To, 1997
Fenichel O.: Trattato di psicoanalisi, Astrolabio, Roma, 1945
Ferenczi S. (1909): Introiezione e transfert, Opere, Raffaello Cortina Editore, Mi, 1989
Freud S.: Tre saggi sulla teoria sessuale, 1905, O.S F., IV, Boringhieri, To, 1970
Freud S.: Pulsioni e loro destini, 1915, O.S F., VIII, Boringhieri, To, 1976
Freud S.: Lutto e melanconia, 1915, O.S.F., VIII, Boringhieri, To, 1976
Freud S.: Introduzione alla psicoanalisi, 1933, O.S.F., XI, Boringhieri, To, 1979
Gaddini E.: (1968) Sull’imitazione, in: Scritti, Raffaello Cortina Editore, Mi, 1989
Greenson R. R.: (1954): “The struggle against identification” Int. J. psychoanal, 2: 200-217
Hartmann H. e Loewenstein R. M (1961) Note sul Super-io in: Scritti di Psicologia Psicoanalitica, Boringhieri, To, 1978
Hendrick I. (1951) “Early development of the Ego: Identification in infancy”, Psychoanalytic quarterly, 20, 1, 44-61
Hinshelwood R.D.: Dizionario di Psicoanalisi kleiniana, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1990
Klein M. (1946): Note su alcuni meccanismi schizoidi, Scritti 1921-1958, Bollati Boringhieri, TO, 1978
Klein M. (1952): Le influenze reciproche nello sviluppo dell’Io e dell’Es, Scritti 1921-1958, Bollati Boringhieri, TO, 1978
Knight R.P: “Introjection, Projection and identification”, Psychoanalytic qualterly, 9, 3, 334-341, 1940
Laplanche e Pontalis: Enciclopedia della psicoanalisi, Economica Laterza, BA, 1993
Rapaport D.: (1957) “Analisi teorica del concetto di Super Io” in: “Il modello concettuale della psicoanalisi” Feltrinelli, Milano, 1977
Indifferenza

M. Pistoletto
Indifferenza
A cura di A.A. SEMI
L’indifferenza è uno stato affettivo che sperimentiamo quando ci si interessa a qualcosa o qualcuno che non è interessato a noi, qualcuno che sia assolutamente impermeabile a noi o a tutto ciò che proviene da noi. L’indifferenza, per un altro verso, ci permette però di essere sufficientemente distaccati, liberi di dedicarci alla nostra quotidianità, in quanto ci difende da un eccesso di stimolazione, emotiva e cognitiva, da cui saremmo altresì travolti. Si configura, dunque, sia come una barriera più o meno spessa sia come una quantità di energia psichica che sostiene movimenti psichici volta a ridurre o annullare la percezione degli stimoli in arrivo. Queste due configurazioni, barriera e movimento psichico, non sono in antitesi tra di loro ma possono integrarsi o essere due aspetti di un medesimo movimento psichico.
Sacerdoti (1997) nota in primo luogo il fatto che tutti, quando pensiamo all’indifferenza, la collochiamo nell’ambito dei sentimenti, mentre quando pensiamo alla differenza, la cui mancanza dovrebbe determinare appunto la in-differenza, allora pensiamo a contenuti ideativi. L’indifferenza, quando è un atteggiamento cosciente, consiste nell’essere indifferente verso gli altri e talvolta diventa una strategia di vita. Quando, invece, è preconscia considera l’altro come funzione di cui si può fruire. In questo caso, gli altri esistono coscientemente, nel senso che sono percepibili e percepiti, ma inconsciamente non esistono come soggetti ma solo come ostacoli, con cui fare i conti, oppure erogatori di benessere da cui trarre un qualche beneficio. Istintivamente potremmo pensare alle patologie narcisistiche di vario tipo.
L’indifferenza, come sappiamo, viene incentivata dalla nostra cultura in quanto permetterebbe all’individuo il raggiungimento di una condizione di autosufficienza, di lavorare e produrre e di scaricare rapidamente la tensione pulsionale.
Un altro aspetto dell’indifferenza, si riscontra tra i tutti i frequentatori di internet, di blog, di forum, di mailing list, di social network. Qui assistiamo a persone abitualmente compassate o fredde che rivelano emozioni vivissime, quasi che l’interposizione del mezzo telematico potesse consentirne l’espressione. La presenza-assenza (o presenza virtuale) dell’interlocutore o di una massa di interlocutori (dunque scarsamente personalizzati) permette di rivelare l’ uso puramente funzionale dell’oggetto, rendendolo idoneo alla proiezione secca di contenuti importanti, abitualmente repressi. Si richiama questo fenomeno perché esso ha a che fare con l’indifferenza nella vita quotidiana e ne svela la caratteristica di indifferenza come esito di un processo di inibizione al contatto con l’altro.
La clinica psicoanalitica, che a proposito di indifferenza ha dovuto penare a lungo, a partire dalla ‘belle indifférence’ dei pazienti isterici per arrivare a svariati tipi di configurazioni psichiche narcisistiche, può aiutarci a riconoscere ‘l’indifferente compulsivo,’ il professionista o il tecnico che lavorano intensamente per cinque giorni alla settimana e scaricano miseramente il desiderio tramite l’alcool o la cocaina o altre droghe in contesti sociali che condividono l’accettabilità di questo sistema. Essere indifferenti all’altro, in questo contesto culturale, vuol dire evitare di esporsi alla frustrazione. Quel che viene viceversa disincentivato è l’elaborazione di una soggettività consapevole, l’uso degli affetti per conoscere l’altro, la possibilità di arricchirsi e svilupparsi assieme all’altro e agli altri, il riconoscimento delle potenzialità di progetti comuni davvero, nei quali gli altri sono persone e non strumenti per realizzare il progetto. Il problema culturale attuale sembra essere quello di eliminare il soggetto lasciando attivo solo l’individuo, che diventa così il nuovo schiavo. Magari soddisfatto di esserlo.
L’indifferenza attuale è un aspetto inconscio drammaticamente difensivo a fronte di un messaggio continuo proveniente dall’esterno di impossibilità di elaborazione soggettiva degli stimoli esterni e in definitiva di intollerabilità della soggettività. Le esplosioni emotive su internet diventano l’altra faccia della medaglia, quella virtuale, di una condizione di indifferenza necessaria ma alla lunga intollerabile.
L’indifferenza individuale appartiene a quella fase psichica nella quale è possibile soddisfare da sé e in sé le pulsioni. Fase instabile, breve, periodicamente smentita e fallimentare ma che consente comunque di garantirsi l’indifferenza verso l’esterno, verso gli stimoli che provengono dall’esterno. In questo senso, l’indifferenza individuale consente un rifiuto all’altro e agli altri e una sorta di rivolta individuale. Ora, è proprio questo che l’indifferenza culturale favorisce: la rivolta momentanea anziché la “rivoluzione” come forma organizzata e condivisa di cambiamento della realtà. Forse, la psicoanalisi nella misura in cui ricorda il fallimento dell’eccesso di narcisismo e la necessità dello sviluppo della soggettività, ha anche una funzione civile nel segnalare quanto l’indifferenza sia non solo un disastro sociale ma anche un modo di favorire il ritorno della società umana a forme di irresponsabilità che preludono alla schiavitù.
Bibliografia
Sacerdoti (1997) in Sacerdoti G. e Racalbuto A. (a c. di) Differenza, indifferenza, differimento. Dunod, Milano, 1997.
Infant Observation/Storia
A cura di Dina Vallino
Negli anni 1940-60 psicoanalisti di nazionalità diverse si interrogavano su come si sviluppa una personalità sana e alcuni Anna Freud, Spitz, Kris, Bowlby, Mahler, Sander che si occupavano di bambini, impostarono varie metodiche di osservazione sperimentale del bambino piccolo (camere di osservazione, situazioni di osservazione controllata, coadiuvata, in alcuni casi, da registrazioni sonore o cinematografiche. Anna Freud in particolare, assieme a Dorothy Burlingham ci ha lasciato osservazioni molto accurate sul comportamento spontaneo dei bambini nelle war nurseries ). Esther Bick, invece, analizzata a Manchester da Balint e successivamente a Londra da Melanie Klein, concepì un’attività di osservazione molto particolare che, con modalità del tutto naturali e senza procedure sperimentali, permise di conoscere come un neonato cresce nella sua famiglia.
Si trattava da parte dell’osservatore di visitare un neonato, a casa sua, per un periodo di due anni e osservarne lo sviluppo affettivo e mentale nella relazione con la madre. In due anni sono circa 100 ore di osservazioni. E’ un tipo di osservazione definita “partecipe” perché tra l’osservatore e chi viene osservato (madre bambino padre) passano una gamma di sentimenti che possono arricchire ma anche deformare la conoscenza dell’osservatore.
L’assetto mentale dell’osservatore che va a visitare un neonato nella sua famiglia può essere sintetizzato in alcuni punti:
a) vi è un neonato con la sua mamma e il suo papà in un qualsiasi giorno, in una qualsiasi casa; l’osservazione avviene in un orario opportuno per la madre e per il padre del neonato; l’osservazione ha come condizione una continuità nella visita settimanale; da parte dell’osservatore è necessario un profondo rispetto delle abitudini e della cultura della famiglia e dedizione al compito che persegue: conoscere un neonato e apprendere da quei genitori il loro stile di allevamento e di educazione.
b) l’osservatore prende appunti dopo l’ora di osservazione e prepara un protocollo dettagliato che solo successivamente leggerà e discuterà nel gruppo di discussione;
c) un piccolo gruppo di persone, con un conduttore specializzato in infanta observation, riflette sul protocollo e lo commenta.
d) Per imparare a diventare “Osservatore” è necessario un iter formativo lungo e rigoroso e un’attitudine mentale di umiltà.
L’Infant Observation permette di andare in profondità nella comprensione di un neonato come persona, come soggetto che si esprime in varie situazioni del tutto quotidiane della sua vita (mentre è allattato, in braccio alla sua mamma, quando è pulito, se vocalizza, insieme a lei e senza di lei, col papà, con fratelli e sorelle ecc.). L’Infanta observation ci mette in contatto con l’angoscia esistenziale del neonato che rapidamente trascorre, se le cure dell’ambiente sono appropriate, in felicità di vivere. Mi riferisco a un comune <normale> neonato, alle sue angosce e alle crisi che frequentemente investono la sua esistenza e che ripetutamente vengono superate.
In Italia l’Infant Observation è stata introdotta da Lina Generali, nel 1971, con un celebre articolo sulla Rivista di Psicoanalisi, “L’osservazione come metodo di studio in psichiatria infantile”.
Il contributo che l’Infant observation ha dato alla conoscenza della persona del bambino piccolo e alla psicoanalisi infantile è stato e continua ad essere estremamente fecondo. Non è possibile riferire qui la quantità di interventi e applicazioni nel campo della educazione, della pedagogia, della neuropsichiatria infantile che avvenne grazie all’apporto di numerose personalità appartenenti alla Società di Psicoanalisi, all’area della neuropsichiatria infantile, alla Tavistock Clinic e ad altre associazioni di psicoterapia.
L’Infant observation, come movimento di formazione e aggiornamento, ha impegnato la teoria e la tecnica psicoanalitica su nuove frontiere di ricerca. La presa in carico e la cura di bimbi piccoli (0-3 anni) con la loro madre sarebbe stata impensabile senza una adeguata formazione con l’Infant. Ne è derivata, più recentemente, la Consultazione partecipata di bambini e adolescenti, in presenza dei genitori, come momento terapeutico o fase iniziale di una terapia.
Tra i più significativi contributi inerenti al campo della prevenzione e della ricerca voglio menzionare l’Osservatorio della Maternità Interiore, presieduto da Gina Ferrara Mori, che è attualmente il più importante Gruppo di Ricerca e di Prevenzione, originato dall’integrazione dell’infant observation e della psicoanalisi nell’esplorazione della relazione madre-bambino, la quale inizia molto prima della nascita del bambino e si rivela attraverso i vissuti e le rappresentazioni mentali della madre.
Il lavoro di psicoanalista, già pediatra, di Gina Ferrara Mori le ha permesso di individuare precocemente non solo quei segni premonitori di una possibile depressione post-partum, che può indurre la madre a non a prendersi cura del bambino (ad esempio, dettagli depressivi sono particolarmente evidenziabili nelle produzioni oniriche di pazienti incinte durante psicoterapie o psicoanalisi), ma le ha permesso una rivisitazione culturale dei molti ostacoli intrapsichici, interpersonali e sociali che accompagnano l’evento del divenire madre.
Una delle principali funzioni preventive dell’Osservatorio della Maternità interiore, costituito da un folto gruppo di Psicoanalisti medici Assistenti sociali, pediatri psicoterapeuti ecc. è data dall’osservazione partecipe e dall’ascolto delle future mamme. Per tale impegno nei confronti della futura relazione madre-bambino, l’Osservatorio, oltre che luogo di ricerca e di studio, è diventato un luogo formativo di figure professionali preparate a favorire lo sviluppo di un nuovo clima con il quale accogliere le gestanti nei servizi sociosanitari.
APPROFONDIMENTI
Levi Bianchini Marco
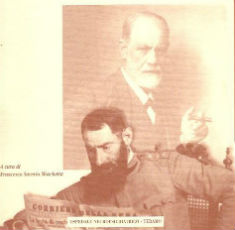
Levi Bianchini Marco
A cura di Rita Corsa
Maestri della psicoanalisi
Levi Bianchini, Marco (Rovigo, 28 agosto 1875 – Nocera Inferiore, 21 agosto 1961)
Marco Levi Bianchini, un eclettico psichiatra tardo positivista dalla personalità complessa e contraddittoria, fu uno degli antesignani e più indomiti sostenitori della scienza freudiana in Italia. Il 7 giugno 1925 fondò a Teramo la prima Società Psicoanalitica Italiana.
La vita e l’attività medico-psichiatrica
Nato a Rovigo il 28 agosto 1875 in una famiglia della borghesia ebraica (1), conseguì la laurea in medicina a Padova, nel 1899, discutendo una tesi psichiatrica d’impostazione lombrosiana. Neolaureato frequentò la clinica psichiatrica di Firenze, ma ben presto iniziò una versatile vita professionale, che lo portò, nel 1901, ad arruolarsi come ufficiale medico in Congo, dove rimase per meno di un anno avendo contratto la malaria. Al rientro dall’Africa, il giovane medico pubblicò alcuni saggi dedicati a patologie infettive e tossicologiche tropicali e due interessanti studi di carattere “psico-sociale” (1904a e 1906a).
Dopo una breve parentesi in qualità di medico condotto a Cervia e ad Adria, si applicò precipuamente in area neuropsichiatrica, realizzando una rapida carriera ospedaliera: dapprima prestò la sua opera nella clinica medica dell’Università di Padova, poi nel manicomio di Ferrara; divenne vicedirettore del frenocomio provinciale di Girifalco (Catanzaro), poi assistente in quello di Nocera Inferiore (Salerno), dove cominciò a lavorare nel 1909. Nel 1913, ottenuta la libera docenza in psichiatria all’Università di Napoli e la nomina a primario nel frenocomio di Nocera Inferiore, intraprese dei viaggi di studio nei principali istituti neuropsichiatrici tedeschi per apprendervi l’organizzazione e gli ordinamenti, poi riassunti in un libricino (1913d) e in un articolo illustrativi (1914). Nonostante avesse studiato alla scuola biodeterminista dell’allora indiscusso maestro Cesare Lombroso, Levi Bianchini non rimase impermeabile alle innovative influenze della psichiatria europea, specialmente quelle di area germanica. Fu proprio nella Clinica di Kraepelin, a Monaco, che si consolidò anche il suo interesse per la psicoanalisi, colà liberamente discussa, anche se fortemente osteggiata.
Allo scoppio della Grande Guerra, Levi Bianchini venne richiamato alle armi come medico militare, con il grado di tenente colonnello.Dall’esperienza maturata negli ospedali da campo, nacquero diversi suoi saggi dedicati alla psicopatologia post-traumatica bellica, in linea con la coeva letteratura europea (1917/1918, 1919 e 1920a).
Al termine delle ostilità, riprese a condurre l’Ospedale Psichiatrico di Nocera Inferiore sino al gennaio 1924, quando fu trasferito a Teramo con l’incarico di dirigere il locale manicomio. Dopo sette, fecondi anni trascorsi a governare e rinnovare il frenocomio di Teramo, nel 1931 tornò a guidare l’Ospedale Psichiatrico di Nocera Inferiore.
Nel 1938, alla promulgazione delle leggi razziali, fu sospeso dal suo ufficio, sebbene avesse aderito al regime fascista, finanche contribuendo alla costituzione del fascio di Teramo – si autodefiniva “fascistissimo” della prima ora (Benevelli, 2013). Nell’epoca buia delle persecuzioni razziali riuscì a nascondersi in Italia, evitando il doloroso espatrio. Dopo la Liberazione, guidò ancora per un breve periodo l’Istituto di Nocera Inferiore, ma ben presto dovette abbandonare l’incarico per raggiunti limiti di età. Rimase tuttavia Direttore Emerito del manicomio campano e – come vedremo – Presidente Onorario della S.P.I., e proseguì ancora per molti anni la sua attività di medico e di psichiatra. Passò il resto della sua vita a Nocera Inferiore, dove si spense il 21 agosto 1961.
Le iniziative editoriali
Fin dal 1913 con l’opera “L’isterismo dalle antiche alle moderne dottrine” Levi Bianchini «aderì apertamente alla Psicoanalisi, di cui divenne un fervido divulgatore in Italia con una attività instancabile» (Musatti, 1961).
Nel 1915 Levi Bianchini crea la Biblioteca Psichiatrica Internazionale, con lo scopo di dischiudere la rivista Il Manicomio. Archivio di Psichiatria e Scienze Affini (il giornale neuropsichiatrico del frenocomio di Nocera Inferiore) ai nuovi orientamenti della psichiatria europea e alla novella scienza freudiana. Il numero d’esordio della Biblioteca viene inaugurato dalla prima traduzione italiana di un’opera di Freud, nobilitata da una prefazione dello stesso padre della psicoanalisi. Si tratta delle Cinque conferenze sulla psicoanalisi, i seminari tenuti da Freud alla Clark University, durante il viaggio in America nel settembre 1909. La traduzione è a cura di Levi Bianchini.
Prima traduzione italiana di un’opera di Freud (a cura di Marco Levi Bianchini)
Nella Prefazione, Freud indirizza parole di grande lode e gratitudine allo psichiatra italiano, capace di «straordinaria comprensione (…) a garanzia di una corretta interpretazione». Il lavoro di Levi Bianchini riceve l’incondizionato assenso della nomenclatura psicoanalitica internazionale. Ma la Biblioteca rimane penalizzata dall’angusto humus intellettuale campano dell’epoca e da questioni di ordine economico, che la condannano a ridurre gradualmente il suo servizio. Al periodico va comunque riconosciuto lo straordinario merito di aver coraggiosamente inaugurato l’avvento del pensiero freudiano nel nostro paese.
La Biblioteca Psicoanalitica Italiana origina dalle ceneri della Biblioteca Psichiatrica Internazionale, sempre ad opera di Marco Levi Bianchini, con la collaborazione di Edoardo Weiss, in qualità di redattore. Freud riconosce ed apprezza gli sforzi dei due seguaci italiani, impegnati a ritagliare alla psicoanalisi un posto di rilievo nell’editoria nazionale.
Alla fine degli anni Venti, la casa editrice Idelson assume la stampa della Biblioteca Psicoanalitica Internazionale. Serie Italiana, ulteriore evoluzione dell’originaria Biblioteca di Levi Bianchini. Stavolta, però, il direttore è Edoardo Weiss, che realizza tale giornale con lo scopo di raccogliere contributi inediti internazionali e le traduzioni italiane di altre opere freudiane e di analisti stranieri. Con questo passaggio di mano, il periodico acquisisce un vero respiro transnazionale.
Il 25 marzo 1920, l’incontenibile dinamismo editoriale dello psichiatra rodigino sfocia nell’istituzione a Nocera Superiore – presso il Manicomio Materdomini (succursale del Frenocomio Interprovinciale di Nocera Inferiore) – della rivista Archivio Generale di Neurologia e Psichiatria. Concepito come naturale continuazione de Il Manicomio, l’Archivio è diretto da Levi Bianchini in collaborazione con diversi celebri psichiatri e cattedratici dell’epoca. Tra i venti componenti della redazione, spicca il nome di Edoardo Weiss, che compare sin dal numero d’esordio dell’ormai leggendario giornale.
I due fascicoli della prima annata presentano alcuni lavori di stampo psicoanalitico, dove vengono offerte corpose citazioni dai saggi di Freud, Breuer e Ferenczi.
Nel 1921 Levi Bianchini trasforma il suo Archivio – senza addurne le ragioni – in Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, più che dimezza il comparto redazionale (Weiss rimane al suo posto) e sposta la sede da Nocera Superiore a Nocera Inferiore, sino al 1923/24, quando passa a dirigere il frenocomio di Sant’Antonio Abate di Teramo ed ivi colloca anche la riproduzione del periodico.
Dall’inserimento della locuzione Psicoanalisi (2), la rivista inizia ad accogliere viepiù scritti di carattere psicoanalitico, sia italiani che stranieri, e ad offrire una vasta gamma di recensioni dei più aggiornati studi di psicoanalisi.
I fascicoli del 1922 sono quasi completamente dedicati alla psicoanalisi e riportano, tra gli altri contributi, un dettagliato resoconto del Settimo Congresso Psicoanalitico Internazionale, tenutosi a Berlino dal 25 al 27 settembre 1922, dove Levi Bianchini ed Edoardo Weiss «per la prima volta avevano rappresentato l’Italia nella vita della Psicoanalisi» internazionale. Al termine del Congresso, Marco Levi Bianchini viene accettato come membro della Società Psicoanalitica Viennese, dove rimarrà iscritto sino al 1932.
levi%20bianchini%20marco1
Foto con dedica autografa donata da
Sigmund Freud a Marco Levi Bianchini
(dicembre 1921)
Nel 1925 viene creata a Teramo la Società Psicoanalitica Italiana, di cui l’Archivio è consacrato organo ufficiale, a partire dal 1926 e sino al 1931 compreso. Levi Bianchini continua a ricoprire la carica di Direttore; tra i cinque redattori spicca ancora il nome di Edoardo Weiss, l’unico psicoanalista dell’intero gruppo.
Il giornale, che di fatto si propone per diversi anni come il principale veicolo di discussione e diffusione delle tesi freudiane in Italia, è diviso in due sezioni: nella prima vengono riportati gli articoli originali, nella seconda recensioni e segnalazioni di opere e di libri di psicoanalisi e di psichiatria, italiani e stranieri.
Nel 1932, con la riorganizzazione della Società Psicoanalitica a Roma e la nascita della Rivista Italiana di Psicoanalisi quale organo specifico del movimento, l’Archivio ridimensiona drasticamente le sue ambizioni psicoanalitiche e torna a rappresentare l’operosità scientifica del frenocomio di Nocera Inferiore, di cui lo psichiatra rodigino ha ripreso la direzione nel 1931. Nel 1935 Edoardo Weiss e gli altri analisti italiani interrompono ogni contatto con l’Archivio. Resta comunque sempre corposa la sezione dedicata alla recensione di opere psicoanalitiche, curata esclusivamente dallo stesso Levi Bianchini, che nel contempo dedica altrettanto spazio alla presentazione di un’enorme mole di libri (oltre dieci mila!) delle più svariate discipline mediche e culturali (neuropsichiatria, anatomia, biologia, fisiologia, antropologia, etnologia, letteratura, storia delle religioni, etc.), trasformando il periodico in uno strumento personale d’informazione.
L’Archivio chiude la sua attività nel 1938, quando, in seguito all’emanazione delle leggi razziali, l’ebreo Levi Bianchini viene bruscamente sostituito da padre Agostino Gemelli, che già l’anno seguente riavvia il periodico, con il nome Archivio di Psicologia, Neurologia, Psichiatria e Psicoterapia, purgandolo di qualsivoglia riferimento alla psicoanalisi.
Nell’immediato dopoguerra Marco Levi Bianchini si lancia nell’ennesima avventura pubblicistica, dando vita all’Archivio di Scienza della Cerebrazione e degli Psichismi (Giornale di Psicobiologia, Neuropsichiatria e Psicoanalisi): di questo «nuovo giornale» – bollettino dell’ospedale psichiatrico di Nocera Inferiore, che egli nuovamente guida – Levi Bianchini «non è solo l’editore, ma anche “il proprietario, il curatore e il direttore responsabile” (…) e, inoltre, l’unico autore degli articoli e delle numerose recensioni di libri» (Weiss, 1947). Il periodico, che alla fine degli anni Quaranta muterà ancora il nome in Archivio di Neuropsichiatria e Psicoanalisi, non lascerà alcuna traccia scientifica di rilievo.
La nascita della Società Psicoanalitica Italiana
Il 7 giugno 1925, alle ore 15, nei locali della Direzione del Manicomio Sant’Antonio Abate di Teramo, presso Porta Melatina, viene posta la prima pietra della Società Psicoanalitica Italiana. Sono presenti di persona 8 medici, tutti provenienti dalle istituzioni sanitarie locali, e per delega altri 5 dottori, operanti in diverse regioni italiane (3).
L’indiscusso fautore dell’iniziativa è il Prof. Dott. Marco Levi Bianchini, Direttore del Manicomio di Teramo. Su 13 membri, ben 9 lavorano nei servizi psichiatrici e/o sanitari della città abruzzese.
Nel primo Statuto, messo ai voti ed approvato all’unanimità, si proclama ufficialmente la fondazione della Società Psicoanalitica Italiana, con sede temporanea a Teramo (Abruzzi); si costituisce il Comitato di Direzione provvisorio, composto di tre membri (Rezza, Levi Bianchini e Weiss), incaricati di compilare lo statuto definitivo entro il 31 dicembre 1925; si stabilisce che l’Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi è per diritto l’organo ufficiale della Società e ne pubblica gli atti ed i resoconti (Atti Ufficiali della S.P.I., Teramo, 7 giugno 1925).
La notizia viene subito comunicata a Freud e a vari organi istituzionali scientifici e culturali italiani ed esteri. La reazione del mondo psicoanalitico internazionale è calorosa e viene riportata da Levi Bianchini nella successiva seduta ordinaria della S.P.I., tenutasi a Teramo il 29 novembre 1925. In questa assemblea sono distribuite ufficialmente le cariche sociali: Edoardo Weiss, che non è presente di persona ma per delega, viene eletto Presidente; la Vicepresidenza va a Del Greco e la Segreteria a Levi Bianchini. Viene poi data lettura dello Statuto sociale, compilato dal Comitato provvisorio e costituito da dieci articoli. In gran sintesi, nei primi punti si ribadiscono la data della fondazione, la sede sociale e l’organo ufficiale per la pubblicazione degli atti (Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi); nei successivi commi si definiscono l’organigramma del Comitato di Presidenza (un presidente, un vicepresidente e un segretario tesoriere); le tre classi dei soci (ordinari, aderenti e onorari) (4); le quote d’iscrizione; le riunioni ufficiali annue (almeno due, di cui una possibilmente in forma di Congresso) e le funzioni preminenti della S.P.I. («diffondere in Italia lo studio dottrinale e la pratica clinica della psicoanalisi freudiana (…) Non ammette alcuna servitù scolastica ed è aperta a tutte le correnti») (Atti Ufficiali della S.P.I., Teramo, 29 novembre 1925). La seguente seduta ordinaria viene fatta ancora a Teramo, il 25 novembre 1926. Weiss non è presente, ma ha inviato un’ampia relazione sullo stato attuale della società, sul suo carattere e sulle sue finalità, dal titolo “La Società Psicoanalitica Italiana”. Si tratta di un lungo elaborato, che racchiude il chiaro intento di sottolineare, impietosamente, l’assoluta impreparazione psicoanalitica dello sparuto gruppo di soci, che non hanno fatto un’analisi personale, che non hanno partecipato ai convegni e ai seminari psicoanalitici europei e che non possiedono conoscenze teoriche aggiornate, viste le difficoltà di introdurre le opere freudiane in Italia. Edoardo Weiss teme l’eccessivo avventurismo psicoanalitico di Levi Bianchini e dei suoi discepoli, che maneggiano in maniera assai improvvida il congegno analitico.
Le iniziative della S.P.I. proseguono in maniera stentata, anche se si svolge con regolarità l’assemblea annuale dei soci, che si riunisce sempre a Teramo: il 5 maggio 1928 il Segretario Levi Bianchini legge un’altra breve lettera di Weiss – come al solito assente – dove si ribadisce che, nonostante gli sforzi fatti, la «nostra Società» progredisce davvero poco e rimane del tutto «sola ed isolata» (Atti Ufficiali della S.P.I., Teramo, 5 maggio 1928). Null’altro ci è dato sapere delle attività istituzionali della prima fase della S.P.I., che gradualmente si affievoliscono, sino a spegnersi del tutto.
Il primo ottobre del 1931, a Roma, in via dei Gracchi 328-A, nello studio privato di Edoardo Weiss, la Società Psicoanalitica Italiana riprende vita, per volere di quest’ultimo, che ne diviene Presidente, mentre Rieti è nominato segretario-tesoriere. Levi Bianchini è unanimemente acclamato Presidente Onorario ad vitam. La continuità della Società non viene formalmente interrotta, limitandosi a trasferire la sede ufficiale da Teramo a Roma. Tuttavia, nei fatti, si tratta di una sostanziale riorganizzazione: nei primi mesi del 1932 sarà redatto il nuovo Statuto e creato uno specifico organo editoriale, la Rivista Italiana di Psicoanalisi, totalmente dedicato a scritti di natura psicoanalitica. A Marco Levi Bianchini non viene affidato alcun ruolo decisionale nella politica del nuovo movimento. Egli presenzierà sino a tarda età alle celebrazioni ufficiali della S.P.I., in qualità di padre fondatore e di Presidente Onorario, ma non comparirà mai un articolo a suo nome sulla Rivista Italiana di Psicoanalisi, né sulla Rivista di Psicoanalisi, ricostituita nell’immediato dopoguerra.
Per tutta la vita Marco Levi Bianchini, scienziato poliedrico, sentì come una missione farsi paladino delle idee di Freud, che lo incoraggiò e gli dette un buon credito. Ma, in ultima istanza, il medico rodigino rimase uno psichiatra tardo positivista, che aveva la pretesa di costringere la psicoanalisi nelle maglie della psichiatria organicista d’inizio Novecento. I suoi articoli psicoanalitici, infarciti dei tanti neologismi che egli amava coniare – tra cui “psichismo”, che ormai è entrato nell’uso comune – rappresentano proprio una temeraria operazione d’intersezione di qualche concetto freudiano con gli assunti deterministi della contemporanea psichiatria germanica.
In conclusione, Marco Levi Bianchini è stato senz’altro «il più clamoroso e indefesso esponente» della «fase pre-pionieristica» della psicoanalisi italiana, «caratterizzata per un verso da un’angosciata e distorta divulgazione del pensiero di Freud (…) e dall’altro da una prima concomitante organizzazione di difesa» nei confronti della neuropsichiatria ufficiale, contraria al messaggio freudiano (Gaddini, 1974). Un temerario e generoso precursore della disciplina psicoanalitica nel nostro paese (5).
Note
(1) Marco era il primogenito di quattro fratelli maschi (Angelo, Achille e Leone), nati dal banchiere Michelangelo Levi e da Enrichetta Bianchini. Quando Marco era adolescente, il nucleo familiare si disgregò, poiché il padre subì un tracollo finanziario che lo costrinse a riparare all’estero, mentre la madre si dovette trasferire a Padova, portando con sé i quattro figlioli. Il traumatico cambiamento dell’assetto familiare scatenò in Marco un disturbo nevrotico da lui definito “neurosi reattiva vegetale”. A suo dire, tale sofferenza psichica lo spinse ad incuriosirsi alla psicoanalisi e l’incontro con la disciplina freudiana lo avrebbe completamente guarito. Egli, però, non si sottopose mai ad un’analisi personale.
Agli inizi del secolo scorso Marco si coniugò con Nella Saravalle, una ricca ebrea padovana, che rimase sempre al suo fianco. La loro unica figlia morì in tenera età.
(2) A proposito del termine italiano “psicoanalisi”, Freud aveva affermato che per lui psicanalisi o psicoanalisi era lo stesso, anche se Levi Bianchini nelle sue traduzioni aveva optato per la seconda denominazione (Schinaia, 2005). Quindi dobbiamo a Levi Bianchini la canonizzazione di quella “o” che , nel tempo, è diventata un segno distintivo della disciplina freudiana in Italia.
(3) Oltre a Levi Bianchini partecipano direttamente i dottori: Egisto De Nigris e Leonardo Claps, ambedue primari del frenocomio di Teramo; Nicola Ciaranca, medico ordinario le medesimo manicomio; il prof. dott. Dario Maestrini, direttore dell’Ospedale Civile di Teramo; il dott. Giovanni Lucangeli, Maggiore Medico P.A.S., Presidente della Congregazione di Carità di Teramo; il dott. Romolo Lucangeli, direttore del Brefotrofio Provinciale di Teramo; il dott. Luigi Lucidi, direttore del Dispensario Celtico Provinciale della stessa città.
Non di persona, ma per delega, risultano presenti: il prof. dott. Alberto Rezza, direttore del Manicomio Provinciale di Fermo (Ascoli Piceno); il prof. dott. Francesco Del Greco, direttore del Manicomio Provinciale di Aquila degli Abruzzi; il dott. Raffaele Vitolo, primario del Manicomio Interprovinciale di Nocera Inferiore; il dott. Edoardo Weiss, primario [sic!] del Manicomio di Trieste; il dott. Giovanni Dalma, medico ordinario dell’Istituto Psichiatrico S. Lazzaro di Reggio Emilia.
(4) Tuttavia il titolo di “ordinario” non conferisce il diritto all’esercizio della pratica psicoanalitica: solo la Presidenza potrà deliberare, con seguente pubblicazione agli atti, l’elenco dei “Soci ritenuti competenti per esercitare la terapia psicoanalitica”.
(5) Bellanova rammenta con commozione che, nel 1962, alcuni psicoanalisti, guidati da Servadio, si recarono a Nocera nella vecchia casa di Levi Bianchini, da poco scomparso, per acquistare 1000 volumi della sua enorme biblioteca, costituita da oltre 12.000 libri. Questo legato dello psichiatra rodigino andò a costituire il primo nucleo della biblioteca del Centro psicoanalitico di Roma.
Cronologia essenziale degli scritti di Marco Levi Bianchini
La produzione scientifica, quella pubblicistica e di recensore e quella editoriale di Marco Levi Bianchini sono sterminate e spaziano in molti campi del sapere.
Ci si limita a segnalare alcuni contributi di natura medica e neuropsichiatrica e gli scritti fondamentali in campo psicoanalitico.
LEVI BIANCHINI M. (1902). Ematuria tropicale fulminante. Annali di Medicina Navale, VIII, 1, 599-611.
LEVI BIANCHINI M. (1903a). Meningite cerebro-spinale nei neri dell’Africa centrale: osservazioni di patologia esotica. La Riforma Medica, XIX, 1327-1329.
LEVI BIANCHINI M. (1903b). Nel centro dell’Africa: perizia medico-legale in un caso di supposto avvelenamento. Riv. Mensile di Psichiatria Forense, VI, 281-285.
LEVI BIANCHINI M. (1903c). Sull’età di comparsa e sull’influenza dell’ereditarietà nella patogenesi della demenza primitiva o precoce. Riv. Sperimimentale di Freniatria e Medicina Legale delle Alienazioni Mentali, XXIX, 559-575.
LEVI BIANCHINI M. (1904a). Il Congo e la colonizzazione dell’Africa centrale. La Riforma Medica, XXI, 326-340.
LEVI BIANCHINI M. (1904b). Sulla patogenesi del mutacismo (sommersione del linguaggio) nella demenza precoce. Il Manicomio. Archivio di Psichiatria e Scienze Affini, 110-127.
LEVI BIANCHINI M. (1906a). La psicologia della colonizzazione nell’Africa periequatoriale. Riv. di Psicologia Applicata alla Pedagogia e alla Psicopatologia, II, 395-403.
LEVI BIANCHINI M. (1906b). Monogenesi e varietà cliniche della demenza primitiva – Ricerche e studi di Psichiatria, Neurologia ecc. dedicati al prof. E. Morselli. Milano, Vallardi.
LEVI BIANCHINI M. (1913a). Psicoanalisi e isterismo. Il Manicomio. Archivio di Psichiatria e Scienze Affini, XXVIII, 49-82.
LEVI BIANCHINI M. (1913b). L’isterismo dalle antiche alle moderne dottrine. Padova, Drucker.
LEVI BIANCHINI M. (1913c). Una teoria biologica dell’isterismo. Il Manicomio. Archivio di Psichiatria e Scienze Affini, XXVIII, 83-138.
LEVI BIANCHINI M. (1913d). Elementi di assistenza e tecnica manicomiale. Padova, Drucker.
LEVI BIANCHINI M. (1914). Metodi e progressi della tecnica manicomiale in Germania. Quaderni di Psichiatria, I, 123-131.
LEVI BIANCHINI M. (1917-18). Il coraggio in guerra e in pace. Il Manicomio. Archivio di Psichiatria e Scienze Affini, XXXII-XXXIII, 127-138.
LEVI BIANCHINI M. (1919). Il senso della morte e il senso dell’orrore durante la battaglia. Quaderni di Psichiatria, VI, 233-239.
LEVI BIANCHINI M. (1920a). Diario di guerra di uno psichiatra nella campagna contro l’Austria (1915-1918). Nocera Superiore, Biblioteca Psichiatrica Internazionale.
LEVI BIANCHINI M. (1920b). Negativismo mnesico e negativismo fasico. Contributo allo studio psicoanalitico della “conversione” nelle demenze endogene (primitive). Archivio Generale di Neurologia e Psichiatria, I, 2, 169-193.
LEVI BIANCHINI M. (1921). Cesare Lombroso. Un grande iniziato. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, II, 109-112.
LEVI BIANCHINI M. (1922a). La psicoanalisi della fantasia creatrice ed il pensiero autistico nell’arte e nelle psicosi. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, III, 19-39.
LEVI BIANCHINI M. (1922b). La dinamica dei psichismi secondo la psicoanalisi e lo stato attuale di questa scienza in Italia. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, III, 40-72.
LEVI BIANCHINI M. (1922c). Il VII Congresso Psicoanalitico Internazionale (Berlino, 25-27 Settembre 1922). Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, III, 73-76.
LEVI BIANCHINI M. (1923/1924a). Difesa della psicoanalisi. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, IV-V, 6-13.
LEVI BIANCHINI M. (1923/1924b). Valori e aspetti sociali della psicoanalisi. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, IV-V, 39-100.
LEVI BIANCHINI M. (1925). Atti Ufficiali della Società Psicoanalitica Italiana. Teramo, 7 giugno 1925. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, VI, 239-240.
LEVI BIANCHINI M. (1926a). Il nucleo centrale della psicoanalisi e la presa di possesso della psicoanalisi in Italia. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, VII, 5-12.
LEVI BIANCHINI M. (1926b). Atti Ufficiali della Società Psicoanalitica Italiana. Teramo, 29 novembre 1925. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, VII, 43-49.
LEVI BIANCHINI M. (1926c). Freud e la psicoanalisi. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, VII, 103-120.
LEVI BIANCHINI M. (1926d). Libido-mneme (memoria sessuale) misticismo e chiaroveggenza in un bambino. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, VII, 154-169.
LEVI BIANCHINI M. (1926e). Presbiogenesi. Disfrenie e displasie presbiogeniche. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, VII, 257-286.
LEVI BIANCHINI M. (1927a). Alcune idee psicologiche e psicoanalitiche sui climateri dell’uomo. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, VIII, 133-152.
LEVI BIANCHINI M. (1927b). Atti Ufficiali della Società Psicoanalitica Italiana. Teramo, 25 novembre 1926. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, VIII, 153-167.
LEVI BIANCHINI M. (1927c). Il X Congresso Psicoanalitico Internazionale (Innsbruck, 1-3 settembre 1927). Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, VIII, 287-293.
LEVI BIANCHINI M. (1928). Atti Ufficiali della Società Psicoanalitica Italiana. Teramo, 5 maggio 1928. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, IX, 239-240.
LEVI BIANCHINI M., NARDI J. (1929). Malariaterapia della psicosi maniacodepressiva. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, X, 5-12.
LEVI BIANCHINI M., MORIONDI C. (1930). Le radiazioni dell’atmosfera umana in rapporto alla diagnosi precoce della personalità psichica e psicopatica ed alla profilassi ed igiene mentale. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, XI, 41-43.
LEVI BIANCHINI M. (1930a). Il narcisismo catatonica nella schizofrenia e la sua estrema espressione: la posizione embrionale. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, XI, 43-60.
LEVI BIANCHINI M. (1930b). Virilismo prosopopilare e androfania. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, XI, 121-133.
LEVI BIANCHINI M. (1930c). Aforismi psicoanalitici ed altri contributi alla storia della simbolistica sessuale nell’arte erotica. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, XI, 253-266.
LEVI BIANCHINI M. (1931). Atti Ufficiali della Società Psicoanalitica Italiana. Roma, 1 ottobre 1931. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, XII, 349-351.
LEVI BIANCHINI M., NARDI J. (1932). Malariaterapia delle psicosi non luetiche. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, XIII, 121-170.
LEVI BIANCHINI M. (1933a). Ancora alcuni piccoli aforismi psicoanalitici ed altri. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, XIV, 34-40.
LEVI BIANCHINI M. (1933b). Il suicidio e l’omicidio degli alienati internati negli ospedali psichiatrici. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, XIV, 205-278.
LEVI BIANCHINI M. (1934). La caratterologia psicoanalitica ed i suoi psicobiotipi. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, XV, 134-143.
LEVI BIANCHINI M. (1935). Ricerche cliniche sulla terapia bromobarbiturica delle epilessie con un nuovo preparato sinergico italiano “BROMULIN”. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, XVI, 5-11.
LEVI BIANCHINI M. (1936). La morte neurotica e la morte psicotica (catatonica). Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, XVII, 194-222.
LEVI BIANCHINI M. (1937). Contributo alla storia della stampa psichiatrica e neurologica in Italia dalle origini (fine del secolo XVIII) alla epoca attuale. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, XVIII, 5-20.
LEVI BIANCHINI M. (1938). Biologia sociale e politica demografica. Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi, XIX, 191-199.
LEVI BIANCHINI M. (1955). Difesa della psicoanalisi di fronte alla neurosi cristiana antifreudiana. Archivio di Neuropsichiatria e Psicoanalisi, II, 269-302.
LEVI BIANCHINI M. (1956). Commemorazione del centenario della nascita di S. Freud. Archivio di Neuropsichiatria e Psicoanalisi, III, 421-428.
LEVI BIANCHINI M. (1958). La fonte della vita ovvero il bisogno di essere amati. Archivio di Neuropsichiatria e Psicoanalisi, V, 49-99.
Bibliografia essenziale sulla vita e l’opera di Marco Levi Bianchini
ACCERBONI PAVANELLO A. M. (1990). Sigmund Freud as remembered by Edoardo Weiss, the Italian pioneer of psychoanalysis. Int. Rev. Psycho-Anal., 17, 351-359.
ACCERBONI A.M. (1997). Marco Levi Bianchini e Edoardo Weiss: un insolito sodalizio alle origini della psicoanalisi in Italia. In: DI CHIARA G., PIRILLO N. (a cura di), Conversazione sulla psicoanalisi. Napoli, Liguori.
ACCERBONI A. M. (2002). Fatti e personaggi negli esordi della psicoanalisi in Italia. Riv. Sperimentale di Freniatria, CXXVI, 1-2, 125-136.
BELLANOVA P. (1982). Il Congresso del cinquantenario. Rivista Psicoanal., 28, 403-410.
CAMMARATA M. (2015). Angelo, Achille e Leone Levi Bianchini: al di là del dovere. Relazione letta al Convegno dell’Associazione Italia-Israele, I Levi Bianchini da Trieste al mondo. Trieste, 27 aprile 2015.
CAPPELLI V.M. (1995). Alle origini di un’avventura: Marco Levi Bianchini in Congo (1901). In: MOSCHETTA F.S. (a cura di), Marco Levi Bianchini e le origini della psicoanalisi in Italia. Atti del Convegno Nazionale, Teramo, 26-27-28 ottobre 1995. Sant’Atto-Teramo, Officine Grafiche Edigrafital S.P.A., 2000, 79-88.
CECCARELLI G. (1995). Marco Levi Bianchini e la psicoanalisi: i primi scritti sull’Archivio generale di Neurologia, Psichiatria e Psicoanalisi. In: MOSCHETTA F.S. (a cura di), Marco Levi Bianchini e le origini della psicoanalisi in Italia. Atti del Convegno Nazionale, Teramo, 26-27-28 ottobre 1995. Sant’Atto-Teramo, Officine Grafiche Edigrafital S.P.A., 2000, 111-137.
CORSA R. (2013). Edoardo Weiss a Trieste con Freud. Alle origini della psicoanalisi italiana. Le vicende di Nathan, Bartol e Veneziani. Roma, Alpes.
CORSA R. (2015a). Marco Levi Bianchini. Audace pioniere della psicoanalisi in Italia. Relazione letta al Convegno dell’Associazione Italia-Israele, I Levi Bianchini da Trieste al mondo. Trieste, 27 aprile 2015.
CORSA R (2015b). Marco Levi Bianchini. Lo psichiatra temerario che fondò la Società Psicoanalitica Italiana. Riv. Psicoanal., in corso di stampa.
DAVID M. (1966). La psicoanalisi nella cultura italiana. (Terza edizione riveduta e ampliata). Torino, Boringhieri, 1990.
FREUD S. (1900). Il sogno. O.S.F., 4. [S. FREUD, Il sogno – prima traduzione italiana, sulla seconda edizione tedesca del 1911, (del Prof.) M. Levi-Bianchini, Biblioteca Psichiatrica Internazionale, n. 2, F. Giannini e Figli, Napoli, 1919].
FREUD S. (1905). Tre saggi sulla teoria sessuale. O.S.F., 4. [S. FREUD, Tre contributi alla teoria sessuale – prima traduzione italiana a cura di M. Levi Bianchini, Napoli, Idelson, 1921].
FREUD S. (1909). Cinque conferenze sulla psicoanalisi. O.S.F., 6. [S. FREUD, Sulla psicoanalisi: cinque conferenze tenute nel settembre 1909 alla Clark University di Worcester Mass. in occasione del 20. anniversario di fondazione – prima traduzione italiana sulla seconda edizione tedesca del 1912, (del Prof.) M. Levi Bianchini, Biblioteca Psichiatrica Internazionale, n. 1; Il Manicomio “Archivio di Psichiatria e Scienze Affini”, Nocera Superiore, 1915].
FREUD S. (1914). Per la storia del movimento psicoanalitico. O.S.F., 7.
FREUD S. (1915-17). Introduzione alla psicoanalisi. O.S.F., 8.
FREUD S. (1993). Epistolari. Corrispondenza con Ernest Jones. Volume 1. 1908-1920. Torino, Boringhieri, 2001.
FREUD S., FERENCZI S. (1992). Lettere. Volume Primo. 1908-1914. Milano, Cortina.
FREUD S., FERENCZI S. (1998). Lettere. Volume Secondo. 1914-1919. Milano, Cortina.
FREUD S. (2002). The Complete Correspondence of Sigmund Freud and Karl Abraham 1907-1925 (by Falzeder E.). London, Karnak Books.
GADDINI E. (1974). I settanta di Emilio Servadio. Un tributo. Riv. Psicoanal., 1, 5-13.
GRINSTEIN A. (1956). The index of psychoanalytic writings. New York, International Universities Press.
LEVI BIANCHINI A. (1995). Ricordi. In: MOSCHETTA F.S. (a cura di), Marco Levi Bianchini e le origini della psicoanalisi in Italia. Atti del Convegno Nazionale, Teramo, 26-27-28 ottobre 1995. Sant’Atto-Teramo, Officine Grafiche Edigrafital S.P.A., 2000, 47-52.
LIEBERMAN J., KRAMER R. (a cura di) (2012). The Letters of Sigmund Freud and Otto Rank: Inside Psychoanalysis. Baltimora, Johns Hopkins University Press.
MOSCHETTA F.S. (a cura di) (1995). Marco Levi Bianchini e le origini della psicoanalisi in Italia. Atti del Convegno Nazionale, Teramo, 26-27-28 ottobre 1995. Sant’Atto-Teramo, Officine Grafiche Edigrafital S.P.A., 2000.
MUSATTI C. (1961). Necrologio. Marco Levi Bianchini. Riv. Psicoanal., 1, 3-5.
SCHINAIA C. (2005). Freud e Genova. Riv. Psicoanal., 2, 475-487.
SERVADIO E. (1932). Testimonianza di Emilio Servadio. Riv. Ital. Psicoanal., 1, XXXIII-XXXIV.
SERVADIO E. (1965). La psicoanalisi in Italia. Riv.Psicoanal., 1, 3-8.
THE VIENNA PSYCHO-ANALYTICAL SOCIETY (1922). Bul. Int. Psychoanal. Assn., 3, 133-137.
WEISS E. (1920). Italian Literature. Int. J. Psycho-Anal., 1, 455-456.
WEISS E. (1947). Archivio Di Scienza Della Cerebrazione E Dei Psichismi (Giornale De Psicobiologia, Neuropsichiatria E Psicoanalisi) [sic!]. Psychoanal. Q., 16, 145-146.
WEISS E. (1970). Sigmund Freud come consulente. Roma, Astrolabio, 1971.
Sitografia
ARCHIVIO WEISS – ASPI (Archivio Storico della Psicologia Italiana).
www.aspi.unimib.it/index.php?id=1235
BENEVELLI L. (2013). Marco Levi Bianchini. Considerazioni sugli africani. http://www.psychiatryonline.it/node/4267
MANOTTA M. Archivio Generale di Neurologia, Psichiatria e Psicoanalisi. http://www.aspi.unimib.it/index.php?id=882
MANOTTA M. Marco Levi Bianchini. http://www.aspi.unimib.it/index.php?id=883
MATTANA G. La SPI compie novant’anni
ZANOBIO A. (2005). Levi Bianchini, Marco. http://www.treccani.it/enciclopedia/marco-levi-bianchini_(Dizionario-Biografico)/
Materiale video
CAMMARATA M. (2014). Intervista a Angela Levi Bianchini. Roma, maggio 2014.
Lussana Pierandrea

Lussana Pierandrea
A cura di Andreina Tantini
Pierandrea Lussana è stato, insieme con Adda Corti, uno dei maggiori rappresentanti della psicoanalisi kleiniana in Italia. Nasce a Ivrea nel 1928 da una famiglia lombardo veneta, trascorre l’infanzia e l’adolescenza a Bergamo, poi approda a Milano per gli studi di Medicina rinnovando la tradizione familiare in cui padre, nonno e bisnonno erano medici. Negli anni 50 è a Roma dove consegue la specializzazione in neuropsichiatria infantile e intraprende l’analisi con Emilio Servadio; decide poi di trasferirsi a Londra, dove già si trovava Adda Corti, per il training in psicoanalisi infantile.
A Londra, prima di iniziare il training, incontra Anna Freud, Donald Winnicott, Melanie Klein; sarà quest’ultima a catturarlo, ad orientare le sue scelte e a condurlo nel campo della teoria e della pratica kleiniana. Alla fine degli anni ‘60 rientra a Roma e comincia la sua pratica analitica intensa e rigorosa di orientamento kleiniano sia con i bambini che con gli adulti. Durante gli anni ‘70 e ‘80 a Roma si tengono i seminari di Donald Meltzer, Martha Harris, Herbert Rosenfeld, Hanne Segal, Wilfred Bion, Betty Joseph e ancora Eric Brenman ed Esther Bick. In questo periodo si manifesta il particolare interesse della psicoanalisi ai primi anni di sviluppo del bambino e all’osservazione madre-bambino. In tale clima culturale si colloca il contributo di Pierandrea Lussana alla diffusione del pensiero kleiniano attraverso la pratica analitica, le analisi di training, le supervisioni, i seminari di formazione degli allievi.
Nell’89 con la pubblicazione, nel Trattato di Psicoanalisi Italiana, del capitolo intitolato La Psicoanalisi Infantile su base kleinana si verifica una sorta di investitura ufficiale e di riconoscimento della sua specifica formazione e competenza. Prende così il via la sua produzione scientifica, una produzione attenta, rigorosa e puntuale composta da articoli, comunicazioni e tantissime recensioni. Lussana ripercorre nei suoi lavori i temi fondamentali del pensiero kleiniano, le sue radici nella psicoanalisi freudiana, i suoi sviluppi in Bion. Nel 1990 pubblica un articolo su Riparazione e nel 1992 un articolo su Invidia, due scritti fondamentali dedicati ai due pilastri del pensiero kleiniano. In Riparazione mostrerà come Melanie Klein ha elaborato e sviluppato le idee di Freud sulla sublimazione, come sia passata dal concetto di meccanismo di difesa a quello di meccanismo di sviluppo; scriverà che per Melanie Klein la vera riparazione è costituente fondamentale dell’amore e ingrediente necessario della capacità di lavoro e della creatività.
Nel lavoro sull’Invidia Lussana mostrerà invece come lo studio di Melanie Klein non ha molti predecessori tra gli psicoanalisti, ma semmai tra gli artisti e gli scrittori, Leonardo, Bosch, Melville per citarne solo alcuni. Lussana dirà che se Freud ha scoperto il complesso di Edipo e i fondamenti della gelosia, non c’è dubbio che Melanie Klein abbia scoperto con i fondamenti dell’Invidia quello che potrebbe essere chiamato il complesso di Satana. (1) L’Autore ci ricorderà che quell’Invidia, secondo la Klein innata, inconscia e primaria, è espressione del prevalere della pulsione di morte, che è fonte di impenetrabile resistenza e di reazione terapeutica negativa, che disturba l’istaurarsi di un buon oggetto rendendo in tal modo distruttiva l’identificazione proiettiva. L’Autore parlerà ancora dell’Invidia per il buono e il bello, Invidia per l’inesauribile pazienza della bontà materna e, ricollegandosi a Bion, Invidia per la capacità di tollerare l’ignoranza e la frustrazione. Nel 1992 Lussana scrive il libro intitolato L’adolescente lo psicoanalista l’artista, un contributo che confronta l’adolescente della stanza d’analisi con l’adolescente del romanzo, della pittura, del cinema, alla ricerca di un terreno comune e di una possibile convergenza.
Nel 1998 nel lavoro Melanie Klein: piccolo gatto nero fondamento del futuro della psicoanalisi troviamo una più dettagliata esposizione del pensiero kleiniano e di come la Klein, piccolo e disinibito gatto nero, sia arrivata alle nozioni di posizione schizoparanoide e di posizione depressiva partendo dai concetti freudiani di fasi di sviluppo, di ambivalenza e di meccanismo di difesa. In particolare viene mostrato come la posizione depressiva con i suoi valori di sollecitudine e rispetto reciproco sia il momento culminante dello sviluppo e della salute mentale dell’individuo. Negli ultimi anni Pierandrea Lussana è sempre più attento al pensiero di Bion; nel 2005 scrive: Una ricognizione di Trasformazioni di Bion. In questo lavoro evidenzia la centralità dell’esperienza emozionale con le sue variazioni quantitative e qualitative, il passaggio dall’apprendimento alla crescita, (crescita intesa come essere in contatto) quale trasformazione del paziente e anche dell’analista.
Dai suoi scritti traspare il suo particolare interesse per l’arte, la musica e la letteratura: Caravaggio e la Conversione di San Paolo, Bosch e i Sette peccati capitali, Otello e Racconto d’Inverno di Shakespeare, temi osservati e commentati nella prospettiva kleiniana, un’angolatura e un punto di vista sempre attento alle vicende più profonde e originarie dell’animo umano. Ricordiamo un suo scritto, letto al centro di psicoanalisi romano, in cui, descrivendo impasto e disimpasto delle pulsioni, identificazione proiettiva, colpa e riparazione, confronta l’Otello con Racconto d’Inverno, la distruttività catastrofica della gelosia di Otello e la remissione e la capacità di perdono di Laocoonte.
Lussana aveva simpatia per le grandi figure della storia che hanno diffuso e messo in pratica la nonviolenza, come Aldo Capitini e Mahatma Gandhi; aveva una simpatia particolare per la figura di San Francesco; amava Assisi, le Carceri e il sentiero francescano del Subasio. Amava il Cantico delle Creature anche per la sua musicalità e per quel ritmo lento e ripetitivo, ritmo primordiale della vita e del mondo, come lui lo aveva chiamato. Negli ultimi anni preferiva alternare la sua produzione scientifica con una particolare produzione letteraria; scriveva dialoghi in cui metteva a confronto punti di vista diversi e i diversi stati della mente. “Dialogo di uno psicoanalista, di una ex paziente e di uno psichiatra”, “Dialogo di un viandante, di un folto d’alberi, di un animale nascosto”, “Dialogo di un sommo poeta, di un sommo musicista e di un sommo pittore”, “Dialogo di un vecchio, della morte, di una giovane”, e tanti ancora, dialoghi in cui, rinnovando in qualche modo il dialogo della stanza d’analisi, si interroga su alcuni aspetti della vita e del sapere.
Una produzione originale, arguta, espressione di quel suo pensiero sempre libero e indipendente. Infine ci piace ricordare la qualità letteraria di tutti i suoi scritti, una prosa artistica, più che il pennello, lo scalpello dello scultore, per quella sua capacità di incidere e per l’uso di un linguaggio puntuale, essenziale ed emozionante.
1) Lussana P, (1992), Invidia. Riv. Psicoanal. 1/92, Pag. 139
Cronologia degli scritti
Lussana P. (1972). Aggressività e istinto di morte da Freud a M. Klein: teoria e note cliniche. Riv. Psicoanal. Anno XVIII, n.1, p. 155-178.
Lussana P. (1981). Il cambiamento nel concetto di difesa dalla Klein a Bion. Riv.Psicoanal. Anno XXVII, n. 3/4, p. 587-592.
Lussana P. (1983). Klein. Sentendosi capito e sollevato: su Richard e il senso dell’analisi kleiniana ricordando una visita a M. Klein. Riv. Psicoanal. Anno XXIX, n.2, p. 132-142.
Lussana P. (1984). Quale uso e sviluppo della formazione disponibile. Quad. psicoter. inf. 11, p. 58-63.
Lussana P. (1984). Con Mrs Bick. discutendo l’osservazione madre bebè accanto alle varianti dell’interazione analista analizzando. Riv. Psicoanal. Anno XXX, n3, p. 356-367.
Lussana P.(1989). Linee di struttura e di movimento dell’adolescenza nella visione dello psicoanalista e del romanziere. Letto al Centro di Psicoanalisi Romano.
Lussana P. (1989). I disegni come impalcatura dei sogni nell’analisi di un quattordicenne: sperimentando la duttilità dello strumento psicoanalitico. Quad. psicoter. Inf. 18, p. 119-132.
Lussana P. (1989). La Psicoanalisi infantile su base Kleiniana. In Semi A. Trattato di Psicoanalisi. Milano, Cortina.
Lussana P. (1990). Il concetto di riparazione in M. Klein dai suoi antecedenti in Freud ai conseguenti in Bion. Prosp. Psicoanal. Lav Istituz., 8: 291-304.
Lussana P. (1992). Invidia. Riv. Psicoanal. Riv. Psicoanal. Anno XXXVIII, n.1, p. 122-153.
Lussana P. (1992). L’adolescente lo psicoanalista l’artista. Roma, Borla.
Lussana P. (1993). Identificazione e identità nell’analisi del bambino. Riv. Psicoanal. Anno XXXIX, n. 4, p. 655-658.
Lussana P. (1993). Identità di base e qualità dell’identificazione. Riv Psicoanal. Anno XXXIX, n.4, p. 659-666.
Lussana P. (1994). Dall’interpretazione kleiniana all’interpretazione bioniana attraverso l’osservazione dell’infante. Richard e Piggle. 1/94.
Lussana P. (1998). Melanie Klein: “Piccolo gatto nero o fondamento del futuro della psicoanalisi?” Konos. Anno XIX, n.1, p. 20-33.
Lussana P. (1999). Melanie Klein è davvero nera e piccola nella sua opera? Richard e Piggle. 2/99.
Lussana P. (1999). Introduzione alla teoria e tecnica della supervisione. Riv. Psicoanal. Anno XLV, n.3, p. 465-473.
Lussana P. (2000). L’adolescente in crescita tra mente e corpo, individuo e gruppalità. Koinos. Anno XXI, n. 2, p. 170-180.
Lussana P. (2002). Appunti sul terrorismo: se è concepibile l’idea di curarlo, piuttosto che solo combatterlo per distruggerlo. Riv. Psicoanal. Anno XLVIII, n. 1, p. 182-192.
Lussana P. (2002). Il delirio di gelosia in Shakespeare: quale sequenza di teorie psicoanalitiche traspare in Otello e Racconto d’inverno. Letto al Centro di Psicoanalisi Romano.
Lussana P. (2004). Riparazione. Riv. Psicoanal. Anno L, n. 1, p. 253-264.
Lussana P. (2004). L’interpretazione e la persona dell’analista. Letto al Centro di Psicoanalisi Romano.
Lussana P. (2004). Il Caravaggio felice (se dipinge) in Berti L., Lussana P., Magherini G. Richiamandoci il Caravaggio felice. Nicomp L. E., Firenze.
Lussana P. (2005). Una ricognizione di “Trasformazioni” di Bion. Riv. Psicoanal., Anno LI, n.3, p. 883-892.
Lussana P. (2005). Il canto degli uccelli e il Cantico delle Creature di San Francesco: ritmo primordiale della vita e del mondo. Letto al Centro di Psicoanalisi Romano.
Lussana P. (2006). Nota su conflittualità e reciprocità estetica e su possibile modello estetico. Letto al Centro di Psicoanalisi Romano.
Lussana P. (2008). Ultimi pensieri dialoganti in “L’alba dell’oblio”, obliati inizi. Letto al Congresso Internazionale su Bion.
Luglio 2016
Lutto (Il lavoro del)

Tania Bruguera, 2018
IL LAVORO DEL LUTTO
A cura di Daniela Battaglia
Definizione del concetto
In Lutto e Melanconia, (scritto nel 1915, ma pubblicato nel 1917), Freud afferma che il lutto è la reazione alla perdita di una persona amata o di un’astrazione che ne ha preso il posto; ad esempio la patria o un ideale. Comporta uno stato d’animo doloroso, la perdita d’interesse per il mondo esterno e della capacità di scegliere un nuovo oggetto d’amore, e anche l’avversione per ogni attività che non sia in relazione con l’oggetto d’amore perduto. Freud (1915) aggiunge che nel lutto è presente anche un distacco dai consueti interessi ma sottolinea che, dopo un ragionevole periodo di tempo, il lutto può essere superato.
Ma come accade che questo stato doloroso, che comporta un’inibizione e una limitazione dell’Io, venga superato?
Freud ricorda che è necessario un vero e proprio lavoro psichico e nello stesso testo introduce l’espressione “lavoro del lutto”. Questo concetto ha già in se stesso una portata innovativa in quanto inserisce nella comprensione del lutto un fatto nuovo, cioè che la graduale attenuazione del dolore a seguito di una perdita è il risultato di un’elaborazione psichica dinamica e niente affatto scontata. Può, infatti, anche andare incontro a un insuccesso, come osserviamo nel lutto patologico.
Secondo Freud il lavoro del lutto inizia quando il soggetto si trova costretto, sotto la pressione dell’esame di realtà, a prendere atto della inesorabilità della perdita e della conseguente necessità di iniziare un progressivo ritiro dell’investimento libidico da ciò che riguarda l’oggetto perduto.
La difficoltà delle persone ad abbandonare una posizione libidica precedentemente assunta (resistenza al cambiamento) rende difficile e lento questo processo e determina, in una prima fase, un estraniamento dalla realtà e una tenace adesione all’oggetto perduto. L’Io s’identifica parzialmente con l’oggetto in attesa di un nuovo equilibrio e di una ridistribuzione degli investimenti libidici. Nelle situazioni normali l’esame di realtà ha il sopravvento e quando il lavoro del lutto è giunto al termine, l’Io ridiventa libero superando le inibizioni legate al lutto stesso.
Elaborare il lutto significa, dunque, poter pensare a un dopo, pensare a qualcosa che sembrava impensabile e iniziare a rappresentarsi qualcosa che sembrava irrappresentabile. Pensare a un dopo apre alla speranza, al nuovo, alla possibilità di immaginare che vi sia qualcosa che non conosciamo e che vale la pena di essere conosciuto. Il superamento del lutto ci mette a confronto con la nostra capacità di rimanere vivi emotivamente in un mondo “impoverito” (è il termine usato da Freud) dall’assenza dell’oggetto d’amore. La nascita di una nuova speranza origina da una spinta vitale, che ha a che fare con la capacità di tollerare e accettare la separazione e la perdita.
Il normale processo di elaborazione del lutto, che esita nell’investimento di un altro oggetto significativo, non può avvenire nel melanconico, nel quale la relazione narcisistica e ambivalente con l’oggetto ostacola il normale svolgimento di superamento del lutto.
Freud individua alcuni elementi chiave che distinguono la melanconia dal lutto fisiologico. Il primo consiste in un disturbo della considerazione di sé, presente nella melanconia ma non nel lutto: nella prima si riscontra una mortificazione del sentimento di sé che si esprime in auto rimproveri e auto accuse e culmina nell’attesa delirante di una ritorsione. Inoltre, mentre nel lutto il soggetto avverte il mondo impoverito e svuotato, nella melanconia è l’Io stesso a essere percepito come impoverito e svuotato. In altri termini, a seguito della perdita dell’oggetto, si realizza in questo caso un mutamento del sé di cui il soggetto non è completamente consapevole.
Nel corso dello sviluppo sano del bambino avviene un processo che conduce a una differenziazione tra la libido dell’Io e la libido oggettuale. Non si tratta di operare uno spostamento di amore da se stesso verso l’oggetto, ma piuttosto di un processo per cui il bambino raggiunge una capacità di percepire l’oggetto separato, questo permette una relazionalità con gli oggetti che vengono sperimentati come esterni a sé, fuori dal regno dell’onnipotenza infantile e dotati di vita autonoma e quindi potenzialmente capaci di abbandono. Nel paziente melanconico questo passaggio non ha avuto luogo, per cui di fronte a una perdita o una delusione, egli non riesce a sganciarsi dall’oggetto perduto e regredisce dalla relazione oggettuale narcisistica alla identificazione narcisistica. In questo modo l’oggetto viene preservato nella forma di una identificazione con esso, che ostacola la possibilità di evolvere e interferisce con l’esame di realtà.
L’impossibilità del melanconico di impegnarsi in forme di relazionalità oggettuale non narcisistiche sembra essere l’ostacolo fondamentale all’istaurarsi del lavoro del lutto, come sottolinea Ogden in una interessante lettura del testo freudiano (Ogden 2012). In un certo senso si tratta di un espediente (fallimentare, in realtà) per aggirare l’esperienza del dolore della perdita e della propria impotenza rispetto al fatto che se un oggetto è sentito come altro può abbandonarci mettendo in luce la nostra non onnipotenza. Il prezzo che il soggetto paga è altissimo: in cambio della fuga dal dolore della perdita chi non accede al lavoro del lutto sperimenta un senso di mancanza di vita dovuta al fatto che si trova immerso in una realtà congelata, senza possibilità di elaborare la perdita nella realtà esterna e di entrare in contatto autentico con le proprie emozioni. Inoltre l’impossibilità di padroneggiare il dolore e il tentativo di metterlo da parte potrebbe trasformare un sentimento di delusione, solitudine, rabbia, in qualcosa che somiglia a “gioia, esultanza e trionfo” e immergere il paziente in uno stato in cui predomina il pensiero onnipotente fino ad esitare in una franca reazione maniacale.
Non va trascurato il peso dell’ambivalenza nella dinamica che stiamo osservando: da una parte l’ambivalenza esistente verso l’oggetto, dall’altra l’ambivalenza legata al desiderio di restare vivo, contrapposto al desiderio di essere una cosa sola con l’oggetto perduto. Riguardo al primo aspetto dobbiamo considerare che l’ambivalenza verso l’oggetto, insita nella relazione d’amore, viene esacerbata dalla perdita e che, a causa della regressione del soggetto verso l’identificazione narcisistica, accade che l’odio verso l’oggetto o la situazione deludente e/o abbandonante si riversi sull’Io (le autoaccuse feroci del melanconico) e che il soggetto tragga da queste sofferenze un soddisfacimento di tipo sadico . L’altra particolare forma di ambivalenza presente nel lutto riguarda la lotta tra il desiderio di vivere, sopportando il dolore della perdita, e il desiderio di essere una cosa sola con i propri oggetti interni morti. La persona capace di fare il lutto, a differenza del melanconico, riesce a elaborare questo conflitto. La nascita di una nuova speranza origina da una spinta vitale, che inevitabilmente ha a che fare con la capacità di tollerare e accettare la separazione e la scomparsa dell’oggetto amato. Nel libro “La perdita” Rossanda e Fraire (2008) indagano questo aspetto illustrando come la possibilità di intraprendere un “nuovo viaggio” con noi stessi ma senza l’altro, il potersi sentire creativi e liberi dopo un lutto sia intrinsecamente connesso all’attraversamento del dolore profondo per la perdita e mai da esso completamente disgiunto.
In estrema sintesi, il lutto può avvenire se e quando si è riusciti ad instaurare una reale relazione oggettuale con un oggetto sentito come altro da sé, perché solo allora si può accedere ad una separazione, sperimentarla e elaborarla.
Ulteriori evoluzioni del concetto
Gli studi di Karl Abraham sul lutto e sulla melanconia si collegano alle considerazioni di Freud differenziandosene in parte. Mentre Freud aveva posto in primo piano, ai fini del superamento del lutto, la necessità di un ritiro della libido dall’oggetto d’amore perduto, sotto la pressione della realtà, e la necessità di un nuovo investimento oggettuale, Abraham ha messo in risalto l’importanza della introiezione e della ricostruzione psichica dell’oggetto perduto nel mondo interno del soggetto (De Masi, 2002)
Secondo Abraham (1924) la differenza principale tra lutto normale e patologico consiste nel fatto che il superamento del lutto normale avviene tramite un processo d’introiezione che è prevalentemente al servizio della tendenza a conservare una relazione con l’oggetto d’amore perduto e\o a compensare la perdita subita. Una sorta di ricostruzione interna, che permette di conservare dentro di sé il ricordo dell’oggetto d’amore perduto con una conflittualità tollerabile, che facilita il superamento del dolore. Anche nel melanconico avviene un processo d’introiezione, ma in quest’ultimo, a causa del rapporto libidico fortemente ambivalente con l’oggetto, accade che l’Io non possa evitare di prendere su di sé la quota di ostilità rivolta all’oggetto legandosi così ad esso in un rapporto in cui prevalgono le componenti sadiche che ne impediscono una ricostruzione consolatoria.
Gli studi di Melanie Klein (1940) aprono una nuova prospettiva mettendo in luce come il lutto, sia normale che patologico, determina una riaccensione delle angosce della posizione depressiva infantile in quanto la perdita reale riattiva l’angoscia dovuta alla sensazione di aver distrutto i propri oggetti buoni interni con i conseguenti vissuti di colpa e di persecuzione. Il lavoro del lutto quindi comporta un lavoro psichico che da una parte riguarda la dolorosa necessità di accettare la realtà della perdita e di dover creare nuove relazioni nel mondo esterno e d’altra parte riguarda, in modo importante, la necessità di rigenerare nel proprio mondo interno un contatto con i propri oggetti interni buoni aprendo alla possibilità di accedere a un reale processo di riparazione creativa, che può consentire di vivere il dolore senza che questo comporti una chiusura e un impoverimento affettivo.
La Klein, superando le posizioni di Freud e Abraham, ritiene che il lavoro del lutto non riguardi solo l’elaborazione dell’ambivalenza e del tipo di legame che caratterizzava la relazione con l’oggetto perduto, ma anche la necessità di reinsediare e reintegrare i propri oggetti buoni interiorizzati, cioè i primi oggetti d’amore. E’ come se nel processo del lutto il soggetto si trovasse ad attraversare e poi superare una variante di uno “stato maniaco –depressivo temporaneo” (Klein, 1940), rivivendo in un certo senso situazioni che il bambino si trova ad attraversare normalmente nelle prime fasi dello sviluppo, quando si confronta con angosce persecutorie profonde, sentimenti di perdita e di colpa.
Un cattivo rapporto con l’oggetto primario accresce l’ambivalenza, i vissuti di colpa per aver danneggiato l’oggetto d’amore e le angosce di annientamento e di persecuzione impedendo un processo di riparazione autentico che ristabilisca una buona capacità di rapporto con l’oggetto amato e perduto. La possibilità di ristabilire una maggiore sicurezza nel proprio mondo interiore superando il senso di colpa inconscio, legato all’ambivalenza, e l’idealizzazione difensiva dell’oggetto perduto è frutto di un lavoro psichico complesso d’integrazione e accettazione della realtà, che può vitalizzare i propri oggetti interni e che permette di aprire alla speranza.
Otto Kernberg (2010) ritiene che il lutto non sia un processo limitato nel tempo, come Freud aveva sostenuto in un primo momento, cambiando poi, però, la sua prospettiva come traspare in una lettera scritta a Binswanger (1929). In accordo con M. Klein (1940), Kernberg dice che un’adeguata soluzione del lutto normale, non solo patologico, passa per una riattivazione e successiva risoluzione delle angosce proprie della posizione depressiva, inerenti quindi anche a vissuti di colpa, e attraverso una modificazione della rappresentazione di sé sotto l’influenza della identificazione con un altro significativo (ad esempio il partner, con cui si sono condivisi valori e progetti di vita). A differenza di quanto dice Freud, secondo cui il piacere dell’essere in vita compensa la perdita dell’amato, Kernberg afferma che il piacere di essere in vita è arricchito dalle responsabilità morali derivanti dall’integrazione del mandato interiore della persona scomparsa. Secondo Kernberg, il lutto provoca un’alterazione permanente delle strutture psicologiche che influenzano vari aspetti della vita; si crea così una relazione oggettuale interiorizzata persistente con la persona perduta, che influenza l’Io e il Super Io e l’incorporazione del sistema di valori dell’oggetto perduto nel proprio Ideale dell’Io. Il lutto quindi riattiva la posizione depressiva e costituisce anche un’esperienza che può dare avvio a specifici meccanismi di compensazione della perdita, che favoriscono un nuovo sviluppo strutturale; qualcosa in più rispetto allo stabilirsi di un oggetto interno nuovo in seguito alla funzione riparativa.
Le potenzialità trasformative ed evolutive del processo del lutto sono il principale contributo sull’argomento di P.C. Racamier, (1992) che ritiene il lutto un processo maturativo universale o originario in quanto, egli dice, comincia proprio all’inizio della vita ed è intrinseco alla crescita. Lo definisce come un processo psichico fondamentale che si svolge nel corso dell’intera vita, per il quale l’Io si trova a confrontarsi con la necessità di rinunciare al possesso totale dell’oggetto. In questo modo il soggetto compie il lutto di un’unione narcisistica assoluta e tramite questa rinuncia fonda le sue stesse origini, opera la scoperta dell’oggetto e del Sé e “inventa” l’interiorità. Racamier (1992) ipotizza che il neonato e la madre siano immersi in una relazione di mutua seduzione (seduzione narcisistica) che mira ad escludere e/o neutralizzare le tensioni e stimolazioni e ad abolire l’alterità. Infatti ciò che questo tipo di seduzione tenacemente rifiuta è la differenza, in quanto presupposto della separazione e del desiderio. La chiusura narcisistica aspira all’autosufficienza.
Nelle situazioni in cui la relazione evolve normalmente, le spinte vitali del bambino e della madre insieme tendono a una rottura di questa illusione di onnipotenza e appartenenza totale. E’ qualcosa che ha inizio grazie ad una spinta vitale aggressiva, necessita della complicità materna (anticipazione creatrice) e non si effettua una volta per tutte. Pur essendo un processo che determina un cambiamento radicale esso si svolge nel corso di tutta la vita, in quanto l’aspirazione unificante (narcisistica) e quella differenziante (oggettuale) non si susseguono, ma coesistono nel corso dell’esistenza. D’altra parte l’oggetto perduto come oggetto assoluto esterno viene interiorizzato e ritrovato come oggetto interno.
Racamier (1992) chiama “supporti” quelle condizioni che rendono possibile l’attuarsi del lutto originario e quindi il riconoscimento e l’interiorizzazione dell’oggetto. Rifacendosi a Winnicott (1953), individua nell’oggetto transizionale e nella sua funzione d’intermediario tra l’illusione di onnipotenza e la realtà, uno dei principali supporti psichici al compimento del lutto.
Elaborare un lutto significa quindi poter pensare a un dopo, senza dimenticare un prima e questo ha una intrinseca potenzialità trasformativa ed evolutiva.
E’ importante che il terapeuta che accompagna il paziente nella elaborazione di un lutto di una persona, di una situazione o di una condizione personale perduta sappia riconoscere, soffrire e tollerare il dolore insieme al paziente, vivendo anche momenti di presenza inattiva in cui prevale l’accoglienza e che non sono immediatamente finalizzati a un’interpretazione o a una comprensione di tutto quello che accade. Questo può aiutare il paziente a compiere un sincero lavoro psicologico nel corso del tempo e a entrare in un contatto autentico con la realtà, ad attraversare il proprio dolore e compiere il lavoro del lutto che, come abbiamo visto, ha che fare con la possibilità di diventare più capaci di affrontare la realtà interna ed esterna, di vivere le proprie emozioni e quindi di accedere alla possibilità di cambiamento e crescita.
Bibliografia:
Abraham K. (1924) Tentativo di una storia evolutiva della libido sula base della psicoanalisi dei disturbi psichici Vol. 1 in “Opere” Ed Boringhieri (1975)
De Masi F. (2002) Il limite dell’esistenza, Torino, Bollati Boringhieri
Fraire M, Rossanda R. a cura di L. Melandri (2008) La perdita Bollati Boringhieri ed. 2008
Freud S. (1915 -1917]) Lutto e melanconia.” Opere”, vol 8 Ed. Boringhieri, 1976
Kernberg O. (2010) “Some Observations on the Process of Mourning” inThe International Journal of Psychoanalysis (91(3) 601-619
Klein M. (1940), Il lutto e la sua connessione con gli stati maniaco depressivi in M. Kein Scritti 1921-1958 Boringhieri, Torino 1971
Ogden T.H (2012) Il leggere creativo CIS editore
Racamier P.C. (1992) Il genio delle origini Raffaello Cortina Editore
Winnicott D.W (1953). Oggetti transizionali e fenomeni transizionali. In: Dalla Pediatria alla Psicoanalisi Martinelli, Firenze.
Malattia dell’analista
A cura di Rita Corsa
La malattia fisica dell’analista e, più in generale, il tema del corpo che si ammala in analisi, è uno «scabroso» argomento di confine (Baudrillard, 1979, 204), che occupa una zona franca fortemente perturbante tra la mente e il soma, tra la realtà e la metafora, tra le scienze del corpo e quelle della psiche.
Per Algini «della malattia (…) si può parlare solo per metafore, tanto grande è il suo mistero» (2011, 40), mentre per Sontag, nel suo magistrale saggio, Malattia come metafora, la sofferenza fisica è un «fatto reale», troppo spesso accantonato a favore di «impressionanti figure metaforiche», dalle quali bisogna «liberarsi» (1977, 3) .
Il misterioso salto nella realtà di cui parla Freud, prodotto dalla malattia fisica, obbliga l’individuo a un confronto ineludibile con la vulnerabilità, la finitezza e la caducità umane. Regioni impervie per chiunque, anche per chi si occupa di curare gli altri, medico o analista che sia. Quando «la realtà addosso» (Ambrosiano e Gaburri, 2008) è così naturalmente feroce, le angosce di morte diventano un fatto concreto, che può travolgere il pensiero, privandolo della sua funzione contenitiva, protettiva e terapeutica (Bonasia, 1998 e 2000).
Lo scontro traumatico con la caducità e con il limite (De Masi, 2002) fa vacillare la struttura narcisistica del sé: come denuncia con coraggio Robutti, l’analista colpito da un’affezione a rischio di vita tende di solito a nasconderlo, perché ha paura che la notizia si diffonda, che i colleghi non gli diano più credito e che si riducano le sue opportunità d’impiego (2009).
A fronte, infatti, di una cospicua mole di saggi dedicati alla disamina dei problemi che si pongono nella stanza d’analisi quando sopravviene una seria malattia fisica del paziente, assai più limitato e recente è il numero di studi che affrontano la condizione opposta. Soltanto negli anni Ottanta dello scorso secolo, nell’area psicoanalitica anglo-americana di estrazione protestante, si è cominciato a studiare il problema, esaminato compiutamente nel fondamentale libro di Schwartz e Silver (1990), pionieristica raccolta di scritti psicoanalitici sul tema.
Freud stesso, tuttavia, è stato assillato dal 1923 sino alla fine dei suoi giorni da un tormentoso cancro alla mascella, che gli procurava un dolore inesorabile e che lo obbligò a sottoporsi a diversi interventi chirurgici, assai invalidanti (Schur, 1972). Lasky rimarca che l’innesto delle varie protesi aveva sfigurato «il maestro e il suo stesso parlare era diventato sempre meno comprensibile (…) ma non faceva alcunché per nasconderlo ai suoi pazienti, causando così a sé e agli altri non poco disagio» (1992, 127). Diversi autori considerano che l’atteggiamento di Freud nei riguardi della sua grave infermità era quello di chi non poteva permettere che la malattia intralciasse la crescita della sua creatura, la psicoanalisi (Lasky, 1992; Morrison, 1997 e 2008; Robutti, 2009; Monterosa, 2011).
La discussione nella Società Psicoanalitica Italiana si è aperta appena nel nuovo millennio, ma sembra svilupparsi con attenzione crescente, come risulta da diversi contributi (Artoni Schlesinger, 1997; Vassallo Torrigiani e Marzi, 2005; Stuflesser, 2007; Robutti, 2009; Corsa, 2008, 2009, 2010 e 2014; Monterosa, 2011), tra cui il libro Se la cura si ammala. La caducità dell’analista (Corsa, 2011), preceduto dagli scritti collettanei Intendere la vita e la morte (2010) e La perdita (a cura di Massimilla, 2011). Questi ultimi due, seppur non trattando il tema precipuo della malattia dell’analista, offrono un’ampia riflessione sulla questione quotidiana della morte e della perdita e sulle ricadute in termini di lavoro psichico.
Negazione e ritiro narcisistico
Quando la malattia dell’analista mette in pericolo la vita e il terrore di morire è un fatto concreto, questioni etiche si intrecciano in maniera inestricabile con aspetti dolorosamente umani. L’infermità fisica fa vibrare corde assai intime, che suscitano sentimenti d’inadeguatezza, di colpa, di vergogna e può attivare difese antiche pre-edipiche, di negazione, proiettive e narcisistiche.
Vi è un unanime accordo degli studiosi riguardo alle abituali reazioni dell’individuo – compreso l’analista – al proprio male fisico: prevarrebbero condotte di negazione grandiosa, con tendenza all’isolamento e una certa chiusura narcisistica, in sintonia con quanto già affermava Freud (1914, 452). L’oncologo Tamburini ha osservato che nei pazienti tumorali il livello di negazione della malattia è direttamente proporzionale al grado di severità della patologia: mano a mano che ci si avvicina alla morte, la negazione diviene sempre più massiccia e l’atteggiamento non varia neppure per i medici e per gli psicoterapeuti (Tamburini e Murru, 2007). Vigneri ci insegna che «il fenomeno clinico della negazione», nel caso di situazioni cliniche severe, «è talora talmente evidente e conclamato da potere essere considerato alla stregua di un’allucinazione negativa» (2010, 59).
La fortificazione narcisistica è la risposta psichica più strettamente connessa allo scudo della negazione. La letteratura psicoanalitica converge, infatti, sull’inevitabile costituzione di riparazioni e di ripari narcisistici al cospetto di malattie mortali, che causano un danno fatale al Sé psicosomatico. Per Stuflesser (2007), l’insulto somatico che si abbatte sull’analista può ripercuotersi nella relazione con l’analizzando, al quale possono venir richieste, a livello variamente consapevole, continue conferme narcisistiche del proprio operare. L’esibizionismo narcisistico, che ha il pericoloso scopo di alimentare il sé professionale, può agire da seduttivo richiamo narcisistico anche per il paziente: in un simmetrico gioco di specchi, analista e paziente non fanno più coppia, ma si confondono in un basculante ribaltamento di ruoli e di funzioni, che riflette il momentaneo deficit di funzionamento dei reciproci Sé. Questo è un concetto che va tenuto ben presente, in quanto sta al confine con quelle particolari circostanze, non esenti da pericoli, nelle quali tocca al paziente prendersi cura dell’analista.
L’invidia e la vergogna controtransferali
Il confronto con la propria caducità può far affiorare nell’analista sentimenti molteplici, tra cui quelli dell’invidia e della vergogna controtransferali.
Prima dei rivoluzionari studi di Winnicott sull’odio nel controtransfert (1947), già Ferenczi invitava l’analista ad abbandonare l’arroganza delle teorie e a rinunciare all’«ipocrisia professionale», che spesso celano «l’odio per il malato» (Ferenczi, 1932, 304). L’odio e l’invidia per il paziente, sofferente nella psiche ma sano nel corpo, possono rivestirsi di aspetti così feroci da squassare mortalmente il campo relazionale. Gabbard ha sondato in profondità queste stanze inospitali dell’analisi che, se non riconosciute e bonificate, possono danneggiare il lavoro analitico fino a condurre ad un drammatico fallimento della terapia (1996, 2000 e 2003).
L’analista affetto da una seria malattia può inoltre sentirsi invaso da un altro, comune sentimento, quello della vergogna controtransferale. La vergogna nei confronti dell’analizzando può derivare dall’avvertirsi temporaneamente deficitario riguardo alle proprie competenze e alle funzioni di holding e di rêverie. Ma questo affetto può anche scaturire dalla preoccupazione di essere riconosciuto come oggetto deteriorato: lo sguardo dell’analizzando può cogliere i segni della malattia del terapeuta, che si sente “scoperto” nella sua intima fragilità. Qui si sfiora il delicato tema della self-disclosure da parte dell’analista, che verrà trattato più avanti.
Morrison ha scritto pagine illuminanti sulla vergogna dell’analista ammalato, sentimento che può derivare anche dal timore che la stessa comunità dei colleghi ti consideri inadeguato, non più affidabile, colpevole e ti precluda la partecipazione alla sua vita societaria (2008).
Si ritiene, invero, che l’emersione della vergogna controtransferale può essere un prezioso indice di sincerità, di incorruttibilità e di coerenza, utile a segnalare le difficoltà umane, senza asserragliarsi dietro difese antiche ed accecanti, che creano ipocrisia e falsità nel campo analitico.
Self-disclosure
L’analista malato non può eludere il quesito cruciale della self-revelation e della self-disclosure: quanta realtà dell’analista è colta dall’analizzando e quanta, invece, va dichiarata, svelata sinceramente dall’analista? Ovviamente il problema è più semplice da risolvere quando si ha a che fare con affezioni lievi, che non mettono a rischio la vita e che si risolvono più o meno velocemente, senza lasciare reliquati evidenti. La faccenda si complica per le malattie gravi e per quelle croniche ed invalidanti.
In termini schematici, la disamina della letteratura si declina in tre prospettive teoriche e cliniche assai diverse, in base ai distinti modelli concettuali di riferimento:
in quella classica-intrapsichica, l’analista deve fare ogni sforzo per mantenere la neutralità e l’astinenza più rigorose nel valutare le implicazioni transferali delle fantasie del paziente (Dewald, 1982; Halpert, 1982; Abend, 1982 e 1990; Schwartz, 1987 e 1990; Lasky, 1990a, 1990b e 1992; Dewald e Schwartz, 1993; Gervais, 1994);
in quella relazionale-intersoggettiva, l’analista svela al paziente aspetti della propria malattia, in una relazione collaborativa e simmetrica, tesa a rinforzare l’alleanza terapeutica (Silver, 1982 e 1990; Rosner, 1987; Morrison, 1990, 1997 e 2008; Hirsch, 1992; Little, 1993; Aron, 1996; Pizer, 1997 e 1998; Fajardo, 2001; Kahn, 2003; Deutsch, 2011).
E’ stata descritta, in base all’esperienza clinica, una particolare modalità di self-disclosure, denominata delicate self-disclosure (Corsa 2008 e 2011), caratterizzata da una modulazione dell’informazione offerta all’analizzando in considerazione dei suoi bisogni e della sua sensibilità.
Nel caso di seria infermità, si ritiene inevitabile per l’analista lo svelamento di aspetti privati, cercando tuttavia di conservare una posizione di delicato disvelamento di sé, conseguente ad un’ineludibile self-revelation. Si valuta, infatti, che l’atteggiamento di delicate self-disclosure debba originare dall’eventuale self-revelation (cioè da un’evidenza che non si può dissimulare senza ricorrere alla bugia e all’ipocrisia, da segni oggettivi inequivocabili, oppure intuiti inconsciamente o preconsciamente dall’altro) (Levenson, 1996). Non si concorda, invece, con la posizione estrema di Weimberg e di altri colleghi (1988), tutta centrata sulla realtà concreta, che invitano l’analista a introdurre con l’analizzando la questione della personale malattia, anche quando non sono manifesti indici palesi del male e il materiale transferale non ne presenti traccia.
La partecipazione a un’esperienza umana tanto comune può essere impiegata a favore del processo analitico e rivelarsi per il paziente un’occasione per mettere in campo zone del sé più adulte e mature. Questa è un’opportunità che riguarda soprattutto le analisi già avviate, mentre i pazienti in trattamento da breve tempo, ristabilito l’assetto analitico, verificata la tenuta dell’analista e superata la preoccupazione per la perdita, tendono spesso a porre la faccenda da parte. Si segnala, inoltre, che con i pazienti colpiti da reiterate esperienze abbandoniche e assillati dall’angoscia per la perdita dell’oggetto, l’analista corra maggiormente il rischio di offrire loro troppe informazioni, incorrendo in gravi errori di tecnica (Van Damn, 1987).
Il delicato svelamento del sé comporta precise scelte di natura etica e di tecnica, che l’analista deve dosare in base alle caratteristiche del paziente che sta curando, ma anche ponendo molta attenzione al proprio stato mentale (Clark, 1995).
La maggior parte dei contributi dedicati all’argomento, considerano ipocrita cercare di tenere celati dietro ad una neutralità menzognera quei tratti reali dell’analista che si manifestano con tanta clamorosa evidenza. Robutti, infatti, rammenta che, in tanti anni di storia della psicoanalisi, sono ormai un esercito i pazienti rimasti soli, a causa di una grave infermità o della morte del loro analista, di cui nessuno ha saputo più nulla (2009). Per fronteggiare questo pericolo, Traesdal (2005) propone la costituzione di una sorta di «comitato di crisi», all’interno delle Società di Psicoanalisi, che avrebbe il compito di tracciare delle guide-lines di comportamento da tenere in tali situazioni estreme. In linea con molti altri analisti, si auspica l’approfondimento di questo ostico tema all’interno del consesso psicoanalitico, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura libera e non menzognera del dolore del corpo e della morte.
Bibliografia
AA.VV. (2010). Intendere la vita e la morte. Quaderni del Centro Psicoanalitico di Roma, 4.
Abend S.M. (1982). Serious illness in the analyst: countertransference considerations. J. Am. Psychoan. Assn., 30, 365-379.
Abend S.M. (1990). Serious illness in the analyst: countertransference considerations. In: Schwartz H.I. & Silver Madison A.L. (edited by), Illness in the analyst: implications for the treatment relationship. New York, International Universities Press.
Algini M.L. (2011). Il tempo dell’orizzonte corto. Sull’amore e il lutto. Roma, Robin.
Ambrosiano L., Gaburri E. (2008). La spinta a esistere. Roma, Borla.
Aron L. (1996). A meeting of minds. Hillsdale, NJ, The Analytic Press.
Artoni Schlesinger C. (1997). Memoria delle mie non memorie. In: Algini M.L. (a cura di), La depressione nei bambini. Roma, Borla.
Baudrillard J. (1979). Lo scambio simbolico e la morte. Milano, Feltrinelli.
Bonasia E. (1998). Il sillogismo malato: la paura di morire e il sacrificio della verità. In: Bion Talamo P., Borgogno F., Merciai S.A. (a cura di), Lavorare con Bion. Roma, Borla.
Bonasia E. (2000). La morte: impotenza, terrore e dolore. Psiche, 1, 111-118.
Clark R.W. (1995). The Pope’s confessor: a metaphor relating to illness in the analist. J. Am. Psychoan. Assn., 43, 137-149.
Corsa R. (2008). L’identità violata: quando l’analista perde la salute. Segreti e confessioni nella malattia dell’analista. Riv. Psicoanal., 2, 315-335.
Corsa R. (2010). Caducità e vergogna nel controtransfert. Il corpo malato e l’inconscio nella stanza d’analisi. Atti del XV Congresso Nazionale S.P.I. – Esplorazioni dell’inconscio. Prospettive cliniche, Taormina, 27-30 maggio 2010.
Corsa R. (2011). Se la cura si ammala. La caducità dell’analista. Seriate (BG), Kolbe.
Corsa R. (2014). Narcisismo e speranza nel corpo malato. In: Breccia M. (a cura di), Narciso e gli altri. Roma, Alpes.
De Masi F. (2002). Il limite dell’esistenza. Torino, Bollati Boringhieri.
Deutsch R.A. (2011). A voice lost, a voice found: after the death of analyst. Psychoanal. Inq., 31, 526-535.
Dewald P.A. (1982). Serious illness in the analyst: transference, countertransference, and reality responses. J. Am. Psychoan. Assn., 30, 347-363.
Dewald P.A., Schwartz H.J. (1993). The life cycle of the analyst: pregnancy, illness, and disability. J. Am. Psychoan. Assn., 41, 191-207.
Fajardo B. (2001). Life-threatening illness in the analyst. J. Am. Psychoan. Assn., 49, 569-586.
Ferenczi S. (1932). Diario clinico. Milano, Cortina, 1988.
Gabbard G.O. (1996). Amore e odio nel setting psicoanalitico. Roma, Astrolabio, 2003.
Gabbard G.O. (2000). On gratitude and gratification. J. Am. Psychoan. Assn., 48, 697-716.
Gabbard G.O. (2003). Fallimenti nel trattamento analitico. Riv. Psicoanal., 2, 319-339.
Gervais L. (1994). Serious illness in the analyst: a time for analysis and a time for self-analysis. Canad. J. Psychoan., 2, 191-202.
Halpert E. (1982). When the analyst is chronically ill or dying. Psychoan. Q., 51, 372-389.
Hirsch I. (1992). Extending Sullivan’s interpersonalism. Contemp. Psychoan., 28, 732-747.
Kahn N. E. (2003). Self-disclosure of serious illness. The impact of boundary disruptions for patient and analyst. Contemp. Psychoan., 39, 51-74.
Lasky R. (1990a). Catastrophic illness in the analyst and the analyst’s emotional reaction to it. Int. J. Psycho-Anal., 71, 455-473.
Lasky R. (1990b). Keeping the analysis intact when the analyst has suffered a catastrophic illness. Clinical consideration. In: Schwartz H.I. & Silver Madison A.L. (edited by), Illness in the analyst: implications for the treatment relationship. New York, International Universities Press.
Lasky R. (1992). Some superego conflicts in the analyst who has suffered a catastrophic illness. Int. J. Psycho-Anal., 73, 126-136.
Levenson E. (1996). Aspects of self-revelation and self-disclosure. Cont. Psychoanal., 32, 237-248.
Little M.I. (1993). Il vero sé in azione. Un’analisi con Winnicott. Roma, Astrolabio.
Massimilla B. (a cura di) (2011). La perdita. Lutti e Trasformazioni. Milano, la biblioteca di Vivarium.
Monterosa L. (2011). L’analista e la malattia: un itinerario che approda alla costituzione di un gruppo di studio. In: Corsa R., Se la cura si ammala. La caducità dell’analista. Seriate (BG), Kolbe.
Morrison A.P. (1990). Doing psychotherapy while living with life-threatening illness. In: Schwartz H.I. & Silver Madison A.L. (edited by), Illness in the analyst: implications for the treatment relationship. New York, International Universities Press.
Morrison A. P. (1997). Ten years of doing psychotherapy while living with a life-threatening illness. Self-disclosure and other ramifications. Psychoanal. Dial., 7, 225-241.
Morrison A.P. (2008). The analist’s shame. Contemp. Psychoanal., 44, 1, 65-82.
Pizer B. (1997). When the analyst is ill: dimensions of self-disclosure. Psychoan. Q., 66, 450-469.
Pizer B. (1998). Breast cancer in the analyst: body lessons. In: Aron L. & Anderson F.S. (edited by), Relational perspectives on the body. Hillsdale, NJ, The Analytic Press.
Robutti A. (2009). Quando il paziente perde l’analista. Riv. Psicoanal., 3, 571-590.
Rosner S. (1986). The seriously ill or dying analyst and the limits of neutrality. Psychoan. Psychol., 3, 357-371.
Schur M. (1972). Freud living and dying. New York, International Universities Press. Freud in vita e in morte. Torino, Boringhieri, 2006.
Schwartz H.J. (1987). Illness in the doctor: implications for the psychoanalytic process. J. Am. Psychoan. Assn., 35, 657-692.
Schwartz H.J. (1993). The life cycle of the analyst Pregnancy, illness and disability. J. Am. Psychoan. Assn., 40, 191-207.
Schwartz H.J., Silver Madison A.-L. (a cura di) (1990). Illness in the analyst: implications for the treatment relationship. New York, International Universities Press.
Silver Madison A.-L. (1982). Resuming the work with a life-threatening illness. Contemp. Psychoan., 18, 314-326.
Silver Madison A.-L. (1990). Resuming the work with a life-threatening illness, and further reflections. In: Schwartz H.J. & Silver Madison A.L. (edited by), Illness in the analyst: implications for the treatment relationship. New York, International Universities Press.
Sontag S. (1977). Malattia come metafora. Torino, Einaudi, 1979.
Vassallo Torrigiani M.G., Marzi A. (2005). When the analyst is physically ill: vicissitudes in the analytical relationship. Int. J. Psycho-Anal., 86, 5, 1373-1389.
Stuflesser M. (2007). La malattia dell’analista: considerazioni e riflessioni. Relazione letta al Centro Milanese di Psicoanalisi, 3 maggio 2007.
Traesdal T. (2005). When the analyst dies: dealing with the aftermath. J. Am. Psychoanal. Assn., 53, 1235-1255.
Van Dam H. (1987). Countertransference during an analyst’s brief illness. J. Am. Psychoan. Assn., 35, 647-655.
Vigneri M. (2010). La morte e l’origine dei percorsi simbolici. Riconoscimento e disconoscimento della morte nelle culture e nella clinica. In: AA.VV., Intendere la vita e la morte, Milano, Franco Angeli.
Weimberg H. (1988). Illness and the working analyst. Contemp. Psychoan., 24, 452-461.
Winnicott D. W. (1947). L’odio nel controtransfert. In: Dalla pediatria alla psicoanalisi (1958), Firenze, Martinelli,1975.
Mancia Mauro
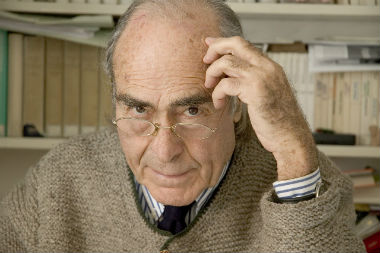
Mauro Mancia
A cura di Pablo Zuglian
Maestri della Psicoanalisi
“Una leggerezza che non è mai un dono ma un traguardo”
Mancia Mauro (Fiuminata [MC], 1929 – Milano, 2007)
Mauro Mancia, considerato uno dei padri delle neuroscienze in Italia, è stato allievo di Musatti e Fornari e ha effettuato la sua analisi con Senise. Ha dedicato la vita a due discipline, neuroscienze e psicoanalisi, che sembravano allora due parallele destinate a non incontrarsi e che oggi, anche grazie ai suoi studi, stanno iniziando a dialogare in un modo sempre più proficuo. In un’intervista ancora inedita, in cui si raccontava ad una giovane laureanda interessata al sogno e ai suoi studi, spiegava che “la mente è un epifenomeno complesso che epistemologicamente si differenzia dal cervello, ma che ontologicamente è legato al cervello e alle funzioni cerebrali” e sosteneva chiaramente che “la mente non può che essere il risultato di operazioni del cervello” (Senaldi, a.a.2006-2007,) Convinto che le due scienze fossero indispensabili per la conoscenza della mente umana, si è occupato a lungo, in entrambi gli ambiti, di memoria e di sogno, considerandoli come ponti tra le due discipline e verso la conoscenza dell’uomo. Un discorso scientifico, quindi, sempre sviluppato lungo queste due direttrici di fondo, con la forte convinzione, e la determinazione che ne derivava, che avessero un rapporto stretto tra di loro, che l’oggetto dell’una fosse, con tutta probabilità, una proprietà emergente di quello dell’altra.
Il ricordo di Mancia come docente e come maestro, con la sua inesauribile curiosità e la sua forte passione per la
 scoperta e l’integrazione dei saperi, è ancora molto vivo nella comunità psicoanalitica. Un ricordo più privato e personale, essenziale per comprenderne l’estrema duttilità e versatilità di scienziato e di analista, riguarda la sua “leggerezza”, vissuta come il frutto di un costante lavorìo affettivo-cognitivo da svolgere quotidianamente. “Una leggerezza che non è mai un dono ma un traguardo”, che ci rimanda alla possibilità di vedere le cose da vertici osservativi differenti, magari proprio a ponte tra due saperi diversi, o di vivere la propria vita all’interno di vari ruoli (padre, professore, psicoanalista, neuroscienziato ..), potendosi spostare facilmente tra l’uno e l’altro. Complementare alla leggerezza, così nella scienza come nella vita, era una forte tendenza ai legami, per cui i suoi collaboratori e colleghi erano, e si vivevano, come parte di una famiglia.
scoperta e l’integrazione dei saperi, è ancora molto vivo nella comunità psicoanalitica. Un ricordo più privato e personale, essenziale per comprenderne l’estrema duttilità e versatilità di scienziato e di analista, riguarda la sua “leggerezza”, vissuta come il frutto di un costante lavorìo affettivo-cognitivo da svolgere quotidianamente. “Una leggerezza che non è mai un dono ma un traguardo”, che ci rimanda alla possibilità di vedere le cose da vertici osservativi differenti, magari proprio a ponte tra due saperi diversi, o di vivere la propria vita all’interno di vari ruoli (padre, professore, psicoanalista, neuroscienziato ..), potendosi spostare facilmente tra l’uno e l’altro. Complementare alla leggerezza, così nella scienza come nella vita, era una forte tendenza ai legami, per cui i suoi collaboratori e colleghi erano, e si vivevano, come parte di una famiglia.
La vita
Mancia nasce a Fiuminata, nelle Marche, un piccolo borgo appenninico di circa quattromila abitanti posto dietro alle colline che scendono verso il mare, cui rimarrà sempre profondamente legato.
Si laurea alla Sapienza di Roma in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti. Durante i primi anni dopo la laurea viaggia molto, ricercando assiduamente validi maestri con cui formarsi e perfezionarsi nello studio della neurologia e della neurofisiologia. Trascorre un periodo presso il Karolinska Institutct di Stoccolma, dove si occupa di studiare le funzioni del midollo spinale con Torsten Wiesel, e nella seconda metà degli anni ’50 inizia il suo training con Moruzzi in Neurofisiologia all’Università di Pisa. Moruzzi è uno dei più importanti ricercatori internazionali nello studio dell’attività elettroencefalografica e del sonno. Nei primi anni ’60, dopo un periodo passato alla University of California – Los Angeles (dove in quegli anni lavorava Greenson), si trasferisce all’Università Statale di Milano, dove può aprire un suo Laboratorio di Neurofisiologia. Qui, con il suo gruppo di ricerca, Mancia si dedica allo studio della funzione del sonno e del sogno, dal correlato neurofisiologico fino alle valutazioni dello stato di coscienza, conduce studi di neuroanatomia delle strutture cerebrali coinvolte nel controllo del sonno (principalmente al livello del proencefalo basale/ipotalamo anteriore), di neurochimica del sonno (ruolo dei sistemi serotoninergici e colinergici nel controllo del sonno) e neuroimmunologia (interazione tra le citochine e i classici neurotrasmettitori).
Nel 1966 sposa la dr.ssa Alessandra Piontelli e nel 1968 nasce il suo unico figlio, Filippo, attualmente docente di Fisiologia e Biofisica cellulare alla Columbia University di New York. Verso la metà degli anni ’70 si separa da sua moglie senza risposarsi in seguito.
Mancia diviene professore ordinario (poi emerito) di Fisiologia Umana all’Università degli Studi di Milano, dove ha diretto l’Istituto di Fisiologia Umana II dal 1983 al 2001. E’ stato presidente dell’ASSORN (Associazione per la Ricerca Neurofisiologica), presidente della SIRS (Società Italiana di Ricerca sul Sonno), di cui nel 1996 è uno dei fondatori, e fonda il Centro Sperimentale di Ricerca sul Sonno “G. Moruzzi”, che dirige per alcuni anni.
Nel 2003, in occasione del cinquantesimo anniversario della scoperta del sonno REM, riceve il premio come Significant Early Contributor alla fondazione della scienza sul sonno.
Così lo ricorda il neurofisiologo McGinty: “Ha dato alla Neurofisiologia del sonno una spinta mostrando le interazioni tra tronco encefalico, talamo e area preottica” (Imeri, 2007).
In questo modo il neurofisiologo Imeri, suo allievo, ne indica le qualità: “Mi sembra che il tratto più caratteristico e importante della figura scientifica di Mancia consista nel suo essere stato un neurofisiologo ed uno psicoanalista che ha praticato entrambe le discipline di prima mano. Mancia, l’attività dei neuroni cerebrali non solo l’ha studiata, ma l’ha registrata direttamente in laboratorio. E, insieme, per anni ha visto pazienti e supervisionato colleghi. Mi sento di dire che non credo siano in molti, non solo a livello italiano, ma internazionale, ad avere (o avere avuto) un percorso professionale così peculiare, che ha fornito a Mancia un punto d’osservazione speciale e prezioso sulla relazione mente-corpo” (Imeri, 2007).
Dal racconto di quegli anni, sembra che Mancia abbia sempre desiderato unire all’attività del ricercatore di laboratorio quella del medico clinico, nutrendo una profonda passione per la conoscenza dell’uomo e delle cause (e quindi possibilità di cura) della sua sofferenza mentale. Prima di avvicinarsi alla psicoanalisi, si era infatti avvicinato alla psichiatria clinica, per poi discostarsene in tempi piuttosto brevi, dopo una non felice frequentazione del reparto di Psichiatria del Policlinico di Milano (allora diretta dal padre della psichiatra italiana, il prof. Aldo Cazzullo).
L’interesse clinico-antropologico per la condizione umana colta nella sua dimensione soggettiva, che coltiva parallelamente alla sua attività di ricercatore, lo porta ad un avvicinamento fecondo con la psicoanalisi. Negli anni settanta fa la sua analisi personale con Senise e si forma come analista con Fornari a Milano e Meltzer a Londra. Nella metà degli anni ’90 assume la qualifica di analista con funzioni di training.
La passione di Mancia per la conoscenza lo conduce anche su strade meno battute, dalla musica e musicalità in psicoanalisi al rapporto con la filosofia. Queste strade sono però inestricabilmente collegate con la ricerca e con la clinica psicoanalitica. La passione per la musica gli ha permesso di cogliere appieno l’importanza della musicalità nella relazione madre-bambino e nella seduta analitica, parlando di dimensione musicale del transfert come ulteriore strumento in grado di aiutare l’analista nel processo di ricostruzione emotiva delle prime esperienze precoci del bambino.
Una sua caratteristica spesso citata era la passionalità che metteva in ciò di cui si occupava. Questa l’ha portato ad occuparsi anche di politica e di religione, portando avanti una sua vivace spinta integrativa al collegamento. Da uomo profondamente di sinistra sentiva la necessità di collegare i bisogni individuali con quelli gruppali e sociali e, rispetto alla religione, da uomo ateo nutriva un atteggiamento di interesse e di rispetto verso la fede altrui, che lo portava spesso ad atteggiamenti di confronto e, a volte, di scontro.
 Il contributo alla psicoanalisi
Il contributo alla psicoanalisi
Per Mancia le evidenze sperimentali di derivazione neurofisiologica ed embriologica mostrano come alcune attività mentali (in particolare l’alternanza tra fasi REM e non REM di sonno) siano presenti già prima della nascita. In particolare la presenza di uno stato di sonno attivo prolungato (equivalente del sonno REM) nel feto può essere pensato come una rete organizzante le primitive esperienze mentali, esperienze che si potrebbero definire proto-oniriche. Quest’attività primitiva consiste nel leggere o decodificare i messaggi ritmici provenienti dall’ambiente materno portando allo sviluppo di un nucleo primitivo di attività mentale il cui compito è quello di trasformare, durante il sonno attivo, gli oggetti esterni, le esperienze, in oggetti interni, le rappresentazioni.
Mancia arriva a studiare il sogno partendo dalla sua esperienza nella neurofisiologia del sonno e rifacendosi alle definizioni di Meltzer del modello del sogno kleiniano come teologico e di quello bioniano come epistemologico (1987, 1988). Mancia mette in risalto la necessità del sogno, in quanto la mente ha bisogno di questo tipo di conoscenza per il suo sviluppo. Il sogno diventa quindi una religione della mente, qualcosa che svolge una funzione organizzatrice del mondo interno al fine di rappresentarne, alla stregua di una religione per una società, gli aspetti sacri (identificati dagli oggetti interni che assumono un significato teologico nello sviluppo dell’individuo).
Un altro tema di cui si è occupato a più riprese è il narcisismo (1976, 1990, 2004a, 2010) osservandolo, come gli era congeniale, da più punti di vista, teorico, clinico e sociale, per provare ad identificare un aspetto che collegasse queste differenti dimensioni. Nei vari lavori ha sempre attentamente studiato il pensiero dei differenti autori che se ne erano occupati prima di lui, fornendo anche una ricca bibliografia e un abbondante materiale di studio per chi si accingeva ad occuparsi dell’argomento.
Egli ci dice che “il narcisismo come struttura della personalità va visto in questo contesto relazionale ed evolutivo”. “Un’organizzazione dominata da oggetti interni autarchici, protesici e sostitutivi, di oggetti familiari sentiti come inaffidabili, assenti, impotenti”. Più avanti aggiunge che “queste modalità interessano in una certa misura tutti gli individui che vivono in società come le nostre, altamente competitive e costantemente minacciate dalla depressione” (2010). Riprendendo la Generali, e soprattutto Rosenfeld e Joseph, intende mostrarci dal punto di vista clinico come il meccanismo del furto in analisi sia un aspetto tipico della struttura narcisistica, in grado di assolvere al compito di potersi difendere da aspetti come dipendenza, separazione, ma anche odio, invidia e ambivalenza vissuti molto dolorosamente. In particolare su questo argomento sembra che Mancia tenesse particolarmente alla sua vocazione integrativa sia tra saperi diversi sia tra varie teorie dentro lo stesso sapere, (Freud, Klein, Bion, Kohut, Kernberg, Generali, Grunberger, per rimanere nel tema del narcisismo).
Questa spinta integrativa ha permesso a Mancia di riflettere sulla psicoanalisi partendo dalla scoperta da parte delle neuroscienze dell’esistenza di due sistemi della memoria:
▪ La memoria esplicita: a lungo termine, dichiarativa, autobiografica, relativa alla propria identità e storia personale, e che permette il ricordo.
▪ La memoria implicita: che invece non è passibile di ricordo e non è verbalizzabile.
Da qui si sviluppa l’ipotesi che le tutte esperienze infantili dei primi due anni di vita, prima dello sviluppo del linguaggio, siano depositate nella memoria implicita e che in questo sistema di memoria siano contenute le esperienze più arcaiche, anche traumatiche, relative alle prime relazioni del bambino con la madre.
Svolgendo tale ipotesi egli sviluppa il concetto di inconscio non rimosso. Questo permette la costruzione di un ponte tra le due discipline sul quale far transitare aspetti centrali nella clinica psicoanalitica come transfert e costruzione-ricostruzione delle fantasie ed esperienze infantili precoci.
È possibile mettere in relazione la memoria implicita con un’organizzazione inconscia, cosiddetta “non rimossa”, in quanto la rimozione necessita dell’integrità delle strutture neurofisiologiche (ippocampo, corteccia temporale e orbito-frontale) e della maturazione delle stesse, indispensabili per la memoria esplicita. La rimozione è pertanto collegata espressamente alla memoria esplicita, ma siccome tale memoria non è matura nel bambino prima dei due anni di vita, tutto ciò che avviene prima entra nella memoria implicita e si deposita in una forma d’inconscio che non può essere rimossa. Evidenzia in diversi scritti come le aree deputate alla memoria implicita siano invece già formate nell’infante permettendo appunto il deposito di queste tracce mnestiche in strutture non rievocabili verbalmente e coscientemente.
Le tracce mnestiche depositate nella memoria implicita e nell’inconscio, che non può essere rimosso, costituiscono il marchio, la struttura portante, il carattere e la personalità dell’individuo, e continueranno a condizionare la vita affettiva, emotiva, cognitiva per sempre. L’inconscio non rimosso deriva da prime esperienze infantili che non possono essere ricordate. Nella clinica l’inconscio dinamico si manifesta nel transfert attraverso la dimensione semantica della narrazione, mentre l’inconscio non rimosso si manifesta attraverso la musicalità del transfert e attraverso le funzioni simboliche del sogno.
Queste osservazioni permettono un ampliamento del concetto di inconscio, ridimensionando l’aspetto legato alla rimozione a favore di esperienze non rimosse. L’inconscio è considerato come una funzione della mente indispensabile per conoscere anche la coscienza e per poter comprendere i comportamenti, i sentimenti e le sensazioni dell’individuo. In questo senso, i risultati delle ricerche neuroscientifiche aiutano a conoscere le strutture o a comprendere maggiormente come si organizza la memoria, sia implicita che esplicita, offrendo una misura di come si organizza l’inconscio.
Una questione di particolare interesse affrontata da Mancia è il rapporto tra il concetto di non conscio o non consapevole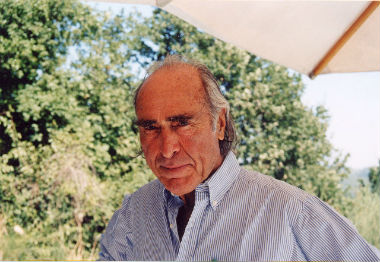 (unaware) delle Neuroscienze e quello di inconscio (unconscious) della psicoanalisi. Definire chiaramente i due concetti evita confusioni semantiche ed epistemologiche, infatti la non consapevolezza trattata dalle Neuroscienze riguarda eventi esterni al proprio Sé (neglect, prosopoagnosia, anosognosia ecc), in quanto non radicati nella storia affettiva ed emotiva del soggetto né nella sua memoria esplicita o implicita, mentre sono proprio questi ultimi aspetti che riguardano essenzialmente il concetto di inconscio della Psicoanalisi.
(unaware) delle Neuroscienze e quello di inconscio (unconscious) della psicoanalisi. Definire chiaramente i due concetti evita confusioni semantiche ed epistemologiche, infatti la non consapevolezza trattata dalle Neuroscienze riguarda eventi esterni al proprio Sé (neglect, prosopoagnosia, anosognosia ecc), in quanto non radicati nella storia affettiva ed emotiva del soggetto né nella sua memoria esplicita o implicita, mentre sono proprio questi ultimi aspetti che riguardano essenzialmente il concetto di inconscio della Psicoanalisi.
Memoria affettiva ed emozionale, viste da Mancia come dimensioni della memoria implicita, implicano la presenza di un nucleo inconscio del sé, un inconscio non rimosso, completamente differente dal “classico” inconscio dinamico rimosso freudiano. L’inconscio non rimosso non è il risultato della rimozione e contiene esperienze presimboliche che non possono essere rievocate ed espresse in parole, in quanto la loro dimensione è “semplicemente” non verbale. Queste memorie influenzano enormemente la nostra vita ed emergono non nella comunicazione verbale, simbolizzata, bensì in quella non verbale, negli agiti transferali (o forse potremmo dire nei pattern transferali-controtransferali) e nel sogno, che attraverso la sua finzione simbolo-poietica permette una trasformazione di questi aspetti preverbali e presimbolici in esperienze dicibili e, quindi, accessibili alla coscienza.
Il sogno ha la capacità simbolo-poietica di trasformare esperienze all’origine pre-simboliche in contenuti verbalizzabili, e l’analisi dei sogni può favorire questo processo ricostruttivo, offrendo immagini pittografiche ed emozioni che permettono di simbolizzare, mentalizzare e quindi rendere pensabile ciò che il bambino non poteva pensare. Mancia tiene molto a sottolineare la tecnica ricostruttiva che nasce da queste sue considerazioni teoriche. Ricostruttiva in senso nuovo, in quanto non serve a rendere conscio l’inconscio dinamicamente rimosso, ma a rendere rappresentabile e dicibile quell’inconscio non rimosso che si esprime in acting-out, agiti al di fuori del setting analitico e nella comunicazione paraverbale ed infraverbale. Definisce questa posizione come essenzialmente “ricostruttiva”, in quanto fondata non tanto sul recupero del passato storico del soggetto ma su quello della sua storia emotiva a partire dall’hic et nunc della seduta e, quindi, su un processo essenzialmente costruttivo basato sul transfert e sul sogno.
Per Mancia, che riprendendo Betty Jospeph (1985) parla di situazione transferale totale, esistono due aspetti semantici del linguaggio, da un lato il contenuto della narrazione e dall’altro la forma della comunicazione, cioè tono, timbro, volume e ritmo della voce, sintassi, tempo e prosodia del linguaggio. Il transfert è visto in una dimensione relazionale totale. La musica è quindi un linguaggio sui generis nel quale la struttura simbolica è isomorfica al mondo emozionale ed affettivo.
La memoria implicita contiene artificialmente al suo interno tre dimensioni, distinte in: priming, che rappresenta l’abilità di un individuo di scegliere un oggetto una volta che vi sia già stato esposto preliminarmente; memoria procedurale, che rappresenta esperienze cognitive e sensomotorie legate ai movimenti (dall’uso della bicicletta al suonare il violino); memoria emotiva ed affettiva, che riguarda le esperienze emotive così come le fantasie e le difese collegate alle prime relazioni del bambino con il suo ambiente. Con “prime relazioni” si intende il periodo che va dall’ultimo trimestre di gravidanza fino ai due anni di vita circa.
Mancia chiarisce che la sua prospettiva differisce da quella del Boston Group, in quanto, ai fini del processo terapeutico, non è sufficiente un’esperienza emozionale correttiva, ma l’inconscio non rimosso dell’infanzia necessita di una “ricostruzione”, ossia di una interpretazione, di una possibilità di rappresentazione e di una “storicizzazione” (2003). Ovviamente, egli specifica che non può essere ricordato, ma ri-esperito, rivissuto, agito nella relazione interpersonale. Può essere rappresentato nel sogno, il teatro per eccellenza della memoria, che apre così al transfert.
La voce materna rappresenta una sorta di imprinting, perché attraverso la voce il bambino riconosce il carattere della madre, gli aspetti affettivo-emozionali del suo modo di porsi. Il bambino risulta, già in epoca molto precoce, sensibile all’intonazione e alla musicalità della voce materna, che rappresenta la radice su cui si fonda la sua prima e fondamentale esperienza relazione e affettiva. “Io ho definito tutto questo come la dimensione musicale del transfert, che costringe l’analista a sviluppare una particolare forma di rêverie, cioè quella che può essere definita una rêverie acustica. L’analista non è più soltanto colui che deve decodificare una narrazione, trasformandola nel suo equivalente metaforico, ma è anche colui che deve poter usare l’aspetto infraverbale e musicale della comunicazione. Tutto questo per potere risalire alle primissime esperienze oggettuali infantili del paziente, e quindi ricondurre a quelle emozioni che la voce materna ha veicolato in lui e che si ricollegano alla voce stessa dell’analista e alla sua intonazione, al suo ritmo e al suo volume quando offre un’interpretazione”. Prosegue chiarendoci che “l’analogia della relazione madre-bambino, si ripropone all’interno della relazione analitica […] E poiché queste esperienze precoci riguardano proprio la memoria implicita (poiché hanno a che fare con i primi mesi di vita) la mia ipotesi è che attraverso l’analisi della comunicazione del paziente e anche dei suoi sogni, si possa risalire a esperienze emozionali, anche traumatiche, molto precoci. L’analista potrà così utilizzare questo materiale per operare una ricostruzione delle esperienze emozionali del paziente” (Senaldi, a.a. 2006-2007).
La voce assume, in maniera complementare, un determinato valore come esperienza di sé e, nello stesso tempo, come espressione di sé nella relazione psicoanalitica.
La passione per la psicoanalisi e il desiderio di conoscenza spingono Mancia a occuparsi del rapporto Wittgenstein-Freud, quindi del problema dello statuto epistemologico della psicoanalisi (2002, 2003)
Mancia sostiene che vi sia “tra Wittgenstein e Freud […] una forte opposizione. Tuttavia alcune obiezioni che Wittgenstein fa a Freud sono ancora quelle che, a distanza di cento anni dalla scoperta dell’inconscio, facciamo in parte anche noi. Ad esempio l’obiezione che il sogno sia sempre una soddisfazione allucinatoria di un desiderio, oppure la distinzione che non sempre in Freud è chiara tra cause e ragioni. C’è anche da ricordare che la personalità di Wittgenstein era molto disturbata e pertanto alcune delle sue obiezioni alla psicoanalisi sono più dettate da una sua difficoltà psicologica che non da una reale profonda valutazione del metodo psicoanalitico che peraltro conosceva solo in parte. Nonostante le differenze, credo tuttavia che il confronto filosofico e psicoanalitico tra Freud e Wittgenstein sia estremamente utile e arricchente la stessa teoria psicoanalitica della mente” (2002).
Da psicoanalista e scienziato, Mancia ha fortemente a cuore il futuro della psicoanalisi. Sembra, come sempre, un precorritore dei tempi quando afferma che “Da quando è nata, la psicoanalisi è sempre stata criticata e attaccata. Una delle ragioni l’aveva già espressa Freud nel dire che l’umanità non ama troppo conoscere se stessa ed attacca dunque qualsiasi metodo che permette tale conoscenza. A questo si aggiunge la religione, che si sente spodestata e che teme di perdere il potere sulle coscienze. Attualmente i più ‘pericolosi alleati’ della psicoanalisi sono i cognitivisti e quei neuroscienziati che non credono nel metodo analitico. Essendo alleati delle neuroscienze, più che non gli psicoanalisti, i cognitivisti si vantano di una maggiore “scientificità” della loro disciplina”.
Per Mancia, la causa maggiore della crisi della psicoanalisi sta forse proprio nella sua artificiale chiusura al mondo delle scienze e in particolare delle neuroscienze. L’autoreferenzialità ha comportato un girare intorno agli stessi temi e concetti, spesso non definiti adeguatamente, ed ha finito dunque per inaridire la stessa disciplina. Molti giovani analisti ripetono le formule prese in prestito da analisti più anziani senza pensare con le loro teste e senza elaborare le loro esperienze direttamente. Questa è una delle cause principali della crisi della psicoanalisi.
L’’opportunità di avviare un dialogo fra psicoanalisi e neuroscienze non si fonda tanto sulla ricerca di una conferma della prima nelle seconde, quanto piuttosto sull’apertura di nuovi orizzonti teorico-clinici e nuove prospettive di ricerca in entrambi gli ambiti. Egli riteneva che solo in questo modo la psicoanalisi potesse continuare a rimanere una disciplina radicata nella nostra società.
Vorrei ringraziare la dr.ssa Alessandra Piontelli, il dr. Filippo Mancia e la sig.ra Laura Matteini per i preziosi racconti e suggerimenti, la dr.ssa Senaldi per la sua intervista al prof. Mancia e il dr. Mattana per il generoso aiuto nella stesura di questo testo.
Bibliografia ragionata delle opere.
Mancia, M. (1976). Considerazioni sull’evoluzione del pensiero freudiano in tema di narcisismo. In Eros e onnipotenza. Studi psicoanalitici sul narcisismo, E. Gaburri (a cura di). Guaraldi, Rimini-Firenze.
Mancia, M. (1977). Fisiologia del sistema nervoso. Cortina, Milano.
Mancia, M. (1980), Neurofisiologia e vita mentale. Zanichelli, Bologna.
Mancia, M. (1981). On the beginning of mental life in the foetus. International Journal of Psychoanalysis, 81(3), 351-357.
Mancia, M. (1987). Il sogno come religione della mente. Laterza, Roma-Bari.
Mancia, M. (1988). The dream as a religion of the mind. International Journal of Psychoanalysis, 69(3), 419-426.
Mancia, M. (1990). Nello sguardo di Narciso. Laterza, Roma-Bari.
Mancia, M. (1990). Costruzioni e ricostruzioni nell’analisi. Rivista di Psicoanalisi, 36, 923-933.
Mancia, M. (1993). Neurofisiologia, R. Cortina, Milano.
Mancia, M. (1994). Dall’Edipo al sogno. Modelli della mente nello sviluppo e nel transfert. R. Cortina, Milano.
Mancia, M. (1995). Percorsi. Psicoanalisi contemporanea. Bollati Boringhieri, Torino.
Mancia, M. (1996). Sonno e sogno. Laterza, Roma-Bari.
Mancia, M. (1996). Imitazione, rappresentazione, identificazione: loro ruolo nello sviluppo e nel transfert. Rivista di Psicoanalisi, 42, 225-247.
Mancia, M. (1998). Coscienza, Sogno, Memoria. Borla Editore, Roma.
Longhin, L., Mancia, M. (a cura di) (1998). Temi e problemi in psicoanalisi. Bollati Boringhieri, Torino.
Mancia, M. (1999). Psychoanalysis and the Neurosciences: A Topical debate on Dreams. International Journal of Psychoanalysis, 80, 1205-1213.
Mancia, M. (2000). Il sogno: una finestra aperta sul transfert. Rivista di Psicoanalisi, 46, 255-268.
Longhin, L., Mancia, M. (a cura di) (2001). Sentieri della mente. Filosofia, letteratura, arte e musica in dialogo con la psicoanalisi. Bollati Boringhieri, Torino.
Mancia, M. (2002). Wittgenstein’s personality and his relations with Freud’s thought. International Journal of Psychoanalysis, 83(1), 161-177.
Mancia, M (2003). Dream actors in the theatre of memory: their role in the psychoanalytic process. International Journal of Psychoanalysis, 84(4), 945-952.
Mancia, M. (2004a). Sentire le parole. Archivi sonori della memoria implicita e musicalità nel transfert. Bollati Boringhieri, Torino.
Mancia, M. (2004b). Il sogno e la sua storia. Dall’antichità all’attualità. Marsilio, Venezia.
Mancia, M. (Ed) (2006a). Psicoanalisi e Neuroscienze. Springer-Verlag.
Mancia, M. (2006b). Implicit memory and early unrepressed unconscious: Their role in the therapeutic prosess (How the neurosciences can contribute to psychoanalysis). International Journal of Psychoanalysis, 87(1), 83-104.
Imeri, L., Mancia, M. (2006). Neurofisiologia, R. Cortina, Milano.
Imeri, L. (2007). A Tribute to Mauro Mancia — 1929 – 2007. Sleep, 30(11), 1595–1596.
Senaldi, C. (a.a. 2006-2007). Il sonno e il sogno: le neuroscienze in dialogo con la psicoanalisi. Tesi di Laurea Magistrale in Psicologia. Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.
Mancia, M. (2010). Narcisismo. Il presente deformato allo specchio. Bollati Boringhieri, Torino.
Massa in Psicoanalisi (La)

William Kentridge, 2011
La Massa
in Psicoanalisi
a cura di Laura Ambrosiano
La nozione di massa è un tema centrale delle riflessioni di S. Freud nel secondo decennio del novecento. Il tema delle masse è uno sviluppo del precedente “Totem e tabù” (1912-1913), ma si allarga in un discorso ampio con i contributi successivi “L’avvenire di una illusione” (1927) e il Disagio della civiltà” (1929).
La massa, come fenomeno sociale e politico, ha dominato le vicende del XX secolo, e la conta dei morti ad essa riconducibile è stata poi uno choc per l’intera umanità.
Alla grande celebrazione del decennale della rivoluzione bolscevica, il 7 novembre 1927, la Piazza Rossa era piena di una folla oceanica, felice, commossa, inneggiante al paradiso rivoluzionario in terra. Parate militari si susseguivano, cortei di lavoratori che portavano a spalla il sarcofago della borghesia, o i pupazzi di Mussolini, Lloyd George e Chamberlain. Sembrava di vedere una moltitudine di uomini in marcia all’unisono verso un radioso avvenire. Nella massa c’erano anche molti intellettuali europei e americani, scandinavi, italiani, svizzeri, cileni, e così via, tutti egualmente emozionati al canto dell’Internazionale intonato in trenta lingue diverse. Tutti sembravano pensare che si stesse realizzando un sogno e ne parlavano tra loro, scambiandosi lettere e racconti. In quel giorno di novembre a Mosca c’era anche Romain Rolland che si sentiva tanto travolto dall’entusiasmo della piazza da considerare l’evento come un prototipo del “sentimento oceanico” di cui scriveva a Freud (H. e M. Vermorel 1993).
Nello stesso mese del 1927 usciva “L’avvenire di una illusione” (OSF 10) cui Freud stava lavorando da tempo. Il libro presentava una risposta ampia e precisa all’entusiasmo dell’amico Rolland, entusiasmo che Freud non condivideva; a quegli avvenimenti Freud guardava con lo scetticismo e il realismo di uno studioso attento al funzionamento delle masse.
Ma torniamo all’inizio del decennio.
Nell’estate del 1920 Freud va sulle Alpi, in vacanza, e porta con sé i libri di Le Bon, di Trotter, e quello di Mac Dougall appena uscito, sulla massa, appunto.
La domanda che Freud ha in mente è: cosa tiene unite le masse? Egli non è soddisfatto delle risposte disponibili fino a quel momento relative all’istinto gregario, alla suggestione o ad una sorta di inconscio collettivo. Freud intende cogliere un elemento emotivo, psicoanalitico, capace di spiegare l’aggregarsi degli individui in grandi gruppi.
In “Psicologia delle masse e analisi dell’Io” (1921) il riferimento alla massa è a due livelli: il primo si riferisce ad un fenomeno sociale disorganizzato e brutale, il secondo a masse organizzate e compatte, come per esempio, la chiesa e l’esercito. Ma in entrambi i casi ciò che sostiene la massa è, per Freud, una tensione emotiva e una condizione mentale che permea gli individui in modo indifferenziato.
La massa rappresenta per Freud un tipo particolare di connessione sociale che indica un funzionamento che elude il pensiero individuale e spinge i singoli verso la condivisione senza scarti delle idee dominanti.
Freud vuole individuare il meccanismo su cui poggiano questi fenomeni, e immagina un qualche legame libidico capace di rendere gli individui come granelli anonimi partecipi di una mentalità, condivisa senza l’apporto della riflessione personale.
Questo nesso emotivo viene individuato nell’identificazione, “la prima manifestazione di un legame emotivo con un’altra persona” (Freud ibid. 293).
Nel discorso di Freud la massa si fonda sulla identificazione con il padre arcaico, sulla aggregazione dei fratelli intorno allo stesso ideale dell’Io (paterno-arcaico), soggiogati da una comune fantasia egualitaria. Freud parla di identificazione ma nelle pagine successive sembra riferirsi più precisamente ad un meccanismo più arcaico, si tratterebbe infatti di una sorta di infezione psichica che insorge sotto la spinta di una vorace pulsione di essere tutto, di essere senza confini. Più avanti, nel 1927, Freud potrà descrivere in un modo più specifico questa dimensione, quando parlerà di una impregnazione psichica che si avvia nelle aree indifferenziate della mente, e che resta disponibile lungo l’intera esistenza, accanto a funzionamenti più separati.
Sulla base di queste ipotesi possiamo immaginare uno spazio mentale inconscio in cui l’individuo si impregna dell’umore e dell’atmosfera emotiva dell’ambiente: il bambino di quella dei familiari, l’adulto della mentalità inconscia del gruppo di appartenenza. Si tratta di una dimensione assimilabile al rapporto tra ipnotizzatore e ipnotizzato, di uno stato mentale quasi dissociato, uno stato di torpore ipnotico, una sorta di trance autoindotta che invade la mente e tiene sotto scacco funzionamenti più liberi ed evoluti (P. Rizzi 1999).
L’impregnazione offusca le distinzioni tra dentro e fuori, anzi essa partecipa a costituire l’apparato psichico e il suo funzionamento come contaminato dal mondo esterno. Basta pensare alle esperienze del lutto per toccare con mano l’intensità del desiderio appassionato di essere una sola cosa con l’altro (un altro mai raggiunto pienamente e sempre in parte perduto). In questo modo nel 1921 Freud presenta l’ipotesi di una mente estesa, costituita da uno spazio intrapsichico e da uno spazio gruppale e trans-individuale. Si tratta di una parte del nostro apparato psichico che eccede la soggettivazione, affonda nella specie, nel biologico, come nel gruppo.
Proprio all’avvio del lavoro Freud afferma che nella vita psichica del singolo l’altro è regolarmente presente come modello, come oggetto, come soccorritore, come nemico, pertanto la psicologia individuale è anche, fin dall’inizio, psicologia sociale. Per psicologia sociale egli sembra proprio intendere una connessione naturale che è alla base dell’Io, che viene così concepito come ibridato, piegato e arricchito dall’incontro con l’altro. La massa rappresenta una modalità di questa connessione, un funzionamento mentale che può riguardare gruppi, Istituzioni, ma anche coppie e famiglie.
In questa chiave, infatti, ogni gruppo, ogni famiglia, ogni istituzione può essere aggregata da un legame “a massa” in cui l’insieme è fondato su un movimento di aggiramento e diniego dei conflitti tra i membri, dei limiti e dei confini, e sulla intolleranza delle differenze, della caducità e della morte.
Una volta che un gruppo funzioni sulla base di meccanismi a massa, che l’elemento aggregante sia religioso, scientifico, o ideologico, esso necessita, per la sua sopravvivenza, di appoggiarsi sulla intolleranza nei confronti degli esterni. Questa sorta di identità “a massa” è intrisa di settarismo e di una appartenenza rigida che non accoglie la diversità se non per colonizzarla.
Per cui il movimento delle masse appare come un agitarsi senza pensiero, in cui sembra impossibile districare gli eventi e coglierne le ragioni. Le masse non sembrano dominate da fenomeni leggibili, piuttosto sembrano semplicemente dominate dal non pensiero, dalla ricerca di una libertà dal pensare, dai valori e dalle tensioni etiche, e perfino dal proprio volto e dalla propria individualità e specificità. La massa infatti consegna ciascuno ad un anonimato che oscura i tratti personali e che, proprio per questo, sembra offrire paradossalmente un senso di sollievo. Ciascuno è corpo e movimento, anche i confini tra i corpi diventano laschi, ci si tocca, ci si urta, ci si abbraccia, e ci si impasta.
La massa preme per una risposta istantanea che non consente pause, non una sosta di pensiero, essa risponde alle situazioni sulla base di un macchinario dell’istantaneo (De Monticelli 2013) . Il pensiero individuale si frammenta e le masse si spostano oltre il bene e il male, avvertendo solo la pressione alla sopravvivenza della massa stessa e della sua mentalità.
La massa, nota Freud, dà al singolo l’impressione di una potenza illimitata, quando è isolato il singolo si sente incompiuto, ma può adeguarsi e rendere così inoperanti le opzioni personali, ottenendo, in cambio, una base di condivisione e sicurezza. La condizione di psicologia di massa viene descritta come fondata sul timore che i sentimenti e i pensieri individuali siano troppo deboli per potersi far valere da soli.
La massa dà al singolo l’impressione che è pericoloso opporsi a essa e si è tranquilli se ci si adegua all’esempio che si mostra tutt’intorno, se si ulula con i lupi (Freud 1921).
In questo modo Freud ci mette in contatto con la drammaticità di un conflitto molto particolare e invasivo, quello tra soggettivazione e appartenenza, dalla sua descrizione, infatti, cogliamo questo dilemma: fuori dal branco si rischia la morte, a ululare con i lupi, dentro il branco, si rischia la morte del Sé.
Sembra che il singolo possa rinunciare al proprio modo di essere personale per lasciarsi impregnare dalla mentalità condivisa e così stare in armonia con gli altri, anziché contrapporsi a essi e affrontare i conflitti (Freud 1921). Questa armonia sostanzia la speranza delirante di poter avere tutti un destino simile, di poter avere giustizia e benessere uguali per tutti, qui sulla terra, e subito.
L’adesione al funzionamento mentale a massa, nelle parole di Freud, è connessa con il bisogno di sicurezza, e la fonte di sicurezza più efficace è per ciascuno l’appartenenza senza scarti ad un gruppo pieno di certezze, questa appartenenza promette di non lasciare mai soli. Si tratta della ingenua aspettativa di una benevola complementarietà (tra se stessi e il mondo) che rende il singolo adattabile, lo dispone a condividere qualsiasi cosa per conformarsi e appartenere. Per quanto questa inclinazione venga avvertita come naturale, essa rappresenta anche un rischio: quello di conformarsi-alienarsi nel gruppo, in un mimetismo che ostacola la soggettivazione e può portare a qualunque cosa.
Fino a questo momento la riflessione di Freud sembra anticipare le posizioni dei filosofi della fine del secolo scorso molto attenti a studiare i fenomeni collettivi. In particolare pensiamo alla definizione di Simone Weil (1957) del gruppo come un “gros animal” senza pensiero, ripresa oggi tanto da poter affermare che non esiste una intelligenza collettiva, che non esiste un soggetto plurale capace di pensiero (De Monticelli 2012). La definizione del gruppo come “gros animal” rende bene l’idea che Freud ci ha trasmesso del funzionamento quasi somatico della massa, della sua corporeità invischiante, della ottusità che essa può diffondere nei singoli tanto da innescare guerre, genocidi, terrorismo.
Ma il discorso di Freud non si ferma a questo livello, e, negli sviluppi successivi del lavoro del ’21, apre un ampio campo di ricerca per i suoi continuatori, culminante negli studi di W.R. Bion sui gruppi.
Infatti, nonostante le osservazioni fin qui proposte, Freud non vuole demonizzare la massa, anzi ne sottolinea le potenzialità creative quando scrive che l’anima della massa è capace di creazioni spirituali geniali, cosa dimostrata innanzitutto dal linguaggio e resta da assodare in quale misura il singolo pensatore o poeta sia debitore ai suggerimenti della massa in cui vive, e se cioè egli non si limiti a portare a compimento un lavoro mentale cui insieme hanno collaborato gli altri (Freud, 1921). Invece di demonizzare questa dimensione egli la interroga e cerca di individuare se e in quali condizioni la massa possa evolvere verso il pensiero e la tensione etica. Grazie a questa ricerca lo scritto di Freud offre importanti spunti sul gruppo inteso come crogiuolo di lavoro mentale e di pensiero. Vediamo i suoi passaggi.
Mentre esplora la massa come condizione mentale, Freud le giustappone un’altra condizione mentale: quella del padre, capo supremo e guida. Il padre primordiale, prototipo narratologico della condizione mentale individuale, è libero, non necessita di convalida. Mentre nella dimensione di appartenenza alla massa il singolo sente la sua volontà troppo debole, il padre primordiale è autonomo e scarsamente vincolato libidicamente, non ama nessuno all’infuori di sé, egli non cede agli oggetti nulla di superfluo.
Il padre primigenio personifica una condizione mentale narcisistica. Ma, in questo contesto, anticipando gli sviluppo successivi di Bion, il narcisismo sembra venire indicato come polo irrinunciabile dello sviluppo proprio perché esso mantiene viva la spinta alla separazione e alla individuazione.
Possiamo immaginare il personaggio del padre primigenio che “non cede agli altri nulla di superfluo”, che non si lascia impregnare dalla mentalità a massa, come il prototipo dell’Io emergente dalla condizione mentale di massa, grazie alla funzione organizzativa del narcisismo. Tale funzione organizzativa si frappone alla possibilità di influenzamento eccessivo da parte dell’altro.
Opporsi all’influenzamento da parte dell’oggetto ha effetti molto ampi come sappiamo, si tratta di un movimento che corre sul bordo del delirio, può produrre distacco e rottura dei legami con il mondo, ma anche apre alla possibilità di accedere a una identità organizzata sulle proprie differenze.
Nel 1921 Freud afferma che ogni individuo partecipa di molte anime collettive, ma che può sollevarsi al di sopra di esse fino a un minimo di autonomia e originalità, attraverso un transito trasformativo da una condizione mentale all’altra (Freud, 1921).
Tale transito viene individuato da Freud, nei Complementi all’opera, nella possibilità di mettersi al posto del padre (ideale-idea guida) e di introiettare e fare propri gli aspetti desiderabili dell’oggetto. Nella impostazione freudiana, in questo passaggio, troviamo l’identificazione edipica intesa come spinta alla evoluzione personale e alla rinuncia all’essere tutto promessa della massa. Questa introiezione non solo lascia andare l’oggetto e la sua idealizzazione, ma rinforza la struttura psichica arricchendone le risorse di creatività e amore. Questa trasposizione del singolo nel posto del padre può comportare momenti di trionfo e mania, ma, più naturalmente, comporta colpa-responsabilità per avere spodestato, messo di lato, il padre.
La psicoanalisi ha sottolineato che crescere, nella fantasia inconscia, è sempre avvertito come un atto trasgressivo, del resto la cultura stessa emerge dalla concorrenza battagliera tra le idee, non necessariamente sanguinosa.
Perché il gruppo si offra come luogo di pensiero, è importante che tolleri uno spazio profano della trasgressione (Gaburri 1999), cioè della possibilità di obiettare, dubitare, rimodellare i pensieri, allargare, tradire la tradizione gruppale alla ricerca di nuove vie di conoscenza e di sviluppo (M. Badoni 2016). Si tratta, appunto, della possibilità di recidere il legame appassionato con gli oggetti dati (genitori-mentalità-ideologie) e riconquistarli dentro di sé come nuove dotazioni personali.
Dissacrare le verità acquisite è un compito del gruppo stesso nella sua evoluzione, il gruppo ha bisogno di rivedere, smontare e indagare, nutrirsi della dialettica tra tradizione e tradimento, tra continuità e rottura. Da questa dialettica il gruppo evolve, da gruppo-massa va verso posizioni più complesse e articolate, si trasforma nel suo funzionamento mentale e organizza ampie costruzioni culturali.
Un gruppo capace di pensiero può essere immaginato come un luogo che lascia ai singoli uno spazio per coabitare, e uno per fare esperienza fuori casa, in una condizione mentale appartata.
Il gruppo stesso diventa allora un transito non coatto di messa in comune dei singoli punti di vista per il tempo necessario a trasformare l’insieme.
In ogni momento, secondo le circostanze, il gruppo può tornare ad addensarsi di appartenenza ottusa, e, in luogo di cultura e di evoluzione, può ricomparire il gros animal da cui ci si può aspettare di tutto.
Poi Freud continua dicendo che, dopo aver affrontato questo transito, il singolo sa, tuttavia, ritrovare il cammino che riconduce alla massa, va infatti e racconta alla massa il mito di un transito possibile verso l’individuazione, così anche gli altri componenti della massa potranno, identificandosi con l’eroe, condividere l’anelito verso l’emancipazione.
La sublimazione, la narrazione, il mito, viene, dunque, indicata come una attività psichica che offre la possibilità di svincolarsi dalla mentalità e dagli ideali dell’Io acriticamente condivisi. È una premessa questa per un ritorno al gruppo con una diversa capacità di partecipazione: come individui specifici capaci di scambio differenziato. Il gruppo, quando ha risorse di pensiero, ha una preziosa funzione di contenimento della paura della realtà, dei limiti, della morte.
In definitiva Freud, in “Psicologia delle masse e analisi dell’Io”, attraverso il suo linguaggio personificato, descrive la relazione tra due condizioni mentali e i transiti dall’una all’altra, possibili lungo il corso dell’intera esistenza.
Veniamo ora al nesso tra massa e illusione.
Freud aveva guardato con scetticismo alle descrizioni della folla oceanica nella Piazza Rossa nel novembre del 1927, temeva le ideologie forti e compatte capaci appunto di aggregare le masse, per lui si trattava di illusioni condivise. Ma era anche consapevole che, per proteggere la mente che, nell’impatto con la realtà, potrebbe esplodere, abbiamo bisogno di illusioni. Per sporgersi ad accostare la realtà dobbiamo creare-nutrire illusioni (R. Valdrè 2016). Del resto le illusioni non sono menzogne, né deliri, ma danno parola alle nostre pulsioni, bisogni, desideri (Freud 1927).
Ma, quando le illusioni diventano ideologie forti e integraliste, esse evitano di fare il conto dei morti e dei danni, e allora affondiamo nella massa densa dell’ideologia e del conformismo (Gaburri Ambrosiano 2003). La massa si aggrega proprio intorno a illusioni dense e indiscutibili che offrono una illusoria protezione, ma, senza illusioni, rischiamo di cadere in una apatia sfiduciata che diffonde passività e inerzia mentale. Per questo, occorre immaginare che il farsi degli individui e della cultura sia una continua attività di costruire e poi smontare delle illusioni che, per un certo periodo, illuminano il percorso, ma poi si fanno rigide e decadono in pregiudizi e preconcetti.
Il discorso sulla massa trova così il suo complemento ideale in quello sull’illusione capace di dar luogo si ad aggregazioni scomposte e caotiche dominate dalla pretesa di essere tutto e di poter ottenere il paradiso in terra. Per impregnarsi anonimamente di una mentalità illusoria non occorre il pensiero, né un individuo differenziato, il conformismo corre in automatico.
Infine, non si può chiudere questa voce dell’enciclopedia psicoanalitica senza almeno accennare ad un’altra dimensione cui la nozione di massa allude: il sentimento oceanico. Questa ipotesi è al centro della affascinante corrispondenza, cui si è accennato all’inizio, tra Freud e Romain Rolland. Una parte importante del “Disagio della civiltà” (1929) è ad essa dedicato. La vicinanza, l’unisono, quasi corporeo, tra i membri impersonali della massa rimanda, secondo Rolland, come nella sua esperienza nella Piazza Rossa, ad un legame basico, emotivo, tra gli individui di una stessa specie con un comune destino. Freud non condivide questa ipotesi, la riconduce ad una regressione allo stato iniziale del neonato che si sente come senza confini, che si vive in una unità con il tutto, con la madre, con l’ambiente, con il mondo.
Ma che sia regressivo, come sostiene Freud, o che sia un elemento basilare della nostra umanità, come sostiene Rolland, le dimensioni dell’ in-comune e dell’unisono che cancella confini e differenze, ha potenzialità ed evocazioni tali da sottolineare la preziosa complessità del fenomeno della massa.
Bibliografia
Badoni M. (2016) Il buon uso del tradimento. Corruttori e corrotti. Ambrosiano Sarno (a cura di) Mimesis Milano
Donaggio E. (2016) Direi di no. Desideri di migliori libertà. Milano Feltrinelli
Gaburri E. (1999) Per un’etica profana. In Nuove geometrie della mente, Lorena Preta (a cura di) Bari Laterza
Gaburri E. Ambrosiano L. (2003) Ululare con i lupi. Conformismo e reverie Torino Bollati Boringhieri
De Monticelli R. (2012) La questione morale Milano Cortina
De Monticelli R. (2013) Sull’idea di rinnovamento. Milano Cortina
Freud : (1921) Psicologia delle masse e analisi dell’Io. OSF 9
Freud S. (1927) L’avvenire di un’illusione OSF 10
Freud S. (1927 b) Dostoevskij e il parricidio. OSF 10
Freud S. (1929) Il disagio della civiltà. OSF 10
Rizzi P. (1999) L’Istituzione ipnotica. Psiche, 7, 87-95)
Valdrè R. (2016) La morte dentro la vita. Riflessioni psicoanalitiche sulla pulsione muta. La pulsione di morte nella teoria, nella clinica e nell’arte. Torino Rosenberg e Sellier
Vermorel H. e M. (1993) Sigmund Freud et Romain Rolland correspondence 1923-1936 Paris PUF
Weil S. (1957) La persona e il sacro. Milano Adelphi 2012
Matte Blanco Ignacio
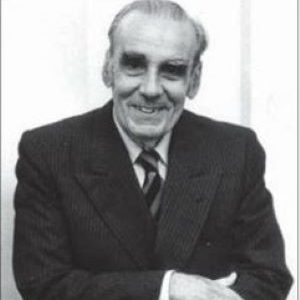
MATTE BLANCO
A cura di Alessandra Ginzburg
I maestri della psicoanalisi
Matte Blanco, Ignacio
(Santiago del Cile 1908- Roma 11.1.1995)
Matte Blanco ha introdotto l’infinito nella psicoanalisi ( Eric Rayner, 1995). La sua ricerca è stata dedicata prevalentemente al funzionamento dell’inconscio non rimosso e delle emozioni . Era infatti convinto che la più grande scoperta di Freud relativa alla illogicità dell’inconscio potesse essere ricondotta ad un vero e proprio sistema coerente di funzionamento, grazie agli strumenti della logica formale della matematica.
La vita
Era nato a Santiago del Cile nel 1908. Dopo la laurea in medicina conseguita nel 1930, già professore di fisiologia, decise di trasferirsi a Londra nel 1934, dedicandosi alla formazione come psichiatra e come psicoanalista. Analizzato da Walter Schmideberg, genero di Melanie Klein, con quest’ultima aveva fatto l’esperienza di seminari che riteneva decisivi per l’elaborazione delle sue teorie sull’emozione. Divenuto membro della Società Britannica nel 1938, si era trasferito successivamente negli Stati Uniti dove aveva soggiornato fino al 1944 insegnando in diverse università.
Dopo il suo rientro nel Cile, si era impegnato con l’entusiasmo che gli era caratteristico in diversi progetti di ricerca. Nel 1949 era stata riconosciuta ufficialmente dall’IPA la Società psicoanalitica Cilena, a cui aveva dato un impulso determinante. In quel periodo era diventato professore nella locale cattedra di Psichiatria, facendosi promotore, fra l’altro, della costruzione di un ospedale psichiatrico modello.
Dopo essere andato in pensione nel 1966, si era trasferito in Italia, un paese amato da sempre. A Roma era entrato a far parte del Centro di Psicoanalisi Romano, acquisendo nuovamente la funzione di analista didatta. Era stato inoltre docente di psicopatologia alla scuola di specializzazione dell’Università Cattolica, attivando un gruppo di ricerca intorno alle sue ipotesi teoriche.
Il contributo alla Psicoanalisi
Nel contatto quotidiano con la malattia mentale, Matte Blanco viene colpito dalle analogie fra il pensiero schizofrenico e le caratteristiche dell’inconscio messe in luce da Freud. Arriva così a descrivere una nuova e compiuta forma di logica, la denomina simmetrica perché rende reversibile e dunque simmetrica qualsiasi relazione, ed è antitetica a quella classica formulata da Aristotele, basata sul principio di non contraddizione. Questa forma di logica è, per la sua qualità irriducibile, incompatibile con il pensiero perché dove si manifesta dissolve le differenze e trasforma ogni somiglianza in identità.
Matte Blanco getta così le basi di una nuova epistemologia, attraverso la formulazione dei due principi basilari, e dei loro corollari, che caratterizzano la logica simmetrica. Il primo, il principio di generalizzazione dove l’inconscio tratta una cosa individuale, persona, oggetto o concetto, come se essa fosse un membro o un elemento di un insieme o classe ce contiene altri elementi; il secondo, il principio di simmetria dove l’inconscio tratta la relazione inversa di qualsiasi relazione come se fosse identica alla relazione. Nell’applicazione sistematica dei due principi, Matte Blanco individua un’antinomia costitutiva dell’essere umano che si risolve in due modi di essere simultanei.Uno dividente, assimilabile al pensiero, che opera sulla differenza, l’altro indivisibile, analogo all’emozione, che tende all’indifferenziazione.
A partire da queste modalità contrapposte ma continuamente compresenti, la mente viene descritta come una entità stratificata i cui livelli più profondi coincidono progressivamente con la formazione di classi sempre più ampie ed onnicomprensive fino ad arrivare all’indivisibilità. Una dimensione questa che può essere sperimentata tanto come disorganizzazione del pensiero quanto come esperienza mistica.
Proprio l’esperienza dell’indivisibilità, suggerisce Matte Blanco, ha portato l’uomo a concepire l’infinito, un infinito che suddivide e moltiplica in parti ciò che nel profondo è sentito come una sola unità irriducibile. Tuttavia nella maggior parte del tempo è una terza logica quella di cui ci serviamo quotidianamente: la bi-logica in cui a seconda dei casi predomina l’una o l’altra componente di pensiero.
Ma anche nelle emozioni più intense, rileva Matte Blanco, si verificano gli stessi presupposti: l’individuo viene sostituito dalla classe e all’interno di essa per effetto della simmetrizzazione che opera nei livelli più profondi ogni elemento che la compone diviene identico e intercambiabile ad ogni altro: in questo modo la parte diventa identica al tutto, così come avviene nella definizione degli insiemi infiniti formulata da Cantor.
Poiché la grandezza dell’emozione è una funzione del livello di profondità, ne deriva che conflitti e manifestazioni patologiche possono essere visti come la conseguenza parossistica di una infinitizzazione che il pensiero non riesce a contenere e a tradurre se non in misura parziale, riducendo la multidimensionalità dell’esperienza emotiva altrimenti improponibile visti i limiti tridimensionali della coscienza.
Scopo della terapia psicoanalitica, da questo punto di vista, è spogliare l’individuo o la situazione dagli attributi infiniti impliciti nella classe.
Alcuni psicoanalisti, come Mauro Mancia hanno tratto ispirazione dalla concezione dell’inconscio non rimosso proposta da Matte Blanco, limitandola però al periodo non verbale. Un’ipotesi che sembra riduttiva rispetto alla visione più ampia di una mente che nel suo complesso e in tutte le sue manifestazioni accompagna l’essere umano lungo tutto l’arco della vita, acquistando però maggiore peso ed influenza nei periodi critici o francamente patologici dell’esperienza del singolo.
Il pensiero di Matte Blanco, giudicato a volte troppo astruso, non ha trovato sufficiente attenzione da parte degli psicoanalisti nonostante le grandi possibilità che offre alla clinica. E’ stato invece accolto con particolare interesse, fra gli altri, dagli studiosi di letteratura, presso cui molti dei suoi concetti hanno trovato applicazione e sviluppo.
E’auspicabile che concetti basilari come quelli relativi alla antinomia costitutiva di pensiero ed emozione, alla simmetrizzazione e alla mente come struttura bi-logica stratificata possano diventare patrimonio comune anche degli analisti, entrando a far parte del patrimonio di strumenti comuni che la psicoanalisi si è forgiata negli anni a partire dalla scoperta dell’inconscio e delle sue peculiarità.
Alessandra Ginzburg
Bibliografia
AAVV. Matte Blanco: Bi-Logiche dell’Inconscio in Rivista di Psicoanalisi LII-3-206
Ginzburg A, Lombardi R. ( a cura di) L’emozione come esperienza infinita. Matte Blanco e la psicoanalisi contemporanea, Milano, Angeli 2007.
Lombardi R., Formless Infinity. Clinical Explorations of Matte Blanco and Bion, Routledge, London 2015.
Matte Blanco I., L’Inconscio come insiemi infiniti. Saggio sulla bi-logica,Torino, Einaudi 1975.
Matte Blanco I., Il sogno: struttura bi-logica e multidimensionale in Branca V,Ossola I., Resnik S (a cura di) I linguaggi del sogno, Sansoni, pp. 267-91
Matte Blanco I., Pensare, sentire, essere. Riflessioni cliniche sull’antinomia fondamentale dell’uomo. Einaudi, Torino, 1995.
Rayner E., Unconscious Logic, Routledge, London, 1995
Memoria Implicita

Sigalit Landau, 2005
Memoria Implicita
A cura di Cristiana Pirrongelli
Le memorie implicite sono particolari tipi di memoria che contengono esperienze non passibili di ricordo cosciente né verbalizzabili. Le prime ricerche neuroscientifiche attorno ad esse datano tra la fine degli anni 80 e i primi degli anni 90 (M. J. Cohen 1980, M. Mishkin e T. Appenzeller 1987, H. L. Roediger 1990, D. L. Schacter 1992, L. R. Squire 1994, E. Kandel 1989, 2002, J. LeDoux 1994 etc.) fino alle più recenti, legate soprattutto al team di Cristina Alberini, allieva di Kandel (2009, 2011, 2014).
Cenni storici
Già Freud (1887, 1904, 1914,1924, 1937) aveva sottolineato l’esistenza di ricordi d’infanzia molto precoci, di cui non si ha memoria, che lasciano però, tracce indelebili nell’individuo.
La mancanza di memoria di tali episodi è opera della rimozione o dello spostamento che evita così l’esistenza di memorie perturbanti. Nonostante Freud indicherà nelle libere associazioni, nel transfert e nel sogno vie per accedere a questa forma di memoria depositaria di tracce o episodi particolarmente rilevanti degli albori della nostra vita, non approfondirà mai tali aree precoci.
Melanie Klein (1928) per prima si focalizzerà sull’importanza delle esperienze edipiche e pre-edipiche precoci, pre-verbali e pre-simboliche. Successivamente (dagli anni 50) a partire dagli analisti del “Gruppo di mezzo” (W. Fairbairn, D. Winnicott, M. Balint, J. Bowlby, Guntrip etc.), altri autori psicoanalitici si sono avventurati nello studio delle memorie implicite inconsce e non rievocabili. Ricordiamo W. Bion (1965), R. Money-Kirle (1978), H. A. Rosenfeld (1987), M. Mancia (1998), I. Matte Blanco (2000), D. Meltzer (1987), C. Bollas (1987), Pally R (1997), J. S. D. Stern (1998), A. H. Modell, P. Fonagy, D. (1998, 1999) Siegel (1999), J. Holmes (2000) Gabbard G. O., Westen D. (2005) e altri. Tra i neuroscienziati, G. Edelman (1991,1993), LeDoux (1994, 2013) A. Damasio (2000), W. Bucci (2001, 2002), E. Kandel (2002), C. Alberini (2009, 2011, 2013, 2014).
Definizione del concetto
Le memorie implicite possono contenere tre diversi tipi di apprendimenti mnemonici:
1) Il Priming: è una proprietà di origine evolutiva che consiste nella capacità di riconoscere uno stimolo, cui si è stati esposti sia pur a un livello subliminale di coscienza (percettivo, semantico o concettuale), che può essere riconosciuto le volte successive senza averne consapevolezza;
2) La Memoria procedurale, che contiene esperienze motorie, percettive o cognitive, che ci portano ad acquisire comportamenti motori automatici come l’andare in bicicletta o suonare uno strumento; compiere una serie di azioni quotidiane come il vestirsi e il lavarsi; acquisire alcune abilità, cognitive o percettivo, come riconoscere “al volo” una persona dal modo di camminare.
3) Infine le Memorie emotive e affettive sono le memorie più antiche, tra cui la memoria “intrauterina” della voce e dell’ambiente materno, e le prime relazioni sensoriali ed emotive del neonato con la madre e con l’ambiente esterno.
Mauro Mancia (1998, 2003, 2006, 2008), neurologofisiologo e psicoanalista italiano, si è particolarmente dedicato allo studio delle memorie implicite dei primi due anni di vita individuando in esse un ponte di interesse tra la psicoanalisi e le neuroscienze. Tali memorie implicite infantili pur essendo elementi inconsci, non sono materiale rimosso perché la rimozione richiederebbe l’integrità delle strutture neurofisiologiche, tipo l’ippocampo, la corteccia temporale e le orbito-frontale che maturano verso i due anni di età. L’amigdala, invece, è già presente e coinvolta nella registrazione di tali memorie, soprattutto di quelle traumatiche.
Tali memorie non diventeranno mai del tutto consce, in quanto fissate nella memoria emozionale implicita, ma lasciano tracce mnestiche responsabili di abitudini “caratteriali” di tipo emozionale e di schemi di comportamento secondo modalità per lo più inconsce e automatiche. Non si avrà mai la possibilità di conoscere il loro stato di relativa attivazione o disattivazione e di avere la capacità riflessiva sul perché della reazione emozionale in corso (come nelle reazioni di transfert).
Queste memorie influenzano enormemente la nostra vita ed emergono negli agiti transferali, negli schemi transferali-controtransferali e nel sogno, che attraverso la sua finzione simbolo-poietica, permette una trasformazione di questi aspetti preverbali e presimbolici in esperienze in qualche modo “dicibili” e, quindi, accessibili alla coscienza.
A queste Memorie emotive ed affettive vanno aggiunte le Memorie traumatiche, spesso soggette a difese di tipo dissociativo come l’amnesia, la fuga dissociativa, la derealizzazione e la depersonalizzazione. Le tracce delle Memorie Traumatiche si possono presentare alla nostra osservazione in numerosi modi ma non necessariamente sono rievocabili. In essi, è la componente emotiva, spia della loro salienza, a fungere da attivatore della loro archiviazione, con una partecipazione prioritaria dell’amigdala (a differenza delle memorie esplicite e rievocabili che vedono l’ippocampo come elemento primariamente implicato) nonché, di neocorteccia, corpo striato e cervelletto.
Studi recenti (Alberini et al. 2014, Inda et al. 2011, Alberini 2011) riportano come la memoria, compresa quella implicita, non sia statica bensì soggetta ad una continua programmazione e riprogrammazione e come, con il passare del tempo, si riattivi più volte per via di eventi impliciti o espliciti, compreso anche quanto accade durante l’attività di riposo e il sonno.
Tecniche di lavoro sulle memorie implicite
Le tecniche di lavoro sulle memorie implicite, soprattutto quelle legate a vissuti spiacevoli o traumatici, devono tenere conto della variabile tempo e dell’esistenza di specifiche “finestre terapeutiche” al di fuori delle quali la semplice rievocazione del ricordo, non è, di per sé, utile alla sua elaborazione; al contrario, la rievocazione può funzionare come un possibile fattore di riconsolidamento e stabilizzazione del ricordo, (Finsterman C. et al 2015). Se, però, nel corso della rievocazione si produce un’ “interferenza” di tipo adeguato (fenomeno per il quale il richiamo alla memoria di un’informazione può essere ostacolato da un’altra informazione fonetica o semantica, da un intervento chimico o comportamentale o situazionale), si assiste a un significativo indebolimento o addirittura a una perdita del ricordo (Przybyslawski J. 1997, Nader K. et al. 2000, Nader K. 2015, LauZhu 2019). Nella fase di “labilizzazione” si può intervenire modificando, indebolendo o addirittura vanificando il ricordo. A ridiventare temporaneamente labili, sarebbero soprattutto le componenti emotive, piuttosto che quelle cognitive. Per chi utilizza il trattamento psicoanalitico e psicoterapeutico, nei casi di disturbo post-traumatico da stress, depressione, fobie e in genere dei disturbi che hanno a che fare con memorie perturbanti implicite parzialmente o per nulla rievocabili, questo dato è di grande utilità. Ciò che vive nella memoria implicita, secondo la maggioranza degli psicoanalisti, può essere raggiunto in analisi attraverso il lavoro sul sogno, l’attenzione alle dinamiche transferali e controtransferali, agli enactment, all’ascolto prosodico della voce (Di Benedetto, 2000; Mancia 2004; Correale 2006), e a elementi extraverbali come l’osservazione dell’espressività facciale e posturale e altri elementi sensoriali e percettivi (la terapia sensomotoria di Pat Ogden 2016), capaci di creare risonanze evocative nelle memorie implicite non rappresentabili.
Altri, come Stern e il suo gruppo (1998), hanno teorizzato modi diversi per arrivare a incidere sulla memoria procedurale, come i “now moments”, i momenti di autentico incontro tra analista e paziente, le “sloppyness”, una sorta di “svagatezza che favorisce le libere associazioni” e i WFM, acronimo usato dalla polizia per definire “i terribili dannati momenti”, imprevedibili e bizzarri, magari carichi di disagio o tensione da parte di entrambi: paziente e terapeuta. Mancia precisava che la sua prospettiva differiva da quella del Boston Group cui appunto apparteneva D. Stern, insieme a E. Tronick ed altri psicoanalisti, in quanto, ai fini del processo terapeutico, non è sufficiente un’esperienza emozionale correttiva, ma l’inconscio non rimosso dell’infanzia necessita di una “ricostruzione”, ossia di una interpretazione, di una possibilità di rappresentazione e di una “storicizzazione” (Mancia 2003).
Le metodiche d’intervento sulle memorie implicite patogene, sono, ancora in una fase di studio sperimentale. Secondo le più recenti acquisizioni neuroscientifiche, nella situazione analitica, che potrebbe di per sé rappresentare un esempio di “interferenza” poiché relazione priva di esperienza negativa o traumatica, positivamente empatica, il ricordo primitivo non è comunque passibile di modifica né di diverso riconsolidamento: quello che può accadere è che se ne aggiunga uno nuovo (C. Alberini e E. Kandel 2014, Nader K.2015) che metta a disposizione del paziente una nuova memoria non traumatica che può costituire una risorsa per arrivare a sostenere e ad elaborare l’antico ricordo.
Bibliografia
Alberini C. M. (2009) Transcription factors in long-term memory and synaptic plasticity. Physiol Rev 89:121–145.
Alberini C. M. (2011) The role of reconsolidation and the dynamic process of long term memory formation and storage. Front Behav Neurosci5:12.
Alberini C. M., Ledoux J. E. (2013). Memory reconsolidation. Curr Biol. 2013 Sep 9;23(17):R746-50.
Alberini, C. M. (2014). Memoria: traccia fragile e dinamica, in Cena, L., Imbasciati, A. (2014), Neuroscienze e teoria psicoanalitica. Milano: Springer
Alberini C. M., Kandel E. R. (2014).The regulation of transcription in memory consolidation. Cold Spring Harb Perspect Biol. Dec 4;7(1):
Ammanniti, M., Gallese, V. (2014). La nascita dell’intersoggettività. Milano: Raffaello CortinaBalint M., (1952). L’amore primario Trad. ed R.Cortina, Milano 1991
Bion, W. R. (1965). Trasformazioni. Il passaggio dall’apprendimento alla crescita. Roma: Armando, 1973.
Bollas B. (1987). The Shadow of the Object Free Association Books: 1987 Columbia University Press).
Boston Group for the Study of Change Process (Stern D. L.W. Sander, J. P. Nahum, A. M. Harrison, Bowlby, J. (1969). L’attaccamento alla madre. Torino: Boringhieri, 1972.
Bucci W. (2001). Pathways of emotional communication. Psychoanal.Inq. 21:40-70.
Bucci W. (2002). The Language of Emotions. Evolution and Cognition, 8, 2: 172-183.
Correale A. (2006). Linee di sviluppo del gruppo di studio su “Memoria implicita, Neuroscienze e Psicoanalisi” nell’ambito del gruppo di studio nazionale della SPI su Psicoanalisi e Neuroscienze. Pubbl. su “Psychomedia” Scienze e pensiero. Psicobiologia e Neuroscienze. 2006
Damasio A. R., (2000). Emozione e coscienza, Adelphi, Milano, 2000
Di Benedetto A. (2000). Prima della parola. Milano, FrancoAngeli.
Edelman G. M. (1991). Il presente ricordato, Rizzoli, Milano
Edelman G. M. (1993). la materia della mente, Adelphi, Milano.
Finsterwald C. et al. (2015). From Memory Impairment to Posttraumatic Stress Disorder-Like Phenotypes: The Critical Role of an Unpredictable Second Traumatic Experience. J Neurosci. Dec 2; 35(48): 15903–15915.
Fonagy P. (1998). Moment of change in psychoanalytic theory: discussion of a new theory of psychic change. Science, Vol. 19(3), 346-353.
Fonagy P. (1999). Memory and therapeutic action. International Journal of Psychoanalysis, 80, 215-223.
Freud S. (1887–1904). Lettere a Wilhelm Fliess. Bollati Boringhieri, Torino
Freud S (1899). “Ricordi di copertura” id.OSF 2
Freud S (1914). “Ricordare, ripetere, rielaborare id. OSF 7
Freud S (1924). Note sul notes magico id.OSF 10
Freud S (1937). Costruzione in analisi” id. OSF11
Gabbard G. O., Westen D. (2005). Ripensare l’azione terapeutica. L’annata psicoanalitica internazionale 1:51-73 (Borla). Tradotto da Gabbard G.O. & Westen D. (2003). Rethinking therapeutic action. Int.J.Psycho-Analysis, 84, 823-841.
Holmes, J. (2000). Memory and therapeutic action, Letters to the Editor. Int.J.Psychoanal., 81: 353-355.
Inda M. C, Muravieva E. V, Alberini C. M. (2011) Memory retrieval and the passage of time: from reconsolidation and strengthening to extinction. J Neurosci 31:1635–1643.
Jacoby L. L., Witherspoon, D. (1982). Remembering without awareness. Canadian Journal of Psychology, 36(2),300–324.
Kandel (2002a,b). Emozione e coscienza. Adelphi, Milano.
Klein, M. (1928). I primi stadi del conflitto edipico. In: Scritti 1921-1958, Torino: Boringhieri, 1978, pp.214-226.
Klein M. (1946). Note su alcuni meccanismi schizoidi. In: Scritti 1921-1058, Torino: Boringhieri, 1978,pp.526-535.
Klein M. (1928). I primi stadi del conflitto edipico. In: Scritti 1921-1958, Torino: Boringhieri, 1978, pp.214-226.
Klein M. (1946). Note su alcuni meccanismi schizoidi. In: Scritti 1921-1058, Torino: Boringhieri, 1978, pp.526-535.
Klein M. (1958). Sullo sviluppo dell’attività psichica, Scritti 1921-1958. Torino: Boringhieri, 1978, pp.540-550.
Lau-Zhu A., Henson R. N., Holmes E. A. (2019). Intrusive memories and voluntary memory of a trauma film: Differential effects of a cognitive interference task after encoding. J Exp. 2019 Apr 25.
LeDoux, J. (1994). Emozioni, memoria e cervello. Le Scienze 53 (312): 32-40.
LeDoux J, Paulson S, Aciman A, Schacter D, Winter A. (2013). The mystery of memory: in search of the past. Ann N Y Acad Sci. Nov;1303:36-55.
Lyons-Ruth K., Morgan A. C., Bruschweiler-Stern, N.,Tronick E. Z.) (1998). “Non interpretive mechanisms in psychoanalytic therapy: The ‘something more’ than interpretation”. n. 5/1998 dell’International Journal of Psychoanalysis.
Mancia M. (1998). Coscienza Sogno Memoria. Roma: Borla.
Mancia, M. (2003). Dream actors in the theatre of memory: their role in the psychoanalytic process. International Journal of Psychoanalysis, 84(4), 945-952
Mancia, M. (2004a). Sentire le parole. Archivi sonori della memoria implicita e musicalità nel transfert. Bollati Boringhieri, Torino.
Mancia, M. (2006). Psicoanalisi e Neuroscienze. Springer-Verlag. Implicit memory and early unrepressed unconscious: Their role in the therapeutic process (How the neurosciences can contribute to psychoanalysis). International Journal of Psychoanalysis, 87(1), 83-104.
Mancia M. (2008). The early unrepressed unconscious in relation to Matte-Blanco’s thought. International Forum of Psychoanalysis, Vol. 17 Issue
Matte Blanco I. (2000). L’inconscio come insiemi infiniti: saggio sulla bi-logica, (a cura di P. Bria), Torino, Einaudi, 2000
Meltzer D. (1984). Dream-Life. Clunie Press, Londra
Mishkin, M., Appenzeller T. (1987). L’anatomia della memoria. Le Scienze 39 (1987) in Le Scienze Quaderni “Apprendimento e Memoria” 82: 13-21, 1995
Modell, A. H. (2003). Imagination and the meaningful brain. MIT Press.
Money-Kyrle, R. (1978). Scritti 1927-1977(introduzione e cura di M. Mancia) Torino: Boringhieri, 2002 (1ª ed. Torino: Loescher, 1984
Nader K., Schafe G. E, LeDoux J. E. (2000). Fear memories require protein synthesis in the amygdala for reconsolidation after retrieval. Nature 406:722–726.
Ogden P., Fisher J. (2016). Psicoterapia sensomotoria, Raffaello Cortina Editore
Pally R. (1997). Memory: brain systems that link past, present and future. Int. J.Psychoanal., 79: 903-921. 78: 1223-1234.
Przybyslawski J, Sara S. J. (1997). Reconsolidation of memory after its reactivation. Behav Brain Res. 1997 Mar;84(1-2):241-6.
Roediger H. L (1990). Implicit memory: Retention without remembering. Am Psychol 45 (9): 1043-56.
Rosenfeld H. A. (1987). Comunicazione e interpretazione. Torino: Bollati Boringhieri, 1989
Schacter, D. L., Church, B. A. (1992). Auditory priming: Implicit and explicit memory for words and voices. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 18(5), 915–930
Schacter D. L. (1995). Implicit memory: A new frontier for cognitive neuroscience. In The cognitive neurosciences, ed. MS Gazzaniga, Cambridge, MA: MIT Press.
Schacter D. L. (1998). Memory and awareness. Science 280: 59-60
Schore, A., Siegel, S. J. (1999) Right Brain Affect Regulation: An Essential Mechanism Of Development, Trauma, Dissociation, And Psychotherapy. PhDUCLA David Geffen School of Medicine (1999). La mente relazionale. Neurobiologia dell’esperienza interpersonale, Milano: Cortina.
Siegel S. J. (1999). La mente relazionale. Neurobiologia dell’esperienza interpersonale, Milano: Cortina.
Squire L. R. (1994). Declarative and Nondeclarative Memory: Multiple Brain System Supporting Learning and Memory, in Schacter D.L. – Tulving E. (1994) (eds) Memory Systems, The MIT Press, Cambridge (Mass).
Squire L., Kandel E. (2002a). La memoria non cosciente. Le Scienze Dossier “La memoria” 14: 60 65.
Stern D. N. (1998). The process of Therapeutic change involving implicit knowledge: some implication of developmental observations for adult psychotherapy. Infantil mental Health Journal, Vol. 19(3), 300-308.
Stern, D. N. et al. (1998). Non-interpretative mechanisms in psychoanalytic therapy: the ‘something more’ than interpretation. Int. J. Psychoanal., 79: 903-921.
Winnicott D., (1965). Sviluppo affettivo e ambiente. Trad. ed. Armando, Roma 1970.
Mentalizzazione

Il pensatore di Auguste Rodin
A cura di Lucina Bergamaschi
La mentalizzazione è una forma di attività mentale immaginativa, principalmente preconscia. Coglie e interpreta il comportamento umano in termini di stati mentali come bisogni, desideri, emozioni, credenze, obiettivi, intenzioni e motivazioni, Mentalizzazione e funzione riflessiva sono termini affini, sono spesso utilizzati in letteratura in modo intercambiabile. Specificatamente la funzione riflessiva misura la mentalizzazione, in situazioni di ricerca. E’ definibile come l’operazionalizzazione del processo psicologico che sottende la capacità di mentalizzare.
Quando si mentalizza, l’immaginazione sostiene la possibilità, priva di certezze, di formulare ipotesi circa i pensieri e le emozioni presenti nella mente altrui. La stessa tensione immaginativa è necessaria anche per la comprensione delle proprie esperienze mentali, soprattutto se coinvolgono emozioni intense. La mentalizzazione è indispensabile per l’auto-organizzazione e per la regolazione affettiva. Lo sviluppo della capacità di “tenere a mente la mente” affonda le sue radici nelle relazioni precoci di attaccamento. Secondo questa prospettiva teorica, l’attaccamento svolge la funzione evolutiva primaria di sollecitare protezione nel caregiver, ma soprattutto consente al bambino di vivere l’esperienza, fondamentale per la regolazione affettiva, di essere contenuto psicologicamente a fronte di stati affettivi altrimenti intollerabili.
Attraverso il rispecchiamento emotivo, l’attenzione condivisa e l’interazione educativa il caregiver aiuta il bambino a formarsi gradualmente un sé interiore e a rappresentare nel profondo se stesso come agente intenzionale, dotato di sentimenti e di pensieri propri.
Il bambino diviene poco a poco in grado di percepire come significativo e prevedibile l’universo relazionale e di sviluppare la capacità di reagire in modo resiliente alla complessità della vita sociale.
Lo sviluppo della capacità di mentalizzare è quindi un processo interpersonale, che comporta l’acquisizione di una sempre più sofisticata capacità di generare azioni, volte al conseguimento di determinati scopi (agency/agentività).
Come e quanto ciascuno di noi padroneggi questa competenza vitale dipende quindi dall’eredità genetica e dalle prime esperienze di attaccamento.
Origini del concetto di mentalizzazione Il concetto di mentalizzazione è stato sviluppato in un vasto contesto di studi empirici sui processi sottesi alla trasmissione transgenerazionale dell’attaccamento, presso l’Anna Freud Centre di Londra.
Fonagy, Steele, Moran, Steele e Higgitt hanno tratto ispirazione per lo sviluppo del concetto di mentalizzazione dal lavoro psicoanalitico con i pazienti borderline e utilizzato questo concetto per la prima volta nel 1989, riferendosi al modo in cui esso è stato operazionalizzato dai ricercatori della teoria della mente (The origins of “Teory of Mind “Leslie, A.M. 1987).
Fonagy e collaboratori identificano nel deficit di mentalizzazione un aspetto centrale della patologia borderline e riconoscono il loro debito intellettuale verso gli psicoanalisti Bion, Rosenfeld, Green, Kenberg e verso i teorici delle relazioni oggettuali nordamericani, che hanno indicato come la capacità di rappresentare se stessi e gli altri, in termini di stati mentali, sia l’esito di uno sviluppo radicato nella qualità delle prime relazioni.
Infine, la psicoanalisi infantile e il lavoro di ricerca di Mary Target e di Peter Fonagy hanno influenzato, in modo altrettanto fertile, lo sviluppo di una teoria della mentalizzazione, che prende le distanze in modo netto dall’assunto cartesiano per il quale la mente è trasparente a se stessa e l’abilità umana di riflettere sulla propria mente è innata.
L’evolversi della capacità di mentalizzare dipende dall’interazione con menti mature e sensibili, ne consegue la centralità della qualità dell’attaccamento in questo processo.
Il modello di sviluppo della mentalizzazione
Vincolato alla nascita da una “equivalenza psichica” tra mondo interno e mondo esterno per lui indistinguibili, il neonato è guidato nella differenziazione tra mondo degli oggetti e mondo della mente, attraverso il processo di rispecchiamento affettivo dal caregiver, che per essere efficace, si avvale di markers che introducono altri significati. Per esempio, la madre risponde al pianto del figlio, con un’espressione di tristezza, intercalando sorrisi sereni, volti a calmarlo e consolarlo. Il bambino impara così a conoscere le proprie emozioni, a interiorizzare una rappresentazione della sua esperienza emotiva e a differenziare i propri stati interni da quelli di un altro, in una situazione relazionale. Questo processo è alla base della percezione di poter influenzare con il proprio comportamento non solo il mondo degli oggetti ma anche le altre persone.
Atteggiamento teleologico: a partire dagli otto, nove mesi il bambino è capace di attenzione congiunta, può dirigere lo sguardo della madre su un oggetto, a cui sta prestando la propria attenzione, e divenire consapevole della differente rappresentazione che ne hanno lui e la madre. Può apprendere qualcosa sul mondo, sull’altro e sulla differenza tra se e l’altro. Con l’ acquisizione della capacità di rappresentazioni di secondo ordine degli stati emotivi si gettano le basi per la regolazione affettiva e il controllo degli impulsi. Infatti, cercando lo sguardo della madre di fronte ad un oggetto nuovo, il bambino deduce, dall’atteggiamento di lei, l’eventuale pericolosità della situazione e il comportamento da assumere. Il bambino comincia a comprendere se stesso come agente teleologico, che può scegliere l’alternativa più efficiente per raggiungere l’obiettivo. In questa fase, tuttavia, l’agentività ė intesa esclusivamente in termini di azioni e di costrizioni fisiche. Il bambino si aspetta che l’altro si comporti razionalmente, considerando gli stati intenzionali chiaramente fisici.
Il Sé come agente intenzionale e rappresentazionale Durante il secondo anno, il bambino comincia a capire che lui stesso e gli altri sono agenti intenzionali, le cui azioni sono causate da stati mentali sottostanti come i desideri e che le sue azioni possono portare a cambiamenti sia nelle menti sia nei corpi degli altri, per esempio, attraverso il gesto di indicare. In questa fase, la capacità di regolazione emotiva riflette il rapporto passato e presente con il caregiver primario. Ancora più importante, il bambino comincia ad acquisire un linguaggio sugli stati interni e le capacità di ragionare in maniera non egocentrica sui sentimenti e i desideri degli altri. Paradossalmente, questo diventa evidente non solo attraverso l’aumento dell’attività congiunte dirette ad uno scopo, ma anche attraverso le provocazioni rivolte ai fratelli più piccoli. Tuttavia il bambino non è ancora in grado di rappresentarsi gli stati mentali in modo indipendente dalla realtà fisica e non è stata ancora pienamente raggiunta la distinzione tra interno ed esterno tra apparenza e realtà. Questo significa che la realtà interna viene vissuta talvolta secondo la modalità dell’equivalenza psichica: per Il bambino le cose sono come a lui sembrano, proietta i suoi pensieri e i suoi sentimenti sulla realtà esterna, senza riconoscere che l’esperienza del mondo esterno risulta distorta. L’equivalenza psichica, come modalità di esperienza del mondo, interno può generare angoscia poiché la proiezione è percepita come assolutamente reale (Il bambino chiede e ottiene in regalo dal padre il costume da Batman. Il costume è però così realistico che il bambino davanti allo specchio si spaventa e rifiuta di indossarlo).
Altre volte invece il bambino adotta un secondo modo di costruire gli stati mentali : il “ far finta”. Secondo questa modalità i sentimenti e i pensieri sono totalmente privi di implicazioni relative al mondo esterno. L’esperienza interiore del bambino è isolata dal resto dell’Io. Ad esempio: il bambino che fa finta di sparare con una sedia/ carro armato, sa che il suo far finta non è reale, ma non è consapevole della sua finzione bensì la realtà psichica, che gli consente di far finta, richiede una netta separazione dalla realtà esterna.
Né la modalità dell’equivalenza psichica né quella del “far finta” possono generare esperienze interne interamente assimilabili alla natura intrinseca della realtà interiore: la prima è troppo reale, la seconda troppo irreale.
In un quadro evolutivo, gradualmente, attraverso la vicinanza di un altro capace di mantenere simultaneamente unite le due modalità: l’equivalenza e il far finta, è possibile il processo di integrazione e può prendere vita una realtà psichica dove i sentimenti e le idee sono riconosciuti come interni, ma sono connessi con ciò che appartiene alla realtà esterna. (Il genitore che rassicura il bambino che il costume di Batman è il costume di Batman ma che nel frattempo lo toglie dalla stanza). L’atteggiamento genitoriale giocoso è un fattore determinante per l’integrazione delle due modalità rappresentazionali. In una relazione giocosa genitore-figlio i sentimenti, i desideri e le credenze possono essere vissute dal bambino come aspetti importanti e apprezzati e nello stesso tempo essere esperienze riferite ad un altro livello di realtà, rispetto a quello fisico, il che consente la trasformazione delle due modalità “fare finta” e “equivalenza psichica” e il crearsi dello “spazio transizionale”.
Verso i quattro anni, il bambino comincia a capire che le azioni delle persone sono causate dalle loro credenze. Da questo momento il bambino può comprendere se stesso gli altri come agenti rappresentazionali. Egli sa che le persone non sempre provano ciò che in apparenza sembrano provare e che le loro reazioni emotive ad un evento sono influenzate dallo stato d’animo del momento oppure da pregresse esperienze emotive vissute in eventi simili. Il raggiungimento di questa pietra miliare dello sviluppo trasforma le sue interazioni sociali. La comprensione delle emozioni è associata a un comportamento empatico e a relazioni positive con i pari.
In seguito, non oltre i sei anni, avvengono ulteriori evoluzioni, il bambino diviene in grado di connettere i ricordi delle proprie attività ad esperienze intenzionali all’interno di un’organizzazione spazio-temporale coerente, cioè acquisisce una percezione temporale del Sé.
Se per qualsiasi ragione il genitore non riesce a rispondere in modo adeguato, congruente e accentuato, il bambino interiorizzerà l’esperienza o le difese del genitore. L’angoscia sarà così rispecchiata o evitata senza prima essere metabolizzata. Quando il rispecchiamento del caregiver ė incongruente, la rappresentazione dello stato interno del bambino non corrisponderà allo stato costitutivo del Sé, predisponendo il bambino a sviluppare una struttura di personalità narcisistica, analoga al “falso se” di Winnicott. Quando invece il rispecchiamento non è marcato, l’espressione del volto del caregiver esternalizza l’esperienza del bambino, che si sente sopraffatto dal suo stato, vivendolo come contagioso, sempre più intenso, non regolabile. Può così costituirsi una predisposizione a sperimentare emozioni attraverso gli altri, come accade nelle strutture borderline di personalità.
Il bambino, in casi estremi, dovrà ricorrere come difesa all’inibizione della mentalizzazione.
Bibliografia:
Allen, J.. Fonagy, P., Bateman, A. (2008)., La mentalizzazione nella pratica clinica Tr. It. Raffaello Cortina, Milano 2010
Fonagy,P, Target,M., (2001) Attaccamento e funzione riflessiva. Raffaello Cortina, Milano
Leslie, A.M.(1987) “Pretense and rapresentation: The origins of ‘Teory of Mind’ ” In Psychological Review,94,pp.412-426
Slade,A., (2010) Relazione genitoriale e funzione riflessiva. Casa editrice Astrolabio
Società Psicoanalitica Italiana, (2013) Attaccamenti Alpes
Target,M., Fonagy,P.,(1996) Giocare con la realtà II. Lo sviluppo della realtà psichica da un puntodi vista teorico” Tr.It. In Attaccamento e funzione riflessiva. Raffaello Cortina, Milano 2001
Metapsicologia
A cura di Francesco Conrotto
Con il termine metapsicologia si intende il complesso di ipotesi teoriche e di concetti extra-clinici in grado di spiegare i fenomeni clinici.
La prima definizione del termine metapsicologia risale alla lettera n° 160 del 10 marzo 1898 (Freud 1887-1904 p. 339) nella quale Freud, quasi retoricamente, domanda a Fliess se può usare il termine “metapsicologia” per la sua “psicologia che conduce dietro la coscienza”.Il prefisso “meta” rende visibile la derivazione aristotelica di questo termine in quanto nell’ordinamento del corpus teorico aristotelico, gli scritti di metafisica, “tà metà tà physikà”, definita “filosofia prima”, quindi scienza che si occupa dei caratteri fondamentali dell’essere e che traccia i principi generali da cui derivano tutte le scienze particolari, erano collocati dopo i libri di fisica. In questa prospettiva, è possibile ammettere che la metapsicologia, sia semplicemente la “psicologia dell’inconscio”, quindi una sorta di sinonimo della psicoanalisi.
Una definizione più ampia risale al 1915, ove nel saggio su L’inconscio”, Freud dice “che, se riusciamo a descrivere un processo psichico nei suoi rapporti dinamici, topici ed economici, la nostra esposizione sia chiamata metapsicologica” (1915 p.65). Partendo da questa definizione possiamo concordare con Assoun (1981) che i modelli scientifici extraclinici sui quali si è fondata la metapsicologia freudiana sono stati: la neuroanatomia, appresa nel laboratorio di fisiologia del cervello diretto da Brüke. Essa è stata la base topologica della “topica”. La psicologia della dinamica delle rappresentazioni di Herbart che è stata la base della “dinamica”. L’imperativo della misurabilità, realizzato attraverso l’energetismo che deriva da Fechner e Helmholtz. Esso è stato la base dell’”economica”.E’ opportuno ricordare che più tardi (1910) Freud non aderì all’invito di W. Ostwald, teorico dell’energetismo, a scrivere un articolo sulla rivista Annalen der Naturphilosophie (Jones 1953 p. 105), forse perché Ostwald riteneva di andare oltre il materialismo meccanicistico.
A questo punto è lecito domandarci quale sia lo statuto epistemologico della metapsicologia. Già nel 7° Capitolo della “Interpretazione dei sogni” Freud ci aveva messo sull’avviso di “non scambiare l’impalcatura per la costruzione” (1900 p.490), vale a dire che l’“apparato psichico” deve essere inteso come il prodotto di una “costruzione” di un “modello finzionale” che deriva dal modello anatomico, cioè dal “preparato anatomico” del cervello (1900 p.489) Pertanto, lo statuto epistemologico della metapsicologia sarebbe quello del “come se” (Als ob). Si tratterebbe quindi di “rappresentazioni ausiliarie”. Per questo motivo, la metapsicologia costituisce un “sapere congetturale” e non la conoscenza di qualcosa che esiste in quanto tale. D’altro canto, riferendosi all’inconscio, che, in quanto tale, è inconoscibile, non potrebbe essere diversamente. Infatti, a proposito delle ipotesi metapsicologiche, Freud parla di “presentazioni metapsicologiche” (Metapsychologische darstellungen) e non di teorie metapsicologiche, quindi si tratterebbe di una messa in forma di qualche cosa che, proprio a causa del suo statuto di inconscieità, non può essere conoscibile direttamente.
Freud è ritornato su questo argomento alla fine della sua opera dove in “Analisi terminabile e interminabile”, definendo la metapsicologia “la strega”, dice che “non si può avanzare di un passo se non speculando, teorizzando – stavo per dire fantasticando – in termini metapsicologici”. (1937 p.508). Qui l’artificio retorico, utilizzato attraverso la formula – “stavo per dire” – mostra la centralità della “speculazione immaginativa” nella costruzione di questa parte del pensiero psicoanalitico.
Possiamo, dunque, ritenere che l’inconscio stesso sia il primo “oggetto metapsicologico” (Assoun1993) cui fanno seguito il concetto di “apparato psichico”, nonché quelli di “pulsione”, di “ripetizione” e di “transfert”.
Negli Stati Uniti, intorno alla metà del 20° secolo si aprì un grande dibattito circa la scientificità della psicoanalisi (Conrotto 2000). D. Rapaport (1960) fu colui che tentò di accreditare alla psicoanalisi uno statuto che la integrasse perfettamente tra le scienze naturali ma altri autori, tra i quali Holt (1965), Rubinstein (1965) e Peterfreund (1961), ritenevano che fosse necessario aggiornare la metapsicologia freudiana sostituendo i suoi fondamenti scientifici ormai obsoleti con le recenti acquisizioni della neurobiologia e della cibernetica.
G.S. Klein (1976), più radicalmente, sostenne che la psicoanalisi dovesse essere soltanto una disciplina clinica e che la metapsicologia non avesse alcun valore scientifico. Successivamente, numerose correnti del pensiero psicoanalitico, soprattutto anglosassone, hanno abbandonato qualsiasi riferimento alla metapsicologia a favore del relazionalismo intersoggettivista o della ricerca empirica.
Dobbiamo tuttavia segnalare che tutti i differenti modelli psicoanalitici postfreudiani hanno creato, esplicitamente o implicitamente, una loro metapsicologia. Basti pensare, ad esempio, ai concetti di “invidia primaria” e di “identificazione proiettiva” formulati dalla Klein e a quello di “fenomeno transizionale” di Winnicott. Essi rappresentano ipotesi teoriche di fondo utilizzate per illustrare e spiegare dei fenomeni clinici. Ma, i due autori che, finora, hanno elaborato una vera e propria autonoma metapsicologia sono stati: Lacan e Bion. Il primo, facendo riferimento allo strutturalismo linguistico è pervenuto alla formulazione della teoria del “significante” (1966). Più tardi con il riferimento alla geometria topologica ha formulato la teoria del “Mathema” (1991). Bion, utilizzando un modello quasi matematico (1963), ha potuto costruire una “Griglia” dalla quale è pervenuto a formulare la sua “Teoria delle Funzioni” (1965, 1970).
BIBLIOGRAFIA
Assoun P. L. (1981) Introduzione alla epistemologia freudiana. Edizioni Theoria,Roma-Napoli, 1988.
Assoun P. L. (1993) Introduction à la métapsychologie freudienne. Quadrige, PUF
Bion W.R. (1963) Gli elementi della psicoanalisi, Armando, Roma, 1973.
Bion W.R. (1965) Trasformazioni Armando, Roma, 1973.
Conrotto F. (2000) Metapsicologia: da Freud agli Stati Uniti, Riv. Psicoanal.,46, 3, 561-586.
Freud S. (1985) Lettere a W. Fliess (1887-1904). Boringhieri, Torino, 1986.
Freud S. (1900) L’interpretazione dei sogni. O.S.F., 3.
Freud S. (1915) L’inconscio. O.S.F., 8.
Freud S. (1937) Analisi terminabile e interminabile. O.S.F., 12.
Holt R.R. (1965) Ripensare Freud. Boringhieri, Torino, 1994.
Klein G.S. (1976) Teoria psicoanalitica, i fondamenti. Raffaello Cortina,Milano, 1993.
Lacan J. (1966) Funzione e campo della parola in psicoanalisi. In ScrittiEinaudi, Torino, 1974.
Lacan J. (1991) Il Seminario Libro 17, Il rovescio della psicoanalisi. Einaudi,Torino, 2001.
Rapaport D. (1960) Struttura della teoria psicoanalitica, Boringhieri, Torino.1969.
Peterfreund E. (1971) Information Systems and Psychoanalysis. New York
Rubinstein B.B. (1965) Psychoanalytic theory and the mind-body problem. In Greenfield N. Lewis W (EDS) Psychoanalysis and Current Biological Thought. Madison, The University of Wisconsin Press.
Molinari Egon

Egon Molinari
A cura di Alberto Spadoni, con la collaborazione di Manuela Martelli
Maestri della psicoanalisi
“L’equilibrio e la generosità, la sapienza e l’ironia furono e saranno principali virtù di Molinari” (Gino Zucchini, per i festeggiamenti dei 90 anni di Egon Molinari)
Egon Molinari (Trieste 25.06.1911 – Bologna 28.02.2002)
Egon Molinari è un autorevole pioniere della psicoanalisi italiana, insieme a Edoardo Weiss, Emilio Servadio, Nicola Perrotti e Cesare Musatti, del quale fu allievo.
Già pienamente attivo negli impervi anni cinquanta, fu il primo psicoanalista a Bologna, dove introdusse la pratica e la cultura psicoanalitica, l’unico tra il Po e il Tevere sino agli anni ’70.
Studioso raffinato e discreto, di grande umanità e competenza, insieme all’amico e collega Glauco Carloni fondò il Centro Psicoanalitico di Bologna, che nasce nei primi anni ’70 dalle riunioni del Mercoledì in casa Molinari.
Persona riservata, poco prolifico nella produzione scientifica, trasmetterà la sua grande capacità clinica e i suoi insegnamenti agli allievi attraverso l’operato di analista e supervisore. Sul suo ben piantato lettino si sono formati personaggi dello spessore di Glauco Carloni, Giovanni Hautmann, Pier Mario Masciangelo e Stefano Bolognini.

La vita
“Anche noi, tra i più stagionati dei suoi allievi – lui riservato per alto pudore e schivo di ogni mondanità – abbiamo dovuto carpirgli i segmenti sparsi della sua lunga biografia: le radici ebraiche, l’infanzia presto orfana a Trieste, gli studi di giurisprudenza e poi di medicina, la professione medica a Lussino, a Gorizia e poi a Cesena e a Faenza, l’opera data nella Resistenza, l’approdo a Bologna.” (G. Zucchini, “Il dolore, la memoria, la nostalgia.” Bologna, 2002)
La storia di Egon Molinari comincia a Trieste nel 1911, dove nasce da genitori ebrei ungheresi; visse successivamente nei pressi di Vienna, dove aveva studiato, qualche anno prima di Freud, il nonno, ufficiale sanitario. Rimasto orfano di madre da bambino e di padre da adolescente, fu costretto a lavorare durante gli studi, che furono prima di Diritto ed Economia e poi di Medicina. Laureato in Medicina, esercitò a Lussinpiccolo, a Gorizia, a Cesena e a Faenza, ma dopo il ’36 fu costretto ad abbandonare il lavoro nelle istituzioni pubbliche a causa delle leggi razziali.
Egon Molinari, con leggerezza ed eleganza, si portava dentro un gran bagaglio di terribili disavventure collegate alla lunga notte italiana, dalla legge filonazista antisemita del1938 fino alla Liberazione nell’aprile del 1945. Non avendo mai accettato il ruolo del discriminato o quello della vittima, in quegli anni tragici doveva apparire ai familiari e agli amici molto più come un eterno affaccendato che per quello che realmente era, un perseguitato. Per sfuggire ai mastini della Gestapo aveva lasciato casa per rintanarsi a Roma: gli andò sempre bene, compresa quella volta che, per miracolo, non finì alle Fosse Ardeatine.
A sostenerlo c’era sempre Tullia, la dolce consorte trentina, conosciuta e subito amata mentre entrambi si occupavano di paludismo, lei crocerossina, lui medico militare, nella piana, allora depressa, di Manfredonia.
In quegli anni difficili, è sempre stato un uomo probo, coraggioso e ottimista. Ne dà un’idea l’episodio della valigia rubata. Siamo a Faenza nel ’44, dove esercita come libero professionista sotto falso nome. Due soldati della Wermacht gli strappano di mano la sua bella valigia di cuoio. Infuriato, si precipita al Kommandantur a protestare in forbito tedesco per il furto subito. A noi, sbalorditi, disse semplicemente che sapeva di poter tentare senza troppo rischiare. Riottenne il maltolto e si divertì pure.
Alla fine della guerra, dopo un periodo a Bologna, raggiunse Milano, dove incontrò Cesare Musatti, col quale si formò e mantenne in seguito l’amicizia e la collaborazione scientifica.
Con il suo lavoro ha contribuito alla formazione della discendenza degli psicoanalisti dell’Emilia-Romagna e di diversi colleghi della Toscana e del Veneto.
Ha svolto il ruolo di Segretario nel Comitato Esecutivo della SPI dal 1951 al 1955.
E’ morto a Bologna il 28 febbraio 2002.

Il contributo alla Psicoanalisi
Egon Molinari sapeva trattare alla pari, con amichevole accoglienza, sia i pazienti che gli allievi. A tal punto che, quando ti sedevi in casa sua o ti stendevi sul lettino eri così a tuo agio da non volertene più andare.
La tecnica terapeutica di Egon Molinari era lieve, come lieve e sapiente era il suo silenzio, ma non per questo era meno tenace la sua determinazione a portare a termine il percorso di analisi.
Come testimonia il suo scritto “Il silenzio in analisi”, che nasce come articolo sulla Rivista Italiana di Psicoanalisi nel 1957 e poi diventa un volumetto, pubblicato da Guaraldi nel 2011, scritto da lui ritenuto il suo contributo più significativo, Molinari si è molto interessato alle diverse sfumature del silenzio nella situazione analitica. Questo lavoro matura in un periodo in cui l’analista stava molto in silenzio, cercando di dare significato all’alternarsi della parola e del silenzio del paziente; è un contributo che rimane assai significativo, nonostante i cambiamenti che si sono verificati nella pratica analitica.
Ripensandolo ora, dopo aver conosciuto tanti valenti colleghi, anche forestieri, Molinari appare come l’esatto contrario dello psicoanalista ancora invischiato in quel che resta, e non è mai poco, del proprio narcisismo originario che, come si sa, l’analisi di formazione, anziché liquidare, non di rado consolida. Credo che questo sia stato uno dei suoi primati: quello di condurre l’analisi, comprese quelle “didattiche”, col fine mirato di far evolvere in senso maturativo tutti quegli aspetti del sé che conservano l’impronta del narcisismo infantile, anche quando si limita a nutrire segretamente la convinzione di essere sotto sotto speciali e quindi di meritarsi, prima della fine, quel plauso generale, capace di cancellare per sempre i sani dubbi sul proprio valore.
In linea con il suo interesse nei confronti del narcisismo, va ricordata la sua amicizia con Bela Grünberger e la scelta di farcene conoscere l’opera, invitandolo a Bologna per i seminari di primavera degli ultimi anni sessanta. L’esordio riguardò proprio la relazione che il collega franco-ungherese aveva tenuto a Lisbona nel ’56, con Janine Chasseguet-Smirgel, sul “Narcisismo dell’analista” e che aveva suscitato l’ammirazione di Molinari e negli altri più fastidio che consensi.
Fondamentale è stato il suo contributo alla diffusione della psicoanalisi in Emilia, Toscana e Veneto e alla crescita della Spi nel centro-nord d’Italia. Ha avuto il grande pregio di svolgere una funzione unificante, sia per aver saputo accogliere e diffondere il pensiero di tutte le principali correnti di ricerca, sia per aver condotto una preziosa opera di avvicinamento e pacificazione fra Nord e Sud, favorita dalla posizione geografica e dallo speciale calore della città di Bologna.
Non dobbiamo dimenticare che Molinari e Carloni hanno saputo tessere e ricucire legami che hanno contribuito a impedire, per molti anni, che si verificassero scissioni.
E’ per la regia di Egon Molinari e nello spazio della sua bella casa di via Fermi n°4 a Casalecchio di Reno, che il Centro bolognese ha mosso i suoi primi passi, rappresentati dal seminario settimanale del mercoledì sera e da quelli mensili del fine settimana, condotti prima da Musatti sulla traduzione dell’Opera di Freud e successivamente da Francesco Corrao, su Bion e Meltzer, da Pier Mario Masciangelo su Freud e da Eugenio Gaddini sulla funzione paterna. Si era fra gli anni sessanta e settanta, generosamente confortati dalla premura nutriente della Signora Tullia.
Ci abbiamo messo del tempo ad accorgerci che aveva in testa l’intera sua biblioteca e non solo quella scientifica, e che conosceva bene, oltre al tedesco, anche il francese, l’inglese e lo spagnolo. Capitava in quelle sere che, mentre sembrava solo attento a riempirti il bicchiere di Porto, correggesse un errore di traduzione di Fabio Zambonelli, che ci leggeva l’autobiografia di Bion. Molinari era anche quello che, non visto, ci aveva preceduto immancabilmente alla cassa del bar e del ristorante.
E’ per merito di Molinari, col fondamentale aiuto di Carloni, che gli psicoanalisti italiani hanno conosciuto il contributo teorico-clinico di Sandor Ferenczi, tramite la traduzione, le presentazioni e la cura della pubblicazione dei quattro volumi che ne accolsero l’Opera per l’editore Guaraldi nel 1972. Molinari e Carloni furono anche gli ispiratori della collana “La sfinge”, dello stesso editore, attraverso cui furono conosciuti in Italia diversi testi della psicoanalisi mondiale.
Da questo interesse e dialogo scientifico, deriva una pratica psicoanalitica ispirata allo “stile materno” di Sandor Ferenczi, coltivata sia sul piano teorico che clinico. Molinari ha trasmesso il suo stile relazionale caldo e stimolante al gruppo bolognese fin dagli albori, mettendolo nella condizione di offrire un prezioso esempio di come andasse costruito un centro di formazione permanente e di ricerca in campo analitico, al riparo dai rischi delle tentazioni paternalistico-egemoniche o di quelle fraterno-conflittuali. Non credo che esageri chi pensa che, in quegli anni di impetuosa crescita della Spi, il gruppo bolognese, guidato da Molinari e Carloni, sia stato un utile esempio per i colleghi di Milano e di Roma di come sia preferibile e conveniente lavorare in un clima di grande apertura culturale e di rispetto per le diversità, con conseguente apprezzamento dei vantaggi di queste. (vedi Il Madro, a seguire)
Il Madro, un modello conveniente per gli analisti in formazione
Già alla fine degli anni sessanta, il mercoledì sera ci si riuniva in casa di Egon Molinari a Casalecchio di Reno, per parlare e leggere felicemente di psicoanalisi, nello stesso appartamento dove avevamo da poco terminato l’analisi.
Il salotto che ci accoglieva era un’altra parte della pancia di Molinari, quella più ampia, conviviale, più adatta ai rapporti di gruppo, dove il nutrimento era reale, non solo simbolico.
In pentola stava bollendo la traduzione e la pubblicazione dell’opera di Sandor Ferenczi e se ne respiravano i profumi, benché noi, ultimi arrivati, ce ne saremmo resi chiaramente conto solo più avanti. I vecchi, solo di analisi, non di età, erano, oltre al padrone di casa, Carloni, Masciangelo e Zambonelli. Completavano il cerchio la Zennaro, la Mori, la Silvia Molinari, Spadoni e Zucchini.
In realtà non vi erano fasce gerarchiche; era veramente un gruppo democratico, di affratellati, dove quelli più esperti e sapienti ti trattavano pur sempre e inaspettatamente alla pari.
Una pacchia, per la comodità di apprendere senza fatica, per l’incremento dell’autostima e i vantaggi all’identità professionale, per il piacere di sentirsi già grandi senza esserlo ancora, forti della presenza di chi, in trasferta, avrebbe affrontato egregiamente il confronto societario senza esporci a brutte figure, lasciandoci in panchina. Una condizione, per gli allievi, invidiabilissima ma non riproducibile in mancanza di Egon Molinari, di Glauco Carloni e della Signora Tullia, la gentile e generosa padrona di casa.
Fu in una di queste piacevolissime serate che Carloni venne a parlare, per la prima volta, di stile materno e degli attributi necessari allo psicoanalista per ben operare; questi, a suo parere, avevano tutti più a che fare col temperamento materno che con quello paterno. Egon Molinari era in linea di massima d’accordo e, tuttavia, propose una soluzione personale, di compromesso, dicendo che l’analista doveva essere un madro, una figura che riunisse in sé le migliori qualità della madre e del padre insieme. Forse pensava alla coesistenza non confusa di due stili terapeutici famosi, le fondamenta vere della nostra tecnica, quello di Freud e quello di Ferenczi, la compostezza egoica dell’uno, con il calore empatico dell’altro, l’ocnofilia tipica dell’allievo più illustre e il filobatismo del Maestro (http://it.wikipedia.org/wiki/Michael_Balint )
Ma, a dire il vero, in quei seminari domestici si respirava la presenza materna fin dall’inizio della serata, quando compariva la padrona di casa con in mano una torta calda di forno e delicatamente profumata. Egon svolgeva la sua parte complementare offrendoci un saporito bicchiere di Porto o, per i viziati, di grappa.
Il madro nacque in questo clima speciale, o meglio, lo avevamo avuto alle spalle durante l’analisi e ora l’avevamo di fronte: lo riscoprivamo in tutte le sue umanissime sfaccettature e ne godevamo a pieno l’amicizia, la generosità, l’attitudine a soccorrere, senza darlo a vedere.
Finalmente era possibile oggettivarlo, mentre prima eravamo stati a lungo un tutt’uno con lui, in una beata mescolanza, avvolti nella nube del fumo delle nostre sigarette e del suo sigaro. Mentre per il bimbo le prime esperienze di separatezza sono fonte di angoscia, per noi furono di giubilo.
Solo chi lo ha frequentato ha potuto godere a pieno delle sue eccezionali doti affettive, della sua peculiare concavità, che ha garantito una specialissima accoglienza, fatta di vicinanza, di delicata premura e di assoluta discrezione.
L’aria severa di Trieste la si poteva cogliere nella sua insofferenza agli elogi; gli unici complimenti che, pure a stento, lasciava passare con un sorriso erano quelli relativi alla straordinaria bravura dei figli.
Molinari, finché è vissuto, e per nostra fortuna è campato a lungo, non ha mai disertato le riunioni del Centro Bolognese, le conferenze dei colleghi, sia in sede che all’Università, persino le riunioni amministrative. Seduto in prima fila, nella poltrona centrale, conferiva agli incontri il senso della continuità, della coscienziosità, della familiarità. C’era dunque sempre almeno un madro, per di più disposto a condividere il suo misurato ottimismo, le sue battute spiritose, le sue terapeutiche barzellette.
Voglio infine ricordare un aneddoto. In un break durante un seminario bolognese Musatti, scherzando ma non del tutto, disse all’improvviso: “Bisogna avere il coraggio di ammetterlo!” “Ammettere cosa?” rispose la Nissim, che era a braccetto di Molinari.
“Che siamo delle gran puttane. Come le puttane amiamo a pagamento!”
La Nissim dell’accostamento non ne volle sapere.
Conciliante intervenne Molinari per dire: “Forse ha ragione il Professor, siamo un po’ puttane, ma non siamo frigide!”
(Testimonianza di Alberto Spadoni, scritta il 28.02.2002)

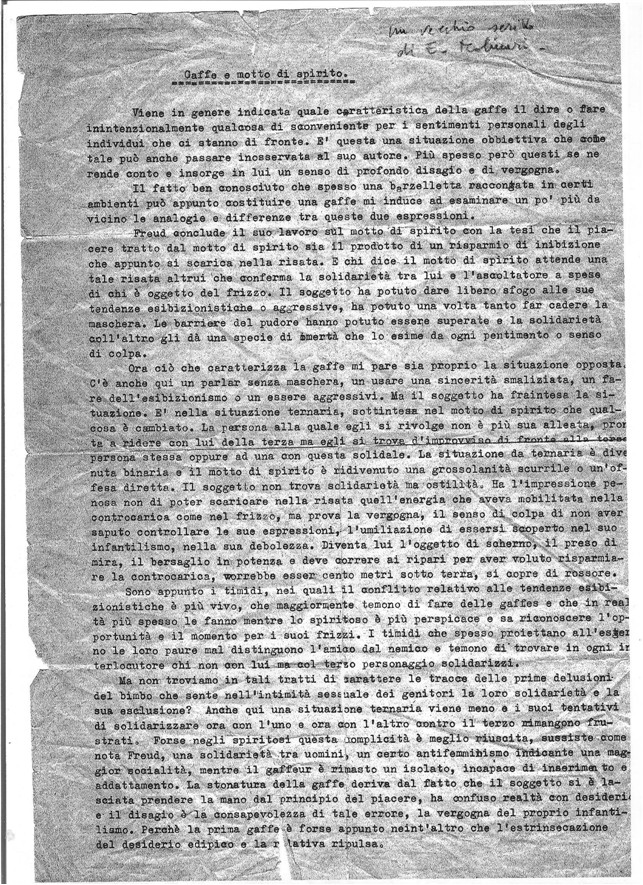
(Fotocopia di un vecchio scritto di Egon Molinari gentilmente concesso dai familiari)
Scritti
1) Molinari E., 1957. “Le Fisime”. L’Economia Umana, fascicolo 3; Recensione della Redazione in Rivista di Psicoanalisi vol.3 anno 1957 pag 232-233.
2) Molinari E., 1955. “Considerazioni sulle situazioni conflittuali in alcuni casi di impotenza psicogena” Rivista di Psicoanalisi vol.2 pag 57-65
3) Molinari E., 1955. “Sentimento di inferiorità e sentimento di colpa” Rivista di Psicoanalisi vol 3 pag 37-42
4) Molinari E., 1957. “Il silenzio in analisi” Rivista di Psicoanalisi vol 1 pag. 19-34
5) Molinari E., 1958. “Meccanismi di difesa e paralogismi” in Rivista di Psicoanalisi vol.1 pag 25-52
6) Molinari E., 1990. “I comandamenti dall’analista”.
7) Molinari E., 2007. “Il sogno: un’area “transizionale” tra il corpo vissuto e il corpo pensato” Rivista di Psicoanalisi vol. 3 pag.657-672
8) Carloni G., Molinari E., 1972. Introduzione e cura di: S. Ferenczi, Fondamenti di psicoanalisi, vol. I, Le parole oscene e altri saggi, Guaraldi, Firenze, pp.7-13.
9)Carloni G., Molinari E., 1973. Introduzione e cura di: S. Ferenczi, Fondamenti di psicoanalisi, vol. III, Psicoanalisi delle abitudini sessuali e altri saggi, Guaraldi, Firenze, pp.11-15.
10) Carloni G., Molinari E., 1975. Cura di: S. Ferenczi, Fondamenti di psicoanalisi, vol. V, Indice analitico, Guaraldi, Firenze
Bibliografia su Egon Molinari
1) Molinari E. “Il silenzio in analisi”. Omaggio a Egon Molinari. A cura di Nicolino Rossi e Irene Ruggiero. Ed. Guaraldi 2011
2) Centro Psicoanalitico di Bologna Il dolore, la memoria, la nostalgia. Per Egon e Glauco A cura di Gino Zucchini. 2002
3) Spadoni A. “Il lettino di Molinari”. In E l’analisi va. Ed. Guaraldi 2007

“Balance and unselfishness, knowledge and wit were and will be the main virtues of Molinari (Gino Zucchini, for the 90’s of Egon Molinari)
Egon Molinari (Trieste 25.06.1911 – Bologna 28.02.2002)
Egon Molinari is an eminent forerunner of italian psychoanalysis, together with Edoardo Weiss, Emilio Servadio, Nicola Perrotti and Cesare Musatti, who has been his teacher.
Operating in the hard 50’s, he was the first psychoanalyst in Bologna, where he started the psychoanalytical practice and culture, the only one between the two rivers, Po and Tevere, until the 70’s.
Refined and discreet academic, with great humanity and skill, together with his friend and colleague Glauco Carloni, he founded the Psychoanalytical Center in Bologna, which was born in the first 70’s from the Wednesday meetings in Molinari’s house.
Reserved and quiet person in the scientific output, he gave the students his great clinic capacity and training becoming their analyst and supervisor.
On his firm couch, important personalities like Glauco Carloni, Giovanni Hautmann, Pier Mario Masciangelo and Stefano Bolognini became analysts.
The life
“We too, the most matured among his scholars – he such reserved, modest, unwishing worldliness – we had to work out the scattered fragments of his long biography: the Jewish roots, the early orphan childhood in Trieste, the law and medical studies, the medical profession in Lussino, Gorizia, Cesena and Faenza, his fighting in the Italian Resistance during the second war, his landing in Bologna.” ( G. Zucchini, “Il dolore, la memoria, la nostalgia” Bologna, 2002)
Egon Molinari’s story starts in Trieste in 1911, where he was born from jewish hungarian parents; he later lived near Vienna, where his grandfather had studied as official doctor, a few years before Sigmund Freud. He became motherless in his childhood and fatherless in his adolescence. So he had to work while he was studing, Law before and then Medicine. He was a doctor in Lussinpiccolo, Gorizia, Cesena and Faenza but the racial laws stopped his work in the public institutions.
Egon Molinari carried on an undeclared experience of terrible misadventures, as he lived in the dangerous italian night, from the Nazi law against the Jewish in 1938 to the Liberation in 1945. He never accepted the role of a discriminated and a victim; for this reason, during those tragic years, he probably appeared to his family and his friends much more as an everlasting doing man than a victim of a persecution as he really was. To escape from Gestapo he left to Rome; he was always lucky, also when he risked to go to Fosse Ardeatine. His gentle wife Tullia, coming from Trieste, always supported him. They knew and immediately loved each other while they were both interested in malaria, when she was a nurse and he was a military doctor in the depressed plain of Manfredonia.
In those difficult years he was always a proud, principled and optimistic man as we can see from the episode of the stolen suitcase. We are in Faenza, in the ’44, where he works as a professionist with a false surname. Two Wermacht soldiers extort him his beautiful leather suitcase. He rushes to the Kommandantur to complain for the theft, in a perfect german language, hot under the collar. He just told us, who were astonished,
that he knew to risk not so much. He regained the stolen goods and was amused as well.
When the war finished, he stayed in Bologna and then went to Milano, where he met Cesare Musatti, who was at first his teacher and then became a friend and a scientific partner.
His work contributed to the development of many psychoanalysts in Emilia- Romagna, in Toscana and in Veneto.
He was the administrator in the SPI Executive Committee from 1951 to 1955.
On 28 february 2002 he died in Bologna.
The contribution to Psychoanalysis
Egon Molinari was able to handle, with the same friendly welcome, both patients and scholars. Insomuch as, when you sat down in his home or you laid down on his couch, you felt so well you don’t want to go away anymore.
His therapeutic method was so soft, as his wise silent; but he was really determined to bring to the end the analytical process.
He considered “The silence in analysis” as his most significant piece of writing, first published on the Italian Psychoanalytical Magazine in 1957 and that then became a little book printed by Guaraldi in 2011. Molinari was very interested in the different shades of silence in the psychoanalytical situation. In that period the analyst was very silent during the session, trying to give sense to the patient’s turnover of words and silence. This paper is still very meaningful, although the psychoanalytical method has changed.
Compared to many important Italian and foreign co-workers, Molinari seems to be lacking of the early narcissism, which very often doesn’t disappear and, quite the contrary, strengthens with the training analysis. I think one of Molinari’s records has been to do analysis, also training ones, with the principle aim to ripen the childish narcisism, also that which strengthens the firm and secret belief to be, under all, unique, deserving, before the end, that universal praise which deletes forever the healthy doubts about the one’s own value.
Consistent with his appeal to narcissism, was his friendship with Bela Grungerger and his decision to invite him in Bologna for the spring seminars in the late 60’s, to learn more about his job. The first relation was about “The analyst’s narcissism “, which Grunberger had presented with Janine Chasseguet-Smirgel in Lisbona in ’56 and which has been hardly argue by all except Molinari, who was delighted by it.
His contribution has been fundamental to spread psychoanalysis in Emilia, Toscana e Veneto and he made grown up the SPI in the north and the center of Italy.
He worked for unity between north and south of Italy, thanks to the geographic location and the special warmth of Bologna. He received and broadcasted all the important thesis in psychoanalysis, coming from all around the world.
We always remember that Molinari and Carloni weaved and resewed bonds, for many years they avoided splits.
The Psychoanalytic Centre in Bologna arose in Egon Molinari’s house, in street Fermi n.°4, in Casalecchio of Reno, during the 60’s and the 70’s. We met every wednesday evening and once a month in the week-end; Musatti and Pier Mario Masciangelo came to talk about Freud’s Opera, Francesco Corrao about Bion and Meltzer, Eugenio Gaddini spoke about the paternal function. Lady Tullia generously feeded all of us.
At first we had not realized that he knew his library to the full, not only the scientific book. He was able to understand and speak German, French, English and Spanish.
During those evenings, while he was filling the glass with Porto, he could correct Fabio Zambonelli in his translation of Bion’s biography.
He usually came first to pay when we were in a restaurant or in a coffee.
Thanks to Molinari and Carloni the Italian psychoanalysts knew Sandor Ferenczi’s theory and method. They saw about the translation, the launch and the printing of this author’s Opera, four volumes pubblished by Guaraldi editor in 1972. By this editor, they also inspired the collection “La sfinge” which made known in Italy many worldwide authors of psychoanalysis.
As a consequence of this interest and scientific exchange, Molinari inspired his psychoanalytical theory and practice to the Sandor Ferenczi’s “maternal style” . From the beginning Molinari passed on his relationship’s wise style, so warm and exciting, to the group in Bologna; he gave an example in building an everlasting psychoanalytical training and research center, without paternalistic control and fraternal conflicts.
We don’t go too far if we think that, while SPI was impetuously growing, the group in Bologna, driven by Molinari and Carloni, has been, for the colleagues in Milano and Roma, a useful example to show how it makes suitable to work in a situation of cultural opening and respect for the differences, getting many benefits. (see the following Il Madro)
The Madro, a suitable model for the training psychoanalysts
In the last 60’s we were use to meet at Egon Molinari’s house, in Fermi Street n° 4 in Casalecchio di Reno. We happily read and talked of psychoanalysis, in the same flat where we have just finished our analysis.
The sitting room receiving us was a part of Molinari’s stomach, that wider, friendly, more suitable to the group relations, where the nourishment was not only symbolic but real.
The translation and printing of Sandor Ferenczi’s opera was getting on and we could smell something that we would realize only later, being the last to arrive. The olders, not for age but for analysis, were, in addition to the master of the house, Carloni, Masciangelo and Zambonelli. The circle was completed by Zennaro, Mori, Silvia Molinari, Spadoni and Zucchini.
Without a power elite, it was truly a democratic group, a brotherhood situation, where those more expert and skilful made the others feel as peers.
It was a godsend for the convenience of learning without effort, to increase self-confidence and to sharp the professional identity; we enjoyed to feel grownup without being yet, we were protected by who, abroad, would have faced pretty well the corporate debate and let us staying on the bench.
This enviable state for us, scholars, was realized by Egon Molinari, Glauco Carloni and Lady Tullia, the kind and benevolent house owner.
During one of these very pleasing evening, Carloni came and talked, for the first time, about “maternal style” and what he thought was necessary for the good job of a psychoanalyst: more concerned with maternal disposition than with paternal one.
Egon Molinari was in agreement but submitted a personal compromise: the psychoanalyst should be a madro, a role which gathers the best qualities of mother and father.
He probably thought to keep together, not confused, two famous styles of therapy, the real ground of our technique, from Freud and Ferenczi, the ego grace of the first and the empathic heat of the second, the typical ocnophilia of the most famous scholar and the philobatism of the Master.
Telling the truth, from the early evening, in those domestic seminars we breathed the maternal presence, when the house owner appeared with a smelling cake, just taken out from the oven. Egon did his part giving us a tasty glass of Porto or, for who was pampered, of Grappa.
The Madro came into the world in that special mood, we have had him backward during the analysis and now we saw him in front of us: we discovered all his human sides, we fully enjoyed his friendship, generosity, his capacity to help without being seen.
We could finally objectify him, while before we have been cohesive with him, happily blended, wrapped in the smoke’s cloud of our cigarettes and of his cigar. The child is usually anguished by the first detachments, we were rejoicing.
Who spent time with him, could enjoy his emotional talents, his particolar being concave, his peculiar welcome, made of proximity, mild care and unlimited reserve.
Born in Trieste, uncompromising town, he didn’t put up with praises. He only accepted with a smile the approbations of his children’s special skills.
Molinari fortunately lived a long time and he always attended the meetings in the Psychoanalytic Center in Bologna, the coworkers’ lectures at the university, the administrative meetings. He was sitting in the middle of the first row, giving a feeling of continuity, diligence and intimacy. He was always our Madro, who shared his careful optimism, his humor, his therapeutic jokes.
Finally I want to remember a story. We were in a pause of a seminar in Bologna, Musatti, joking but not definitely, suddenly said: “We must have the nerve to face up to it!” “What?” Nissim asked, arm in arm with Molinari. “We are big whores, as we love with fee!” Nissim didn’t agreed with him. Molinari, tried to placate and said: “Perhaps the Professor is right, we are a bit whores but we aren’t frigid!”
(written by Alberto Spadoni on 28.02.2002)
Morra Mauro

Mauro Morra
A cura di Renata Rizzitelli e Milvia Morra
Maestri della psicoanalisi
Breve biografia professionale
Mauro Morra nasce il 2 luglio 1922 a Genova. Si trasferisce a Milano con la famiglia a soli 12 anni, dove frequenta regolarmente le scuole dell’obbligo ed il liceo per poi iscriversi alla facoltà di medicina. Dopo aver interrotto gli studi per la lotta nella resistenza, si laurea in Medicina. Sceglie di lavorare in ambito psichiatrico, in particolar modo nell’Ospedale Psichiatrico di Mombello e presso la clinica privata Ville Turro dove conosce il dottor Franco Fornari, anch’egli non ancora psicanalista; insieme iniziano la propria formazione psicoanalitica. Possiamo collegare questo incontro con Franco Fornari con il passo decisivo che avvicinerà definitivamente Mauro Morra alla psicoanalisi.
La prima analisi didattica nella carriera ricchissima del dottor Morra avviene con Cesare Musatti. Diviene analista verso la fine degli anni ’50 e nel 1967 è analista didatta.
Nel frattempo egli vive un’esperienza di lavoro a Ginevra, presso il Centro Psicosociale: proprio a Ginevra intraprende e porta a termine la seconda analisi didattica con De Saussure, psicoanalista, figlio del celebre linguista.
Sempre in Svizzera, il dottor Morra approfondisce, studia ed apprende la teoria e la tecnica dello psicodramma di Moreno, ma non intraprende ancora nessun cammino di formazione nell’ambito della psicoanalisi infantile; rammentiamo che tale pratica non esisteva ancora, in modo specifico, né in Italia né in Svizzera.
Rientrato in Italia da didatta, Mauro Morra incomincia ad occuparsi di psicoanalisi infantile, facendo una supervisione con l’analista argentina -di formazione kleiniana- Marcelle Spira.
Da questo momento egli si accosta per la prima volta a questa branca della psicoanalisi, guardando con interesse crescente tale approccio, specialmente per quanto riguarda la psicologia e le psicosi infantili. Il dottor Morra considerava il trattamento di casi infantili simile a quello con gli adulti, perché anche nell’adulto è possibile -secondo l’approccio kleiniano- ravvisare il bambino, con tutte le sue angosce primitive.
A tutto ciò si aggiungano la vice-presidenza e l’incarico di tesoriere presso l’Istituto di Psicoanalisi.
Proprio qui si colloca la decisione di seguire una terza formazione didattica, questa volta di tipo kleiniano. Mauro intraprende un’altra analisi personale con Hanna Segal a Londra e ciò comporta il trasferimento di tutta la famiglia. Siamo nell’anno 1973: la famiglia Morra rimarrà in Inghilterra fino al 1987.
L’interesse per la psicoanalisi infantile è pienamente condiviso con la moglie Milvia, che proprio a Londra inizia la propria formazione di psicoterapeuta di bambini presso il Centro Tavistock.
Nel suo periodo londinese, oltre a svolgere l’attività privata di psicoanalista, il dottor Morra lavora in ospedali psichiatrici come il Saint Bernard e in ospedali generali, tra cui Hammersmith ed Edgware, occupandosi di pazienti psichiatrici singoli e in gruppo, sviluppando qui l’applicazione di un lavoro psicoanalitico con pazienti in gruppo.
Alla fine degli anni ’70, Mauro Morra sceglie di seguire un seminario di formazione per l’osservazione del neonato a cura di (e condotto da) Esther Bick. Un’ulteriore esperienza formativa deriva dai contatti con il Tavistock, dove il dottor Morra allarga la propria conoscenza sulle dinamiche di gruppo, conducendo gruppi formati da medici secondo il “metodo Balint”.
La sua formazione specifica nel campo della psicoanalisi infantile avviene presso l’Istituto di Psicoanalisi di Londra, con la supervisione di tre analisti per bambini: Elizabeth Spillius, Irma Pick e Betty Joseph. In questo periodo sceglie di lavorare con i bambini e gli adolescenti presso consultori infantili ed in un centro diurno per bambini autistici nonché in una comunità per adolescenti disadattati.
Prima di rientrare in Italia, gli viene richiesta una consulenza da un gruppo di giovani psicoterapeuti di Genova, presso il “Centro di Psicoterapia psicoanalitica infantile”, per la formazione sul lavoro con bambini e adolescenti (1982). Tenendo inizialmente un seminario per questo gruppo di “Work discussion”, egli fa quindi la spola tra Londra e Genova.
Dopo breve tempo, inizia con parte di questo gruppo e con altri professionisti interessati un Corso di Osservazione del neonato “modello Tavistock”, con la collaborazione di altri psicoanalisti di formazione londinese, tra cui Giovanna Pasquali e Selina Marsoni.
Nel 1984 prendono l’avvio anche le consulenze con l’Ospedale Gaslini.
Il ritorno definitivo a Genova avviene nel 1987. Come lui stesso diceva, questo trasferimento in Liguria rappresentava una sorta di ritorno al suo passato, alle sue origini.
Al rientro nella “patria natale”, il dottor Morra continua (ed anzi intensifica) tutte le attività di formazione apprese a Londra (la formazione di lavoro dei giovani terapeuti, il corso di Osservazione del neonato e le consulenze con il Gaslini), facendo inoltre formazione con un gruppo di psicoterapeuti interessati solo alla psicoterapia psicoanalitica degli adolescenti.
Nel 1990, gran parte del suo tempo è dedicata al progetto per un centro diurno (di cui aveva un ricordo positivo relativamente all’esperienza inglese) di Quarto, per la cura dei bambini autistici; tale progetto, tuttavia, non andrà mai definitivamente in porto, con grande rammarico dello stesso Morra.
Ricordiamo inoltre l’attività di insegnamento nel master di Osservazione Psicoanalitica del Tavistock, in collaborazione con l’A.I.P.P.I. di Milano e l’Università East London; il dottor Morra teneva specificatamente i corsi di “Psicoanalisi teorica” e “Osservazione del neonato”.
Ovviamente, a tutto ciò si aggiunge l’attività clinica personale e di didatta della S.P.I. nel suo studio privato di Genova-Nervi. Nella seconda metà degli anni ’90 (novembre 1988) Mauro Morra fonda il Centro di Psicoanalisi di Genova insieme ad altri psicoanalisti.
Per quanto riguarda le pubblicazioni relative al tema infanzia ed adolescenza, ricordiamo:
L’analisi di un adolescente sull’ International Journal of Psycho Analysis;
L’analisi di un bambino autistico sul Journal of Child Psycho therapy;
Lo studio di un caso di psicosi infantile sulla Rivista di psicoanalisi;
Collezioni di libri, tra cui, ad esempio: A stranger in my own body – atipical gender identity developement and mental health, edito da Karnak Books con il contributo di Domenico di Ceglie e David Freeman, che ha come tematica principe l’adolescenza.
Ripensando a Mauro Morra, che con grande generosità ha contribuito alla formazione di moltissimi allievi appartenenti sia alla S.P.I che al Tavistock ed alle scuole di psicoterapia infantile secondo il modello Tavistock, quali l’A.I.P.P.I, gli aggettivi che immediatamente lo definiscono meglio sono: semplicità, generosità, empatia, rigore, vitalità e bontà.
La semplicità e l’immediatezza che contraddistinguevano Mauro derivavano, oltre che dalle sue caratteristiche di personalità, anche da una formazione profonda e da un rigore professionale, etico ed umano di rara qualità che gli consentivano, caratteristiche di pochi, di essere schietto, diretto, chiaro. Durante le supervisioni era capace di trasmettere le più profonde verità ed i punti critici dell’allievo in modo assolutamente comprensibile e senza mai cadere nella retorica o, peggio, nel giudizio, rendendo il percorso di apprendimento una vera e propria esperienza interpersonale con un maestro di grandi capacità; l’esperienza era molto agevole, perché ciò avveniva in un clima di collaborazione amichevole. Le forti capacità empatiche ed affettive di questo maestro gli consentivano di calarsi immediatamente nelle situazioni che gli venivano portate, sia come psicoanalista che come supervisore.
Il suo modo di essere ha consentito a molti di noi di seguire le sue orme perché ciò che trasmetteva, pur non indietreggiando mai nel comunicare difficoltà e difetti, era la fiducia nella possibilità di realizzarsi professionalmente come analisti; è doveroso sottolineare anche come egli, con il suo rigore e la sua passione, indicasse strade di realizzazione professionale nel campo psicoanalitico che prevedevano una formazione seria ed approfondita all’interno di scuole altrettanto affidabili.
Mauro Morra era una persona completa e con grandi passioni: la musica, la passione civile, la vita all’aperto (in particolare passava ore sul mare) oltreché, naturalmente, il suo lavoro che esercitava con grande competenza a tutto tondo perché lavorava con persone di tutte le età.
Maggio 2014
Musatti Cesare

Cesare Musatti
A cura di Sergio Anastasia
Maestri della psicoanalisi italiana
Musatti, Cesare Luigi,
Mira di Dolo (Ve), 21 settembre 1897 – Milano 21 marzo 1989.
“Abbiamo dunque un teatrino interno.e se
riusciamo a superare il preconcetto di una
persistente unità dell’Io e a vedere
effettivamente tutto quello che avviene in noi
stessi, siamo, e restiamo perpetuamente a
teatro”
Musatti, Il pensiero dialogato, 1988
Cesare Musatti è considerato il Padre della Psicoanalisi Italiana.
Intellettuale, ricercatore, è tra i fondatori della Società Psicoanalitica Italiana, di cui più volte ne ha ricoperto la carica di Presidente (negli anni 51-55 e 59-63).
Ha pubblicato numerosi scritti sulla Rivista di Psicoanalisi, fondata nel 1932 da Edoardo Weiss, e ne è stato Direttore tra il 1955 ed il 1971, dopo che ne ha contribuito alla rinascita post-bellica.
Professore di Psicologia all’Università di Padova, dove ha preso il posto di Vittorio Benussi, suo maestro, nel 1927, venne costretto dieci anni dopo ad abbandonare la cattedra a causa delle leggi razziali.
Nel ’47 divenne titolare della prima cattedra di psicologia post-fascista presso l’Università di Milano e nel ‘67 Direttore della Scuola di specializzazione in psicologia presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia e Lettere e Filosofia di Milano
Uno dei maggiori lasciti psicoanalitici di Musatti è la traduzione italiana delle Opere di Freud (O.S.F., Bollati Boringhieri, 12 vol.). La più completa ed approfondita traduzione delle Opere tra quelle che si possono trovare in giro per il mondo, ricca di contributi personali e dotata persino di un indice analitico.
Nel 1963 è tra i co-fondatori del Centro Milanese di Psicoanalisi (CMP), che nel 1989, anno della sua scomparsa, verrà a lui intitolato, divenendo “Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti”.
Musatti è autore di numerosi scritti letterari che hanno contribuito alla divulgazione del pensiero psicoanalitico e la diffusione in ambiti differenti, come il cinema, la ricerca o la psicopatologia della vita quotidiana. È stato Presidente della Casa della Cultura di Milano.
In ambito giuridico, si è distinto per un’intensa opera scientifica e per aver ricoperto la carica di Membro aggiunto della sezione minorile della corte di appello di Milano.
Musatti si è sempre dedicato ad un attivo e costante impegno politico, candidandosi a deputato e ricoprendo più volte il ruolo di consigliere comunale a Milano.
La vita
La vita di Cesare Musatti è raccolta in alcuni saggi ricchi di aneddoti scritti da suoi amici e colleghi, dove viene descritto da tutti come un vero e proprio maestro. Una persona unica, capace di coniugare ironia e saggezza, curiosità verso nuovi approcci e nuove teorie, ma al contempo rigore verso i fondamenti originari della disciplina freudiana.
Celebre è la massima: “Non si può andare oltre Freud senza esserci passati attraverso”.

Un’operazione che ha attraversato l’intera vita professionale di Musatti e che lo ha visto coinvolto negli anni dal 1966 al 1980, nel completamento dell’opera di traduzione e pubblicazione. Un vero e proprio dono che generazioni di psicoanalisti, ricercatori, studenti, appassionati e curiosi hanno potuto apprezzare, non solo per la chiarezza del linguaggio e l’accuratezza delle traduzioni, ma soprattutto per i contributi originali, contenuti nelle presentazioni, nelle avvertenze e nelle note. Materiale che è stato poi raccolto e pubblicato nell’anno della sua morte (1989), nel volume “Leggere Freud” che costituisce un ottimo e fruibile manuale di introduzione al pensiero freudiano.
Fig.1 La Copertina delle Opere curata da C. Musatti per la Bollati Boringhieri.
Musatti nasce da una famiglia di origine ebrea. Fattore che ne condizionerà l’esistenza, durante il ventennio fascista e che contribuirà a forgiarlo come persona dotata di grande sensibilità, capacità di ascolto, desiderio di comunicare e partecipare attivamente alla vita intellettuale e politica del suo paese.

Figlio di un deputato socialista, Musatti mostra, sin dalle prime esperienze di insegnamento in un liceo padovano, un evidente orientamento antifascista. Questo, assieme all’interesse e la passione verso la psicoanalisi – che a quell’epoca, era considerata una scienza pericolosa, in quanto dissacrante e di derivazione ebraica (“Judenwissenschaft”) – procurarono a Musatti parecchie noie e problemi di sorta, non ultimo l’allontanamento dall’insegnamento accademico, qualche anno dopo avere ottenuta la cattedra di Psicologia presso l’Università di Padova nel 1927, alla morte del suo maestro Benussi.
Fig.2 Musatti ai tempi dell’insegnamento accademico, presso l’Istituto di Psicologia di Padova.
La morte di Benussi, costituisce un momento assai importante nella vita di Musatti: egli era non solo il proprio superiore all’Università, ma era anche l’analista con cui aveva condotto la propria analisi. Questo costituì inizialmente un elemento di valutazione negativa sull’opinione del Musatti psicoanalista, al momento della fondazione della costituenda Società Psicoanalitica Italiana (SPI), che veniva istituendosi alla fine degli anni ’20. Il dibattito che ne seguì, sulla possibilità che Musatti potesse o meno accedere come membro fondatore della SPI, interessò personalmente lo stesso Freud, il quale si espresse a favore dell’accesso di Musatti alla Società, anche in virtù dell’impegno profuso nell’insegnamento della psicoanalisi nelle Università.
Insegnamento che fu infatti condotto per decenni, nonostante il clima di vero e proprio oscurantismo.
Musatti si è distinto nel suo lavoro di psicoanalista, per l’estremo rigore e per la primaria attenzione rivolta alla propria auto-analisi, muovendo dalle parole del maestro Freud, pronunciate a Norimberga nel 1910, in occasione del secondo Congresso Internazione di Psicoanalisi. In questa occasione, Freud declamò l’importanza fondamentale che l’analista svolga continuamente su di sè un’approfondita autonalisi e che questa lo accompagni per tutta la vita professionale. Solo attraverso la comprensione di sé stessi, è possibile comprendere e quindi trattare le persone sofferenti. Musatti fece proprie queste parole, andando oltre e contribuendo ad evidenziare una delle caratteristiche fondanti dell’esperienza analitica: essa è inevitabilmente influenzata dalle caratteristiche personali ed affettive dell’analista, il quale è direttamente coinvolto con i propri “complessi”, conflitti, affetti, emozioni, sentimenti ed esperienze di vita. La psicoanalisi non può dunque scindersi dalla vita, non solo del paziente, ma anche dell’analista, il quale è chiamato ad un lavoro profondo di introspezione e di conoscenza di sé e del mondo, tale che gli permetta di lavorare comprendendo a fondo i fenomeni psichici dei pazienti, ma soprattutto distinguendo tra quelli che sono i conflitti, i desideri ed i bisogni dell’analista, da quelli che sono propri del paziente. Un atteggiamento che richiede introspezione, ascolto, estrema cautela, pazienza, rigore ed astinenza.
Questi aspetti entreranno a far parte stabilmente della professione analitica, andando a costituire il fondamento di quello che sarà poi definito l’assetto analitico, che frequentemente è stato confuso ed appiattito su di un’immagine dell’analista cupo, severo e riverso silenziosamente su di sé.

Musatti ha saputo opporre a queste immagini, pur incarnando con estrema disciplina l’ascolto rispettoso richiesto dal lavoro dell’analisi, quelle di una persona carica di ironia, senso di responsabilità istituzionale e grandi doti comunicative in pubblico, che soprattutto negli ultimi anni della sua vita, lo hanno condotto a manifestare il suo pensiero attraverso scritti ed interviste sui media, compresa la televisione.
Fig.3 Musatti (a sinistra), assieme ad A. Moravia (a destra), in un’intervista televisiva di introduzione al film di Pasolini (di spalle): Comizi d’amore (1963).
Una delle caratteristiche dell’uomo e psicoanalista Musatti è stata la capacità di incontrare gli altri, intesi come pazienti, colleghi, culture ed approcci.
Attraverso la curiosità e la dedizione, egli ha potuto fare fronte ai traumi dell’antisemitismo e della morte (le prime due mogli di Musatti sono morte ancora giovani), traendo da questi nuova forza ed un rinnovato interesse verso la vita.
 Vita che egli ha condotto studiando, scrivendo, ma soprattutto impegnandosi attivamente nella vita Istituzionale della Società Psicoanalitica: è stato più volte Presidente della SPI e del Centro Milanese di Psicoanalisi (CMP); ha ricoperto inoltre il ruolo di Direttore della rivista ed ha pubblicato numerosi scritti, tra i quali, su tutti spicca il “Trattato di Psicoanalisi” del 1949, un vero e proprio manuale su cui si sono formati generazioni di psicoanalisti e studenti e che tuttora resta uno dei capisaldi della formazione psicoanalitica.
Vita che egli ha condotto studiando, scrivendo, ma soprattutto impegnandosi attivamente nella vita Istituzionale della Società Psicoanalitica: è stato più volte Presidente della SPI e del Centro Milanese di Psicoanalisi (CMP); ha ricoperto inoltre il ruolo di Direttore della rivista ed ha pubblicato numerosi scritti, tra i quali, su tutti spicca il “Trattato di Psicoanalisi” del 1949, un vero e proprio manuale su cui si sono formati generazioni di psicoanalisti e studenti e che tuttora resta uno dei capisaldi della formazione psicoanalitica.
Fig.4 Il trattato di Psicoanalisi, 1949.
Ma l’impegno dell’uomo Musatti si caratterizza per il grande contributo negli ambiti della ricerca, della psicologia giuridica e della politica. Attività cui egli si è dedicato per l’intera vita.
Come ricercatore ed epistemologo, Musatti, attraversando gli studi sulla percezione, mutuati dall’esperienza della teoria della Gestalt (Gestalttheorie), e con cui entra in contatto attraverso l’esperienza presso l’Istituto di Psicologia diretto da Benussi, giunge a teorizzare l’arbitrarietà del concetto metrico, fondato su di una convenzione postulata e non empiricamente verificabile. Ciò che contraddistingue l’uomo dalla scienza è esclusivamente il concetto di enumerazione, che rende la seconda quantificabile. Su base di tali concetti, la psicoanalisi assurge a rango elettivo di scienza. Se l’essenza epistemica della psicoanalisi è appunto quella di essere scienza dell’individuo, del soggetto unico ed irripetibile – che, attraverso la conoscenza di sé, può essere liberato da costrizioni imposte da una sofferenza che ne inibisce lo sviluppo e la crescita – e se ogni misura metrica che caratterizza la scienza è a tutti gli effetti il corrispondente di una misura psichica, appare evidente come la psicoanalisi diviene la scienza con la “S” maiuscola: solo attraverso la propria indagine, il soggetto osservante – l’analista e l’analizzato assieme – possono giungere alla scoperta del fondamento unico ed irripetibile della misura metrica soggettiva del paziente e quindi, conseguentemente, della realtà. Un’esperienza, cui nessuna altra scienza può ambire.
Dobbiamo al Musatti psicologo giuridico una moltitudine di concetti che caratterizzano tuttora la psicologia forense e della devianza. A lui si ascrivono teorizzazioni rivoluzionarie e ancora attuali, come ad esempio la sindrome di Stoccolma o più semplicemente la tendenza ad agire nelle relazioni, l’esperienza traumatica vissuta antecedentemente. Nella prospettiva musattiana, la condotta deviante viene sottratta al pensiero comune, secondo il quale questa corrisponderebbe ad un mero atto di egoismo ed etero-aggressività, per divienire espressione, al contrario, di un agito auto-aggressivo rivolto ad un Super-Io troppo severo, venutosi a formare a partire da esperienze traumatiche e di violenza subita. Persino nell’omicida, si possono individuare quelli che sono i presupposti di un funzionamento anticonservativo: egli diviene vittima di scariche di aggressività determinate da un deficit delle barriere psichiche deputate a salvaguardare la propria vita e quella degli altri, da possibili danni o pericoli. Cosa che è ampiamente verificabile, a partire dall’analisi di esperienze traumatiche di incidenti più o meno gravi, correlati il più delle volte a deficit attentivi, ma spesso nei casi più importanti, come ad esempio incidenti sul lavoro, scrive Musatti, a condizioni di vera e propria perdita del contatto con la realtà.
Sempre Musatti è colui che teorizza per la prima volta concetti quali: l’accanimento terapeutico e la verosimiglianza o viceversa distorsione dei processi mnestici delle testimonianze. Egli sottolinea come la ricerca della verità non possa in alcun modo avvenire a partire dalla realtà dei fatti, ma possa essere soltanto un’interpretazione di avvenimenti, così come possono essere solo riferiti da coloro che li hanno osservati o vissuti. Il che comporta quindi delle enormi ricadute sull’attendibilità o meno delle testimonianze nei casi di processo.
Naturalmente questi postulati hanno una valenza importante anche per quanto riguarda il lavoro psicoanalitico; però, prima di addentrarci più in dettaglio nell’opera di Musatti psicoanalista (si veda il punto successivo), ci soffermiamo per un istante sul Musatti politico. Egli, come detto, durante i primi anni della sua vita, visse l’impegno politico, essenzialmente come una naturale reazione al regime fascista opprimente ed oscurantista. A partire dal ’38 e dal suo trasferimento a Milano, Musatti si dedicherà più attivamente alla formazione di sindacalisti, di giovani partigiani che a causa del conflitto avevano dovuto interrompere il proprio percorso formativo, accademico o professionale.
Questo in un’ottica di partecipazione e condivisione nell’opera di ricostruzione economica, sociale, morale e politica del paese.

Fu quindi attivo esponente del partito Socialista, ricoprendo la carica di Consigliere Comunale a Palazzo Marino a Milano e tentando in alcune circostanze di candidarsi come deputato. Completano la sua intensa attività culturale decine di scritti, interviste, eventi culturali promossi, anche in qualità di Presidente della Casa della Cultura di Milano, un luogo elettivo di scambio e partecipazione alla vita culturale della città, del paese e del panorama internazionale.
Fig.5 Musatti abbraccia l’amico e compagno di partito: il Presidente della Repubblica Sandro Pertini.
Musatti muore il 21 marzo 1989. Alla sua morte, viene a lui intitolato il Centro Milanese di Psicoanalisi, che diviene “Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti”, da poco trasferitosi da Via Corridoni, 1 a Via Corridoni, 38.
Egli non riuscì a vedere il nuovo centro, immaginato e pensato dai colleghi del CMP che videro in questo spazio, dove attualmente risiede, un luogo sufficientemente ampio per ospitare il fiorire dell’interesse culturale e professionale sollevato in quegli anni dalla psicoanalisi ed anche dalla sua figura. Egli, infatti, negli ultimi anni della sua vita aveva concentrato i propri sforzi per la promozione della psicoanalisi nei confronti del vasto pubblico dei media, ma anche per la realizzazione di una formazione psicoanalitica, il training e l’attività scientifica del Centro, rigorosa ed improntata su criteri di eccellenza.



Fig.6 Musatti, così come era spesso possibile vederlo durante i dibattiti.
Fig.7 Musatti durante un’intervista televisiva.
Fig.8 Musatti in un’intervista televisiva, durante un viaggio in treno.

Fig.9 Musatti (al centro), Direttore della Scuola di Specialità in Psicologia Clinica di Milano.

Fig.10 Musatti (a sinistra), alla Casa della Cultura di Milano.
Il contributo alla psicoanalisi
Qualsiasi tentativo di sintetizzare qual è stato il contributo di Musatti alla psicoanalisi non può che essere riduttivo. Lo sviluppo stesso del movimento psicoanalitico in Italia è legato in maniera indissolubile al coraggio, tenacia, rigore ed impegno costante che egli ha profuso nel’insegnamento, nella traduzione dell’opera freudiana, nella divulgazione semplice, ma puntuale, dei concetti psicoanalitici che potevano arrivare così alla comunità scientifica, come al vasto pubblico. Musatti non amava parlare dei suoi pazienti, perché ne rispettava la riservatezza e la profondità dei sentimenti e delle sofferenze. Il suo materiale clinico è dunque scarno, ma parlano comunque per lui le generazioni di psicoanalisti formatisi attraverso supervisioni ed analisi condotte direttamente da lui e con lui, in uno spirito di partecipazione, scambio e confronto anche internazionale che hanno sempre contraddistinto il suo insegnamento.

La vita stessa del Centro Milanese di Psicoanalisi, coincide con la vita di Musatti, a partire dagli anni dalla fondazione – era il 1963 – sino alla sua morte, nel 1989.
Durante quegli anni, Musatti era Presidente dela Società Psicoanalitica Italiana, e in quella veste partecipò con Sigurtà, Ciprandi e Veltri alla fondazione dell’ “Associazione Centro Milanese di Psicoanalisi”. La sede fu individuata in Via Corridoni, 1 a Milano e da allora divenne la sede dei tradizionali circoli del giovedi, mutuati dall’esperienza viennese dei mercoledi scientifici condotti da Freud, e sino ad allora tenuti nelle stanze degli appartamenti dello stesso Musatti.
Fig.11 Musatti, in una foto dell’epoca.
Costituiscono gli insegnamenti più rilevanti della lezione musattiana: l’importanza dell’autoanalisi condotta dall’analista, mai del tutto compiuta, e della capacità di immedesimarsi continuamente nella vita dei suoi pazienti e nelle loro vicende, pur distinguendo tra i bisogni, i complessi ed i desideri dell’uno e dell’altro; il lavoro di accompagnamento del paziente all’acquisizione anch’egli di una propria capacità di disvelarsi, quale persona unica e mai definitivamente compiuta; il ruolo fondamentale della lezione freudiana e dell’analisi didattica, accanto alle supervisioni di analisti esperti, come percorso formativo rigoroso ed ispirato a criteri di eccellenza, dei futuri analisti; l’interpretazione dei sogni, come via regia per la comprensione dell’inconscio; la sfida della complessità, sino ai limiti dell’analizzabilità in quei campi, quali la psicosi, la dipendenza, le Istituzioni totali, la devianza, la massa, in cui la psicoanalisi è chiamata ad intervenire, quale scienza che deve sempre aspirare alla verità.
Enorme è il lascito di scritti, nei quali è possibile “incontrare non solo la psicoanalisi, ma uno psicoanalista” (Ferruta e Monguzzi, 2012).
Di seguito, alcune date o avvenimenti significativi della vita del Musatti psicoanalista, sistemati secondo un ordine cronologico. Tale elenco non vuole naturalmente in alcun modo esaurire tutti i contributi che è possibile trovare nelle biografie e anche nei testi pubblicati postumi.
1927 Diviene Professore di Psicologia all’Università di Padova, dove prende il posto di Vittorio Benussi, suo maestro
1931 Pubblica “Elementi di psicologia della testimonianza”, in cui si marca un punto determinante per il successivo sviluppo della psicoanalisi, ovvero la natura epistemica di questa scienza, come “Scienza della Verità”
1937 Musatti viene allontanato dal regime fascista dalla cattedra di Psicologia di Padova per i suoi insegnamenti psicoanalitici, considerati pericolosi e di chiara matrice giudaica
1938 Musatti si trasferisce a Milano
1946 Contribuisce con Servadio e Perrotti, alla rifondazione della Società Psicoanalitica Italiana, sciolta nel 1938 dal regime fascista
1946 Viene nominato Docente di Psicologia alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano
1947 Viene nominato Docente di Psicologia alla facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Milano
1949 Viene pubblicato per Einaudi, il Trattato di Psicoanalisi, un manuale dove egli raccoglie tutto il materiale utilizzato sino a quegli per l’insegnamento della psicoanalisi nelle Università
1951-1955 ricopre il ruolo Presidente della Società Psicoanalitica Italiana
1955-1971 È nominato Direttore della Rivista di Psicoanalisi
1956-1980 è impegnato nell’opera di traduzione, divulgazione e commento alle Opere di Freud, pubblicate in 12 volumi per la casa editrice Bollati Boringhieri
1960 Pubblica: Psicoanalisi e Vita Contemporanea
1963 Contribuisce attivamente alla fondazione dell’ “Associazione Centro Milanese di Psicoanalisi”, dove troverà sede l’attività scientifica psicoanalitica, fino a quel punto sviluppatassi nelle dimore di Musatti e dei colleghi psicoanalisti
1967 Diviene Direttore della Scuola di specializzazione in psicologia presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia e Lettere e Filosofia di Milano
1971 Pubblica: Libertà e servitù dello spirito. Diario culturale di uno psicoanalista (1945-1971)
1979 Esce il libro: Il pronipote di Giulio Cesare, dove sono contenuti tutti i commenti che in quegli anni Musatti pubblicava su riviste e quotidiani e dove con sapienza veniva mostrata al grande pubblico la potenzialità e la portata dei meccanismi inconsci nei fenomeni sociali, culturali e politici dell’epoca. Il libro, che inaugurerà il filone dei seguenti scritti a carattere prevalentemente divulgatico, vince il Premio Viareggio, un importante riconoscimento letterario.
1982 Pubblica: Mia sorella gemella, la psicoanalisi. Pensieri, confessioni, memorie tra scienza ed avventura. Qui e nei successivi scritti (tra gli altri: 1983, Questa notte ho fatto un sogno; 1984, I girasoli), Musatti prosegue nell’esposizione, attraverso anche il racconto di momenti significativi ed intimi della propria vita, dell’unicità e singolarità che caratterizzano l’esperienza soggettiva dell’uomo-psicoanlista, ma anche dell’uomo-paziente unico ed irripetibile, che attraverso la narrazione, costruisce il proprio percorso irripetibile verso la piena realizzazione di sè.
1988 Viene pubblicato l’ultimo libro: Psicoanalisti e pazienti a teatro, a teatro!, due commedie teatrali ed altri scritti.
1989 È il 21 marzo, quando al telegiornale nazionale viene annunciata con il cordoglio delle alte cariche istituzionali del paese, la morte di Cesare Luigi Musatti, il padre della psicoanalisi italiana.
1989 Quello stesso anno, viene a lui intitolato il Centro di Psicoanalisi di Milano, che diviene C.M.P- Cesare Musatti.
Scritti principali
1926 Analisi del concetto di realtà empirica, Il Solco, Città di Castello
1931 Forma e assimilazione, in: Archivo italiano di psicologia 9, S. 61-156.
1938 Gli elementi della psicologia della forma, Gruppo Universitario Fascista, Padova
1949 Trattato di psicoanalisi, Bollati Boringhieri, Torino
1964 Condizioni dell’esperienza e fondazione della psicologia, Editrice Universitaria, Firenze
1967 Riflessioni sul pensiero psicoanalitico e incursioni nel mondo delle immagini, Bollati Boringhieri, Torino
1979 Il pronipote di Giulio Cesare, Mondadori Milano
1982 Mia sorella gemella la psicoanalisi, Editori Riuniti, Roma
1983 Questa notte ho fatto un sogno, Editori Riuniti, Roma
1987 Chi ha paura del lupo cattivo?, Editori Riuniti, Roma
1988 Psicoanalisti e pazienti a teatro, a teatro!, Mondadori, Milano
Pubblicati postumi:
1989 Leggere Freud, Bollati Boringhieri, Torino
1991 Curar nevrotici con la propria autoanalisi, Mondadori, Milano
2012 Sulla Psicoanalisi, Bollati Boringhieri, Milano
Bibliografia
Chiari P., 2009, Per una storia del Centro Milanese di Psicoanalisi, Seminario tenuto il 15 gennaio presso il Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti.
Giaconia, G., Masciangeli, P.M., 1989, Cesare Musatti (1897–1989. Rivista di Psicoanalisi, 35:455-471
Ferruta, A., Monguzzi, M., a cura di, 2012, Musatti, C.L: Sulla Psicoanalisi, Bollati Boringhieri, Torino
Ramano, D.F., Sigurtà, R., 2000, Cesare Musatti e la psicologia italiana, Franco Angeli, Milano

Cesare Luigi Musatti is considered the Father of the Italian Psychoanalysis.
Intellectual and researcher, first of all. He contributed to the Italian Psychoanalytic Society’s foundation and He was the President between 1951 to 1955 and from 1950 to 1963.
He Published a lot of writings on the Italian Psychoanalytical Journal, which is founded on the 1932, by Edoardo Weiss. Musatti was a Director of this journal from 1955 to 1971, which is closed from the fascista regime and it re-birth thanking his direct intervention.
At the moment of the death of Vittorio Benussi, his maestro, in 1927, Musatti was called to teach as Professor of Psychology in the University of Padova. After ten years, Musatti was forced to leave the academy, for the racial laws of the fascista regime. In 1947, He came back to be a Professor of the first Psychology’s professorship after the war. In 1967, He was appointed Director of the Specialization School of Psychology in the Universities of “Medicine and Surgery” and “Philosophy and Letters” of Milano.
Musatti translated the whole freudian Opera, which is published by Bollati Boringhieri Editor in 1980. This is the most complete and depth version of the world, because He enriched the volumes with his personal tributes, notes, comments and even an analytic index.
In 1963 he co-founded the Milanese Center of Psychoanalysis (MCP), which was entitled to his memory and it became “Centro Milanese di Psicoanalisi (MCP) – Cesare Musatti”, how actually is still called.
Musatti is author of a lot of literary writings, where he contributes to disclosure of the psychoanalytic thought in the different contexts, as the cinema, research, the psychopathology of everyday life.
He was a President of Culture’s House of Milan.
In the legal field, Musatti distinguished by a great scientific work and for the Istitutional commitment as Juvenile Judge in the Appeal’s Court of Milano.
In the political field, he was candidate as deputy, and more times he was elected as in the citizen council of Milan.
Musica e psicoanalisi

Lucy on the piano _ Peanuts
A cura di Ludovica Grassi
La musica ha un ruolo centrale nella strutturazione somato-psichica e nell’intersoggettività primaria, e in particolare nel dispiegarsi dei processi di simbolizzazione e soggettivazione. Essendo fatta dello stesso materiale e delle stesse dinamiche della vita psichica, la musica può essere utilmente impiegata nella clinica e nella ricerca in psicoanalisi, sensibilizzando l’ascolto e la risposta alle forme di sofferenza radicate nelle esperienze originarie.
Freud amava definirsi totalmente privo di sensibilità musicale, giustificando la propria incapacità di apprezzare la musica con una scarsa predisposizione fisiologica e, soprattutto, con la difficoltà a utilizzare per la musica un approccio razionalistico o analitico (Il Mosè di Michelangelo, 1913). Barale e Minazzi (2008) paragonano l’arretrare di Freud di fronte all’ignoto e all’indifferenziato del linguaggio asemantico della musica al ritiro di Breuer di fronte all’irruzione del transfert, ritenendolo dunque un rifiuto ad entrare nella sfera del pre-rappresentazionale (sentimento oceanico) per non minare le basi della giovane scienza psicoanalitica. Eppure la talking cure nasce come metodo di cura basato sulla parola, che è un tipo specifico di produzione sonora e che, come la musica, ha fra i suoi strumenti fondamentali l’ascolto e l’interpretazione.
Lo studio dei fenomeni musicali secondo una prospettiva psicoanalitica cominciò già fra i primi partecipanti alle “riunioni del mercoledì”. Max Graf, musicologo e critico musicale (e padre del piccolo Hans) pubblicò lavori su opere specifiche, quali ad esempio L’olandese volante di Wagner (1911), che Freud fece pubblicare sulla sua rivista di psicoanalisi applicata, oltre a uno studio sulla psicologia del processo compositivo (1947). Nella prima metà del secolo scorso, tuttavia, gli psicoanalisti analizzarono prevalentemente altre espressioni della creatività artistica, con un graduale passaggio dal modello basato sulla regressione dell’Es, che tendeva a correlare creatività e patologia, a concettualizzazioni in linea con la psicologia dell’Io, quindi imperniate su aspetti aconflittuali, adattativi, meno connotati da patologie nevrotiche e psicotiche. Un esempio di questa svolta, per quanto riguarda la musica, è l’articolo di Kohut e Levarie (1950) in cui il rapporto del soggetto con musica è ritenuto basarsi sul lavoro organizzativo e difensivo dell’Io, conscio e inconscio, di fronte a stimoli incomprensibili e traumatizzanti.
Theodor Reik ha avuto il merito di riportare l’attenzione degli psicoanalisti sulla dimensione uditiva, trascurata dalla centralità data dalla psicoanalisi all’immagine visiva nei processi rappresentativi, e sulle forme sonore e musicali, più vicine ai processi inconsci e ai moti affettivi: ascoltare con il terzo orecchio facilita la comunicazione inconscia fra analista e paziente, l’intuizione e la sorpresa.
Particolarmente influente sulle concettualizzazioni della musica è stato il pensiero di Susanne Langer (1951), che ha evidenziato come la struttura della musica sia isomorfa ai movimenti psichici, in grado di suscitare emozioni ma priva di oggetto e contenuto, una forma significante. Analogamente Anzieu (1987) ha definito significante formale una forma preliminare di struttura psichica e ha sottolineato il ruolo fondante di un involucro sonoro che originariamente avvolge la diade madre-bambino costituendo un primo confine fra sé e non-sé.
Molti sono i tipi di approccio che vengono usati per indagare il rapporto fra musica e psicoanalisi, quali ad esempio:
-gli studi biografici dei musicisti in rapporto con il loro stile e le loro modalità compositive, ma anche l’analisi delle composizioni musicali indipendentemente dalla personalità degli autori;
-l’analisi dei libretti d’opera o dei testi di forme musicali cantate, e dei contenuti cui alludono i titoli o le didascalie poste dagli autori stessi alle loro composizioni;
-le teorie su cui si basano le diverse forme di musicoterapia;
-l’uso di concetti musicali per definire elementi o processi psichici;
-le teorie che considerano la musica vettore ottimale di affetti non esprimibili verbalmente o mediante altre arti;
-lo studio degli elementi della musica e del loro ruolo nello sviluppo primario e in particolare nella relazione madre-bambino;
-l’approfondimento degli isomorfismi tra musica e funzionamento psichico.
L’infant research e le neuroscienze hanno sottolineato la funzione essenziale del ritmo e della musicalità nei primi scambi fra neonato e adulto di riferimento. In particolare Panksepp e Trevarthen (2009) individuano nella musicalità umana un sistema motivazionale autonomo e ipotizzano che gli stimoli musicali possano modulare l’espressione di specifici geni del cervello umano dando luogo a trasformazioni epigenetiche permanenti. L’importanza attribuita alla musica nelle relazioni primarie trova sostegno sia nell’ipotesi evoluzionistica di un precursore comune per musica e linguaggio (musilinguaggio cioè un sistema comunicativo, emotivo e referenziale, successivamente sdoppiatosi in due linguaggi con regole e finalità differenziate), sia negli studi di neuroimaging, che hanno evidenziato già nel neonato aree cerebrali specifiche di entrambi gli emisferi capaci di interpretare sequenze strutturate di suoni, soprattutto se con ritmi corrispondenti a quelli dei processi corporei.
Particolarmente interessanti sono gli studi che approfondiscono elementi musicali che hanno un ruolo fondante nei processi psichici, a partire dallo sviluppo del senso dell’udito e del tatto, che precede di gran lunga nella vita fetale l’organizzazione di altri canali sensoriali come la vista, qualificando le prime memorie ed esperienze prenatali come prevalentemente uditive oltre che tattili e propriocettive. La temporalizzazione, cardine dei processi di soggettivazione e simbolizzazione, ha origine non solo dall’andamento, ritmo e pulsazioni delle vibrazioni e poi dei suoni e silenzi percepiti dal feto e quindi dal bambino, ma anche dai suoi primi movimenti corporei che consistono in variazioni di posizione nello spazio e nel tempo. Maiello (1993, 2011) ha sottolineato il ruolo strutturante delle reminiscenze prenatali di suoni e ritmi che restano nella memoria del bambino come oggetto sonoro. In particolare la voce materna, caratterizzata dalla costanza qualitativa e dalla discontinuità nel tempo, avrebbe la funzione di introdurre il principio della differenza già nella vita prenatale. Le prime forme di rappresentazione potrebbero essere dunque di natura sonora, e precedere quelle visive.
La musica in tutte le sue forme è isomorfa alla successione di tensione/rilassamento e attesa/risoluzione che caratterizza la psicosessualità umana ed emerge nei primi scambi preverbali e imitativi tra il bambino e l’ambiente umano. La continuità dell’esistere che non tollera pressioni eccessive o interruzioni è infatti un tempo ritmico, e lo stesso meccanismo dell’après-coup può essere considerato una forma ritmica, costituita di pieni e di vuoti. La ripetizione, quale componente essenziale del ritmo, è un altro operatore di base del funzionamento psichico, già evidente nei giochi infantili presimbolici: la ripetizione e il silenzio (o pausa) producono un vuoto generativo di quella che sarà la rappresentazione dello stimolo assente. Inoltre il processo del lutto, essenziale alla vita psichica e ai suoi processi trasformativi, è parte integrante dell’esperienza musicale, in cui ogni suono distrugge quello precedente, comportando una serie ininterrotta di lutti e un costante lavoro della memoria.
Sul piano clinico, una maggiore attenzione alle componenti musicali e ritmiche nella relazione transfero-controtransferale, unita a una sensibilità specifica, sia nell’ascolto sia nell’interpretazione, agli aspetti infra-verbali della comunicazione, arricchisce il lavoro psicoanalitico con i pazienti, permettendo l’elaborazione di forme e contenuti inconsci ancora non rappresentabili.
Per concludere, va segnalato come numerosi psicoanalisti italiani abbiano dato importanti contributi all’area dell’incontro fra musica e psicoanalisi: per citarne solo alcuni, Antonio Di Benedetto, Alberto Schön, Mauro Mancia, Fausto Petrella e Riccardo Lombardi. Spesso dialogando fra loro, questi autori hanno arricchito la bibliografia esistente con l’analisi di opere e brani musicali, del rapporto fra interpretazione psicoanalitica e musicale, dell’ascolto musicale nella relazione analitica, delle relazioni fra espressione musicale e forme di sofferenza psichica, e tante altre tematiche che meriterebbero di essere approfondite.
Anzieu D. (1987). I significanti formali e l’Io-pelle. In: D. Anzieu et al. Gli involucri psichici. Trad. it., Milano: Dunod (Masson S.p.A.), 1997
Barale F. e Minazzi V. (2008). Off the beaten track: Freud, sound and music. Statement of a problem and some historico-critical notes. Int. J. Psycho-Anal. 89: 937-957
Freud S. (1913). Il Mosè di Michelangelo. O.S.F., 7
Graf M. (1911). Richard Wagner im Fliegenden Holländer. Ein Beitrag zur Psychologie Künstlerischen schaffens. Schriften zur Angewandten Seelenkunde, Vol. 9, 1970. Nandeln, Liechtenstein:Kraus
Grassi L (2015). Ascoltare la relazione. Musica e legami originari. Interazioni, 1-2015/41
Kohut H. and Levarie S. (1950). On the enjoyment of listening to music. Psychoanalytic Quarterly, 19:64-87
Langer S. (1951). Filosofia in una nuova chiave. Roma, Armando, 1972
Maiello S. (1993). L’oggetto sonoro. Un’ipotesi sulle radici prenatali della memoria uditiva. Richard e Piggle, 1/1993
Maiello S. (2011). Dialoghi antelitteram. Note sugli elementi ritmici e sonori del linguaggio e della comunicazione verbale. Richard e Piggle, 19, 3/2011: 246-266
Panksepp J., Trevarthen C. (2009). The neuroscience of emotion in music. In Communicative musicality: exploring the basis of human companionship. Oxford: Oxford University Press
Rose Gilbert J. (2004). Between couch and piano: Psychoanalysis, music, art, and neuroscience. Hove: Brunner-Routledge
Febbraio 2015
Narcisismo

Metamorfosi di Narciso 1937 Salvador Dalí
A cura di Laura Contran
Il termine prende il nome dal celebre personaggio della mitologia greca creato da Ovidio nelle Metamorfosi. Il racconto narra di un giovane di rara bellezza e di straordinaria vanità, figlio del dio Cefiso e della ninfa Liriope, così preso da sé da rifuggire il mondo e l’amore degli altri. Di Narciso si innamora perdutamente la ninfa Eco la quale viene però sdegnosamente respinta e in preda al dolore e alla vergogna per il rifiuto subito vaga per valli e caverne fino a quando il suo corpo si consuma e di lei non resta che la voce. La dea Nemesi, per punire la superbia del giovane, lo condanna ad un amore impossibile: quello per la propria immagine che egli vede, per la prima volta, riflessa nell’acqua di uno stagno. Nel disperato tentativo di raggiungere e congiungersi con questa immagine Narciso annega. Al suo posto nasce un fiore che prenderà il suo nome. La parola narciso deriva dal greco narkè – sopore, stupore – una fissità che, come insegna il racconto di Ovidio, può rivelarsi mortifera.
Il mito e le sue suggestioni, di carattere etico ed estetico, hanno trovato ampia risonanza nell’ambito filosofico, letterario ed artistico. Nel linguaggio comune, la definizione di narcisista ha una connotazione negativa e si riferisce a persone con atteggiamenti eccessivamente egocentrici, poco empatiche e sostanzialmente disinteressate agli altri .
Con la psicoanalisi il narcisismo diventa un concetto centrale in quanto viene individuato come elemento costitutivo e originario della soggettività umana e, da Freud in poi, gli studi psicoanalitici sul narcisismo approfondiranno le sue possibili evoluzioni in senso sano e patologico.
Storicamente una prima lettura del narcisismo viene proposta in ambito psichiatrico dallo psichiatra tedesco H. H. Ellis nel 1892 al fine di descrivere un aspetto patologico della vita sessuale, legato all’autoerotismo, allorché un soggetto tratta il proprio corpo come oggetto sessuale fonte di desiderio e di piacere. Successivamente nel 1899 lo psichiatra H. Näcke lo utilizzerà riferendosi alle perversioni sessuali.
In una prima fase, Freud riprenderà queste tesi in relazione all’omosessualità e all’eziopatogenesi della paranoia. Nel suo studio sull’infanzia di Leonardo da Vinci (1910) descrive il meccanismo per cui l’investimento libidico porta a una scelta omosessuale dovuta alla fissazione dei bisogni erotici della figura materna e attraverso l’identificazione con lei “[…[ il ragazzo mette se stesso al posto della madre, si identifica con lei e prende la sua stessa persona come un modello a somiglianza del quale egli sceglie i nuovi oggetti del suo amore […] Egli trova gli oggetti del suo amore lungo la via del Narcisismo”. Nella psicosi (Il caso Schreber, 1911) il narcisismo diventa la manifestazione patologica del ritiro dell’investimento libidico dagli “oggetti” e quindi dalla realtà esterna; Freud in questo senso concorda con quanto già sostenuto da K. Abraham (1908) a proposito della demenza precoce.
Successivamente (Totem e tabù, 1912) Freud ridefinisce il narcisismo come fase intermedia dell’evoluzione sessuale che si colloca tra l’autoerotismo e l’amore oggettuale, tesi che riprenderà nel 1914 nel saggio Introduzione al narcisismo, il vero punto di svolta della sua teorizzazione che apre ad altre vicissitudini dell’Io quali l’amore di sé, la scelta sessuale, l’idealizzazione, la sublimazione, la pulsione di morte. In questo importante lavoro il narcisismo viene rivisto come una forma d’investimento pulsionale necessario alla vita soggettiva, non più dunque come una condizione psicopatologica ma come un dato “strutturale” all’origine della formazione dell’Io: “[…] un completamento libidico dell’egoismo della pulsione di autoconservazione”. Ma, aggiunge Freud, le pulsioni sessuali che in origine si manifestano in modo caotico e disorganizzato si legano al primo oggetto d’amore – l’Io – che è, innanzi tutto, Io corporeo.
Con la costruzione della seconda topica (Es, Io e Super-Io) Freud distingue due forme di narcisismo: primario e secondario. Il narcisismo primario (deducibile teoricamente solo a posteriori) è così definito in quanto legato a una prima fase dello sviluppo del piccolo dell’uomo che vive in uno stato indifferenziato non essendo ancora in grado di distinguere tra sé e l’altro, tra l’interno e l’esterno (il prototipo è la vita intrauterina). “Il narcisismo primario è una sorte di amore, che, più che di se stesso, può essere definito con se stesso” (Semi, 2000, 30).
Freud inoltre mette in rilievo la posizione dei genitori nella costituzione del narcisismo primario dell’infans (His majesty the baby). Il loro amore nei confronti del figlio “che deve appagare i loro sogni e desideri irrealizzati” è, di fatto, una reviviscenza del loro narcisismo tornato a nuova vita (1914).
Il narcisismo secondario è una situazione psichica più tardiva che comporta l’investimento libidico nei confronti di un oggetto esterno il quale, al tempo stesso, viene vissuto “come il proprio io”.
Il narcisismo secondario nasce dal fallimento del primo, da questa illusione di completezza “[…] ed esprime un tentativo di ricostituire delle condizioni interiori, psichiche, di piacevolezza, di autoconservazione, di sicurezza che quello illusoriamente garantiva (Semi, ibid, 62).
Tale passaggio costituisce il momento inaugurale del riconoscimento dell’alterità: un intervento esterno che soccorre e aiuta l’infans nella sua impotenza fisiologica (Hilflosigkeit).
Evoluzioni post freudiane del concetto di narcisismo
Sull’esistenza di un narcisismo primario e secondario, le posizioni degli analisti post freudiani si sono nel tempo differenziate spesso divergendo tra loro. Al contrario di Freud, il quale ipotizzava l’esistenza di uno stadio anteriore alle relazioni oggettuali in cui la libido rimane “in vacuo” fissata al corpo del lattante, Melanie Klein giunge a sostenere, attraverso la sua esperienza clinica di analista infantile, che sin dalla nascita esiste nell’infans la percezione dell’oggetto, anche se parziale (il seno materno). Inoltre, mentre per Freud l’oggetto è soprattutto la meta della pulsione, per la Klein l’oggetto è anche la meta delle emozioni, delle fantasie e delle difese del lattante. In questo senso Klein e gli autori successivi riprendono e sviluppano ulteriormente la correlazione già posta d Freud tra narcisismo e “onnipotenza del pensiero” in rapporto al preedipico, all’aggressività e alla pulsione di morte.
Tra gli psicoanalisti kleiniani H. Rosenfeld (1964) tenta di integrare il narcisismo con le concezioni di M. Klein. Egli rivede criticamente le tesi freudiane sostenendo che il narcisismo primario è da considerarsi l’espressione di un rapporto oggettuale primitivo in cui l’oggetto viene incorporato in modo onnipotente e viene trattato come proprietà del bambino che si identifica con esso.
L’ipotesi di fondo di Rosenfeld è che esiste un narcisismo libidico che va tenuto distinto da un narcisismo distruttivo, distinzione che si fonda sulla qualità dell’oggetto che viene idealizzato. Il narcisismo libidico è caratterizzato da un eccesso di idealizzazione per il Sé che viene mantenuto mediante identificazioni onnipotenti (proiettive e introiettive) con gli oggetti buoni e le loro qualità, ma non ha una valenza antirelazionale bensì è una difesa da sentimenti di dipendenza, di vuoto e di invidia.
Il narcisismo distruttivo corrisponde alla idealizzazione di parti cattive del Sé volte a colonizzare la parte più sana e meno narcisistica della personalità. Questa struttura psicopatologica nega e rigetta ogni sentimento di dipendenza, e quindi di separazione, nei confronti dell’oggetto (incluso l’analista) proclamando, per così dire, la propria autosufficienza, ma in realtà impedisce al soggetto di stare in contatto con le proprie emozioni e di entrare in relazione con gli altri.
Allontanandoci dal territorio kleiniano e spostandoci oltre oceano, uno psicoanalista che su questo tema ha dato un contributo senz’altro originale è H. Kohut, ispiratore della corrente della psicologia del Sé, che ha fatto del narcisismo l’asse portante del suo pensiero teorico conferendogli una “autonomia” inedita. Kohut ritiene che esistono due linee parallele di sviluppo della libido: una oggettuale, che porta all’amore per l’altro e una narcisistica che porta all’amore per sé.
Secondo lo psicoanalista americano, esiste uno stadio infantile, successivo al narcisismo primario, in cui si stabilisce il Sé grandioso del bambino (che si manifesta attraverso l’esibizionismo e le fantasie grandiose) da ritenersi non patologico ma sano e adattivo. In questa fase svolge una funzione fondamentale una presenza genitoriale capace di empatia e tenerezza rispecchianti (Mirroring) assicurando il consolidamento di questo arcaico Sé grandioso.
La sua teoria nasce soprattutto dall’osservazione clinica di pazienti con disturbi narcisistici che nel corso del trattamento analitico sviluppavano due modalità di transfert definite da Kohut: speculare e idealizzante. La prima corrisponde al bisogno del paziente di “ammirazione” e “rispecchiamento” da parte del terapeuta, la seconda, complementare alla prima, di idealizzare il terapeuta. Questi tipi particolari di transfert hanno portato Kohut ad ipotizzare un difetto originario da parte delle figure genitoriali nella loro capacità di accogliere empaticamente gli aspetti di onnipotenza infantile. Ciò comporterebbe un arresto dello sviluppo psichico del bambino allo stadio del “Sé grandioso arcaico” compromettendo la sua evoluzione più matura che conosciamo comunemente nella forma del sentimento di autostima e di fiducia in noi stessi.
La differenza sostanziale, rispetto alla teoria freudiana, è l’importanza che viene ad assumere l’ambiente (e quindi il conflitto tra il Sé e gli oggetti) nella costituzione soggettiva laddove Freud postulava una conflittualità intrapsichica (tra Io-Es e Superio).
I due specchi: Winnicott e Lacan
Lo stadio dello specchio costituisce il primo grande contributo di J. Lacan alla teoria psicoanalitica. E’ uno dei suoi concetti più famosi, una riformulazione della teoria del narcisismo freudiano e dell’identificazione. Ricordiamo, infatti, che per Freud il narcisismo rinvia al rapporto del soggetto con la propria immagine ideale (l’Io ideale) e alla funzione che l’immagine ideale svolge nella formazione dell’Io. La nascita del soggetto avviene attraverso questi due oggetti fondamentali: il corpo materno (il suo sguardo, le sue cure) e l’immagine del corpo proprio. Da qui si determinerebbero le successive scelte oggettuali, come ricorda lo stesso Freud, o forme d’amore: anaclitica (dalla funzione di sostegno esercitata dalla madre) e quella narcisistica nella quale l’oggetto è amato perché restituisce al soggetto un’immagine ideale di sé.
Lo stadio dello specchio rappresenta per Lacan la matrice originaria della formazione dell’Io o, come scrive nel suo lavoro L’aggressività in psicoanalisi, un “crocevia strutturale” nella costituzione della soggettività umana. Il senso di questa fase si dà a posteriori e si riferisce all’esperienza dello sviluppo psichico del bambino in un’età collocabile tra i 6 e 18 mesi, periodo in cui l’infans non padroneggia ancora il linguaggio né il coordinamento motorio. Il bambino può vedersi nell’immagine riflessa, può riconoscersi com’è osservandosi nell’immagine dell’altro che lo specchio gli restituisce e di fronte al quale il bambino ha un moto di giubilo. Vi è tuttavia una “discordanza” tra ciò che lo specchio gli rimanda – illusione di padronanza e di unità del proprio corpo – e la condizione di prematurità strutturale che caratterizza la condizione di dipendenza del piccolo dell’uomo. La funzione dello specchio è quella di produrre uno sdoppiamento nel soggetto per cui egli può “oggettivarsi” nell’immagine speculare dell’altro da sé, al fine di potersi riconoscere in un’alterità che lo identifica, in un’esteriorità che lo riflette.
Ciò che Lacan teorizza e intende far comprendere con lo stadio dello specchio è “[…] quanto c’è nell’uomo di slegato, di frammentato, di anarchico (che) si pone in rapporto con le sue percezioni sul piano di una tensione assolutamente originale. E’ l’immagine del suo corpo a essere il principio di ogni unità che percepisce gli oggetti. Ora, di questa stessa immagine egli percepisce l’unità solo al di fuori e in modo anticipato. Per il fatto di avere questa relazione doppia con se stesso, è sempre intorno all’ombra errante del suo proprio io che si struttureranno tutti gli oggetti del suo mondo”. (Seminario II, 191).
Lacan quindi sottolinea che lo stadio dello specchio assume una funzione anticipatoria e nello stesso sancisce quell’aspetto di alienazione – l’impossibilità di essere Uno – che contraddistingue l’essere umano.
Anni dopo Winnicott in Gioco e realtà del 1967 riconosce a Lacan il merito di aver introdotto l’esperienza dello specchio come tappa evolutiva dell’essere umano, ma la declina in tutt’altra prospettiva teorica. Rispetto alla ricostruzione metapsicologica di Lacan, Winnicott ne dà una versione più specificamente relazionale. Egli, infatti, sostiene che il precursore dello specchio è il volto della madre nel quale il lattante si vede: […] In altre parole la madre guarda il bambino e ciò che essa appare è in rapporto con ciò che essa scorge” (1967, 191). E’ da questo sguardo che l’infans riceve il primo riconoscimento del suo“essere”. E’ un gesto inaugurale che lo istituisce in quanto soggetto appartenente alla comunità umana e lo introduce nell’ordine simbolico.
Il lato oscuro del narcisismo
Un Autore che si è a lungo occupato del narcisismo dal punto di vista metapsicologico è lo psicoanalista francese André Green. In uno dei suoi lavori più famosi Narcisismo di vita, narcisismo di morte, Green ha messo in luce, a partire dalla clinica psicoanalitica e dal trattamento delle patologie gravi, gli aspetti negativi e distruttivi del narcisismo collegandoli alla pulsione di morte intesa non come distruttività pulsionale ma come forma di disinvestimento che permea tutte le relazioni d’oggetto. Nella clinica psicoanalitica Green ha individuato alcune forme di narcisismo negativo (che si rivelano e si riattualizzano nel transfert) in cui nei pazienti predominano sentimenti di impotenza che vanno dalla incapacità di amare, di coltivare le proprie risorse, e di vivere, più in generale, una vera soddisfazione nonostante il raggiungimento di risultati.
Tra le varie configurazioni patologiche, attribuibili a una ferita narcisistica originaria, la più nota è quella descritta da Green come Il complesso della madre morta (1983). Non si tratta di un lutto reale subito dal bambino nei primi anni di vita (Green lo definisce lutto bianco), ma di una depressione materna, insorta a causa di eventi di vita dolorosi e improvvisi, a seguito della quale la madre ha distolto bruscamente il proprio investimento affettivo nei confronti del figlio: “Il lutto della madre modifica il suo atteggiamento fondamentale nei confronti del figlio, ch’essa continua ad amare, continuando ad occuparsi di lui. Ma, come si dice, “senza metterci l’anima” (ibid.). Per il bambino questo distacco emotivo, a cui non è in grado di attribuire un senso, rappresenta una vera e propria catastrofe e viene a creare, per usare l’immagine proposta da Green, un “buco” nella trama psichica soggettiva. Da adulto potrà avere una vita relazionale e lavorativa apparentemente soddisfacenti, ma dentro di sé continuerà a tenere inconsciamente in vita questa immagine della madre morta identificandosi con lei.
Ma che cosa si intende dunque per narcisismo sano? Fermo restando che ciascuno di noi ha bisogno di sentirsi riconosciuto e amato come persona nella sua unicità, ciò che può variare (in termini quantitativi oltre che qualitativi) è il valore che attribuiamo allo “sguardo” del mondo esterno. In linea di massima possiamo affermare che il narcisismo sano è dato dalla capacità di un individuo di mantenere un sufficiente “equilibrio oscillatorio” tra investimenti libidici e affettivi che riguardano il proprio Io (amore per se stessi) e gli altri. Accade tuttavia che in alcuni momenti o fasi della vita (si pensi all’adolescenza o alla vecchiaia) questo equilibrio può andare incontro a forti turbolenze. Altre cause possono essere rappresentate da eventi o situazioni traumatiche (come ad esempio un lutto o una malattia) che causano, seppure transitoriamente, una regressione, ovvero un ritiro dall’Io dalla realtà che lo circonda.
Freud in una lettera ad Abraham dopo la stesura del suo saggio del 1914 scriveva “Il narcisismo è stata una dura fatica e porta tutti i segni delle relative deformità”. La frase di Freud risuona in un certo senso attuale poiché, nonostante i passi compiuti e la grande ricchezza dei contributi apportati dal punto di vista teorico e clinico dagli psicoanalisti postfreudiani nel trattamento di pazienti con disturbi narcisistici, il narcisismo rimane un campo di indagine ancora da esplorare anche alla luce delle patologie del nostro tempo che sembrano caratterizzate da questa impronta.
Bibliografia
Freud S. (1910) Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci, OSF 6, Boringhieri.
Freud S. (1910) Osservazioni psicoanalitiche su un caso di paranoia descritto autobiograficamente. (Caso clinico del presidente Schreber), OSF 6, Boringhieri.
Freud S. (1912) Totem e tabù, OSF 7, Boringhieri.
Freud S. (1914) Introduzione al narcisismo, OSF 7, Boringhieri.
Green A. (1983) Narcisismo di vita, narcisismo di morte, Borla.
Kohut H. (1971) Narcisismo e analisi del sé, Boringhieri, 1976.
Lacan J. (1947) Lo stadio dello specchio come formatore della funzione dell’Io, in Scritti, vol. I, Einaudi, 1974.
Lacan J. L’aggressività in psicoanalisi, in Scritti, vol. I, Einaudi, 1974.
Lacan J. (1954-55) L’Io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi, Il Seminario libro II. Einaudi.
Laplanche e Pontalis (1967) Enciclopedia della psicoanalisi, vol. II, Laterza, 2010.
Rosenfeld H. A. Stati psicotici. Un approccio psicoanalitico, Armando editore, 1990.
Semi A. A. Il narcisismo, Il Mulino, 2007.
Winnicott D. (1967) Gioco e realtà, Armando editore, 2005.
Aprile 2015
Negazione
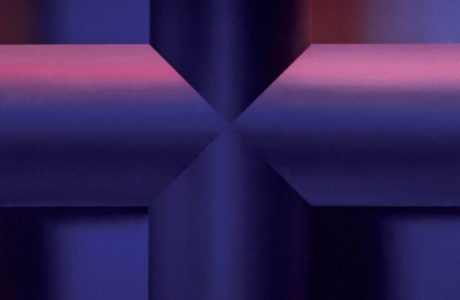
SAMIA HALABY 1969
NEGAZIONE
di S. Lombardi
Freud usa il termine verneinung o, talvolta, il suo equivalente di origine latina negation, per indicare un’operazione psichica e linguistica di respingimento: 1) dalla coscienza, di rappresentazioni rimosse quando affiorano nella cura analitica; 2) dall’apparato psichico in formazione, delle percezioni che suscitano dispiacere.
La definizione del concetto avviene nel saggio[1] del 1925.
In esso si apprezzano gli esiti di una speculazione sul riscontro della presenza nel pensiero e nella comunicazione di fenomeni di esplicito rifiuto.
Nell’ottica di una comprensione della rimozione nella strutturazione nevrotica, sono riconoscibili come meccanismi difensivi, che potenzialmente aprono la strada verso l’acquisizione di contenuti inconsci: il soggetto, con un atto intellettuale e con gli artifizi della razionalizzazione, nega gli possano appartenere nel momento in cui ne coglie l’imbarazzante esistenza. E’ in questo modo (una cognizione, ma non un’elaborazione affettiva) che l’Uomo dei topi prende le distanze dall’ambivalenza nei confronti del padre.
Il rapporto tra rimozione e negazione era sempre stato esplorato da Freud negli anni precedenti il 1925: ne fanno mostra le recise opposizioni di Dora alle sue interpretazioni dell’innamoramento per il padre e per il signor K [2]; ma anche le trasformazioni nel contrario in cui trova espressione la rimozione attuata dall’Uomo dei lupi di un’eccitazione che, con l’emissione delle feci , assume un significato negativo e svalutativo[3].
L’interesse epistemologico nasceva dalla scoperta che nel sistema Inconscio non esiste la negazione né il dubbio né livelli diversi di certezza[4] . Questi vengono istituiti dalla censura, attiva fra Inc. e Prec.. Il contrasto, la contraddizione, il contrario rimangono necessariamente confinati in unità di significato ambivalente, che ci trasmettono il senso di un’assurdità , manifestazioni di inibizione, pensieri di scherno o sarcasmo, come nel sogno[5]; o in certe parole primordiali che riuniscono opposti concettuali[6].
La negazione, messa a punto nel 1925, ribadisce essere questa un sostituto della rimozione ad un livello più vicino alla coscienza. Il disvelamento del rimosso è ancora solo intellettuale. Trova la sua forma nel simbolo linguistico del “no”.
Freud procede, poi, a fini metapsicologici facendone lo strumento costitutivo del giudizio nella formazione dell’apparato psichico. Il pensiero può, infatti, funzionare più liberamente se sgravato dalla rimozione. Le “ tre antitesi” che dominano la vita psichica (soggetto-oggetto, piacere-dispiacere, attivo-passivo) [7]discendono dal rifiuto (il più antico è di marca cannibalica) che il neonato decide di esprimere di fronte al mondo esterno, optando, quindi, per un’inclusione o un’esclusione. Se l’Io-piacere-originario può decidere quanto è buono e quanto è cattivo e, dunque, delineare una prima distinzione fra dentro e fuori, l’Io-realtà-definitivo dovrà, invece, stabilire se la rappresentazione dell’oggetto può essere confermata nella realtà. Talvolta, come nella psicosi, il negativismo ostinato esita in una scissione del soggetto.
Lavorando intorno al giudizio di attribuzione ed al giudizio di esistenza, Freud avvia, suo malgrado, la tessitura di una rete concettuale[8]. E’ difficile, infatti, non cogliere uno scivolamento dalla negazione al rinnegamento, concetti ai quali aveva destinato termini ed usi diversi: verneinung e verleugnung.
Nel 1923[9] aveva auspicato che restassero separati, al pari della rimozione e del disconoscimento[10] (della castrazione femminile) nell’ambito del complesso di evirazione, per poter spiegare il prototipo della perversione: il feticismo.
Da questo crocevia si dipartono le strade percorse dagli epigoni: Klein, Bion, Winnicott, ciascuno nell’ambito del proprio paradigma, fino alla psicoanalisi contemporanea.
Se, infatti, la negazione, nel discorso freudiano, istituisce un limite generativo di simboli, segni e rappresentazioni, essa è anche il vertice di condensazione della pulsione e della mancanza o dell’assenza. A tal proposito A. Green (2003)[11] , il cui concetto di negativo non è circoscritto alla psicopatologia, ha osservato che Freud ha scritto il lavoro del 1925, avendo ormai riconosciuto come fondativa dell’umano l’esistenza della pulsione di morte. Egli osserva anche che la posta in gioco è il rapporto con il linguaggio, ovvero con il simbolico: nel rinnegamento della percezione, questo rapporto non c’è.
[1] Freud S. (1925) La negazione, O.S.F. 10
[2] (1901) pp. 347-349, O.S.F. 4
[3] (1914) p. 555 nota, O.S.F. 7
[4] (1915) Metapsicologia O.S.F. p. 70
[5] (1899) L’Interpretazione dei sogni O.S.F. 3 p. 293-300-310; (1900) Il Sogno O.S.F. 4 p.29; (1915-1917) Introduzione alla psicoanalisi O.S.F.8 p.348
[6] (1910) Significato opposto delle parole primordiali O.S.F.6 p.185
[7] C. Le Guen (2013) Negazione, denegazione, diniego p.800 in Dizionario freudiano, Roma, Borla
[8] T. Bokanowski (2022) Le “je … ne … pas”. Dénégation et clinique contemporaine, R.F.P. 2023 LXXXVII-2
[9] L’organizzazione genitale infantile, p.565 nota, O.S.F. 9
[10] Feticismo (1927), O.S.F. 10
[11] A. Green (2003) Negativo e negazione in psicoanalisi in La clinica del negativo a cura di A. Baldassarro, 2023, Roma, F. Angeli
Nevrosi ossessiva

experience and the brain
A cura di Carlo Brosio
All’inizio del secolo con “Il caso dell’Uomo dei topi”, Freud (1909) si trova davanti ad una delle più affascinanti e misteriose patologie mentali che contribuirà a far uscire dalle nebbie del misticismo ottocentesco permettendone una comprensione clinica. Le sue costruzioni esplicative resero praticabile un avvicinamento ai tormenti dell’ossessivo, ai suoi dubbi, ai suoi rituali e ruminazioni. La descrizione psicoanalitica della nevrosi ossessiva compiuta da Freud ha reso atto della lotta senza quartiere affrontata da questo giovane paziente contro la sofferenza psichica: la sua ambivalenza, il bisogno disperato di controllo delle emozioni, la lotta contro i desideri proibiti, la qualità rigida e implacabile delle sue proibizioni interne, la necessità per sopravvivere psichicamente, di fare ricorso al pensiero magico.
Già nel 1907 in “Azioni ossessive e pratiche religiose” Freud focalizza il tema del rapporto fra ossessività e rituali cerimoniali indicando nella nevrosi ossessiva la religione privata dell’individuo. E ancora in “Totem e Tabù” (1912-13) torna sulla concordanza fra fenomeni ossessivi e rituali magici delle società arcaiche. Nel 1925 con “Inibizione, sintomo e angoscia” egli riprende più distesamente il concetto di “rendere non accaduto” già incontrato nell’analisi dell’Uomo dei topi, che qui diventa una delle radici del cerimoniale ossessivo e consente la comprensione della coazione a ripetere. Il genio di Freud permise di assegnare alla nevrosi ossessiva un posto stabile fra i grandi quadri nosografici inaugurati dalla psicoanalisi: egli infatti definì la specificità eziopatologica di questa nevrosi dal punto di vista dei meccanismi di difesa (spostamento dell’affetto, isolamento, annullamento retroattivo), dal punto di vista pulsionale (ambivalenza, fissazione anale, regressione), topico (interiorizzazione di un super-io crudele) e relazionale (sado-masochismo, carattere anale).
I contributi successivi a Freud sono ben sintetizzati dalle osservazioni di Anna Freud presentate al termine del Congresso dell’International Psychoanalytic Association del 1965 sulla Nevrosi Ossessiva che sostanzialmente ribadiscono le posizioni classiche: centralità dei fattori costituzionali responsabili dell’intensità anomala delle tendenze sadico-anali e della scelta da parte del nevrotico ossessivo degli specifici meccanismi di difesa che determinano il quadro sintomatologico. Aspecificità, dal punto di vista eziologico, della ricerca di cause determinanti il disturbo ossessivo nello sviluppo precoce del bambino; importanza delle relazioni famigliari e delle modalità di educazione nell’attivare invece la regressione e la conseguente fissazione alla fase anale determinata dalle tendenze libidiche costituzionali; difetto della funzione sintetica e conseguente difficoltà nella fusione di amore/odio, passività/attività, mascolinità/femminilità.
L’approccio alla nevrosi ossessiva è quindi rimasto saldamente ancorato ai concetti metapsicologici della tradizione classica, mentre si è assistito a sempre più sottili quanto utili distinzioni in ambito clinico-diagnostico fra nevrosi ossessiva propriamente detta, manifestazioni ossessive, carattere ossessivo, tratto e stile ossessivo. Grande lavoro è stato fatto, attraverso l’osservazione e il trattamento dei pazienti ossessivi, per individuare le peculiari difese che distinguono questa patologia: isolamento, spostamento, annullamento, depersonalizzazione sono i meccanismi difensivi specifici attraverso i quali l’ossessivo si protegge da angosce insopportabili.
Il successivo apporto della scuola kleiniana, sviluppa il tema dell’ossessività individuando l’evolversi della qualità dei fenomeni ossessivi che procedono da un’ossessività primitiva caratterizzata da angosce psicotiche legate al controllo e al dominio, fino ai meccanismi ossessivi connessi alla riparazione dell’oggetto e accompagnati quindi dalla cura, dall’amore e dalla considerazione per esso.
Tra i più importanti successori della Klein, Meltzer (1975) considera l’utilizzo difensivo dei meccanismi ossessivi in bambini autistici come tentativo di ipersemplificazione massiva dell’esperienza attraverso la separazione e il controllo onnipotente sugli oggetti interni o esterni. Ma lo stesso meccanismo di funzionamento ossessivo è strumento fondamentale alla modulazione e integrazione fra sviluppo emotivo e intellettuale e contribuisce all’equipaggiamento dello spirito scientifico che, attraverso i modelli sperimentali della scienza, modula l’onnipotenza a scopo conoscitivo.
La psicoanalisi non ha elaborato una tecnica specifica per il trattamento della nevrosi ossessiva: analisti diversi, in momenti differenti della storia della nostra disciplina, hanno elaborato aspetti e peculiarità specifiche della sintomatologia, della struttura psichica e della cura. Complessivamente nella letteratura internazionale viene evidenziata la necessità di costruire condizioni di fiducia nella relazione analitica mantenendo viva l’attenzione a evitare che il sintomo ossessivo aderisca, rinvigorendosi, alle ritualizzazioni del setting o dell’analista. Il peculiare metodo delle libere associazioni è infatti particolarmente ostico all’ossessivo che tende a vivere come una grave minaccia il libero flusso dei contenuti che si presentano alla coscienza come portatori di quote di emozioni avvertite come incontrollabili. La stessa interpretazione è spesso percepita dal paziente come contropartita quantitativa dell’onorario elargito all’analista quando non direttamente intrusiva e sadica. La relazione analitica è quindi costantemente polarizzata dal conflitto fra il bisogno dell’ossessivo di porre fine al proprio soffocante isolamento affettivo e la grande angoscia che promuove una condizione di intimità nel rapporto.
L’evidenza clinico-teorica dell’impossibilità di permanere oggi nel quadro concettuale di una psicologia unipersonale, ancorata al modello pulsionale freudiano, di cui è paradigma la cura del paziente ossessivo, rende necessario costruire nuovi modelli teorici e clinici che tengano conto dell’importanza non solo dell’equazione personale dell’analista, ma della complessa interazione della coppia analitica e degli apporti legati all’ipotesi traumatica dell’eziologia della sofferenza mentale.
Un’ipotesi che, in questa prospettiva, supera l’eziopatogenesi del conflitto intrapsichico nella nevrosi ossessiva, considera l’ambiente primario deficitario in relazione al predominio dei criteri quantitativi nelle prime relazioni oggettuali che non consentirebbe al bambino di sostare sufficientemente nell’area fusionale: una madre inadeguata a vivere l’esperienza che sta attraversando non riuscirebbe a farsi usare come oggetto trasformativo accettando naturalmente la rinuncia temporanea a una chiara demarcazione del confine del proprio sé. L’indisponibilità materna nel donarsi generosamente, senza calcolo, ma con calore e pienezza al contatto mentale e fisico non fornirebbe quell’ambiente necessario alle esperienze appropriate alle prime fasi dello sviluppo del bambino.
Il deficit evolutivo connesso alla mancanza di specificità nei modi di accudimento primari sarebbe responsabile, almeno in parte, degli adattamenti patologici che esitano nei fenomeni ossessivi: si può tentare l’ipotesi che questi rappresentino il tentativo di porre rimedio a una inadeguatezza traumatica della capacità di reverie materna consistente nel privilegiare aspetti quantitativi su quelli qualitativi: un tipo di accudimento centrato su spazio, tempo, contiguità, opposizione, regole e doveri che irrigidirebbero lo spazio mentale in una prospettiva bidimensionale. Il difettoso funzionamento della reverie materna condurrebbe alla formazione di un’istanza superegoica rigida e controllante che non consentirebbe la metabolizzazione delle proto emozioni. (Brosio, 2005)
Ciò che appare di particolare evidenza nella tecnica di lavoro con un paziente ossessivo è che l’interpretazione classica, la decodificazione simbolica e l’insight come suo momento ostensivo, non offrono sollievo e non producono efficace trasformazione, attivando semmai compiacenza, fraintendimento e pensiero conformista. Il controllo anale ritentivo dell’ossessivo permette di mantenere la sequenza del discorso attraverso una logica controllante e asfissiante al fine di neutralizzare la mente dell’analista. Lo stile narrativo ossessivo costituisce l’espressione empirica dei tipici meccanismi di difesa della nevrosi ossessiva: formazione reattiva, annullamento e isolamento (Libermann, 1974).
I pazienti ossessivi appaiono dunque abitati da un mondo di relazioni oggettuali antivitali e mortifere codificate da un rigido controllo che soffoca ogni emozione perché esplosiva e caotica. L’isolamento affettivo a cui essi si condannano può essere superato attraverso una paziente e ripetuta offerta di un ambiente – l’analisi – che faciliti la regressione e l’emergenza dei sentimenti traumatici e confondenti che appaiono al limitare di questa fase.
Nella terapia del paziente ossessivo la funzione interpretativa deve essere dunque veicolata da interventi più interlocutori e narrativi destinati, non solamente alla descrizione del mondo interno del paziente, ma anche alla costruzione di una reciproca sintonizzazione (Stern, 1998) che possa facilitare i processi evolutivi della coppia analitica. Il paziente ossessivo ha bisogno di un analista intatto e solido, capace di riconoscere le proprie manchevolezze senza colpa o mortificazione, che lo incoraggi a pensare liberamente e a giudicare la propria realtà interna ed esterna. L’analista che offrirà qualità affettive (pazienza, coraggio e simpatia) e disponibilità emotiva, pur nelle inevitabili ripetizioni dei fallimenti empatici primari, potrà permettere al paziente di emozionarsi e tornare a vivere con pienezza. Incontrando questi individui mortificati nel loro diritto a esistere, l’analista potrà affrontare il loro isolamento e le loro ritualizzazioni ponendosi in ascolto di quegli elementi non ancora sufficientemente strutturati per essere riconoscibili: sensazioni, disagi somatici, immagini mentali e quant’altro percorra il campo emotivo in cerca di consistenza e parola. L’insorgere di riverberi controtransferali costituisce l’unica traccia da poter seguire per raggiungere isole di affetti spesso sorprendenti.
Bibliografia
Baranger M. (1992) La mente del analista: de la escucha a la interpretation. Revista de Psicoanalisis, XLIX, 174-193
Brosio, C. (2001) La psicoanalisi dei fenomeni di campo. Setting, anno VI, n.11, 101-125
Brosio, C. (2005) Trauma e fenomeni ossessivi. In Mangini E. (a cura di) Nevrosi Ossessiva. Rivista di Psicoanalisi Monografie. Roma, Borla.
Fachinelli, E. (1979) La freccia ferma. Milano, L’Erba Voglio.
Freud, A. (1966) Obsessional Neurosis. Int. J. Psycho-Anal., 47, 116-138
Freud, S. (1907) Azioni ossessive e pratiche religiose. OSF, vol.4
Freud, S. (1909) Osservazione su un caso di nevrosi ossessiva. OSF, vol.5
Freud, S. (1913) Totem e Tabù OSF, vol.7
Freud, S. (1925) Inibizione, sintomo, angoscia. OSF, vol.10
Liberman, P. (1974) – Complementariedad estilistica entre el material del paziente y la interpretacion. Revista de Psicoanalisis, vol.31, 564-589
Mangini, E. (2005) (a cura di) Nevrosi Ossessiva. Rivista di Psicoanalisi Monografie. Roma, Borla
Meltzer, D. e altri (1975) Esplorazioni sull’autismo. Torino, Boringhieri, 1977
Nacht, S. (1966) The interrelationship of phobia and obsessional neurosis. Int. J. Psychoanal., 47, 345-367
Nagera, H. (1976) Obsessional Neurosis. Aronson, New York
Sandford, B. (1955) Il bisogno di essere mantenuto di un paziente ossessivo. In Nuove vie della Psicoanalisi. Milano, Il Saggiatore, 1966.
Shapiro, D. (1965) Stili Nevrotici. Roma, Armando, 1969.
Spaçal, S. (1989) La nevrosi ossessiva. In A.A. Semi (a cura di), Trattato di psicoanalisi. Milano, Raffaello Cortina Editore
Speziale-Bagliacca R. (2005) L’assedio e la breccia. Nota tecnica per l’analisi delle nevrosi ossessive. In A.A. Mangini (a cura di), Nevrosi Ossessiva. Rivista di psicoanalisi Monografie. Roma, Borla
Stern D. (1998) Le interazioni madre-bambino nello sviluppo e nella clinica. Milano, Raffaello Cortina Editore
Stolorow, R.D., Atwood, G.E., Brandchaft, B. (1994) (a cura di) La prospettiva intersoggettiva. Roma, Borla, 1996
Tuckett, D. et al. (2008) I modelli della psicoanalisi. Roma, Astrolabio Ubaldini Editore, 2009
Settembre 2016
Nissim Momigliano Luciana

Luciana Nissim Momigliano
A cura di Cristina Feri
Maestri della psicoanalisi
Luciana Nissim Momigliano (Torino 1919 – Milano 1998)
Luciana Nissim è stata una protagonista del cambiamento del modo di fare psicoanalisi avvenuto negli anni ’80 del Novecento. Italiana di famiglia ebraica, Luciana Nissim, dopo una breve militanza nel movimento partigiano, nel 1944 fu deportata ad Auschwitz. Della Shoah e dell’esperienza del campo ha dato la propria testimonianza in alcuni importanti scritti e in numerose interviste. Tra le poche donne italiane a laurearsi in Medicina prima della guerra, Luciana Nissim svolse la formazione psicoanalitica a Milano, prima con Franco Fornari e in seguito con Cesare Musatti sviluppando, tuttavia, nel corso di vent’anni, un percorso clinico e scientifico molto personale e innovativo. Psicoanalista rigorosa quanto capace di cambiare e aliena da ogni dogmatismo, ella ha dato un contributo importante nell’orientare l’attenzione dal paziente alla stanza d’analisi, verso la relazione analitica e un ascolto dell’altro che, non più “sospettoso”, divenisse autenticamente “rispettoso”. Per Luciana Nissim ciò che è importante non è solo interpretare quello che avviene nel paziente ma tra paziente e analista, punto di vista che la portò a interessarsi anche del peso della personalità dell’analista nella cura psicoanalitica, accanto al riconoscimento del paziente come “miglior collega”. Analista didatta molto apprezzata dalle generazioni più giovani, ha dedicato una parte della sua produzione scientifica al tema della supervisione psicoanalitica e della formazione degli psicoanalisti. Di aspetto particolarmente minuto, questa piccola grande donna era capace di sorprendere e interpellare chiunque la avvicinasse con la sua presenza carismatica, la sua intelligenza libera e la sua eccezionale capacità relazionale. La storia della sua vita, anche oggi, è testimonianza di onestà etica e umana ed esperienza di speranza.
LA VITA
 Luciana Nissim nacque a Torino il 20 ottobre 1919, in una solida famiglia borghese italiana di religione ebraica. Il padre, Davide, laureato in giurisprudenza, aveva combattuto nella prima guerra mondiale e in seguito aveva trovato impiego nell’amministrazione pubblica ma, poco dopo il matrimonio, si era trasferito con la famiglia a Biella per dedicarsi al commercio della lana. La madre, Cesira Muggia, apparteneva a una famiglia benestante del vercellese: bella, abbiente, sebbene non particolarmente colta, Cesira Muggia infuse e sostenne nella figlia il senso di un valore, del tutto laico, delle proprie origini, nonché di una solida appartenenza alla comunità intellettuale umana più attiva dell’epoca. Oltre a Luciana, la famiglia Nissim comprendeva altre due figlie: Lea, nata nel 1922, e Fernanda – detta “Dindi” – nata nel 1927, quest’ultima amatissima da Luciana che con lei conservò un legame privilegiato, dolce e intenso, fino alla morte.
Luciana Nissim nacque a Torino il 20 ottobre 1919, in una solida famiglia borghese italiana di religione ebraica. Il padre, Davide, laureato in giurisprudenza, aveva combattuto nella prima guerra mondiale e in seguito aveva trovato impiego nell’amministrazione pubblica ma, poco dopo il matrimonio, si era trasferito con la famiglia a Biella per dedicarsi al commercio della lana. La madre, Cesira Muggia, apparteneva a una famiglia benestante del vercellese: bella, abbiente, sebbene non particolarmente colta, Cesira Muggia infuse e sostenne nella figlia il senso di un valore, del tutto laico, delle proprie origini, nonché di una solida appartenenza alla comunità intellettuale umana più attiva dell’epoca. Oltre a Luciana, la famiglia Nissim comprendeva altre due figlie: Lea, nata nel 1922, e Fernanda – detta “Dindi” – nata nel 1927, quest’ultima amatissima da Luciana che con lei conservò un legame privilegiato, dolce e intenso, fino alla morte.
Non sono molte le descrizioni e i racconti che Luciana Nissim ha riservato alla propria famiglia di origine, ma la profondità e l’intensità di quei legami sono costantemente testimoniate dall’uso del “noi” ogni volta che ella parla o scrive di sé e delle proprie vicende autobiografiche: affiora, allora, chiaramente, l’immagine di una famiglia solida, sufficientemente serena, libera, colta nella casa di Biella ma spesso anche nelle belle villeggiature, in montagna e al mare, o impegnata nelle attività quotidiane, lo studio, i rapporti con gli amici, l’intimità domestica. Foto3
Quanto all’ebraicità, i Nissim non erano osservanti e la dimensione religiosa, nel senso sia identitario sia spirituale, è assente nei ricordi e nei racconti di Luciana. Solo nella piena maturità, sul finire degli anni ’80, quando con dolore si risolse a mettere mano al suo passato, ella sentì riemergere l’antico invito allo Shema, all’ascolto attento di un mondo, piccole ritualità e atteggiamenti che erano stati propri della sua famiglia e che solo allora ritrovava in se stessa: “ (…) ricordo però che anche a casa mia qualche volta veniva usata da parte degli adulti qualche parola di un dialetto ebraico-piemontese che, come suggerisce Primo Levi in “Argon” (…) conservava le tracce di un’antica funzione dissimulatrice e sotterranea, ma probabilmente alludeva anche a un orgoglio segreto di appartenenza e di continuità con la tradizione.
Ripensandoci ora, mi accorgo che anche in tanti atteggiamenti della mia famiglia così assimilata, si sarebbero potute leggere le tracce modificate delle antiche tradizioni: mio padre non metteva i tefillim, ma a noi bambini era stato insegnato lo Shema, non osservava i precetti giornalieri, ma era impensabile che andassimo a tavola senza esserci lavate le mani…”(Luciana Nissim, 1989).
Bambina curiosa e intellettualmente precoce , fu sostenuta e assecondata in queste sue attitudini in particolar modo dalla madre che le insegnò a leggere a cinque anni, consentendole di iniziare il percorso scolastico con un anno di anticipo. Questo fatto, apparentemente insignificante, viene invece spesso ricordato dalla Nissim giacché gravido di conseguenze fortuite e decisive per la sua stessa vita. Brillante studentessa, frequentò il liceo classico di Biella e conseguì nel 1937 la maturità con il massimo dei voti. Decise allora di iscriversi alla facoltà di medicina di Torino “ (…) una scelta abbastanza inconsueta per una ragazza nei tempi e nell’ambiente in cui vivevo; comportava il trasferimento a Torino (…) e i miei genitori furono completamente d’accordo con me e mi appoggiarono in tutti i modi”. In effetti, Davide Nissim comprese e sostenne l’intelligenza ma anche l’originalità e l’indocilità della figlia, alla quale lo legavano sentimenti e passioni comuni, prima tra tutte quella per la montagna.
Luciana iniziò l’Università nel 1937 e nel 1938 furono emanate in Italia le leggi raziali, in base alle quali ai cittadini ebrei era vietato l’accesso alla scuola pubblica, ma – per una strana e inspiegabile eccezione – era consentito agli studenti universitari già frequentanti di ultimare il loro corso di studi. Pertanto, Luciana poté completare gli studi fino alla laurea, conseguita, con lode, l’8 luglio 1943. Gli anni torinesi furono anni di studio ma soprattutto d’incontri e amicizie, quelle di una vita. Luciana Nissim era una ragazza brillante, amava la vita, la montagna, ma anche l’amore e i deliziosi vestitini che le donavano, il conversare lungo e raccolto con le amiche, lo scambio intellettuale con i ragazzi della biblioteca della scuola ebraica. Tuttavia, la sicurezza di essere una, spesso la migliore, tra eguali, fu incrinata e l’identità ebraica, fino ad allora mai sentita veramente come una parte di sé, le venne imposta. “Il ’38 fu veramente sentirsi crollare la terra sotto i piedi. Io ho sentito proprio che perdevo i punti di riferimento. E’ stato tremendissimo. E’ stato veramente un crollo dove tutto il mondo in cui credevi di muoverti e di camminare e di essere al sicuro, improvvisamente diventa un mondo ostile in cui tu non avevi più nessun punto di riferimento. E’ stato tremendo il ‘38”(Luciana Nissim, 1995). Le discriminazioni entrarono nella vita dei Nissim e non fu più possibile negarle. Luciana trovò, come altri coetanei, un punto di riferimento e d’incontro nella biblioteca della scuola ebraica di Torino dove erano approdati, fra gli altri, anche i fratelli Emanuele e Ennio Artom, Franco Momigliano, Vanda Maestro, Giorgio Segre, Eugenio Gentili Tedeschi, Franco Tedeschi, Guido Bonfiglioli, Lino Jona, Alberto Salmoni, Giorgio Lattes, Anna Maria e Primo Levi. In questo gruppo così colorato di amicizie, tre nomi erano destinati ad assumere una tonalità più intensa: Vanda Maestro, l’amica più cara di quegli anni, così diversa da Luciana, accogliente, fragile ma ironica; Primo Levi, deportato insieme a Vanda e Luciana ad Auschwitz, che condivise con la Nissim l’esperienza di sopravvissuti e il ritorno dal campo; Franco Momigliano, un giovane affascinante, dotato di rara intelligenza ma anche di un carattere spigoloso e umbratile, appassionato e distante, che diventerà suo marito.
La vita e il mondo dei Nissim e il loro mondo non sembrano avere incontrato senza grandi difficoltà fino all’8 settembre 1943, allorché in Italia iniziò la fase della “persecuzione delle vite”. La famiglia decise di rifugiarsi in Valle d’Aosta, a Brusson e di qui Luciana, insieme a Vanda Maestro, mosse alla volta di Amay per unirsi a un gruppo partigiano da poco costituito da Primo Levi, Aldo Piacenza e altri. “Mi sembrava che quello che facevo avesse un senso: io non avevo il senso dell’ebraismo, della persecuzione, me l’ero aggiustata così: che ero una combattente che subiva le infelicità, i dolori e i rischi di chi aveva deciso in quel momento di combattere contro il nazismo” (Luciana Nissim, 1995). Nella notte tra il 12 e il 13 dicembre 1943 il gruppo partigiano venne arrestato e condotto nella prigione di Aosta. Primo Levi, Vanda Maestro e Luciana Nissim si autodenunciarono come ebrei, ingenuamente fiduciosi che tale “colpa” fosse meno grave di quella di essere dei “banditi”. Furono invece trasferiti al campo di internamento di Fossoli di Carpi, nei pressi di Modena, dove rimasero dal 20 gennaio al 22 febbraio 1944. Qui, infine, insieme ad altre 600 vite, furono caricati sul convoglio per di Auschwitz, dove arrivarono nella notte del 26 febbraio 1944.
Il resto della famiglia Nissim, intanto, dopo aver tentato invano di ottenere il rilascio della figlia, trovò riparo in Svizzera, ove rimase fino alla fine della guerra.
“Ricordi della casa dei morti”
La deportazione, l’esperienza del campo e quella di sopravvissuta della Shoah meritano un approfondimento a parte nella biografia di Luciana Nissim, essendo la sua una testimonianza, per certi versi, non convenzionale e originale, come lei.
Luciana Nissim rese la sua prima testimonianza di deportata in campo di concentramento pochi mesi dopo la sua liberazione e il rientro in Italia, nel 1946. Il testo fu redatto in due versioni simili: una come relazione rilasciata dalla Nissim e conservata presso L’Archivio delle Comunità Ebraiche Italiane, a Roma (datata in modo incerto tra l’ottobre e il dicembre 1945); l’altra pubblicata nel 1946 (ma datata ottobre 1945-aprile 1946) in un volume a cura di Pelagia Lewinska, “Donne contro il mostro”, con il titolo di “Ricordi della casa dei morti”. Dopo di che, ella tacque per oltre quarant’anni. Solo dopo la morte di Primo Levi, (colui che si era assunto il sacrificio di testimone e di voce che cerca le parole), nel 1987, e del marito, Franco Momigliano, nel 1988 , Luciana Nissim tornò a mettere mano ai “Ricordi”. Nel 1989, pubblicò l’articolo “Una famiglia ebraica tra le due guerre”, e negli anni seguenti, oltre a ritornare a Birkenau, rilasciò importanti interviste e testimonianze. “Ricordi della casa dei morti” (titolo che cita testualmente l’opera di Dostoevskij) è un testo particolarmente prezioso, non solo per comprendere appieno la biografia della Nissim: esso costituisce anche, in assoluto, uno dei primi documenti testimoniali di sopravvissuti alla Shoah, fornendo una narrazione lucida, ma al contempo drammaticamente prossima e personale, delle donne incontrate, della vita nel campo, della realtà dello sterminio.
Luciana Nissim arrivò al campo di Fossoli di Carpi (in provincia di Modena) nel gennaio del 1944: qui i tre amici – oltre alla Nissim, Primo Levi e Vanda Maestro – incontrarono un giovane di origine napoletana ma trasferito a Torino, Franco Sacerdoti, con il quale strinsero un rapporto complice e affettuoso. Luciana, in particolare, si legò a lui, ricordando, anche molti anni dopo, Franco Sacerdoti come colui che l’aveva fatta sentire protetta, abbracciata, e al quale aveva affidato, in quei giorni sospesi, il compito di tenere vivi nel suo cuore l’amore e la passione per la vita. E’ grazie a lui che la Nissim non ricorderà il gelo invernale della sua prima prigionia, ma, al contrario, il sole, l’amicizia, lo stare bene con Vanda, Primo e Franco S., la sua intraprendenza di capo-baracca impegnata nell’accogliere e rassicurare i nuovi giunti. Lo sterminio e le persecuzioni contro gli ebrei erano ancora lontani, non veri. E soprattutto, lei non era sola.
Poi tutto precipitò e il 22 febbraio iniziò il viaggio alla volta di Auschwitz. Chiusa nel convoglio, per 4 lunghi, freddi giorni, Luciana non prova angoscia né disperazione ma ne è circondata: il viaggio è duro, le privazioni e il processo di disumanizzazione sono già attuati con sadica determinazione, l’umanità di ciascuno è svilita, quasi annullata ogni solidarietà. Un pensiero la sostiene: Franco, Primo e soprattutto Vanda sono con lei, e non ci sono bambini o familiari per i quali essere preoccupata. No, è giovane, può farcela.
Arrivarono ad Auschwitz nella notte del 26 febbraio 1944: era buio, freddo, il gruppo di amici fu subito diviso, gli uomini da una parte, le donne dall’altra. Non rivide più Franco Sacerdoti- che fu ucciso poco prima che gli alleati liberassero il campo-, né Primo Levi che ritrovò solo dopo il rientro in Italia. Ma Luciana rimase con Vanda. “Ich bin Ärtzin”: sono medico, imparò fulmineamente a dire appena giunta, e questo le risparmiò la rasatura dei capelli e la vita e, dopo il mese di quarantena, le consentì di essere impiegata come medico nel Revier, l’infermeria del campo, e di accedere a condizioni di vita relativamente migliori. Come ella stessa ha dichiarato, fu a Birkenau che iniziò il suo apprendistato di medico: lì dove non c’era nulla con cui curare, dove il desiderio di salvare qualcuno curandolo poteva condannarlo ad “andare in gas” e risospingerlo verso il campo poteva ucciderlo, lì dove nascere non era permesso. Stupisce la rapidità con la quale Luciana Nissim comprese e reagì all’assurdità della realtà del lager: ma ella seppe ascoltare il racconto delle altre prigioniere e osservare ella stessa cose, volti, storie. Questa costante presenza a se stessa e lucidità, impossibile da preservare per la maggioranza delle prigioniere, e l’aver mantenuto un senso dell’altro con cui essere in relazione, in dialogo, quasi in una strenua lotta contro una solitudine mortale, sono alcuni dei tratti peculiari della testimonianza e dell’esperienza nel lager della Nissim. In modo al contempo simile ma assai lontano da quanto ha fatto Primo Levi nei suoi scritti, i “Ricordi della casa dei morti” iniziano con una narrazione al singolare, “Sono partita da Fossoli di Carpi (…)” , ma, poco dopo, colei che narra non è più sola e diventa “Vanda e io…” e più oltre ancora “noi”, in una dualità che rimarrà una sua cifra esistenziale.
Sul finire dell’agosto 1944 Luciana Nissim si offrì volontaria come medico per accompagnare un trasporto di prigioniere ungheresi: non sapeva per dove né per cosa ma voleva dire uscire da Birkenau. Voleva anche dire lasciare Vanda Maestro, l’amica amatissima, ormai allo stremo e che non avrebbe fatto ritorno, ma anche colei che al momento di salutarla le disse: “Fai bene ad andare via. Se avrai una bambina, chiamala Vanda”. Luciana Nissim partì così alla volta di Hessisch Lichtenau, in Germania, un campo di lavoro per prigioniere ungheresi dove le condizioni erano lievemente migliori e dove rimase fino alla liberazione da parte delle truppe alleate. Tra il 20 e il 25 aprile 1945, durante uno spostamento delle prigioniere da parte delle SS, la Nissim, insieme a una compagna, riuscì a fuggire. Dopo un periodo di permanenza volontaria a Grimma, un campo allestito dagli alleati, il 20 luglio 1945 arrivò a casa. Erano partiti in 600, di quel trasporto tornarono in poco più di 10.
Che cosa l’esperienza del campo abbia davvero rappresentato nella vita di Luciana Nissim è impossibile dirlo, è rimasto dentro di lei. Ha detto, poco prima della sua morte: “Io amo pensare che ho girato pagina. Che è stato un libro dell’orrore, ma che ho chiuso e ne ho cominciato un altro della leggerezza e dell’amore. Penso anche che tra le varie fortune che ho avuto, ho avuto anche quella di girare pagina. Io sono venuta via da Auschwitz, non sono più là”.(Luciana Nissim, 1989)”.
Dopo il ritorno
La fine della guerra e il ritorno a casa nel luglio del 1945 vollero dire per Luciana Nissim ritrovare un mondo di vivi: tutti gli affetti più cari, ad eccezione di Vanda Maestro, la sua famiglia, molti amici e soprattutto Franco Momigliano erano vivi. Fu un tuffo nella vitalità: si iscrisse a Pediatria a Torino (conseguendo la specializzazione nel 1947), decisa a occuparsi dei bambini che ora, diversamente da quanto vissuto al Revier, potevano nascere ed essere curati; e poi nel novembre del 1946 sposò Franco Momigliano – che a sua volta aveva preso parte alla resistenza italiana – , compagno amato di tutta la sua esistenza. Ma in questo vortice di entusiasmo e desiderio di vita, Luciana Nissim incontrò un dolore quasi fatale per lei: nel luglio del 1947, dopo una gravidanza senza problemi e durante la quale non si era risparmiata nel lavoro, diede alla luce una bambina morta. La chiamò Vanda, come aveva promesso a Birkenau alla “sua” Vanda. Dopo il parto, però, cadde in una condizione di grave malessere, al confine tra la vita e la morte. Rimase ricoverata in ospedale, lo stesso in cui aveva cominciato a curare i bambini, per molti mesi. Poi, anche grazie a un nuovo antibiotico giunto da poco a Torino, guarì.
Dopo il matrimonio Luciana Nissim e Franco Momigliano si erano trasferiti a Ivrea per lavorare all’Olivetti di Adriano Olivetti, in quegli anni una straordinaria officina d’innovazione sociale e culturale. Tra il 1947 e il 1956 Luciana lavorò dapprima come responsabile dell’asilo nido Olivetti, quindi fu nominata direttore del Consultorio dell’Opera Nazionale Protezione della Maternità e dell’Infanzia per la provincia di Torino e, infine, divenne dirigente dei Servizi Sociali dell’Olivetti. Furono anche anni d’impegno culturale, politico e sociale, anni durante i quali la Nissim era vicina al Partito Comunista e, soprattutto, al movimento delle donne e alle battaglie femminili. Nel 1956, in seguito alla rottura dei rapporti con Adriano Olivetti per importanti divergenze sul ruolo del sindacato, sia Franco Momigliano sia Luciana Nissim furono licenziati dall’Olivetti. In seguito, Olivetti cercò di ricomporre tale frattura e Momigliano fu chiamato a dirigere il Centro Studi Olivetti a Milano, mentre Luciana non ricucì questo strappo che, al contrario, segnò un radicale cambiamento nella sua vita.
L’esperienza maturata con i bambini, fin dai primi anni torinesi e poi a Ivrea, aveva voluto dire per la Nissim imparare ad ascoltare anche le mamme, ad avvicinarsi al dolore e alla sofferenza, non solo somatica ma psichica, di piccoli e grandi. Alla fine degli anni ’50, inoltre, Nissim aveva avviato non solo rapporti professionali ma anche una solida e duratura amicizia con Livia Di Cagno, pioniera della neuropsichiatria infantile torinese. L’arrivo a Milano, perciò, coincise con la svolta verso la clinica: ecco allora l’incontro con la psichiatria, disciplina in cui conseguì la specializzazione nel 1959 con una tesi sulla schizofrenia infantile – e quello ancor più importante e appassionante con la psicoanalisi. Nel 1956, infatti, iniziò la sua prima analisi con Franco Fornari e nel 1960 un’analisi di training con Cesare Musatti, divenendo nel 1965 membro associato e nel 1973 membro ordinario della SPI. Peculiare e sorprendente il rapporto della Nissim con il ricordo dei suoi analisti e primi “maestri”, ai quali ella riserverà un ruolo non particolarmente significativo nella formazione della sua successiva identità di psicoanalista: “Ho cominciato ad afferrare veramente qualcosa quando ho letto Bion, non quello dei libri, quello dei seminari. E’ a lui che dobbiamo l’idea della personalizzazione e della intimizzazione dell’analisi”. Emerge qui un tratto del suo carattere, libero e poco incline ai vincoli intellettuali, restio a riconoscersi in una scuola o ad assumere il ruolo di discepola o allieva. Rigorosa quanto anticonformista e poco incline alle cerimonie, non era il bisogno di conservare o custodire a muoverla, ma l’andare incontro al nuovo, all’ignoto che può aprire diverse e migliori vie, il non smettere di lasciarsi interrogare per rimanere vigili.
Nel 1960, dopo una gravidanza coraggiosa, nacque Alberto, figlio amatissimo e a lungo sperato da Luciana Nissim e Franco Momigliano.
Fu una stagione fertile e ricca quella che si aprì con gli anni ’60: fu il tempo della maternità; fu il tempo della formazione psicoanalitica e dei molti incontri con gli autori più amati (Klein, Bion, Rosenfeld, solo per citarne alcuni); fu il tempo, come già la giovinezza, delle amicizie, nuove e rinnovate nelle quali la Nissim amava avvolgersi, così numerose, importanti nella sua quotidianità; fu il tempo, infine, di nuove relazioni, via via più numerose e per lei coinvolgenti, quelle con i pazienti nella stanza d’analisi.
La partecipazione di Luciana Nissim alla vita della Società Psicoanalitica Italiana e del Centro Milanese di Psicoanalisi fu, fin da subito, vivace, preziosa e generosa. Nel 1978 divenne psicoanalista didatta e in seguito ricoprì il ruolo di Segretario Scientifico della SPI e di Presidente del Centro Milanese di Psicoanalisi. Lavorò intensamente per molti anni: lavoro prima di tutto clinico, con i pazienti, ma anche scientifico, attraverso una produzione di articoli e contributi teorici che iniziò nel 1974 con l’articolo “Come si originano le interpretazioni nello psicoanalista” (Rivista di Psicoanalisi) e che è continuata fino agli ultimi anni di vita; e, infine, lavoro di supervisione, a contatto con pazienti e analisti in formazione, ruolo che le calzava a pennello.
Non era ancora arrivato il tempo dell’adagio, però, nella vita di Luciana Nissim. Nel 1987 Primo Levi si tolse la vita, a Torino. Luciana Nissim così lo salutò su La Stampa: “Ciao Primo, testimone sulla terra. Nel dolore disperato di oggi resto ormai sola a ricordare l’altro viaggio, e i carissimi Vanda e Franco S. che l’avevano condiviso con noi e non erano tornati. Luciana, 11 aprile 1987”. Pochi mesi dopo, nel settembre 1988, morì Franco Momigliano. Se Primo Levi era l’unico, insieme a lei, ad essere rimasto vivo ad Auschwitz, Franco Momigliano non era stato solo il compagno di vita. Egli era colui che aveva eletto a suo “specchio e censore, quando cadessi nel banale, o nel convenzionale, o, peggio, nel disonesto” (Lettera di L. Nissim a F. Momigliano, agosto 1945) e al quale, anche solo nel ricordo, si era aggrappata per tenersi viva: “ (…) fuori c’è Franco e mi aspetta!”, si era ripetuta nei giorni di Birkenau. E’ in questa solitudine che Luciana Nissim rimise mano ai dolori e agli orrori della sua vita ma anche a quelle fragilità, mai del tutto riconosciute e dalle quali molto si era difesa, combattendo. Nel 1989, in occasione del 36° IPA Congress a Roma tenne la relazione dal titolo “Una famiglia ebraica tra le due guerre”, nella quale, per la prima volta parlava in pubblico di sé ebrea italiana e superstite della Shoah. Nel 1992, infine, dopo quasi 50 anni, volle tornare, da libera, ad Auschwitz-Birkenau. Sono anni non solo di testimonianza attiva ma anche di ricerca: con spirito assolutamente laico, Luciana Nissim s’interessò all’ebraismo, che scoprì di non conoscere abbastanza, e avviò un rapporto con parti di sé meno vitali e a lungo tenute distanti.
Nel 1995, mentre si trovava in vacanza, Luciana Nissim si ammalò. La malattia tumorale che la porterà via le concesse ancora alcuni anni di vita e di lavoro, circondata, fino all’ultimo, dagli affetti più cari.
Muore, nella sua casa di Milano, il 1° dicembre 1998.
IL CONTRIBUTO ALLA PSICOANALISI
 Una psicoanalista capace di cambiare: è una definizione preziosa che Andreina Robutti, collega, amica e autorevole studiosa di Luciana Nissim, ha dato di questa piccola e affascinante donna della psicoanalisi. Fil rouge di tutto il pensiero della Nissim è, infatti, il suo svilupparsi come un lungo dialogo mai dogmatico, ora interiore ora aperto, con “maestri”, colleghi, pazienti. Rigorosa nella formazione classica, Luciana Nissim ha saputo rimanere in cammino lungo tutto il corso della sua vita e lì, disponibile a comprendere e a interrogarsi, l’hanno incontrata i vari sviluppi che la disciplina psicoanalitica ha avuto nel corso degli anni, da Melanie Klein e la sua scuola, a Bion, agli intersoggettivisti e ai narratologi. Attraverso questo itinerario, tutt’altro che eclettico, Luciana Nissim non solo ha saputo tessere e conservare un modello sempre sufficientemente omogeneo, sia sul piano teorico sia sul versante dell’affidabilità clinica, ma ha dato il proprio originale contributo alla psicoanalisi (cfr. G. Di Chiara, 2003). Esso non va ricercato, tuttavia, in qualche mirabilia psicoanalitico, mai prima concepito. Al contrario. Usando una metafora musicale, si potrebbe dire che, pur essendo una compositrice dotata e originale e una solista squisita, Luciana Nissim è stata soprattutto una grande direttrice d’orchestra, in grado di trarre e a far fluire sonorità nuove a partire dalla sua capacità di ascolto rispettoso e profondo di ogni partitura (la lettura sempre attenta degli psicoanalisti del passato ma anche dei suoi contemporanei, senza preclusione di generi né di scuole), dalla conoscenza dei singoli strumenti orchestrali (la strumentazione teorica e tecnica psicoanalitica) e, infine, da una capacità di attenzione, amorevole ma mai indulgente, verso i componenti dell’orchestra, ossia paziente e analista. Non a caso, d’altronde, la Nissim così intitola il testo che segna una svolta nel suo modo di pensare e fare psicoanalisi: “Paziente e analista: una sonata a quattro mani” (1983).
Una psicoanalista capace di cambiare: è una definizione preziosa che Andreina Robutti, collega, amica e autorevole studiosa di Luciana Nissim, ha dato di questa piccola e affascinante donna della psicoanalisi. Fil rouge di tutto il pensiero della Nissim è, infatti, il suo svilupparsi come un lungo dialogo mai dogmatico, ora interiore ora aperto, con “maestri”, colleghi, pazienti. Rigorosa nella formazione classica, Luciana Nissim ha saputo rimanere in cammino lungo tutto il corso della sua vita e lì, disponibile a comprendere e a interrogarsi, l’hanno incontrata i vari sviluppi che la disciplina psicoanalitica ha avuto nel corso degli anni, da Melanie Klein e la sua scuola, a Bion, agli intersoggettivisti e ai narratologi. Attraverso questo itinerario, tutt’altro che eclettico, Luciana Nissim non solo ha saputo tessere e conservare un modello sempre sufficientemente omogeneo, sia sul piano teorico sia sul versante dell’affidabilità clinica, ma ha dato il proprio originale contributo alla psicoanalisi (cfr. G. Di Chiara, 2003). Esso non va ricercato, tuttavia, in qualche mirabilia psicoanalitico, mai prima concepito. Al contrario. Usando una metafora musicale, si potrebbe dire che, pur essendo una compositrice dotata e originale e una solista squisita, Luciana Nissim è stata soprattutto una grande direttrice d’orchestra, in grado di trarre e a far fluire sonorità nuove a partire dalla sua capacità di ascolto rispettoso e profondo di ogni partitura (la lettura sempre attenta degli psicoanalisti del passato ma anche dei suoi contemporanei, senza preclusione di generi né di scuole), dalla conoscenza dei singoli strumenti orchestrali (la strumentazione teorica e tecnica psicoanalitica) e, infine, da una capacità di attenzione, amorevole ma mai indulgente, verso i componenti dell’orchestra, ossia paziente e analista. Non a caso, d’altronde, la Nissim così intitola il testo che segna una svolta nel suo modo di pensare e fare psicoanalisi: “Paziente e analista: una sonata a quattro mani” (1983).
Il percorso scientifico di Luciana Nissim può essere suddiviso in tre fasi principali.
A cavallo tra gli anni settanta e ottanta, l’impostazione clinica e teorica della Nissim è di matrice kleiniana (il filone kleiniano era stato aperto a Milano da Fornari negli anni ’60 e vi aveva trovato ampio sviluppo), imperniata sui concetti d’invidia (invidia primaria), di narcisismo distruttivo, di onnipotenza, rifiuto della dipendenza e sul più recente, fondamentale, interesse verso il controtransfert. Il primo articolo della Nissim, pubblicato nel 1974 sulla Rivista di Psicoanalisi con il titolo “Come si originano le interpretazioni nello psicoanalista” s’inscrive nel dibattito dell’epoca attorno all’interpretazione (a partire dallo storico articolo di Strachey sulle interpretazioni mutative e comprendendo il lavoro di P. Heimann sul controtransfert), ma il vertice non è quello del paziente, bensì quello della situazione analitica e della mente dell’analista. Nissim cita Corrao (e attraverso di lui Bion, Racker e altri), dove afferma che gli elementi che producono le interpretazioni provengono da entrambi i due co-attori primari e paritetici (paziente e analista) e il suo modo di pensare all’interpretazione è già lontano da un mero processo conoscitivo e cognitivo, è qualcosa di più: “un transito profondo, reticolare, mutativo dell’esperienza del paziente attraverso la mente e gli affetti dell’analista” (F. Barale, 2012). Nei lavori successivi si coglie all’opera la stessa urgenza di re-interrogare e ripensare concetti e prassi molto cari, sentiti come preziosi ma al contempo insoddisfacenti se collocati a contatto con il paziente nella stanza d’analisi. In “Un legato molto pesante: la gratitudine”, del 1983, Luciana Nissim rende omaggio a Melanie Klein (e ai propri maestri: gli amati Rosenferld e Bion tra gli altri) chiarendo che cosa per lei sia la gratitudine: cogliere, oltre alla grandezza, quanto di aperto a sviluppi futuri è presente in ogni lavoro (compreso quello di Freud e della Klein), anche quando questo voglia dire accantonare e dismettere parti fino ad allora ritenute essenziali.
Il punto di svolta nel lavoro e nel pensiero di Luciana Nissim è maturato ed è evidente nel suo lavoro più celebre del 1984 “Due persone che parlano in una stanza”, anticipato, in buona parte, l’anno prima al Centro Milanese di Psicoanalisi in un contributo dal titolo “Analista e paziente al lavoro: una sonata a quattro mani”. “Una Klein rivisitata da Bion potrebbe essere un modo abbastanza efficace di descrivere una certa evoluzione attuale, di capire e praticare psicoanalisi. (…) Cercherò dunque di parlare di questo dialogo che in una pagina delle Letture brasiliane Bion definiva ‘una conversazione che dovrebbe assomigliare alla vita reale’, come ha luogo quando due persone sono insieme in una stanza, e la relazione tra queste due persone è a two way affair, una faccenda a due, un parlare di qualcosa che è tra loro, invece che una questione relativa al parlare intorno all’analista e all’analizzando” (L. Nissim, 1984). Due persone che parlano in una stanza, dunque, ma delle quali una – l’analista – sia disposta a raggiungere l’altra – il paziente – ovunque questi si trovi, dismettendo i propri panni e mettendosi dalla parte dell’altro. Da questo vertice di osservazione il paziente diviene il miglior collega dell’analista, giacché egli meglio di chiunque altro sa che cosa voglia dire essere se stesso; inoltre, i fraintendimenti e gli inciampi sperimentati, di volta in volta, in seduta, possono essere visti come difficoltà dell’analista a sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d’onda del paziente e non necessariamente come sue resistenze. Da una simile prospettiva, il dialogo che si vede svilupparsi tra paziente e analista assomiglia a una sonata a quattro mani: le associazioni del paziente – ma anche la sua persecutorietà e distruttività – non sono più così “libere” ma sono risposte agli interventi dell’analista nel qui e ora della seduta. L’ascolto analitico, secondo Luciana Nissim, consiste anche, e soprattutto, nell’attenzione a quello che accade in quel momento tra paziente e analista, rinunciando spesso ad interpretare quello che succede nel paziente.
Dopo il 1984 e fino alla sua scomparsa Luciana Nissim ha continuato a esplorare conseguenze e prospettive aperte dalle proprie riflessioni, sempre attenta e curiosa nei confronti dei molteplici filoni psicoanalitici coesistenti, sia quelli sentiti come prossimi (ad esempio, il modello relazionale d’oltre oceano) sia taluni più distanti. Ironica e anticonvenzionale, in “Una stagione a Vienna: ma Freud era freudiano?” studia, senza retorica, il modo di lavorare di Freud con i suoi pazienti, che scopre assai poco “ortodosso”. La sua attenzione si sposta poi sull’analista, sulle sue difficoltà ad affrontare il cambiamento, e sull’ascolto del paziente. In “Setting: tema con variazioni” (1988) si occupa, non a caso, del setting, principalmente inteso come assetto mentale dell’analista, insieme di misure e di atteggiamenti “parlanti”, anche se senza parole, necessario allo svolgersi dell’analisi, ma anche strumento che contribuisce direttamente al suo realizzarsi (G. Di Chiara, 2003). In “Psicoanalista allo specchio” – articolo che raccoglie due contributi, uno del 1989 e l’altro del 1990 – Nissim approfondisce il tema dell’ascolto rispettoso, suggerendo che l’analista abbandoni un modo sospettoso di ascoltare il paziente (“Si, si… tu dici così ma io so che le cose stanno cosà … Ti conosco mascherina!”) e attui un ascolto “rispettoso” delle difese che il paziente si è costruito per riuscire a vivere, della sua storia personale e della sua realtà.
Nel 1992 viene pubblicato il libro “L’esperienza condivisa”, a cura di Luciana Nissim Momigliano e Andreina Robutti che, raccogliendo i contributi di molti autori, può essere considerato il manifesto della scuola milanese sulla relazione analitica, a riprova di un dialogo fecondo di Luciana Nissim all’interno della comunità psicoanalitica.
Infine, parallelamente al lavoro di analista, Luciana Nissim Momigliano ha sempre affiancato quello di supervisore e didatta, impegnata nella formazione delle future generazioni di psicoanalisti. Certamente, la prospettiva offerta dal lavoro di supervisore sulla relazione analitica non è stata estranea al formarsi del pensiero originale della Nissim; al contrario, è stata utile al superamento di certe cecità che impedivano di capire quanto analista e paziente fossero entrambi parte in causa nella relazione analitica (A. Robutti, 2008). Il volume “Il cerchio Magico. Scritti sulla supervisione psicoanalitica”, pubblicato nel 2008 nei Quaderni di Psicoanalisi del Centro Milanese di Psicoanalisi, raccoglie i contributi dell’autrice su questi temi.
Nell’ultimo scritto pubblicato di Luciana Nissim “Pensieri (irriverenti) per un congresso” (1994), il tema dell’ascolto si amplia e, ancora una volta, diventa invito a lasciare che “la pace nel mondo” – anche quella del mondo psicoanalitico e dei singoli analisti – sia disturbata, secondo la famosa frase di Hebbel riferita a Freud e così spesso citata dalla Nissim. Riflettendo sulla crisi della psicoanalisi e sulle molte e feroci critiche che la scuotono, sia dall’esterno sia al suo interno, Luciana Nissim si chiede se non ci sia qualcosa di vero, se non valga la pena di ascoltare, perché le crisi “ se non ne abbiamo troppa paura, possono rivelarsi anche come crisi benefiche, che riescono a mobilitare risorse vitali e costruttive. Ed è così, con questo augurio, che oggi mi commiato da voi”.
BIBLIOGRAFIA
SCRITTI DI LUCIANA NISSIM MOMIGLIANO
(a cura di Andreina Robutti)
1946a. Ricordi della casa dei morti, in Nissim L., Lewinska P., Donne contro il mostro, Vincenzo Ramella Editore, Torino. Anche in Nissim Momigliano L. 2001 (con il titolo Auschwitz) e in Nissim Momigliano L. 2008.
1946b. Luci e ombre sul fattore Rh, in Giornale della Accademia di Medicina di Torino , 7/12.
1946c. Considerazioni sul fattore Rh nella patologia infantile, in collaborazione con Lattes E., Atti del III Congresso Nazionale della Trasfusione del Sangue, Milano.
1947a. Intervento del fattore Rh nella patogenesi dell’eritroblastosi fetale, in La pediatria del medico pratico, 22/2.
1947b. Ricerche sperimentali sul fattore Rh, in collaborazione con Costantini A. e Lattes E., in Minerva medica, 38/1.
1967. Presentazione, in Bruno Bettelheim, L’amore non basta, Ferro Editore, Milano.
1974. Come si originano le interpretazioni nello psicoanalista, Rivista di psicoanalisi, 20, pp. 144-165. Anche in Nissim Momigliano L. 2001.
1975. Una vicenda analitica esemplare: L’uomo dei lupi e le sue vicissitudini, letto al Centro Milanese di Psicoanalisi (CMP), dattiloscritti di Seminari, Biblioteca del CMP.
1976a. The psychoanalyst’ way, in EPF Bulletin, 9, 1977, pp. 17-22.
1976b. Relazione su la Prima Conferenza della Federazione Europea di Psicoanalisi, in Rivista di psicoanalisi, 22/3, pp. 439-440.
1976c. Omaggio a Rosenfeld, in Gaburri E. (a cura di), Eros e onnipotenza, Guaraldi, Rimini. Anche in Nissim Momigliano L. 2001.
1979. Taccuino d’appunti, in Rivista di psicoanalisi, 25, pp. 178-198. Anche in Nissim Momigliano L. 2001 con il titolo Creatività.
1980. Prefazione, in Di Cagno L. – Rovetta F. (a cura di), Le malattie croniche e mortali dell’infanzia. L’angoscia di morte, Il Pensiero Scientifico, Roma.
1981. La memoria e il desiderio, in Rivista di Psicoanalisi, 27/3-4, pp. 533-545. Anche in Nissim Momigliano L. 2001.
1982a. Note in margine a un testo: la supervisione analitica, in Di Chiara G. (a cura di), Itinerari della psicoanalisi, Loescher, Torino.
1982b. From an analyst’s note-book: some considerations on writing a paper, in International Review of Psycho-Analysis, 9, pp. 45-54 (versione in inglese di Taccuino di appunti, 1979).
1983a. Un legato molto pesante: la gratitudine, in Rivista di Psicoanalisi, 29/2, pp. 263-270. Anche in Nissim Momigliano L. 2001.
1983b. Analista e paziente al lavoro: una sonata a quattro mani, letto al Centro Milanese di Psicoanalisi.
1984a. “Due persone che parlano in una stanza” (Una ricerca sul dialogo analitico), in Rivista di Psicoanalisi, 30/1, pp. 1-17. Anche in Nissim Momigliano L. – Robutti A. 1992 e Nissim Momigliano L. 2001.
1984b. Il supervisore al lavoro, in collaborazione con Manfredi Turillazzi S., in Rivista di Psicoanalisi, 30/4, pp. 587-607.
1985. Una stagione a Vienna: ma Freud… era freudiano?, in La cultura psicoanalitica, Atti del Convegno, Trieste, 5-8 dicembre 1985, Edizioni Studio Tesi, Pordenone. Anche in Nissim Momigliano L. 2001.
1987. A spell in Vienna: but was Freud a freudian?, in International Review of Psycho-Analysis 14, pp. 373-389. Anche in Nissim Momigliano L. 2001.
1988a. Il setting: tema con variazioni, in Rivista di Psicoanalisi, 34, pp. 605- 682. Anche in Nissim Momigliano L. 2001.
1988b. Del corpo e del genere sessuale dell’analista: intervento alla discussione, in Russo L. – Vigneri M. (a cura di), Del genere sessuale, Borla, Roma.
1989a. Una famiglia ebraica fra le due guerre, letto alla « Max Heimann Lecture» The Holocaust in Italy, 36th IPA Congress, Roma. Anche in Nissim Momigliano L. 2001 e 2008.
1989b. Al di là del transfert e del controtransfert, letto al Primo Colloquio Psicoanalitico Italo-Francese, Roma, novembre 1989, e al Centro Milanese di Psicoanalisi. Anche in Nissim Momigliano L. 2001 con il titolo La relazione telepatica.
1989c. The psychoanalyst in the mirror: doubts galore but few certainties, «International Journal of Psycho-Analysis»1991, 72, pp. 287-296. Confluito in Nissim Momigliano L. 2001 con il titolo Psicoanalista allo specchio.
1990a. Le psychanalyste et le superviseur devant le mirror: beaucoup de doutes, peu de certitudes, letto alla «XXII Conference Permanente sur la formation», Londra, ottobre 1990, EPF Bulletin 37, 1991, pp. 63-84. Confluito in Nissim Momigliano L. 2001 con il titolo Psicoanalista allo specchio.
1990b. Lo psicoanalista allo specchio: testimonianze, letto al IX Congresso della SPI, Saint Vincent, maggio 1990, poi in Hautmann G., Vergine A. (a cura di ), Gli affetti, Borla, Roma 1991.
1990c. Ringraziamento. La supervisione, ovvero della “nonnità”, in Bartol G. (a cura di), In due dietro il lettino, Teda edizioni, Castrovillari.
1990d. Presentazione, in Neri C., Pallier L., Petacchi G., Soavi G.C., Tagliacozzo R., Fusionalità. Scritti di Psicoanalisi clinica, Borla, Roma.
1991. Il tè nel deserto: ulteriori considerazioni a proposito de Lo psicoanalista allo specchio, in «Rivista di psicoanalisi», 37/4, pp. 773-819. Anche in Nissim Momigliano L. 2001.
1992a. A spell in Vienna: but was Freud a freudian?, in Nissim Momigliano L. 1992f.
1992b. The analytic setting: a theme with variations, in Nissim momigliano L. 1992f.
1992c. The psychoanalyst faced with change, in Nissim Momigliano L. 1992f.
1992d. The supervisor at work, in Nissim Momigliano L. 1992f.
1992e. On the candidate’s side, in Nissim Momigliano L. 1992f.
1992f. Continuity and Change in Psychoanalisis. Letters from Milan, Karnac Books, London- New York.
1992g. Psicoanalisi del futuro: una psicoanalisi “dal volto umano”?, in Di Chiara G. – Neri C. (a cura di), Psicoanalisi futura, Borla, Roma 1993. Anche in Nissim Momigliano L. 2001.
1992h. L’esperienza condivisa, a cura di Nissim Momigliano L. – Robutti A., Raffaello Cortina Editore, Milano. Ed. inglese, Shared Experience, Karnac Books, London- New York.
1993. Il desiderio dell’analista, letto al Centro Milanese di Psicoanalisi, In Nissim Momigliano L. 2001.
1994. Pensieri (irriverenti) per un Congresso, letto al X Congresso Nazionale della SPI, Rimini, 1994. Anche in Nissim Momigliano L. 2001.
2001. L’ascolto rispettoso. Scritti Psicoanalitici, a cura di Robutti A., Raffaello Cortina Editore, Milano.
2008. Ricordi della casa dei morti e altri scritti, a cura di Chiappano A., Editrice Giuntina, Firenze.
2009. Il cerchio magico. Scritti sulla supervisione psicoanalitica. Con un’intervista di Alberto Lampignano, a cura di Robutti A. e Chiari P., Quaderni del Centro Milanese di Psicoanalisi, Milano.
2012. Il contributo di Luciana Nissim alla Psicoanalisi, di Barale F. in Chiappano A., Ferruta A. (a cura di) (a cura di), Luciana Nissim Momigliano. Una vita per la psicoanalisi. Il paziente miglior collega, Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica – Archivio Storico, Roma.
INTERVISTE e VIDEO-INTERVISTE A LUCIANA NISSIM MOMIGLIANO
1995. Luciana Nissim. Interviste alla storia, di Marcello Pezzetti e Liliana Picciotto Fargion, Fonfazione Centro Documentazione Ebraica di Milano (CDEC) – videocassetta.
1997a. La memoria del bene: Luciana Nissim, di Annamaria Guadagni, in Diario della settimana, 2/8, pp. 14-21. Anche in Nissim Momigliano L. 2001.
1997b. Intervista a Luciana Nissim Momigliano di Alberto Lampignano, in Rivista Italiana di gruppo analisi. Accordi analitici tra individuo e istituzioni, 12/3-4, pp. 131-142
1998. Luciana Nissim Momigliano. Survivors of the Shoah, intervistatrice Vanessa Metta Rosen, Visual History Foundation, http://www.shoah.acs.beniculturali.it/index.php?page=Home&;lang=it
SCRITTI SU LUCIANA NISSIM MOMIGLIANO
CAPOZZI P., Luciana Nissim Momigliano. Una Psicoanalista, in Costruzioni Psicoanalitiche 1/2002, Franco Angeli, Milano.
CHIAPPANO A., Luciana Nissim Momigliano: una vita, Editrice Giuntina, Firenze, 2010.
CHIAPPANO A., FERRUTA A. (a cura di), Luciana Nissim Momigliano. Una vita per la psicoanalisi. Il paziente miglior collega, Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica – Archivio Storico, Roma, 2012.
DI CHIARA G., Il Centro Milanese di Psicoanalisi. Storia delle idee, lavoro presentato al Centro Milanese di psicoanalisi – 23 ottobre 2003.
Maggio 2014
SITOGRAFIA
http://www.aspi.unimib.it/index.php?id=1713
http://www.shoah.acs.beniculturali.it/index.php?page=Home&lang=it
www.anpi.it/donne-e-uomini/luciana-nissim/
www.iltempoinsorte.itwww.treccani.it/enciclopedia/luciana-nissim_(Dizionario-Biografico)/
www.enciclopediadelledonne.it/index.php?azione=pagina&id=636
http://metarchivi.istoreto.it/biografie/p_bio_vis.asp?id=502
Nostalgia

Il Rex, dal film Amarcord di Federico Fellini.
A cura di Ludovica Grassi
La nostalgia è un sentimento complesso in cui s’intrecciano il ricordo piacevole e il desiderio struggente di situazioni o persone del proprio passato ora assenti o lontane, spesso evocati dai sensi. Per la sua condensazione di aspetti temporali, spaziali e sensoriali, può essere utile a integrare e specificare concetti più propriamente psicoanalitici, quali il lavoro psichico, il lavoro del lutto, la ritrascrizione delle tracce mnestiche.
Origini del concetto di nostalgia
Nostalgia è una parola coniata nel 1688 dal laureando in medicina Johannes Hofer (1669-1752), per definire una condizione altrimenti chiamata mal de Suisse, riferendosi alla sofferenza dei soldati mercenari svizzeri che, inviati nelle pianure italiane e francesi, sentivano acutamente la mancanza dei paesaggi montani in cui erano nati. L’affezione era caratterizzata da sintomi quali febbre alta, astenia, perdita dei sensi, vertigini, dolori addominali, e si riteneva che potesse condurre anche alla morte. Una delle ipotesi più bizzarre e affascinanti proposte dai medici militari sulla genesi di questa malattia era che fosse dovuta al danno riportato dalle cellule cerebrali dei pazienti in seguito al costante risuonare dei campanacci delle mucche nei pascoli svizzeri: essa veniva pertanto ricondotta ad una stimolazione sensoriale, in particolare uditiva. La parola nostalgia, un neologismo medico, combinava il termine greco antico nostos, che indicava il ‘ritorno a casa’, con algos, dolore, venendo a significare letteralmente un dolore dovuto al desiderio irrealizzato di tornare al luogo originario, con un accento specifico sul processo (il movimento verso casa) piuttosto che sulla sua realizzazione: un’esperienza di perdita e di estraniamento dalle origini molto antiche.
La nostalgia ha il suo prototipo nel mito di Odisseo, che aspira dolorosamente al ritorno a casa ma lo rimanda sempre, illustrando così la componente ambivalente della nostalgia, che forse ha a che fare con la difficoltà di volgersi indietro e confrontarsi con esperienze e aspetti di sé rifiutati e rinnegati. La nostalgia, che ora non ha più posto nella nosologia medica, può considerarsi una condizione inerente alla natura umana, che comporta sia un dislocamento spaziale sia una sfasatura temporale.
Freud (1907) individuò le basi della nostalgia nel desiderio di ritornare in un luogo familiare e segreto, sulle tracce lasciate da antiche esperienze quasi dimenticate che fantasie più recenti hanno successivamente modificato e abbellito. La nostalgia è dunque il desiderio frustrato di ritorno alla madre (1933). Ferenczi (1924) ha specificato la natura sessuale di tale desiderio, che spinge incessantemente verso il ritorno nel grembo materno, dall’autoerotismo al narcisismo, fino al coito stesso, un atto che riporta parzialmente alla realtà la condizione precedente alla dolorosa rottura della nascita. La nostalgia è un effetto après-coup del trauma della separazione, in cui il riconoscimento dell’inesorabile passaggio del tempo s’intreccia con una forte disposizione affettiva rivolta al passato, e in cui l’oggetto perduto possiede un’intensa qualità narcisistica.
Già Kant (1798) aveva posto in evidenza come il luogo in cui chi soffre di nostalgia vorrebbe ritornare non è reale, ma una rappresentazione costruita mediante l’immaginazione dei sensi: dunque non è mai lo stesso in cui si è vissuti in passato, piuttosto l’idea di tutto ciò che è perduto per sempre. Ciò che desidera il nostalgico non è il luogo della sua gioventù ma la gioventù stessa. Il suo desiderio non aspira a qualcosa che egli potrebbe recuperare ma a un tempo ormai perduto definitivamente. Pertanto nella nostalgia il luogo acquista un’ indebita prevalenza sul tempo. Essa può considerarsi uno stato psichico permeato dal tempo e dallo spazio, e caratterizzato da un movimento specifico di andirivieni fra diversi contesti spaziali e temporali.
Temporalità e lavoro psichico
La temporalità è un elemento centrale nel pensiero psicoanalitico: come ha ben descritto Laplanche, esistono diverse forme di temporalità, a partire da quella lineare del sistema Percezione-Coscienza per arrivare a quella specifica dell’inconscio. Questa temporalità umana non corrisponde a quella dell’organismo vivente e si è sganciata dal tempo cosmologico: è discontinua, caratterizzata da un funzionamento in après coup, dunque con un movimento in avanti e all’indietro che permette l’attribuzione di significati sempre mutevoli alle esperienze passate e presenti. Altra funzione fondamentale della psiche è il lavoro, che negli scritti di Freud appare nei più diversi contesti: lavoro psichico, lavoro onirico, lavoro imposto alla psiche dal suo radicamento nel corpo, lavoro del lutto. La nostalgia, sentimento dolce-amaro di struggente desiderio di ritorno a uno spazio-tempo ormai perduto, ha una relazione complessa con la temporalità: essa può apparire una ribellione contro il tempo, un rifiuto di arrendersi all’irreversibilità della storia e del progresso. Rappresenta pertanto una modalità particolare di declinazione del lavoro psichico in una temporalità non lineare in cui la perdita dell’oggetto non ne comporta la rinuncia, ed è caratterizzata da uno stretto legame con la sensorialità che ne sottolinea il radicamento nello psiche-soma.
Potremmo pertanto collocare la nostalgia in una posizione intermedia fra il lutto e la melanconia. Nella melanconia il dolore è dovuto alla rottura di un legame che porta a un sentimento di perdita che non è riconosciuto, ma negato: la perdita è a tal punto assoluta e definitiva che i legami emozionali con l’oggetto perduto non possono essere sciolti, ma vengono anzi intensificati, portando a una fissazione assoluta all’oggetto perduto, che viene sepolto nell’Io mediante incorporazione. Mentre il lutto è un processo che utilizza il tempo per elaborare gli investimenti sull’oggetto perduto e risolverli uno ad uno, la melanconia dà luogo a una pietrificazione della vita psichica, che viene ad essere paralizzata dal legame esclusivo con gli oggetti morti. La nostalgia ha la specificità di voler conservare la relazione con l’oggetto perduto, che si tratti di una persona, un paese o una cultura. Inoltre, la qualità emotiva duale della nostalgia, che comprende sia un sentimento positivo di benessere o felicità riferiti a un altro tempo/luogo, sia un senso di perdita e tristezza inerenti al presente, è alla base della sua natura complessa. Forse è proprio questa erotizzazione della tristezza che rende tanto difficile vincere la nostalgia. L’esito del lavoro psichico implicato nella nostalgia può variare in base alla qualità della rottura che lo rende necessario, cioè dalla misura in cui si tratta di una perdita narcisistica o oggettuale.
Sensorialità, nostalgia e migrazione
Spesso sono proprio le memorie sensoriali, come quelle gustative nel famoso episodio della madeleine di Proust, a suscitare emozioni nostalgiche. Queste tracce sensoriali costituiscono la dimensione fisica della nostalgia, radicata nelle relazioni ed esperienze primarie, ma diffusa spazialmente e temporalmente nella vita del soggetto, come Proust esprime poeticamente. Il legame della nostalgia con il corpo ed i sensi è un elemento cruciale della sua funzione di dare un senso di continuità all’esistenza psichica ed emozionale, creando quell’ involucro sensoriale che costituisce l’Io-pelle, il primo involucro narcisistico del soggetto.
E’ su questo confine, posto a delimitare identità e alterità, che la nostalgia esprime la difficoltà posta dall’incontro con l’altro e dalla sua integrazione nel proprio mondo. Ecco perché la nostalgia permea i sentimenti dei migranti, di chi abbandona, forse definitivamente, la terra madre con i suoi affetti, legami, cultura: svolgendo una funzione fondamentale di legame e continuità sia in ambito individuale che rispetto alla storia e alle tradizioni familiari, essa può evitare lo sprofondamento in una dimensione melanconica o in un’attitudine di diniego rispetto all’esperienza di perdita.
La nostalgia costituisce pertanto una risorsa cruciale per la costruzione da parte del migrante della sua doppia identità, che richiede vitalità, immaginazione e creatività. La possibilità di ricordare con nostalgia favorisce il sentimento di continuità e coesione malgrado le differenze, le perdite e le rotture. Senza la nostalgia, le memorie affettive e relazionali rischierebbero di andare perdute, svuotando la struttura identitaria e minando il significato della vita, con il rischio di lasciare spazio a rappresentazioni di autogenerazione. “La nostalgia crea il soggetto” (Le Fourn, 2013).
Il lavoro della nostalgia
La natura, prevalentemente sensoriale delle memorie implicate nella nostalgia porta a ipotizzare che essa abbia origine da tracce o resti sensoriali non integrati in rappresentazioni, che pertanto mantengono vivo il legame con gli stati originari: una integrazione sempre incompiuta necessaria a mantenere un gradiente fra tempi e spazi diversi che permetta il riattivarsi di un movimento fra vicissitudini dell’esistenza per cui si è transitati senza mai esperirle completamente. Lo svolgersi nel tempo e nello spazio dell’esperienza individuale e dei processi di soggettivazione lascerebbe dunque necessariamente lungo la strada dei resti o ancoraggi sensoriali tali da permettere, in determinati momenti e situazioni successivi, di riprendere e rimodellare i processi d’integrazione somatopsichica, attingendo a questa fonte somato-sensoriale primordiale. La nostalgia sarebbe così strumento al servizio di quel lavoro, postulato da Freud (1896), di ripetuta riorganizzazione e ri-trascrizione delle tracce mnestiche che costituiscono l’inconscio, portando a scoprire nuovi significati ed espressioni a contenuti psichici preesistenti: è l’aspetto creativo della ripetizione, poiché la nostalgia non aspira a ricostituire una situazione reale e conclusa, ma a recuperare formazioni psichiche che ci appartengono ma in quanto partecipi delle vicissitudini dell’inconscio sono permeate d’ignoto.
Autori psicoanalitici che si sono occupati della nostalgia sono: J.-B. Pontalis (2000), che la definisce come il dolore per un tempo che non si limita a passare, ma annienta, e il desiderio di nascite sempre nuove; Masciangelo (1988), per cui la nostalgia è affetto rappresentante, che offre alle memorie di qualità sensoriale dell’oggetto perduto l’impulso per la ricerca di nuovi oggetti, portando alla creatività e alla simbolizzazione; S. Vecchio (2013), che vi coglie la potenzialità, in quanto memoria sognante, di passare dall’agire al sognare; F. Petrella (2015), che ne ha individuato il legame con la musica, in grado di toccare aree emotive implicate nell’intuizione delle origini e nelle esperienze di perdita e di vuoto.
Bibliografia
Anzieu D. (1985). Le Moi-peau. Paris: Dunod, 1995
Ferenczi S. (1924). Thalassa. Saggio sulla teoria della genitalità.Opere. III: 230-302
Freud S. (1896). Lettere a Wilhelm Fliess (1887-1904) a cura di J. M. Masson. N. 112: 239-244. Torino: Boringhieri, 1986
Freud (1907). Il poeta e la fantasia. O.S.F. 5
Hofer J. (1688). “Medical dissertation on Nostalgia”. Bulletin of the Institute of the History of medicine. 2.6 (Agosto 1934): 376-91
Laplanche J. (1989). Temporalità e traduzione. Per rimettere al lavoro la filosofia del tempo. In Laplanche J. (1992), Il primato dell’altro in psicoanalisi, Roma, La Biblioteca, 2000
Le Fourn J.-Y. (2013). L’adolescence n’est elle pas une metaphore de la migration? Adolescence. Malgré les frontiers, 31, 3: 673-676
Masciangelo P. M. (1988). Su Freud per il dopo Freud. Una riflessione metapsicologica. In Semi A. A.: Trattato di psicoanalisi. Vol. I.: 395-473. Milano: Cortina
Petrella F. (2015). Nostalgia: tema con variazioni. Rassegna Eranos-Jung Lectures. Milano, 13-02-2015
Pontalis J.-B. (2000). Finestre. Roma: Edizioni e/o, 2001
Vecchio S. (2013). Nostalgia delle origini. Percorsi della nostalgia, Benevento, 13-14/09/2013
Vedi anche:
Identikit del Terrore – Strategie di Pace – Marzo 2015
ottobre 2015
Novelletto Arnaldo
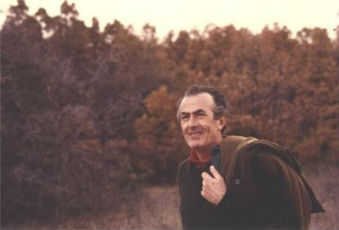
Arnaldo Novelletto
A cura di Paola Carbone
Maestri della psicoanalisi
IN MEMORIA DI ARNALDO NOVELLETTO
31 gennaio 2017
Arnaldo Novelletto ci ha lasciato 11 anni fa, proprio in questi giorni di fine gennaio. Aveva 73 anni ed è stata una fine brusca, che in poche ore ha interrotto tanti preziosi legami e un processo creativo vivo e fecondo.
In quei giorni difficili un piccolo gruppo di carissimi colleghi -Adriana Maltese, Cinzia Lucantoni, Gianluigi Monniello e Giovanna Montinari- nella necessità di fronteggiare il vuoto improvviso si è preoccupato di raccogliere i tanti scritti di Arnaldo che rischiavano di disperdersi perché pubblicati in riviste o in volumi difficilmente reperibili.
E così sono stata amorevolmente coinvolta in una lungo rito di riunioni serali per costruire il libro: L’Adolescente; una prospettiva psicoanalitica (A. Novelletto. Astrolabio, 2009). E’ stato un percorso importante, e ci ha aiutato ad affrontare il grande cambiamento della perdita.
A libro finito, una domenica di ottobre del 2008, Gianluigi Monniello, che era di guardia a Neuropsichiatria Infantile, mi chiese di raggiungerlo per comporre insieme una breve biografia di Arnaldo; passammo tutta la mattina insieme, lui al computer mi chiedeva precisazioni e scriveva; io gli sedevo vicino e gli ero grata. Oggi che anche il carissimo Gianluigi non c’è più è bello per me ricordare tutto il bene che è trascorso tra noi e quanto con la sua amicizia e la sua cultura mi ha aiutato a continuare a sentir vivo Arnaldo.
La breve biografia che segue è frutto di quella domenica mattina e della penna di Gianluigi, di ‘proprio-mio’ c’è solo l’esergo di Melville, una piccola frase a cui tengo moltissimo: la perfetta istantanea di Arnaldo.
Arnaldo Novelletto
(1931-2006)
‘… tu afferri barlumi di quella verità intollerabile ai mortali:
che ogni pensare serio e profondo è soltanto l’intrepido sforzo dell’anima
per mantenere la libera indipendenza del suo mare… ‘
J.H.Melville
Arnaldo Novelletto era nato nel 1931 a Rieti. E’ stato per l’Italia una straordinaria figura di pioniere e un grande maestro nel campo della psicoanalisi dell’adolescenza. E’ morto il 30 gennaio 2006.
Si era laureato in Medicina e chirurgia nel 1954 , a ventitrè anni e nel 1958 era già specialista in Neuropsichiatria. Dopo la laurea aveva iniziato a coltivare contatti con autorevoli colleghi stranieri e nel corso della specializzazione aveva lavorato a Parigi, come Assistant etranger, presso la clinica di neuropsichiatria infantile allora diretta dal professor G. Heuyer. Nel corso di quel soggiorno aveva conosciuto e suscitato la stima di Serge Lebovici che, molti anni dopo lo inviterà, quale rappresentante per l’Italia, a partecipare alla fondazione dell’ISAP (International Society for Adolescent Psychiatry) a Parigi nel 1984.
Ha iniziato a lavorare con gli adolescenti da giovane psichiatra nell’ambito della giustizia minorile ed è sempre rimasto, negli anni, attento alle problematiche del lavoro istituzionale e radicato nell’ impegno civile.
La sua formazione psicoanalitica, iniziata nel 1958, lo vedrà Membro Associato nel 1967, Ordinario nel 1975 e Didatta con funzioni di training nel 1982.
All’interno della Società Psicoanalitica Italiana Arnaldo Novelletto ha svolto un ruolo importante come formatore, come dirigente, come supervisore. Ha fatto parte del Comitato Organizzatore del 26° Congresso IPA (Roma, 1969) e del Comitato Scientifico del 36° Congresso IPA (Roma, 1989). Molti colleghi psicoanalisti e psicoterapeuti di adolescenti italiani lo hanno avuto come analista o come supervisore.
L’insegnamento è sempre stato per lui una grande passione.
La trasmissione delle sue ricerche, delle sue esperienze, delle sue riflessioni è stata generosa e inesauribile. Aveva la rara dote di attivare le menti.
In ambito universitario è stato Professore Associato presso l’Istituto di Neuropsichiatria infantile dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, fino al 1988. Da allora in poi si è dedicato alla professione privata, all’attività di formatore di nuove generazioni di psicoanalisti e di psicoterapeuti dell’adolescenza.
Nel 1984 ha partecipato alla fondazione dell’ISAP, rappresentando l’Italia e portando il suo apporto di clinico e di attento e appassionato conoscitore del funzionamento della mente adolescente. Ha partecipato con importanti relazioni ai Congressi di Parigi, Ginevra, Chicago, Atene, Aix en Provence. Ha promosso le due presidenze italiane dell’ISAP, prima di Adriano Giannotii e poi di Enrico de Vito.
Nel 1986 ha pubblicato il suo libro “Psichiatria psicoanalitica dell’adolescenza”, con la prefazione di Amedeo Limentani, un testo che ripercorre il suo pensiero e rappresenta ancora un contributo fondamentale per tutti coloro che si occupano di adolescenza.
Nel 2000, insieme a Daniele Biondo e Gianluigi Monniello, Arnaldo Novelletto ha pubblicato il libro “L’adolescente violento”.
Dopo aver a lungo collaborato con Adriano Giannotti per il consolidamento e l’insegnamento della psicoanalisi dell’adolescenza in ambito universitario, nel 1994 Arnaldo Novelletto decise di rafforzare ulteriormente il suo impegno nel campo specifico dell’adolescenza fondando, con alcuni suoi allievi, l’ARPAd (Associazione Romana di Psicoterapia dell’Adolescenza) e il corso di formazione per psicoterapeuti dell’adolescenza.
In Italia ha rappresentato una forza culturale aggregante per quei gruppi che cominciavano ad interessarsi all’adolescenza; in questa prospettiva ha organizzato a partire dal 1994, ben sette Convegni Nazionali di Psicoterapia dell’adolescenza; questi convegni, a cadenza biennale e tutti da Novelletto accuratamente preparati sono stati occasioni preziose di incontro che hanno consentito lo sviluppo e il dialogo tra i diversi gruppi italiani impegnati nel lavoro psicoanalitico con gli adolescenti. L’impegno profuso per anni nel creare un terreno comune di incontro ha portato , poco dopo la sua morte, alla nascita dell’AGIPPsA (Associazione Gruppi di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza) , una associazione che testimonia con la sua esistenza la vitalità del messaggio di Novelletto.
Ha diretto la collana editoriale ‘La mente adolescente’, presso la casa editrice Borla, una collana che ha introdotto in Italia i più importanti autori stranieri e presso la quale sono stati pubblicati alcuni testi fondamentali curati da Novelletto stesso, ricordiamo: Adolescenza e Perversione, 1989; Adolescenza, Amore, Accoppiamento, 1992; Adolescenza e trauma, 1995; Separazione e solitudine in adolescenza, 1997; I disturbi di personalità in adolescenza, 2001.
E’ stato Segretario di Redazione di “Infanzia Anormale” (1956-1964), Capo Redattore della rivista “Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza” (1982-1989), Co-direttore della rivista “Adolescenza” (1990-1999) e Fondatore e Direttore della rivista on line “Adolescenza e Psicoanalisi” (AeP) (2001-2006).
Nel 1962 aveva tradotto in italiano ‘Vita e opere di Freud’ di Ernest Jones. La capacità di avvicinare il pensiero degli autori stranieri entrando nelle pieghe originali del linguaggio lo ha portato a promuovere e supervisionare la traduzione in italiano degli scritti di molti psicoanalisti dell’adolescenza (Baranes, Birraux, Braconnier, Chiland, Jeammet, Ladame, Laufer, Marcelli, Braconier, Marohn, Miller) facendoli conoscere – anche personalmente – ai colleghi italiani e instaurando rapporti di amicizia in tempi in cui la psicoanalisi dell’adolescenza era ancora ‘una Cenerentola’ e non ‘una star’, come per certi versi è attualmente divenuta. In particolare Novelletto ha tessuto un forte legame affettivo, di ricerca e di pensiero con Raymond Cahn, ha curato la traduzione di tutti i suoi libri e realizzato con lui, in Italia, molti incontri e seminari clinici. Cahn è socio onorario dell’ARPAd.
Arnaldo Novelletto era uno spirito libero, un ricercatore aperto e sempre critico ; proprio alla luce di questa ricerca e di questa libertà richiedeva a se stesso una totale dedizione verso tutto quanto faceva: che si trattasse di intervenire ad un evento scientifico internazionale, ad una semplice riunione informale, ad un incontro pubblico o privato, ad una serata fra amici.
La sua dedizione non era figlia del ‘senso del dovere’; dal suo prendersi cura traspariva piuttosto il piacere dell’artigiano per la cosa – umile o grande – realizzata ‘a regola d’arte’ e la sua grande passione per l’arte; perché Arnaldo Novelletto non era solo un uomo di vasta e profonda cultura, un raffinato conoscitore della pittura e della musica ( riconosceva al volo epoca di composizione, autore, appartenenza a scuole anche delle opere ‘minori’) ma attraverso l’arte godeva e partecipava del nesso profondo che lega l’opera dell’artista con la vita e con il suo senso.
Quando leggeva il lavoro di un collega o di un allievo lo faceva sempre con la massima attenzione auspicando, in cuor suo, di vederne emergere una serie insospettata di spunti. Provava soddisfazione se poteva sentirsi vicino all’autore e nel suo commento, con generosità arricchiva, ipotizzava pensieri sottintesi, faceva emergere aspetti appena abbozzati nel testo. Cercava di farlo discretamente, ma non dipendeva solo da lui. Ognuno di questi momenti lo impegnava perché era intimamente consapevole del valore del dialogo con se stesso e con l’altro, un dialogo che non andava sprecato, che era significativo.
Così ogni volta che parlava era invariabilmente alla ricerca di nuove riflessioni da proporre. Il suo pensiero si dispiegava per soddisfare al contempo la sua esigenza interiore e quella dei suoi interlocutori attenti. Pensiamo che proprio per questo suo modo di essere il concetto di ‘processo di soggettivazione’ l’avesse subito molto interessato trovando in esso il riconoscimento di un proprio pensiero e di un proprio stile esistenziale.
Aveva titolato la collana di libri che dirigeva ‘La mente adolescente’.
Ha dedicato molte delle sue energie per far arrivare ai colleghi psicoanalisti, agli allievi e per infondere nei suoi pazienti la convinzione che è proprio in adolescenza che la mente si scopre a se stessa, si fornisce i suoi strumenti, si affaccia all’inconscio, raggiunge il suo funzionamento più ampio e decisivo e che, per di più, tutto ciò resta operante. Per Novelletto tale condizione della mente non si esaurisce nell’arco evolutivo di qualche anno, non è solo un transito fra l’infanzia e l’età adulta, ma uno stato della mente in tutti noi presente e potenzialmente attivo. Del resto la più recente ricerca psicoanalitica ci sta confermando che quando il nostro psichismo è in crescita vive una sorta di trasformazione pubertaria.
Nella clinica era semplicemente unico. Rigoroso, attento, partecipe, empatico.
Poteva trattarsi di un bambino, di un adolescente o di un adulto. Il suo ragionamento clinico fluttuava, optava, prendeva una direzione, per poi nuovamente tornare da dove era partito e percorrere nuove traiettorie. (1)
Era un piacere vederlo all’opera.
Aveva una cultura psichiatrica profonda, una frequentazione antica della metapsicologia, un setting del pensiero ed un uso del controtransfert che metteva al servizio della vita psichica della persona del paziente. Era altamente consapevole che l’investimento su di sé è antidoto alle inevitabili proiezioni che l’altro ci riversa e che mettersi al servizio del narcisismo dell’altro è una condizione di innamoramento possibile solo quando lui è lui ed io sono io.
Ha formato con la stessa dedizione tutti i colleghi che hanno vissuto l’esperienza di avvicinarsi a lui.
Gianluigi Monniello
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Nota
(1) Caro Gianluigi , questa nota vale solo per te non andrà nel libro, ma il tuo brano mi ha evocato il seguente brano di Merleau-Ponty, l’ho cercato e copiato per te :‘Una cinepresa ha registrato al rallentatore il lavoro di Matisse: ne risultava una sensazione prodigiosa … . ‘Quello stesso pennello che visto ad occhio nudo saltava da un atto all’altro , ora lo si vedeva meditare, in un tempo dilatato e solenne, come nell’imminenza del principio del mondo, tentare dieci movimenti possibili, danzare davanti alla tela, sfiorarla più volte ed infine gettarsi in un lampo sul solo tracciato necessario’
(‘SEGNI’ , Merleau-Ponty)
Gennaio 2017
Oggetto Invasivo

Kenneth Noland, 1958-70
Oggetto Invasivo
A cura di Maria Antoncecchi
Paul Williams è l’autore che ha coniato il termine di oggetto invasivo. Un concetto originale che si riferisce a un funzionamento mentale che ha come esito l’arresto del processo evolutivo e un danno al nucleo centrale del sé in conseguenza di un trauma emotivo. L’Autore sviluppa la sua riflessione teorico-clinica nel primo capitolo del suo libro “Incorporazione di un oggetto invasivo” in “Oggetti invasivi. Menti sotto assedio”(edizione Mimesis 2020).
L’incorporazione di oggetti invasivi è il risultato dell’espulsione nel bambino di aspetti intollerabili di un oggetto che, usando in modo massiccio il meccanismo proiettivo, crea una situazione di confusione tra l’attività proiettiva dell’oggetto e le proiezioni non contenute del bambino. Questa violenta e primitiva introiezione dà luogo a un’esperienza di inondazione nella mente del bambinoe alla formazione di corpi estranei che danneggiano la personalità nascente del bambino. L’Autore parla di una forma patologica di proto-identificazione che accade nella prima infanzia ed è frutto delle precoci interazioni tra l’infante e l’oggetto e comprende il fallimento del contenimento e delle funzione-alfa materna (Bion 1970, Williams, 2020).
Come chiarisce Paul Williams, l’incorporazione è la prima modalità di relazione che avviene quando non si è ancora formata una separazione tra il sé e l’oggetto e tra psiche e soma. In circostanze ambientali sfavorevoli questa modalità anziché essere abbandonata può prendere il sopravvento e disturbare i normali processi introiettivi. Di conseguenza il sé del bambino si struttura difensivamente intorno a introiezioni mimetiche interrompendo lo sviluppo evolutivo come hanno mostrato Gaddini (1969) nel suo lavoro “Sull’imitazione” e Winnicott (1965) nel suo lavoro “La distorsione dell’Io in rapporto al Vero e al Falso Sé”.
La capacità dell’oggetto di accogliere le identificazioni proiettive del bambino
(Bion,1962) è indispensabile perché possa costruirsi una rappresentazione interna di sé come soggetto distinto e separato. Il fallimento di questa funzione e l’introiezione forzata di aspetti patologici degli oggetti nella psiche ostacolano i processi di integrazione dell’esperienza, necessari ai processi secondari e distruggono lo spazio mentale deputato alla simbolizzazione dell’Io, generando una minaccia “di annichilimento al nucleo originario del senso di sé “(Williams, 2020). A differenza degli oggetti intrusivi che tendono a diventare una caratteristica del soggetto, lo scopo dell’oggetto invasivo non è la colonizzazione della mente dell’altro ma quello di avere un contenitore sempre disponibile per evacuare aspetti indesiderati.
Attraverso il lavoro analitico è possibile rintracciare la presenza di questi stati mentali e somatici avvertiti dal paziente come parti aliene che determinano stati di angoscia cronica, di confusione e di disintegrazione al confine con la psicosi.
A causa della confusione tra il nascente sé infantile e le proiezioni incorporate dell’oggetto è possibile che, durante il trattamento analitico il paziente percepisca il processo di disincorporazione e di disidentificazione dall’oggetto invasivo come una minacciosa perdita del sé, un cambiamento catastrofico (Bion, 1965) indispensabile per il recupero di un buon funzionamento psichico.
Bibliografia
Antoncecchi M. (2021). Note sull’influenza dell’oggetto invasivo in un paziente melanconico. Riv.Psicoanal, LXVII, 3, 531-546.
Bion W.R. (1962). Apprendere dall’esperienza. Roma, Armando,1972.
Bion W.R. (1967). Attacchi al legame. In: Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico. Armando, Roma, 1984.
Gaddini E. (1969). Sull’imitazione. In: Scritti. Milano, Cortina Editore, 1989.
Williams P. (2020). Incorporazione di un oggetto invasivo. In: Oggetti invasivi Menti sotto assedio. Mimesis Edizioni, Milano.
Williams P. (2010). Il quinto principio. Mimesis Edizioni, Milano, 2014.
Winnicott D. (1965). Sviluppo affettivo e ambiente. Studi sulla teoria dello sviluppo affettivo. Armando, Roma, 2004.
Oggetto Parziale
A cura di Maria Paola Ferrigno
Melanie Klein e la nascita della vita psichica: i primi oggetti, gli oggetti parziali.
‘Oggetto parziale’ è un termine che rimanda alla teoria delle relazioni oggettuali nata con il lavoro di Melanie Klein: fa riferimento ai primi passi della vita psichica del neonato, al suo primitivo teatro di oggetti interni ed esterni e alle precoci fantasie che accompagnano la relazione con sé e con il mondo.
E’ a Melanie Klein che si deve una prima esplorazione dell’universo arcaico del funzionamento psichico del bambino.
L’Autrice si avvicinò alla psicoanalisi per cercare comprensione e aiuto per sé e restò profondamente affascinata dal metodo psicoanalitico e dalla sua efficacia.
Ben presto i suoi primi e illustri interlocutori, Sandor Ferenczi e Karl Abraham, riconobbero in lei l’acuta intelligenza, il suo profondo interesse per il metodo psicoanalitico e per lo sviluppo dei bambini e la incoraggiarono allo studio e alla pratica della psicoanalisi, in particolare alla psicoanalisi dei bambini.
Da quel momento, siamo nel 1919, l’Autrice iniziò il suo appassionato lavoro psicoanalitico che, oltre a mettere le basi della tecnica del gioco nell’analisi infantile, permise di fare luce sui funzionamenti primitivi della mente e aprire la strada alla comprensione della schizofrenia e al suo trattamento attraverso il metodo psicoanalitico.
Con il termine ‘Oggetto’, in psicoanalisi, si è indicato, in origine, l’oggetto di un impulso istintuale, inteso come una persona o una cosa che ha la funzione di soddisfare un desiderio, un impulso.
Tale termine è già presente nel lavoro di Abraham e dello stesso Freud: i primi oggetti con cui il neonato stabilisce relazioni inconsce sono oggetti libidici su cui avviene l’investimento delle pulsioni. L’oggetto è considerato, pertanto, meta di impulsi di energia e riconosciuto solo nella misura in cui dà soddisfazione o sollievo alla ‘pulsione’.
Solo negli anni ’30 Melanie Klein, come risultato di un’ attenta osservazione dei suoi piccoli pazienti attraverso la tecnica del gioco, assegna al termine ‘Oggetto’ un significato diverso individuandone una caratteristica più complessa: esso è una componente della rappresentazione mentale di un istinto, primo segnale di vita psichica.
Si tratta di rappresentazioni ‘fantasmatiche’, preesistenti e indipendenti dalla percezione del mondo esterno che permettono al neonato di orientare le pulsioni istintuali. Dall’interazione tra le pulsioni e tali oggetti nasce la relazione oggettuale e si avviano i primi legami.
La Klein diede così l’avvio ad una linea di pensiero psicoanalitico (la scuola delle relazioni oggettuali) che si diffonderà soprattutto nella Società Psicoanalitica Britannica.
Attraverso la tecnica del gioco l’Autrice poté osservare come i suoi piccoli pazienti utilizzavano gli oggetti (giocattoli) che nel loro gioco apparivano vivi e con cui essi stabilivano relazioni molto intense. L’Autrice comprese che, anche in bambini molto piccoli, si sviluppavano sentimenti molto forti per l’oggetto per quanto immaginario esso potesse essere.
Gli oggetti non erano solo passivi ( oggetti su cui il bambino, come sosteneva Freud, scaricava gli istinti) ma erano anche materiale della vita di fantasia del bambino.
Oggetti a cui rivolgere sentimenti, segnali di ‘presenze’ interne che collegavano la dimensione biologica, quella psicologica e quella sociale: corpo, sensazioni, affetti, relazioni.
Descrivendo l’esperienza che il bambino ha dei propri oggetti e il contenuto psicologico delle angosce che egli prova per essi la Klein scoprì che i bambini credono che gli oggetti possiedano intenzioni e motivazioni in linea con i loro particolari impulsi libidici attivi in quel dato momento. Il lattante, che concentra sulla bocca (in quella che viene chiamata ‘fase orale’) l’esperienza con il mondo, può credere anche che l’oggetto frustrante si comporti in consonanza con ciò che lui prova (e quindi può morderlo per vendetta ).
Nel 1952 l?Autrice pubblicò un articolo sull’International Journal of Psychoanalysis in cui affermava con molta forza, sulla base delle sue osservazioni cliniche, una posizione diversa da quella sostenuta da Sigmund Freud.
Mentre il padre della psicoanalisi riteneva che il bambino piccolo vive in uno stato narcisistico che non contempla una relazione con l’altro da sé, la Klein dimostrò mediante l’analisi di bambini piccoli che le relazioni oggettuali, con oggetti interni ed esterni, sono ‘ab initio’ al centro della vita psichica: il funzionamento mentale è dominato, fin dai primi istanti della vita, dalla relazione con ‘oggetti’ distinti dall’Io, presenze interne ed esterne.
Pertanto le pulsioni, a differenza di quanto sostenuto da Freud, sono sempre rivolte all’’Oggetto’ e segnale di una relazione.
La relazione con i primi oggetti, in stretta connessione con le fantasie ad essi collegate, va a comporre, fin dall’inizio, un complesso insieme di realtà oggettuali interne in relazione tra loro e con l’esterno. Esse rappresentano la prima visione del mondo che il neonato ha di sé nel /col mondo.
Nei primi giorni di vita il neonato vive in una sorta di simbiosi con la madre e non distingue il proprio corpo da quello di lei. Egli percepisce il seno materno -oggetto parziale rispetto all’intera madre- come un prolungamento di sé dotato di caratteristiche proprie e onnipotenti.
Il seno, per il neonato, è un oggetto in prima istanza emozionale che ha una funzione piuttosto che un’esistenza materiale. Esso è portatore, nella sua fantasia, di uno stato emotivo -buono o cattivo- e possiede intenzioni e motivazioni nei confronti del neonato stesso.
L’Io, fin dalla nascita, è pertanto coinvolto in un drammatico conflitto tra la pulsione di morte e quella di vita che, di volta in volta, diventano caratteristiche dell’oggetto con cui il neonato entra in relazione: è così che il seno che nutre e che dà quiete, calore, sazietà, benessere e tranquillità viene considerato ‘buono’ mentre il seno che differisce la gratificazione e anima l’angoscia della pulsione di morte diventa il seno ‘cattivo’.
In tale esperienza l’oggetto- seno, con cui il neonato stabilisce una relazione molto intensa, è parziale nel senso che è, per il lattante, una parte ma anche tutto ciò che c’è nell’oggetto.
Attraverso il lavoro di Melanie Klein il neonato non è più visto come immerso in una sorta di beatitudine ma, al contrario, in preda ad emozioni, spesso molto angoscianti, ricollegabili ad una potente angoscia di frammentazione e annichilimento (pulsione di morte) a fronte di esperienze sensoriali e corporee per lui devastanti e misteriose (ad esempio la fame). Nella relazione che egli stabilisce con la madre e all’interno di un continuo scambio con lei, non vi sono pertanto solo sentimenti quali l’amore e la gratitudine ma anche sentimenti distruttivi quali l’invidia, l’odio, la rabbia, la paura di annientamento e l’insoddisfazione.
Il seno della madre –oggetto parziale-, primo e principale oggetto di relazione, alla luce dei desideri istintuali del neonato e delle sue fantasie inconsce, viene investito di qualità che vanno oltre il nutrimento che esso offre.
Il lattante che ha fame, infatti, avverte le sensazioni corporee della fame anche ‘psicologicamente’ e attribuisce il disagio della fame ad un comportamento intenzionale di un oggetto malevolo, concretamente collocato all’interno del suo stomaco; è un’assenza percepita come una presenza che causa la sofferenza della frustrazione: questo oggetto ‘cattivo’ collocato all’interno dell’Io va a far parte del teatro interno popolato di oggetti.
Il neonato pertanto vive in un mondo di buone e cattive relazioni con oggetti ‘parziali’ a seconda delle sensazioni corporee che sperimenta in quel momento: il seno è ‘buono’ quando induce sensazioni piacevoli (ad esempio lo stomaco pieno di latte caldo) ‘cattivo’ quando è causa di sensazioni sgradevoli (ad esempio la fame).
Oggetti ‘buoni’ e ‘cattivi’, attraverso l’introiezione, vanno a far parte del Sè del neonato e danno l’avvio ad un primo senso di esistenza e di identità.
Seno buono e seno cattivo vengono tenuti, nella fantasia inconscia del neonato, ben separati tra loro, come fossero due oggetti distinti.
Egli vive così una situazione tipica della schizofrenia, dove le relazioni sono buone e cattive allo stesso tempo; il neonato teme che il seno cattivo possa perseguitare il seno buono e il Sé cattivo possa danneggiare quello buono: da qui deriva una angoscia di persecuzione di tipo paranoide, come accade nella schizofrenia.
Melanie Klein descrive due modalità di funzionamento del bambino relative allo stato di organizzazione dell’Io in rapporto alle prime relazioni con gli oggetti e alla natura dell’angoscia e alle difese attivate per affrontarla. Una prima modalità, propria di quella che l’Autrice chiama posizione schizoparanoide (nei primi quattro mesi di vita), e una seconda successiva modalità, propria della posizione depressiva, che inizia, temporalmente subito dopo. Il termine ‘posizione’ usato dalla Klein vuole, differentemente dal concetto di ‘fase’ freudiana, evocare l’idea di un continuo va e vieni tra i due stati della mente ed il loro nesso con la qualità della relazione che in quel momento si svolge.
Lo sviluppo del bambino ha alla base una continua elaborazione dei conflitti tra pulsioni di vita e pulsioni di morte, in una costante tensione tra la ricerca dell’oggetto che nutre, dà conforto e benessere e l’angoscia di frammentazione collegata alla frustrazione.
Solo nella seconda metà del primo anno di vita il bambino potrà cogliere l’unità dell’Oggetto, riconoscere la madre come altro da sé e in relazione con altri, in primo luogo il padre. L’unificazione dell’Oggetto apre la strada a un nuovo modo di relazionarsi con l’Oggetto e gli oggetti e porta alla nascita della costellazione emotiva e dei sentimenti.
Ma questa è un’altra storia: è la storia avvincente dell’Oggetto totale e della posizione depressiva che apre nuovi orizzonti alla vita psichica e alle relazioni con il mondo.
Bibliografia
Hinshelwood R.D., 1989, A Dictionary of Kleinian Thought, Free Association Books, London, trad. it. Raffaello Cortina, Milano, 1990,
Klein M., 1935, Contribution to Psychoanalysis 1921-1945, The Hogarth Press, London, 1948, Developments in Pstchoanalysis , The Hogarth Press, London, 1952, trad it. Note su alcuni meccanismi schizoidi, cap. 19 in Scritti 1921-1958,
Kristeva J., 2000, Melanie Klein ou le matricide comme douleur et comme creativitè. Le génie féminin, t. II, La folie, Librairie Arthème Fayard, trad. it. Donizelli, Roma, 2006,
Petot J. M., 1979, Melanie Klein: premières découvertes et premier système 1919-1932, Dunod Paris, trad. it. Borla, Roma, 1982,
Segal H., 1979, Melanie Klein, Karnac Books, trad. It. Boringhieri, 1981.
Novembre 2014
Oggetto transizionale

Linus prima copertina 675
a cura di Gabriella Giustino
Il concetto di oggetto transizionale si riferisce alla comparsa, durante un particolare momento dello sviluppo infantile, di oggetti che assumono un significato speciale per il bambino e di cui i genitori riconoscono intuitivamente l’importanza.
Donald Winnicott, che ha introdotto questo concetto in psicoanalisi, scrive che è ben noto che i bambini appena nati tendono ad usare il pugno o il pollice per stimolare la zona orale ma che poi , trascorsi alcuni mesi, tendono ad usare oggetti speciali (orsacchiotti, copertine ecc.) e ad attaccarsi ad essi in modo da non poterne fare a meno . L’oggetto transizionale ha di solito un potere calmante per il bambino ed egli vi fa ricorso per rilassarsi e dormire.
Dalla suzione del pollice alla comparsa (tra i 4 e i 18 mesi) di un singolo oggetto, dice Winnicott, vi sono molte altre attività (esempio produrre suoni, cantilene, manipolare pezzi di lenzuolo ecc.) che descrivono la progressiva capacità del neonato di maneggiare oggetti non-me e che si collocano tra il pollice e l’orsacchiotto. Queste attività, corredate da fantasie, sono definite dall’autore fenomeni transizionali e si riferiscono ad una area di esperienza del bambino che si colloca nel luogo che collega e separa la realtà interna da quella esterna e che diventerà poi una funzione permanente della psiche.
Winnicott ha scritto molto anche dell’area transizionale (o potenziale) che non è completamente soggettiva né completamente oggettiva e che l’ individuo non cancella mai del tutto. Quest’area infatti viene conservata dall’adulto ed entra in gioco nel campo dell’arte, nella vita immaginativa e nel lavoro scientifico creativo.
L’oggetto transizionale è dunque un oggetto che non fa più parte del corpo del bambino ma non è pienamente riconosciuto come realtà esterna.
Esso è un oggetto reale ma, dal punto vista del bambino, è il suo primo possesso e si manifesta quando il neonato comincia a differenziare tra il Me e il non- Me, passando dalla dipendenza assoluta dalla madre alla dipendenza relativa da lei.
Il neonato per Winnicott nasce in uno stato di estrema soggettività ed è totalmente immerso nella relazione di dipendenza evolutiva dalla madre. L’autore scrive che non esiste un bambino senza una madre (o un’altra figura) che si prende cura di lui per cui lo sviluppo infantile avviene nella diade madre-bambino.
La madre sufficientemente buona (o devota) tende intuitivamente ad adattarsi ai bisogni del bambino ponendo l’oggetto (il seno) esattamente dove e quando il piccolo ha creativamente immaginato di trovarlo.
Se le cose vanno abbastanza bene il bambino deve avere l’illusione di sentire che il seno è anche una sua creazione soggettiva sperimentando una felice sovrapposizione tra oggetto creato e oggetto incontrato.
Una volta stabilita l’illusione necessaria allo sviluppo, la funzione della madre però è anche quella di disilludere il bambino. La madre dà anche misurate e tollerabili frustrazioni dettate dalla realtà facendo di tanto in tanto mancare il seno.
La comparsa dell’ oggetto transizionale è la manifestazione osservabile di questo processo di sviluppo e testimonia perciò la comparsa di uno stato intermedio tra l’ incapacità del bambino di riconoscere ed accettare la realtà e la sua crescente capacità di farlo.
Il bambino ben presto acquisisce diritti sull’oggetto transizionale: lo coccola in modo affettuoso ma nello stesso tempo lo ama in modo eccitato (talora mutilandolo) e questo si riferisce agli stati di quiete ed eccitazione dell’infante in rapporto alla madre.
“Il punto essenziale dell’oggetto transizionale non é il suo valore simbolico”- scrive ancora Winnicott- “quanto il fatto che esso é reale: è un illusione ma é anche qualcosa di reale” .
L’autore scrive anche che non vorrebbe che ci si chiedesse, di questo oggetto, se esso venga dal di dentro o dal di fuori: si deve ammettere il paradosso creativo.
E’ ovvio che qui l’autore si sta occupando anche dei fenomeni misteriosi dello sviluppo dell’immaginazione creativa ed intuitiva della mente umana e delle funzioni inconsapevoli di comprensione emotiva della nostra mente.
Allora, in questo contesto , lo spazio dell’illusione, la condivisione dell’immaginario e l’esperienza che il bambino fa del gioco e di una dimensione ludica condivisa, diventano i propulsori ( nella vita adulta) dell’attività artistica, dell’immaginazione e del pensiero creativo.
Winnicott D.W (1953). Oggetti transizionali e fenomeni transizionali. In: Dalla Pediatria alla Psicoanalisi Martinelli , Firenze.
Winnicott D.W (1971). Gioco e realtà . Armando editore, Roma.
dicembre 2015
Omosessualità

Henry Scott Tuke, 1927
Omosessualità
A cura di Angela Gesuè
Essere omosessuali vuol dire essere maggiormente o esclusivamente attratti/e, sia dal punto di vista sessuale che sentimentale, da persone dello stesso sesso, così come essere eterosessuali indica l’attrazione per il sesso opposto. Entrambi i termini sono recenti.
Il termine omosessuale compare per la prima volta nel 1869 in un pamphlet dello scrittore ungherese Karoly Maria Kertbeny, scritto contro l’introduzione da parte del governo prussiano di una legge che puniva gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso. Termini come ‘pederasti’, ‘sodomiti’, ‘invertiti’, ‘lesbiche’, ‘tribadi’ sono sempre esistiti e sono stati oggetto di testi giuridici, letterari, religiosi. Nel XIX secolo, col prevalere dell’ideale di Salute su quello di Salvezza (M. Foucault), si definisce una sessualità naturale e quindi normale, l’eterosessualità, ed una sessualità deviata, l’omosessualità, non più pratica immorale, ma condizione psicopatologica oggetto di studio e, se possibile, di cura.
L’omosessualità nella letteratura
La letteratura psicoanalitica sull’omosessualità è vasta. Accennerò soltanto ai principali contributi che costruiscono filoni d’idee cui anche autori successivi si riferiscono.
Freud
Nel 1905 nei Tre saggi sulla teoria sessuale, Freud comincia a delineare la fenomenologia di quelle che oggi chiamiamo al plurale ‘le omosessualità’. La preferenza per una persona dello stesso sesso è ‘assoluta’, oppure ‘anfigena’ (oggi si dice: bisessuale); si può verificare in maniera ‘occasionale’, in condizioni quali l’assenza prolungata di un oggetto eterosessuale. Può essere presente fin dall’inizio e persistere per tutta la vita; oppure può comparire o ricomparire anche dopo lunghi matrimoni eterosessuali da cui sono nati dei figli. Alcuni omosessuali vivono la loro tendenza come qualcosa di ovvio e sostengono una parità di diritti con gli eterosessuali. Altri invece sono in conflitto con essa.
Come si forma l’orientamento sessuale nell’essere umano?
Oggi si parla di un intreccio variabile di ognuna delle componenti la triade bio-psico-sociale. Non è una novità. Già in Freud si trova sia una valorizzazione delle molte vicende psichiche che potrebbero interferire con lo sviluppo psicosessuale, sia il riconoscimento di fattori costituzionali. L’omosessualità può essere fatta risalire all’una o all’altra origine, o al comporsi di entrambe.
Nel Ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci (1910), esaminando dipinti e carteggi del grande artista, Freud ipotizza che l’omosessualità sia da collegare al vincolo erotico precoce con la madre. Tale amore troppo intenso è rimosso, ma non ammette di essere sostituito con quello per altre donne. Resta conservato nell’inconscio. Per Freud, un omosessuale di questo tipo si mette al posto della madre, si fonde con essa, e sceglie ragazzi simili a lui da amare come la madre ha amato lui.
In Osservazioni cliniche su un caso di paranoia descritto autobiograficamente (1910), Freud esamina la storia di una malattia psichica narrata in prima persona dal malato, il Presidente di Corte d’appello di Dresda. La linea di riflessione qui suggerita è che sia l’inaccettabilità della pulsione omosessuale passiva verso il padre ad essere il punto di avvio di un processo psicotico. In tal caso, non la presenza dell’omosessualità, ma il suo rifiuto, potrebbe portare ad una grave malattia mentale.
Altre possibili vie di esplorazione dell’omosessualità maschile per Freud: preferire partner dello stesso sesso porterebbe ad evitare la rivalità edipica con il padre, o con figure maschili potenti da cui si temano ritorsioni; oppure ad evitare impulsi di gelosia particolarmente intensi nei confronti di fratelli rivali per il possesso dell’amore materno. Dalla sublimazione delle pulsioni amorose ed aggressive nei confronti dei fratelli può nascere la predisposizione individuale ad occuparsi del sociale.
All’omosessualità femminile Freud dedicherà un solo saggio nel 1920, Psicogenesi di un caso di omosessualità femminile. Pur avendo raggiunto l’interesse per l’uomo ed un tenero attaccamento per i bambini, una giovane di buona famiglia ‘cambia rotta’ quando il padre ha un altro figlio dalla madre, innamorandosi di una signora del bel mondo. Freud ipotizza che la giovane avrebbe voluto un figlio dal padre, ma è stata la madre, l’odiata rivale, ad ottenerlo. Pur non essendo questo l’unico esito possibile, nel suo caso la ragazza, sentendosi delusa e tradita, si identifica con il padre e aumenta l’amore nei confronti della madre per compensare il proprio odio. Non potendola avere come amante, cerca un sostituto cui legarsi al di fuori della famiglia. Diventando omosessuale ‘cede il passo’ alla madre nel rapporto con gli uomini, e così si riappacifica con lei.
Sull’omosessualità femminile, Helen Deutsch, importante allieva di Freud, aggiunge qualcosa in Adolescenza (1944), parlando dei possibili sviluppi dell’omosessualità in quest’epoca della vita, usando le teorizzazioni del maestro sulla bisessualità iniziale. Anche negli adolescenti che diventeranno eterosessuali c’è, per entrambi i sessi, la figura dell’’amico’ o dell’’amica’ del cuore, un doppio di sé che favorisce il distacco dai genitori verso le relazioni con i pari. Invece, nell’analisi di una paziente grave, Deutsch distingue un’omosessualità femminile esclusiva, attribuibile alla necessità di compensare il legame precoce con una figura materna sadica e fonte di sofferenza. Attraverso un’esperienza omosessuale che ricalca i modi di una relazione madre bambina sufficientemente soddisfacente, tale disagio può trovare una riparazione.
Freud nell’ L’io e l’Es (1922), affronta il complesso di Edipo nella sua forma completa (l’amore per il genitore dello stesso sesso – Edipo negativo – l’amore per il genitore di sesso opposto – Edipo positivo) e nelle sue forme parziali. Quando la persona evolve dall’iniziale bisessualità verso l’eterosessualità, per l’influenza congiunta di fattori costituzionali e delle prime relazioni, la componente negativa dell’Edipo si attenua fino a diventare una traccia. Avviene l’opposto quando la persona si forma con un’identità prevalente di tipo omosessuale.
Nel parlare di omosessualità, è costante l’invito di Freud a prestare un’attenzione puntuale alla formazione del mondo interno delle singole persone, al considerarla una variante dello sviluppo e non una malattia (1935). Egli ritiene inoltre che non è possibile trasformare un omosessuale pienamente sviluppato in un eterosessuale (1920), e che la forma di aiuto che un analista può offrire a questo tipo di pazienti è aiutarli a raggiungere il grado maggiore di benessere psichico, che restino omosessuali o meno.
Il dopo Freud
A partire dal dopoguerra si fa strada, soprattutto ma non solo all’interno della letteratura psicoanalitica anglosassone, un atteggiamento più normativo, che vede nell’omosessualità una patologia di gravità diversa: nevrosi, perversione, disturbo nell’area del narcisismo. Nel corso degli anni ’60, autori come Bieber, Ovesey, Socarides, Hatterer sono i capostipiti del movimento delle “terapie riparative” che considerano l’omosessualità una patologia grave, il sintomo omosessuale poliderminato, l’omosessualità curabile e convertibile in eterosessualità attraverso un approccio direttivo-suggestivo. Nell’autobiografia Public Faces, Hidden Lives, H. Brown (1976), un omosessuale che si è sottoposto a questo tipo di trattamento, testimonia che non soltanto non è riuscito a guarire dall’omosessualità, ma ha avvertito vergogna, isolamento e disperazione per il persistere di essa. Numerose analoghe testimonianze riferiscono di sospensioni temporanee delle condotte omosessuali, con inevitabili ricadute dopo transitorie adesioni a una sessualità ‘etero’.
Il cambiamento
Alla fine degli anni ’60 le cose cominciano a cambiare. Prende forza il movimento di liberazione per i diritti degli omosessuali. Una data simbolica: la rivolta di Stonewall (New York) nella notte tra il 27 ed il 28 giugno 1969 (ricordata ogni anno nei vari Gay Pride). Nel 1973 la comunità psichiatrica americana, dopo una lunga “guerra civile” (Lingiardi, 1996), decide l’eliminazione dal terzo Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) dell’omosessualità egosintonica (seguirà poi anche quella ego distonica). Negli anni successivi il vertice da cui si guarda alle omosessualità è diverso.
In Essere omosessuali, un saggio dedicato all’omosessualità maschile, R. Isay (1989) sostiene l’importanza del fattore costituzionale nel determinare la predisposizione all’omosessualità, evidenzia il precoce e prevalente attaccamento del bambino verso il genitore dello stesso sesso e la rivalità con il genitore di sesso opposto. Quest’ultimo può essere per il bambino oggetto d’imitazione per rendersi attraente al genitore desiderato.
L’intensità del legame primario con la madre viene proposto nella letteratura più recente come di estrema importanza per entrambi i sessi. Per le donne, però, è più difficile la differenziazione ed il distacco. Per questo una certa diffusività nell’area della sessualità apparterrebbe a loro più che agli uomini.
Oltre alla disposizione costituzionale, il bisogno di compensare carenze nella relazione con la madre, sentirsi meno ferite dalla mancanza del pene, se può essere sostituita dall’abbraccio materno, e la predilezione per una calda intimità possono far preferire alle future lesbiche una relazione con persone dello stesso sesso (Elise, 2002).
Un altro importante sviluppo suggerisce che, sia per gli uomini che per le donne, la sanità o la patologia all’interno della vita amorosa non coincida più con il genere della persona amata, ma con la capacità di amare; questa, come dicono Bion (1975) e Kohut (1985), sarebbe l’espressione più vera della maturazione psichica della persona.
In Italia, il libro collettaneo Ipotesi gay (2006) segnala la necessità di mantenere uno sguardo insaturo per cogliere le tante possibili articolazioni della tematica omosessuale, da atto creativo e riparativo possibile di fronte all’angoscia di castrazione, a segno di una generale derubricazione del ruolo della psicosessualità rispetto a quello determinante assegnatole da Freud, nel complesso di una visione aperta ed antiessenzialista dell’identità sessuale.
L’omofobia esterna ed interna
Nel 1972 viene introdotto da Weinberg il termine omofobia. Con essa si intende uno spettro di fantasie consce ed inconsce che strutturano una relazione evitante-avversativa, fondata sul disprezzo e sul disgusto nei confronti di tutto ciò che viene sentito come omosessuale (omofobia esterna), oppure sul rivolgimento verso di sé di tale spettro di fantasie, che produce malessere, rifiuto ed autodenigrazione (omofobia interna o interiorizzata). L’omofobia è dovuta all’intreccio di molte radici: la considerazione dell’omosessualità in quel momento storico, frutto del presente, ma anche del persistere di depositi che attraversano le generazioni; la componente personale dovuta all’entità ed alla qualità del trauma che per quel singolo individuo può aver rappresentato la scoperta della propria omosessualità.
Sempre più oggi la richiesta d’aiuto delle persone omosessuali avviene in momenti specifici della vita: in adolescenza, quando prende forma la vita amorosa di ognuno; in età successive, quando si fatica a costruire relazioni che durano, o realizzazioni lavorative che ci rispecchino più autenticamente; oppure quando si cerca di diventare o di ridiventare omosessuali e genitori dopo percorsi di vita passati anche attraverso l’eterosessualità. L’intreccio tra l’omofobia esterna e interna, declinato in modo inedito in ognuna delle situazioni sopra citate, può rappresentare lo specifico di cui gli psicoanalisti sono chiamati oggi ad occuparsi (Gesuè, 2015).
BIBLIOGRAFIA
Bion W.R. (1975) Memoria del futuro. Il sogno. Milano, Cortina, 1993.
Brown H. (1976) Familiar Faces, Hidden Lives. Harcout Brace Jovanovich. New York.
Deutsch, H, (1944) Psicologia della donna. Volume primo: l’adolescenza. Boringhieri, Torino,1997.
Elise D. (2002). The primary maternal oedipal situation and female homoerotic desire. Psychoanalytic Inquiry, 22, 2, 209-228.
Freud, S. (1905) Tre saggi sulla teoria sessuale. OSF. IV
Freud, S. (1910) Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci. OSF. VI
Freud, S. ( 1910) Osservazioni psicoanalitiche su un caso di paranoia descritto autobiograficamente. OSF.VI
Freud, S. (1920) Psicogenesi di un caso di omosessualità femminile. OSF. VIII.
Freud, S. (1922) L’Io e l’Es. OSF. IX.
Freud, S. (1935). Lettera a Nrs. N. In: Jones E. (1935) Vita e opere di Freud, III. Milano, il Saggiatore, 1953.
Gesuè, A (2015) Un futuro a ciascuno. Omosessualità, creatività e psicoanalisi. Milano, Mimesis.
Kohut H. (1985) I Seminari. Teoria e clinica della psicopatologia giovanile. Roma, Astrolabio,1989.
Isay R.A. (1989). Essere omosessuali. Omosessualità maschile e sviluppo psichico. Milano, Cortina, 1996.
Lingiardi V. (1996). Omosessualità: mito psicoanalitico e corredo genetico. Postfazione a: Isay R. A. (1989).
Pozzi O., Thanopulos S. (a cura di, 2006). Ipotesi gay. Roma, Borla.
Padre/immagine paterna

“Figliol prodigo”, Giorgio De Chirico, 1922
A cura di Stefano Lussana
In termini analitici, è possibile attribuire al concetto di padre un duplice significato: come “oggetto esterno” appartenente alla vita familiare e come “oggetto interno” facente parte dell’esperienza psichica individuale ( “avere” un padre); dall’altra possiamo intendere il padre (“essere” un padre), come figura maschile rappresentante un “soggetto”, che genera e cresce dei figli, sostenendo un “ruolo” ed esprimendo una “funzione” per aiutare la prole nella formazione di un’identità personale specifica e nella costruzione di una matrice relazionale condivisa da svilupparsi progressivamente nel corso dell’esistenza. Naturalmente un discorso del tutto simile riguarda la madre. In questo modo si pongono delle differenze generazionali tra genitori e figli e quelle sessuali tra genitore di un sesso e figlio dell’altro. La distinzione di genere, padre di sesso maschile e madre di sesso femminile, non è più certa come una volta, dato che in assenza di uno o entrambi può succedere che chi ne fa le veci, siano il padre o la madre restante o siano una coppia omosessuale adottiva o infine sia una persona appartenente ad un sesso diverso dal genitore che lascia il posto, come nel caso delle coppie omosessuali maschili e femminili.
Il padre è di solito considerato come una persona che è presente all’interno di una relazione di tipo fondamentalmente triangolare, in una posizione di terzietà rispetto alla diade madre bambino. A questa realtà corrisponde un vissuto intrapsichico profondo nel padre e nei figli bene rappresentato dalla costellazione classica del complesso d’Edipo propriamente detto in cui si svolge una dinamica di natura conflittuale a base violenta, improntata sulla rivalità e, in casi estremi, sull’uccisione dell’altro per quanto riguarda il padre e il figlio di sesso maschile e sulla seduzione e, in casi limiti, sullo stupro per quanto riguarda il padre e la figlia di sesso femminile. Il complesso di Edipo si può anche configurare da una parte come complesso di castrazione, che designa la funzione normativa trasmessa dalla legge simbolica del padre, riguardante l’interdizione dell’incesto e la proibizione del parricidio e dall’altra come complesso paterno, che definisce la relazione d’ambivalenza, di odio e amore e di rivalità e alleanza tra i figli e la figura paterna. In quest’ultima area l’Edipo può trasformare un senso di responsabilità del padre verso il figlio in un processo di identificazione del figlio verso il padre. Sussiste una tenace difficoltà a valorizzare la figura del padre come una persona che influenza la relazione diadica madre lattante, una dinamica a carattere specificatamente preedipica, il cui compito sarebbe quello non tanto di interessarsi del figlio in modo diretto, ma quanto di proteggere la madre occupata ad allattare il suo bambino, sgravandola di tutte le altre mansioni della vita quotidiana, in cui offrirle un contenimento per elaborare le intense angosce manifestatesi con la maternità. Un padre, così come una madre, debbono muoversi all’interno di delicati equilibri familiari, tenendo conto di un doppio ruolo e funzione nel gruppo, quello di integrare la genitorialità, la necessaria attenzione ad un investimento affettivo per i figli in crescita, con la coniugalità, la capacità di tenere vivo e di alimentare il rapporto di coppia.
Comunemente si fa riferimento al ruolo e alla funzione di una coppia genitoriale, e quest’ultimo prende corpo sotto forma di una sorta di codice genitoriale modificabile, simile a quello genetico, cioè il dna della vita, che bisogna integrare e adattare all’ambiente circostante. I codici paterno e materno sono, secondo Fornari, un insieme di norme che plasmano le relazioni affettive genitori figli. Il codice paterno è quello che guida, che protegge, mette regole, segna limiti, propone rigore e provoca frustrazioni. Il codice materno accoglie, alimenta, cura, elabora, fornisce comprensione, esprime amore. Ovviamente la realtà è molto più complessa e ci dice che ruoli e funzioni possono essere anche intercambiabili, saltuariamente o stabilmente. Più in dettaglio il ruolo del padre è molto importante come figura centrale ai fini di una buona identificazione maschile da parte del figlio. In questo contesto sono interessate le strutture psichiche paterna e filiale formatesi nel Super Io, a sua volta costituito dall’Ideale dell’Io e dall’Io ideale. In altre parole il ruolo paterno riguarda la struttura, cioè l’identità psichica paterna che deve servire da specchio all’identità psichica del figlio maschio. Allo stesso tempo la funzione del padre è particolarmente rilevante in quanto punto di riferimento nella vita del figlio, avendo lo scopo di modulare i rapporti significativi con l’altro nel quale opera un bagaglio di esperienze che permette la ricerca accurata di una sintonizzazione affettiva. In tale ambito si attua un processo psichico paterno e filiale sul piano delle manifestazioni interattive e trasformative delle relazioni intime, che si propaga ad un campo allargato familiare sociale, comprendendo anche quello culturale ed etico. In altre parole la funzione paterna riguarda il processo, cioè la relazione tra le due menti di padre e di figlio nel corso della vita, da quella tra un adulto e un bambino, a quella tra due adulti. La figura paterna in sostanza cammina su due gambe, il ruolo paterno e la funzione paterna. Tutte e due esprimono intensamente il loro dinamismo dialogando dialetticamente con madre e figlio in diverse condizioni psicologiche e sociali. Un ulteriore considerazione da fare è quella che l’elaborazione mentale della figura paterna dal bambino all’adulto segue il percorso che porta dalla comparsa dell’angoscia del fantasma paterno alla formazione rassicurante del suo simbolo. Quindi infine in termini bioniani, secondo alcuni autorevoli analisti, il ruolo paterno e la funzione paterna sono assimilabili alle oscillazioni costanti tra capacità negativa, la perseverazione nella ricerca e l’istillazione del dubbio, e il fatto scelto, ovvero la capacità di riconoscere e di prendere decisioni.
La figura paterna, pur vivendo un’evidente crisi del suo status, si contraddistingue per una posizione complessa di natura ambigua che oscilla tra condizione concreta e astrazione simbolica, dimensione intrapsichica e fenomeno intersoggettivo, sistema familiare e mondo sociale, e può esprimersi secondo diversi modo di intenderla (si tratta di tipologie paterne parziali e incomplete). Si va dal Padre biologico, colui che genera il figlio al Padre sociale, colui che riconosce il figlio davanti alla legge assumendosene la responsabilità, come ad esempio un padre adottivo; dal Padre rigoroso e severo, colui che proscrive quello che non si deve fare nella vita, interiorizzato nel figlio dal Super Io al Padre ideale e idealizzato, colui che prescrive quello che si dovrebbe essere, interiorizzato nel figlio dall’ideale dell’Io; dal Padre castratore, colui che ha sia una valenza negativa quando mette in pericolo l’incolumità psicofisica e la vita dei figli e sia una valenza positiva quando li sottrae dall’incesto, riducendo il predominio della figura materna e preparando il terreno per l’altro e la legge; al Padre affettuoso: colui che ama il figlio, un padre materno, che può prendersi cura teneramente di lui con le modalità che abbiamo detto; al Padre amante: compagno sessuale e affettivo della madre, necessario per un’equilibrata circolazione degli investimenti emotivi in famiglia; al Padre seduttore, colui che alimenta il desiderio, stimola la progettualità lavorativa e affettiva, spinge ad essere ambiziosi nella vita; e infine al Padre spirituale, il quale fornisce gli strumenti che permettono al figlio di passare dal fantasma al simbolo, in altri termini da una forma di pensiero basata sulle emozioni ad una configurazione dell’intelletto fondato sul ragionamento critico e astratto.
Come si configura nella mente del lattante e del bambino la figura del padre, attraverso quali sensazioni, visioni, fantasie e pensieri? Il modello kleiniano sembra offrire del materiale appropriato a questo riguardo. In estrema sinesi il lattante nella posizione schizoparanoide alterna la presenza gratificante e l’assenza frustrante del seno della madre come oggetto a volte buono o a volte cattivo. In realtà quest’ultima viene sperimentata come una coppia genitoriale, chiamata figura parentale combinata, caratterizzata dalla persecutorietà, al tempo stesso odiata e temuta. Tale configurazione paterno-materna può essere descritta come un oggetto parziale cioè un pene che occupa il seno della madre o l’interno della madre. A questo punto l’esperienza del padre viene riferita ad un oggetto interno per opera della fantasia inconscia del bambino. All’epoca dello svezzamento nella posizione depressiva il bambino potrà riconoscere la madre e il padre come un oggetto totale, separati e autonomi, contemporaneamente un oggetto buono e cattivo. In ultima analisi il padre rappresenta per il bambino la possibilità di esplorare nuovi oggetti nella vita. Come nel racconto biblico la donna viene creata dalla costola dell’uomo, così per il bambino, nella concettualizzazione kleiniana, il pene del padre viene creato dal corpo della madre, figura centrale nell’universo psichico dello sviluppo infantile.
Nella teorizzazione freudiana il padre e quindi di conseguenza il rapporto padre figlio sono stati visti all’interno della dinamica edipica, del complesso d’Edipo, dalla sua insorgenza al suo tramonto, passando attraverso una conflittualità (che può includere fantasie omicide). Questo è sicuramente un modello fondamentale di riferimento, che deve essere integrato da altri contributi. Occorre una visione mitologica non solo tragica, ma basata su altri fattori, diciamo così più pacifici. Contemporaneamente a Freud in campo letterario James Joyce nel suo celebre romanzo Ulisse racconta le avventure quotidiane di un uomo medio contemporaneo che assurge in modo ironico e in maniera elegante ad antieroe e ad antimito dei nostri tempi e si occupa della tematica relativa alle relazioni tra le generazioni in senso bidirezionale, in altre parole possiamo osservare la ricerca del padre da parte del figlio e la ricerca del figlio da parte del padre. In tempi recenti alcuni analisti, in particolare Recalcati, hanno ipotizzato anche la presenza di un complesso di Telemaco che sembra aprire la via al ritorno della speranza di una guida paterna e alla ripresa del desiderio di un mondo che offra un futuro possibile per i figli, tutto questo rappresentato dalle gesta dell’eroe omerico che, dopo un viaggio lungo e avventuroso, fa rientro a casa, coronando le aspettative del figlio in attesa di un padre amichevole. Ritornando a Ulisse di Joyce, il figlio Stephan Dedalus, a proposito del padre Leopold Bloom, o ancora più precisamente di un padre per tutti i figli, afferma dall’interno delle proprie viscere: “un padre è un male necessario”. La nostra vita non può prescindere da un padre o da chi ne fa le veci. Dramma catastrofico è la completa assenza di un padre. Senza idealizzare e senza svalutare il suo ruolo e la sua funzione dobbiamo convivere con l’idea di un padre che costituisca un male minore con il suo ridimensionamento, con le sue mancanze, con le sue debolezze e con le sue rigidità. Questo discorso va integrato su un piano profondamente emotivo, in caso di lutto paterno, relativo alla nostalgia della perdita del padre esterno, accompagnato dall’incoraggiamento ad utilizzare il padre interno. Ciò può alimentare e proteggere la ricerca autentica del bisogno e del desiderio della figura paterna nelle sua potenzialità e nella sua interezza, nelle sue trasformazioni e nei suoi cambiamenti, che culminano nel riconoscimento dell’alterità tra l’identità del padre e l’identità del figlio. Un padre come male necessario o male minore potrebbe intendersi non per forza un padre cattivo, ma, in senso winnicottiano, mutuandolo dalla madre, un padre sufficientemente buono, che, incontrando la concettualizzazione kleiniana, possa alternare sentimenti ostili e affetti amorevoli.
Bibliografia
Bion W. (1962). Apprendere dall’esperienza. Armando, Roma.
Bion W. (1970). Attenzione e interpretazione. Armando, Roma.
Foresti G.(2013). La funzione paterna: fattori intrapsichici, relazionali e sociali. Spiweb.
Fornari F.(1981). Codice vivente. Torino, Boringhieri.
Freud S. (1899). L’interpretazione dei sogni, OSF3.
Freud S. (1905). Tre saggi sulla teoria sessuale.OSF4.
Freud S. (1913). Totem e tabù. OSF7.
Freud S. (1924) Il tramonto del complesso edipico. OSF10.
Klein M. (1958) Scritti 1921-1958. Torino Boringhieri.
Joyce J. (1921). Ulisse. Milano, Mondadori, 1960.
Recalcati M. (2013). Il complesso di Telemaco. Milano, Feltrinelli.
Winnicott D. (1971). Gioco e realtà. Armando, Roma.
Passione

SALVADOR DALÌ , 1934-35
A cura di Anna Migliozzi
Secondo Segal (2007) una delle qualità per essere o diventare psicoanalisti è la capacità di avere o comprendere la passione.
Tuttavia, proprio in psicoanalisi la passione ha vissuto un destino controverso: avvicinata all’isteria, viene descritta come una forma di eccitamento, volta ad eludere l’amore reale per evitare la sofferenza o annullare l’analisi mentre, assimilata al furore, è descritta come un sentimento violento, capace di alterare l’intera personalità.
Già Freud (1915), pur attirando l’attenzione sul potere dirompente della passione (che, nel transfert, prendeva la forma dell’amore), riteneva opportuno governarla, evitando di metterla a tacere con surrogati. Svelando le radici infantili di questa passione amorosa, la paziente avrebbe recuperato una vitalità spenta troppo precocemente, consentendole di riuscire ad amare nella vita reale ( Rappaport 1956; Blum 1973; Meltzer 1974; De Masi 1989; Bolognini 1994; Bollas 1994). Qualora la passione fosse riuscita a far deragliare il processo psicoanalitico o pervertito la dinamica transfert-controtransfert, avrebbe perso la sua qualità trasformativa destinando la paziente a rimanere legata all’analista senza riuscire a proiettarsi nella vita reale e nelle relazioni (Major, 1985; Bergmann 1997).
Per Bion (1963), invece, la passione, che è la prova che ci sono almeno due menti e che sono legate, è un’emozione esperita con intensità e calore, che non rimanda necessariamente a qualcosa di violento e che non tenta ineluttabilmente di offuscare la ragione spingendola verso l’irrazionalità. Anzi, viene considerata un elemento essenziale per il buon funzionamento delle nostre facoltà razionali, in grado di dare significato e senso alla nostra esperienza umana (Ogden, 1991), permettendoci di percepire il “[…] misterioso atto creativo della mente” (Meltzer, 1986, 102). La passione necessariamente presente nel campo analitico, arriverebbe a potenziare la ricettività verso ciò che accade in ogni momento tra paziente e analista e favorirebbe la trasformazione dell’esperienza.
In quanto componente di L, H e K (Love, Hate, Knowledge, elementi astratti per indicare i legami emotivi esistenti tra il sé e gli oggetti e tra gli oggetti) la passione non viene dunque ridotta alla sfera del desiderio sessuale (Il sesso è un nome – Bion, 1991, 206) e nemmeno a quella del teatro d’amore (Io amo ?… si applica al ‘discorso’ non ad amare’ – Bion, 1991: 208) ma offre invece una doppia valenza: è un processo emozionale, che sviluppa legami, ed è un elemento fenomenologico, che crea meta-concetti ( Meltzer, 1978).
In questo modo, nella seduta analitica, la passione permette all’analista di diventare “oggetto dell’esperimento inconscio dell’altro” (Ogden 1997,10), per affrontare ciò che altrimenti sarebbe insopportabile e per portare alla luce ciò che prima era sconosciuto o non ancora rappresentabile (capacità di contenimento). E’ quindi, a tutti gli effetti, un modo di amare perché insieme alla rêverie – la capacità di pensare-sognare – si sviluppa in un rapporto con un oggetto, una madre o un analista, che è in grado di fornire e sviluppare gli elementi costitutivi della mente.
Per Bion, l’amore appassionato “[…] quanto di più vicino ad una trasformazione verbale che ‘rappresenti’ la cosa-in-sé, la realtà ultima, la O”, ci permette di rinunciare alla nostra rigorosa razionalità a favore di una posizione più sfumata che abbraccia l’assenza di chiarezza per riuscire a vedere gli aspetti insoliti della realtà in uno stato d’animo simile a quello dei mistici e dei poeti”.
Bibliografia
Bion, W.R. (1962). Apprendere dall’esperienza, Armando, Roma 1993
Bion, W. R. (1963), Elementi della psicoanalisi, Armando, Roma 1973
Bion WR (1985). Seminari Italiani. Borla, Roma 1985.
Bion WR (1991). Memoria del futuro, Il sogno, Cortina, Milano 1993
Billow RM (2000) From Countertransference to Passion. Psychoanal Q. 69:93-119
Billow RM (2000). Bion’s “Passion”; the Analyst’s Pain. Contemp. Psychoanal., 36:411-426
Bollas, C. (1994). Aspects of the Erotic Transference. Psychoanal. Inq., 14:572-590
Bolognini, S. (1994). Transference: erotized, erotic, loving, affectionate. Int. J. Psychoanal., 75: 73- 86.
Buechler, S. (1999). Searching for a Passionate Neutrality. Contemp. Psychoanal., 35:213-227
De Masi F, Idealizzazione e erotizzazione nella relazione analitica, Rivista Psicoanal., 34:76-120
Freud, S. (1924) Il problema economico del masochismo,
Freud, S. (1915). Osservazione sull’amore di transfert
Grotstein, J.S. (1979). Demoniacal Possession, Splitting, and the Torment of Joy: A Psychoanalytic Inquiry Into the Negative Therapeutic Reaction, Unanalyzability, and Psychotic States. Contemp. Psychoanal., 15:407-445
Grotstein, J.S. (1996). Bion’s Transformations in “O”, the Thing-in-Itself and the Real: Toward the concept of the Transcendence Position. In Journ. of Melanie Klein and Object Relations, 14, 109-141
Grotstein, J.S. (2007) Un raggio di intensa oscurità L’eredità di W. Bion, Cortina, Milano 2010
Major, R (1984). Love for Transference and Passion for Signifiers: Between Sabina S. and Anna G. Psychoanal. Inq., 4:171-191
Meltzer D (1974). Narcissistic Foundation of the Erotic Transference. Contemp. Psychoanal., 10:311-316
Meltzer D (1976) Temperatura e distanza come dimensioni tecniche dell’interpretazione, in La comprensione della bellezza e altri saggi, Loescher, Torino 1981
Meltzer D (1978), The Kleinian Development, Part III: The Clinical Significance of the Work of Bion. Perthshire, England: Clunie Press, London 1978
Meltzer D (1986) Studi di Metapsicologia Allargata. Applicazioni cliniche del pensiero di Bion, Cortina, Milano 1987
Ogden, T.H. (1991). An Interview with Thomas Ogden. Psychoanal. Dial, 1:361-376
Ogden, T. H. (1994). The Analytic Third: Working with Intersubjective Clinical Facts. Int. J. Psycho-Anal. 75:3-19
Segal H. (2007) Encounters through Generations, filmed events organised at the British Institute of Psychoanalysis, London.
Novembre 2014
Pediatria/Psicoanalisi
A cura di Elena Molinari
Ambulatorio pediatrico: domande sorprendenti e nascita di pensieri psicoanalitici
Invece della via storica che ripercorre le tappe dello sviluppo di un dialogo tra pediatria e psicoanalisi, scelgo la via di illustrare con schegge di vita quotidiana il mio essere pediatra e psicoanalista per mostrare come possa mescolarsi il pensiero psicoanalitico a quello medico oggi; pensieri e pratiche di salute psichica e fisica che molti pediatri praticano rimangono meno fecondi perché occultati da una non consapevolezza del loro valore.
Una visita di controllo
“Di quale colore saranno gli occhi della mia bambina?” mi domanda con una sfumatura di preoccupazione giovane mamma. “Importante è che siano sani! Ora sembrano blu perché la cornea è ancora trasparente e si vede il riflesso della retina.
Un piccolo frequente dialogo e una risposta che viene un po’ in automatico considerando solo la spiegazione scientifica. E’ evidente che una tale risposta non serve, ma soprattutto elude un’importante domanda: perché le mamme sono così incuriosite dal colore degli occhi del proprio bambino?
La prima idea da cui ci si può lasciare sorprendere è che le madri si pongono il problema della forma, si interrogano sulle proporzioni, sul colore, la somiglianza e l’allusività che sono questioni che normalmente si pongono gli artisti. La domanda sul futuro colore degli occhi rappresenta quindi qualcosa di più di una domanda o di un corollario della preoccupazione materna.
Una prima ipotesi (psicoanalitica) è che le madri, come gli artisti, possano interrogarsi sulla compiuta bellezza di ciò che hanno generato per rassicurarsi rispetto ai sentimenti di difficoltà che possono aver provato per generare. Se si usa però una teoria già confezionata si avverte che la spiegazione che ci auto-forniamo riguarda appunto ciò che le mamme hanno passato, ma nelle loro domande esse si dimostrano preoccupate su ciò che si deve ancora esprimere compiutamente, cioè qualcosa che riguarda il futuro. Possiamo immaginare che, dovendo dar senso ai molti segnali del loro bambino (perché piange, sorride, dorme o si sveglia), devono come imparare a sognarne il corpo. Come gli artisti devono cioè osservare un dato sensoriale, lo devono de-formare facendolo passare attraverso i propri occhi, lo devono impastare con le proprie emozioni e trasformarlo in un’immagine, poi devono ri-trasformare questa immagine (un vero e proprio sogno ad occhi aperti) in azioni, parole, suoni cucite insieme da un senso possibile. Le madri fanno tutto questo inconsapevolmente e inconsapevolmente creano la mente- corpo dei loro bambini osservando il loro corpo-mente e sognandolo.
Un comune disturbo del sonno

Piero, un bambino di 4 anni ha difficoltà ad addormentarsi e soffre di frequenti angosciati risvegli durante la notte. Mentre mamma e pediatra parlano, Piero disegna la sua casa orgoglioso di aver trovato da poco una soluzione grafica per rappresentare i diversi piani dell’edificio. Che l’acquisizione sia recente lo testimonia la difficile integrazione tra il vecchio schema di casa, cioè il quadrato sormontato da un triangolo, e la forma rettangolare caratteristica di un condominio. Terminata questa prima fase Piero annerisce alcune finestre.
Hai colorato di nero le finestre…così sono chiuse?
Piero: Sono le tapparelle! Se Babbo Natale viene e non ti sei ancora addormentato, non ti lascia i regali.
Immagino che in questo periodo emozioni non facilmente digeribili interrompono il sonno e sopravanzano la sua capacità di costruire il sogno.
Penso perciò che il suo disegno sia non solo il racconto di un evento atteso, i doni natalizi, ma anche un derivato figurativo del sogno della veglia che Piero sta facendo in quel momento mente sente il pediatra e la mamma mentre parlano delle sue difficoltà. Immagino che la funzione trasformativa della sua mente continui a lavorare per metabolizzare sentimenti difficili che caratterizzano il suo rapporto con i genitori in questo momento della sua crescita: un senso di esclusione molto angosciante che nasce dalla richiesta che lui si comporti più “da grande”.
Penso che il disegno rappresenti il desiderio di Piero di essere come i suoi genitori gli chiedono: un bambino capace di ubbidire e di tollerare le difficili emozioni che comporta l’andare a letto separandosi da loro. I doni di Babbo Natale rappresentano la ricompensa attesa rispetto a questo adeguamento che la crescita (che la casa a più piani testimonia) gli impone.
Il travaglio però riemerge sia nella difficile integrazione fra modelli di casa a cui accennavo sopra, sia dal segno che, nell’annerire le finestre, diventa meno controllato, permeato da emozioni intense che faticano a rimanere entro i margini. Questo abbassare le tapparelle o chiudere gli occhi risulta difficile ed è necessario che una speranza, insieme ad un vero e proprio sogno inconscio sostengano il difficile processo elaborativo della solitudine e della rabbia.
Ospedale: quando il sogno diventa un incubo

Questa immagine rappresenta un momento di riposo durante la fuga di una famiglia che cerca di sottrarre alla morte il proprio bambino. Nonostante l’angoscia incombente l’atmosfera che viene rappresentata è di apparente tranquillità; è un momento in cui il bambino, contenuto nell’abbraccio materno, riesce ad addormentarsi. Il padre con il suo doppio nell’angelo sembra costruire il ritmo e la cornice per quest’atmosfera. E’ partendo da questa capacità dei genitori di contenere l’angoscia, di trovare anche durante un viaggio così incerto la capacità di sognare insieme al bambino, che la psicoanalisi ha imparato ad osservare la relazione tra bambini e genitori e a far tesoro di efficaci pratiche di promozione della salute psichica durante i ricoveri ospedalieri per malattie gravi.
La psicoanalisi ed in particolare la capacità osservativa degli analisti infantili, hanno molto contribuito a portare alla luce sia i processi dolorosi che un bambino deve attraversare e il rischio psichico che il dolore fisico può avere sullo sviluppo.
In particolare i bambini devono affrontare il “non senso” di medicine o interventi che invece di guarire spesso inducono malessere e sconcertanti cambiamenti nel corpo (fig. 1), l’enorme dilatarsi dell’immobilità a cui sono costretti (fig. 2), la gravissima sensazione di una possibile morte incombente (fig. 3).
Teresa 8 anni: gli zombi (fig.1)
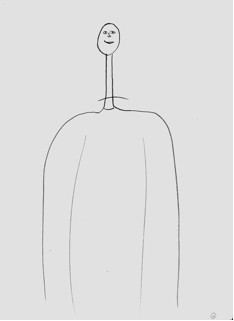
Giulia 7 anni: la flebo (fig.2)

Giuseppe 10 anni: l’incidente ferroviario(fig.3)

Molti studi ci hanno reso famigliare l’idea che soprattutto agli inizi della vita una grave malattia può far sì che la mente perda per un periodo di tempo la trama spazio temporale attraverso cui si struttura e da ordine all’esperienza. Il dolore o anche un’eccessiva stimolazione del corpo possono configurarsi per il bambino come una sensazione di essere sopraffatti dal corpo, come un esperienza di frammentazione che si accompagna ad un vissuto di “terrore senza nome”.
Tuttavia come la nascita, anche la malattia è un evento solo potenzialmente traumatico. Come sottolinea Paula Heimann (1958) le “memorie somatiche” connesse alla malattia possono essere memorie di sopraffazione dell’io, quando gli stimoli esterni sono incontrollabili e memorie di aver superato l’annientamento. Queste seconde, che ovviamente si accompagnano alla guarigione, possono essere fonte di una profonda fiducia in sé e nella propria capacità di superare le avversità.
La salute e la malattia quindi non sono due ambiti di esperienza completamente separati e l’ambiente, nel senso in cui lo intendeva Winnicott, può essere determinante nell’attivare e sostenere le capacità del bambino di trasformare questo tipo di esperienza in una consolidata capacità di affrontare la perdita e di fare il lutto per essa.
Badoni, M.(2000). Corpo—mente: studi clinici sulla patologia psicosomatica in eta evolutiva. Int. J. Psycho-Anal., 81:1041-1044
Balello L., Fischetti R., Milano F., La passione di crescere. Bambini e psicoanalisi negli scritti di Arminda Aberastury, Pitagora, Bologna 1994.
Freud A., Bergmann T., 1946, Kranke Kinder, (tr it. Bambini malati, Boringhieri, Torino 1974 ).
Heimann P. (1958) Osservazioni sullo sviluppo primario, London, The New Psychoanalitical Library, 1989. (tr it. Bambini e non più bambini, Roma Borla 1994).
Hugger, L. (2005). The Psychological Treatment of Children Recovering from Leukemia. J. Infant Child Adolesc. Psychother., 4:408-423
Midgley, N. (2008). Creating a ‘psychological nest’ for vulnerable infants and children: an interview with Annette Mendelsohn. J. Child Psychother., 34:400-410
Sutton, A. (2002). Psychoanalytic Psychotherapy in Paediatric Liaison: A Diagnostic and Therapeutic Tool. J. Child Psychother., 28:181-200
Winnicott D.W. (1971, Colloqui terapeutici con i bambini. (Tr. it., Roma, Armando, 1974),
Winnicott D.W. (1958) Dalla pediatria alla psicoanalisi. Firenze, Martinelli 1975.
Pensieri Ossessivi
A cura di Jones De Luca
L’esperienza di avere dei pensieri che persistono nella mente in maniera insistente è molto frequente: questi pensieri persistenti vengono definiti comunemente “ossessivi”.
Essi non si distinguono inizialmente dagli altri pensieri e possono presentarsi all’individuo come utili, protettivi e spesso altamente morali.
Si propongono soprattutto come pensieri capaci di controllare eventi dannosi che potrebbero essere causati dal soggetto stesso, magari inavvertitamente. Questi eventi sono immaginati come catastrofici, ( ad esempio il ferro da stiro dimenticato accesso che brucia la casa, il gas aperto che fa esplodere tutto) o ingiusti ed immorali e comunque irreparabili.
Una volta che si “infilano in testa” , questi pensieri possono ingigantirsi ed impedire la concentrazione necessaria per vivere, lavorare o studiare. Non è facile liberarsene.
L’unico modo è quello di andare a controllare: hanno ragione? Diventa allora necessario vedere se effettivamente qualcosa di pericoloso è stato fatto, tornare indietro, annullare, rendere non avvenuto qualcosa che magari era stato appena pensato. Si tratta di stabilire ogni volta che non è successo niente.
Dopo ogni controllo però il dubbio si insinua nuovamente ed impone una nuova verifica.
E’ come se l’individuo ingaggiasse una lotta dentro di sé per tentare di eliminare tali dubbi ma questi si ripropongono alla mente in una rimurginazione infinita: sembra che non possano essere dimenticati e sottoposti a quella funzione di oblio “normale” che permette di pensare creativamente.
La mente è ingombra, colonizzata come da un esercito.
In effetti, a questo punto, è chiaro che essi non sono affatto pensieri utili, anzi paralizzano e possono essere fonte di una grande sofferenza.
Più’ precisamente la loro utilità’ potrebbe essere rintracciata da un lavoro psicoanalitico, ma va da se’ che questo lavoro non è una questione di poco conto.
Ma se non sono quello che dicono di essere, allora perché hanno tanto spazio nella mente?
 I pensieri ossessivi vengono da lontano, nascono nell’infanzia e sono spesso il risultato di un clima emotivo teso a controllare l’aggressività vitale del bambino.
I pensieri ossessivi vengono da lontano, nascono nell’infanzia e sono spesso il risultato di un clima emotivo teso a controllare l’aggressività vitale del bambino.
Il bambino ha bisogno innanzi tutto di essere amato e in genere cerca di organizzarsi in modo da non dare troppi dispiaceri ai suoi genitori.
Egli può sviluppare aspetti compiacenti, corrispondere troppo alle aspettative dei genitori su di lui e non permettersi di legittimare dentro di sé una sana capacità di affermarsi e di difendersi. Ciò accade soprattutto quando gli adulti temono troppo le espressioni di rabbia del bambino e gliele prospettano come molto disturbanti spaventandolo sulle presunte conseguenze distruttive dei suoi atti. Allora il bambino tende a confondersi: nella sua mente la rabbia e i normali sentimenti ambivalenti appaiono come profondamente sbagliati e pericolosi; pensa di essere cattivo e distruttivo. Allora comincia a tentare di controllare la propria mente e crede che alcune cose si possano pensare e altre non si debbano pensare.
Tutto ciò viene regolato dal rapporto con gli adulti che per i bambini sono importantissimi, perché sono coloro che devono guidarlo e che ai suoi occhi sanno cos’è il bene e il male.
A volte però gli adulti sono a loro volta sottoposti a necessità di controllare il loro bambino al di là’ della coerenza e della comprensibilità delle proprie azioni.
I bambini sono abituati a decodificare le comunicazioni (anche non verbali) dei genitori nei loro confronti e in questi casi tendono ad assimilare e costruire nel loro mondo interno un sistema di giudizio molto severo.
Si sviluppa nella loro mente un aspetto morale molto rigido e punitivo che non perdona il minimo errore e li confonde su se stessi e sul mondo. Nel tempo il bambino può diventare ossessivo e nascondere dentro di sé un lato ribelle segreto e silenzioso. Teme allora di essere distruttivo e reprime la propria rabbia legittima e vitale.
In adolescenza i pensieri ossessivi possono aumentare proprio perché, come dei guardiani, si propongono di controllare l’impulsività che è tipica di questa fase della vita. La normale vitalità e voglia di affermarsi che si sviluppa in questo periodo è vissuta come pericolosa e si teme di provocare danni catastrofici e irreparabili. La mente degli adolescenti dominati da questo tipo di pensieri può ripiegarsi su se stessa.
Il lato ribelle è terribilmente temuto e deve essere inibito e negato con forza. Dato che la sua forza fisica è aumentata enormemente, il ragazzo si sente realmente pericoloso; questa operazione può arrivare al punto di immobilizzare il ragazzo stesso.
A questo punto gli adulti possono trattare le paralisi conseguenti ai pensieri ossessivi, con un atteggiamento moralistico. Magari con l’obiettivo di stimolare i ragazzi li accusano di indolenza e d’indifferenza, ma questo non fa che aumentare la pressione paralizzante del loro aspetto ipermorale, con il risultato che l’adolescente si blocca e si ritira in se stesso ancora di più.
Bibliografia
Celani ,D.P. ( 2007) .A Structural Analysis of the Obsessional Character .A Fairbairnian Perspective. J Psychoanal., 67:119-140
Winnicott D. W. Comment on obsessional neurosis and “Frankie”; Plenary papers and discussion IJPA 47 143-145 (1966)
Giugno 2014
Perrotti Nicola

Nicola Perrotti con Edoardo Weiss
A cura di Gabriella Gentile
Maestri della psicoanalisi
Perrotti, Nicola (Penne, 1897-Roma, 1970)
La storia di Nicola Perrotti è la storia di un piccolo grande uomo, che ha contribuito a cambiare l’Italia in ambito medico, psicoanalitico e sociale, in modo umile, non tradendo mai i suoi ideali, le sue scelte di libertà, pagando con l’isolamento, la persecuzione, in un periodo particolarmente buio della storia del mondo.
LA VITA
Perrotti nasce a Penne nel 1897, nello splendido Abruzzo, cui la psicoanalisi italiana deve la sua nascita, un paesino tra i monti che mai lasciò totalmente e a cui chiese di tornare alla fine della sua vita. Proviene da una famiglia facoltosa ma di idee socialiste e frequenta il partito già nel 1919. Si iscrive a medicina e parte per la prima guerra mondiale nella Compagnia della Sanità. Nel 1922, si laurea e inizia a leggere libri di psicoanalisi. Alla fine degli anni ’20, intraprende un’analisi con Edoardo Weiss, laureatosi a Vienna, analizzato da Federn e dal 1913 membro della Società Psicoanalitica Viennese e dell’Associazione Psicoanalitica Internazionale. Nel 1924, Perrotti sposa Irma Merloni, compagna di una vita, figlia del deputato socialista condannato nel 1935 dal tribunale speciale. Avrà tre figli: Massimo, Paolo e Daisy. Sarà Paolo a raccogliere brillantemente la sua eredità di medico e psicoanalista, ma anche di uomo impegnato nel sociale. E anch’io sono qui grazie a lui.
Nel 1921, a soli ventitre anni, Perrotti diventa sindaco della città di Penne e nel 1922 aderisce al Psi, il partito di Turati e Matteotti, mentre nel 1924 viene candidato alle elezioni. Nel 1925, viene sottoposto a regime di sorveglianza e inserito nell’elenco dei sovversivi. Inizia ad essere perseguitato quando viene richiesto dai fascisti di mettere dei vessilli alla finestra come festeggiamento per lo scampato attentato a Mussolini. Le finestre della sua casa rimangono chiuse e viene arrestato. Nel 1926, durante una rappresentazione teatrale al suono dell’inno fascista, tutti si alzarono tranne lui e la moglie Irma. Fu arrestato, picchiato e trattato con l’olio di ricino. Irma fu risparmiata perché incinta. Si traferisce a Roma, dove inizia a dedicarsi più sistematicamente alla psicoanalisi, allora vista con sospetto sia dall’ambiente politico che dalla Chiesa. Intanto Weiss, nel 1931, da Trieste si sposta a Roma, rimanendo sempre in contatto epistolare con Freud. Il primo ottobre 1932, con Perrotti, Servadio e Musatti, rifonda la Società Psicoanalitica Italiana, già fondata nel 1925 a Teramo con Levi Bianchini, che ora ne è eletto presidente onorario. Fortunatamente per la causa psicoanalitica, Levi Bianchini aveva in quell’occasione legalmente costituito l’associazione ispirata alle idee freudiane, denominata Società Psicoanalitica Italiana. Sarebbe stato, infatti, molto difficile, in pieno regime fascista, ottenere le autorizzazioni necessarie, ma bastò trasferire la Società, già costituita, da Teramo a Roma. Nella nuova Società, tutti i componenti sono analizzati. Perrotti è l’unico medico del gruppo ed anche l’unico a non avere origini ebree.
Nasce anche la Rivista Italiana di Psicoanalisi, che purtroppo avrà vita breve e nel 1934 verrà chiusa; due numeri rimasero fuori circolazione perché le autorità fasciste non rinnovarono al periodico i permessi necessari. Come ricorda Servadio, in nessuna circostanza storica psicoanalisi e dittatura andarono mai d’accordo. Nel primo numero, compare il primo lavoro di Perrotti: “La suggestione”. Lo stesso Freud ne parlerà a Weiss, esprimendosi così: “il Suo collaboratore Perrotti promette di diventare un elemento di sicuro valore”. Ma Perrotti è stato anche il promotore della nascita de Il Saggiatore, una rivista estranea al partito fascista, sulle pagine della quale rimase famosa la sua polemica con De Ruggero, che dopo aver letto testi di psicoanalisi scrisse un articolo su La critica in cui la liquidava come “serie di banalità”, aggiungendo: “da questo i lettori possono valutare l’intelligenza del Perrotti”. Quest’ultimo prontamente rispose punto per punto alla critica, pur sottolineando che “era ed è mia ferma intenzione non discutere con gli incompetenti-sentimentali”. Weiss aveva anche fondato una Biblioteca Psicoanalitica Internazionale – serie italiana – dove, oltre al suo l’articolo sull’agorafobia, comparvero traduzioni delle opere di Freud, di Anna Freud e della Bonaparte. Nel 1936, in occasione dell’ottantesimo compleanno di Freud, si pubblica anche il volume, Saggio di psicoanalisi in onore di Sigmund Freud, a cui collaborano Weiss, Musatti, Perrotti, Servadio, Merloni, Hirsch e Kovacs. Il ventisette novembre del 1934, su carta bollata da lire cinque, la Società Psicoanalitica Italiana, nella figura di Servadio, ripresenta la sua ennesima “rispettosa istanza affinché venga concesso di appartenere” alla Associazione Psicoanalitica Internazionale ed a quella di Vienna. Naturalmente, il Ministero dell’Interno diffidava e temporeggiava, richiedeva gli statuti delle sconosciute e “sospettabili” Società Psicoanalitiche europee, le cui “finalità” non risultavano “chiare”, alle quali il movimento italiano si ispirava chiedendo ufficialmente di poter aderire. Finalmente. Il primo aprile del 1935, dopo ripetuti scambi epistolari, solleciti e rinvii, il Ministero dell’Interno notificava il proprio rifiuto: restituiva gli Statuti delle Società “straniere”, allegati come da richiesta, e informava gli interessati di “non ritenere opportuno concedere al dott. Servadio l’autorizzazione richiesta”. Comunque, nel 1936, Weiss ottiene che la SPI venga ammessa come società componente dell’Associazione Psicoanalitica Internazionale (IPA), nonostante la “ancora non soddisfacente preparazione analitica degli analisti Italiani”.
Nonostante l’entrata in guerra dell’Italia con l’Etiopia e lo schieramento che si profila, che si formalizzerà nel 1939 con l’alleanza tra Mussolini e Hitler, i padri della psicoanalisi italiana lavorano attivamente sia in patria sia all’estero, come testimonia la loro partecipazione al XIV Congresso Internazionale di Psicoanalisi tenutosi a Marienbad. E’ in questa sede che la SPI viene ufficialmente salutata e riconosciuta dalla comunità psicoanalitica internazionale. Sarà lo stesso Weiss, al ritorno dal congresso, ad incaricarsi di comunicare formalmente questo evento alla prefettura di Roma . Perrotti continua intanto a svolgere con passione anche la sua attività di medico ed è già molto apprezzato tanto da essere considerato uno dei migliori medici di Roma. Ma nel 1938 Freud è costretto ad andare in esilio e la cancellazione totale della psicoanalisi di lingua tedesca fa prevedere che anche l’Italia sarà travolta. Nell’estate del 1938, al Congresso di Parigi, si respira un’aria inquieta ed oppressiva e nel settembre in Italia vengono firmate le prime leggi razziali. Molti sono costretti a scappare: Weiss a Chicago, Servadio in India, Hirsch in Venezuela e chi rimane in Italia è costretto a preoccuparsi della propria incolumità e quella dei suoi cari. Fa seguito un periodo buio in cui in Italia non si sente più nominare la psicoanalisi. Perrotti continua instancabile il suo lavoro e il suo impegno politico. A partire dal 1942, aiuta la ricostruzione in clandestinità del Psi e insieme a Romita e Vernacchi promuove il nucleo romano che ricostruirà il Psup. Le riunioni, a cui partecipano, tra gli altri, Nenni e Pertini, si svolgono nella sua abitazione, poiché la professione poteva fungere da buona copertura.
Nel 1945, viene nominato Alto Commissario Alla Salute e Igiene Pubblica. Nel ’45, dopo la liberazione, torna in Italia Servadio e riprende i contatti con Perrotti e Musatti. Quanta abnegazione, quanta fedeltà e quanta passione per la psicoanalisi! Nel 1947, viene ufficialmente ricostituita la Spi sotto la presidenza del prof. Perrotti. Ne diviene organo ufficiale la Rivista di Psicoanalisi, diretta da Joachim-Flescher, medico polacco. Ma la rivista esce solo per due anni. Flescher si trasferisce in America e alcuni analisti, tra cui Perrotti, danno vita a Psiche, rivista internazionale di psicoanalisi e scienze a carattere scientifico e divulgativo. Il ventidue e ventitre ottobre del1946, si tenne a Roma il primo Congresso italiano di psicoanalisi; il secondo, che si svolse dal venti al ventidue ottobre 1950, sempre a Roma, vertente sul tema dell’aggressività, ebbe notevole risonanza in patria e all’estero. Nel 1952, viene fondato l’Istituto di Psicoanalisi di Roma e la scuola di formazione. Dal 1955, si torna a pubblicare la Rivista di Psicoanalisi che tutt’oggi è l’organo ufficiale della Spi. L’Istituto diventa non solo una importante scuola, ma un luogo di incontro e confronto con le nuove frontiere della psicoanalisi ed ospita Winnicott, Lacan, Bouvet, Spitz, Balint e Nacht . Nel frattempo, il prof. Perrotti nel ’48 viene eletto come deputato nel collegio abruzzese con ventottomilaseicentocinquantuno preferenze, cifra quasi plebiscitaria.
Ho trovato, negli Atti parlamentari, le proposte di legge da lui avanzate in collaborazione con altri deputati, dove ancora emerge l’amore per la sua terra, l’insofferenza per ogni ingiustizia e la protezione per le categorie più deboli (la gente del sud, gli operai, i malati, i terremotati). Ancora più commoventi ed esplicative le richieste che gli giungevano da Pescara, dalle sedi dei compagni che lo avevano appoggiato: prima cambiale della Lambretta, fondi per la distribuzione dei viveri ai compagni bisognosi, fondi per coprire le spese per il processo intentato dai lavoratori del Fucino per la lotta contro i Torlonia.
Un uomo coerente e completo: studioso che ha creduto nella scienza, medico coscienzioso, psicoanalista libero e promotore della libertà come valore umano, convinto che ciascuno di noi contiene l’altro; politico dagli alti ideali che governava per il bene degli altri, credeva nella costruzione di un senso comune, di un socialismo interiore che lo portò, nel ’50, a rinunciare ad un viaggio in Russia, perché non volle firmare l’obbligo di non parlare male del paese del socialismo reale. Pur essendo ormai un uomo all’apice della sua carriera e di fama indiscussa, continuava a tornare nel suo piccolo paese natale e a visitare i suoi pazienti, recandosi anche in posti difficilmente raggiungibili. Si racconta che, quando una donna, al momento del pagamento, aveva estratto dal suo petto un frutto del suo lavoro di contadina, il segretario l’abbia richiamata, ma Perrotti lo abbia zittito dicendo, come se fosse venuto direttamente dal suo cuore: “ma non vedi da dove l’ha cacciato?”. Perrotti muore a Roma nel 1970 e viene sepolto a Penne, dove più di un contadino era solito chiamarlo “San Nicola”.
IL CONTRIBUTO ALLA PSICOANALISI
Nell’accingermi a rileggere gli scritti e a ripercorrere la straordinaria vita di Nicola Perrotti, ho ritrovato un maestro e china mi sono messa ad imparare. Ho amato la libertà mentale ed il coraggio di abbracciare idee nuove e rivoluzionarie, quando queste non erano accettate né promettevano lauti guadagni, ma quando attaccavano il sistema e per questo si veniva perseguitati. Ho toccato con mano l’amore per la scienza, vista come l’impresa che avrebbe salvato l’uomo dall’abbrutimento e dal ripetersi di vicende terribili, come le due guerre che l’umanità aveva appena subito. Una scienza al servizio dell’uomo, poco incline a seguire le mode, che sapeva rinnovarsi pagando il dazio dell’isolamento. Ho trovato un uomo innamorato della vita e degli esseri umani, che provava ad elevare perché fossero liberi di agire, godere pienamente e affrontare le difficoltà dell’esistenza. Uno psicoanalista retto, che rispettava i principi fondamentali dell’anonimato, tanto che tranne in un caso nessuno mai seppe chi fossero i suoi pazienti. Analizzò personaggi noti e meno noti, dei quali nulla sappiamo, fatta eccezione per lo scrittore Giuseppe Berto, che nel 1964 vinse sia il premio Campiello che il premio Viareggio con il noto romanzo Il male oscuro.
Era analista anche al di fuori della sua stanza, sempre in contatto con la realtà e la sofferenza dell’altro, del popolo, delle masse, dell’intero mondo, utilizzando la sua competenza per meglio comprendere la realtà politica e sociale. Un analista che, come raccontano i suoi allievi, riusciva a tirar fuori il meglio di loro, che guardava di loro sempre l’aspetto buono e unico, mentre li invitava a lavorare sulle loro parti oscure. Con una caratterista che ancora oggi differenzia la psicoanalisi da ogni altra terapia: un profondo rispetto dell’essere umano e della singolarità di ognuno. Queste le parole riferite da un allievo, lo psicoanalista Giancarlo Petacchi: “Non importa quanta luce si emette, l’importante è brillare di luce propria, non di luce riflessa”. Un analista votato alla clinica, che introdusse i seminari clinici nel training, pratica non esistente in nessun altro istituto al mondo. Nei suoi pochi ma importantissimi scritti, che toccano molti aspetti della vita quotidiana, scopriamo il grande analista, preciso e puntuale, che come Freud non scinde mai la teoria dalla clinica, che argomenta ogni pensiero e affronta tematiche nuove, come l’aggressività, la depersonalizzazione e il Sé, che diventeranno il futuro della psicoanalisi, con riconoscimenti anche all’estero.
Perrotti ha saputo accogliere ciò che c’era di nuovo nel panorama psicoanalitico mondiale, ma ha anche saputo contestare Freud, dando una lettura dell’istinto di morte originale e diversa. La sua scrittura, così semplice e profonda, da grande narratore, ha spaziato su una grande quantità di temi, dei quali stupisce la modernità e la varietà. Dal racconto sullo sport a quello sul calcio, alla rivendicazione dell’importanza degli aspetti etici e morali, attaccando però sagacemente l’esistenza di una doppia morale, soprattutto in campo sessuale, quando la sessualità veniva ancora considerata un’opera diabolica. Dall’invito a liberarsi delle nostre patologie per liberare la nostra creatività attraverso ogni arte, fino allo splendido decalogo del buon analista, che deve essere curioso di conoscere l’animo umano, curioso di sé e dell’altro, che conosce sé tramite l’altro; che deve avere la capacità di “stabilire una comunicazione col paziente ed il suo desiderio inesauribile di volerlo aiutare e di guarirlo”, che deve saper creare un buon ambiente emotivo, avere una pazienza infinita e intuito. Ma anche possedere un Io robusto eppure agile, comprendere il transfert e controllare il proprio controtransfert, infine, possedere un tratto speciale, “l’angoscia dello psicoanalista, cioè quello speciale bisogno di certezza e di dubbio metodico che è inerente alla professione della psicoanalisi.” Ma voglio concludere il mio inchino con una sua frase detta ad una donna, a cui aveva gratuitamente curato il figlio, che ripetutamente gli chiedeva cosa potesse fare per lui. Questa fu la sua risposta: “Mi ricordi, essere ricordati è un modo per non morire”. Noi, caro Professore, la ricordiamo.
Bibliografia
Accerboni A.M. (1990). Edoardo Weiss e le origini della psicoanalisi in Italia Boringhieri, Torino.
Archivio del CSPL PERROTTI NICOLA (1897-1970)
Bergeret J. (1998). La violenza quotidiana. Riflessioni dello psicoanalista, Psiche, 1.
Breve biografia di Perrotti dal sito Centro Studi di Psicologia e Letteratura.
Breve storia del Centro di Psicoanalisi Romano (2008) (A cura di Elena Lipari e Angelo Macchia), Roma, 12 ottobre.
Camera dei deputati, Atti parlamentari, documenti, disegni di legge e relazioni.
Camplese E. (2015). Relazione inaugurazione Università Libertà Nicola Perrotti, città di Penne, 16 marzo.
Casellario politico centrale, fascicolo 3877, 23 dicembre 1925.
Corrao F. (1970). Nicola Perrotti (1897-1970), Rivista di Psicoanalisi, 1.
David M. (1996). La psicoanalisi nella cultura italiana, Boringhieri, Torino.
Dizionario Biografico degli Italiani.
Dolfin M. T. (2000). Storia della psicoterapia, in Le origini della psicoanalisi in Italia, Archivio
Istituto Psicoanalitico di Orientamento Lacaniano.
Lupinacci M. A. (2015). L’impronta di Nicola Perrotti alle origini della prima sezione romana dell’Istituto Nazionale del Training, Centro di Psicoanalisi Romano.
Martini F. (2015). Relazione inaugurazione Università Libertà Nicola Perrotti, città di Penne.
Merloni, in Dizionario biografico degli Italiani, 73.
Musatti C. L. (1976). La psicoanalisi nella cultura italiana, Rivista di Psicoanalisi. 22.
Neri C. (2000). Idillio, depersonalizzazione, integrazione. Un percorso tra memoria e trasformazione, Psiche.
Novelletto A. (2010). La psicoanalisi in Italia, Rivista di Psicoanalisi, 3.
Perrotti N. (1989). L’Io legato e la libertà, Astrolabio.
Petacchi G. (1987). Vita da pionieri, in La cultura psicoanalitica, Studio Tesi, Trieste.
Servadio E. (1976). Il movimento psicoanalitico in Italia, Rivista di Psicoanalisi , 2.
Tagliacozzo R. (1993). Perché Psiche, Psiche, 1.
Vedi anche
Altre foto:
http://quitrieste.it/edoardo-weiss-e-le-malattie-dellio/casa-weiss/
31 Ottobre 2015, TERAMO, Celebrazione del 90° anniversario della fondazione della S.P.I.
Personaggio in psicoanalisi

Fotografia tratta da: Gottshall J. (2012), L’istinto di narrare. Come le storie ci hanno reso umani, Bollati Boringhieri, Torino 2014
A cura di Maurizio Collovà
Il concetto di personaggio in psicoanalisi
Definizione del tema; teorie e modelli di riferimento.
Gli sviluppi della psicoanalisi contemporanea hanno trovato nella narratologia e nel concetto di personaggio utili strumenti per la cura del disagio psichico. Da Bion in poi, il concetto di personaggio è inteso come il luogo della rappresentazione e trasformazione degli affetti e delle emozioni.
Definire il concetto di personaggio implica occuparsi in modo particolare della funzione svolta dal personaggio e dalle sue narrazioni nello sviluppo del processo psicoanalitico.
In una psicoanalisi post-bioniana (Civitarese, 2011), personaggio non è solo l’umano, il vivente, che appare nel racconto, ma può essere anche un nuvolone nero, una barca di salvataggio, un tacco rotto di una paziente, come pure gli stessi analista e paziente. Anche se, come afferma Ferro (2010) il personaggio umano rappresenta la parte più evoluta del campo.
Ogni personaggio che fa ingresso in seduta, ovvero nel campo, é inteso come narrante una dimensione emotiva che contribuisce a definire il clima del campo e le sue continue trasformazioni (un campo aggressivo, dormiente, paranoicizzato, ecc.) e riguarda la qualità dell’accoppiamento mentale tra A/P.
Una posizione più radicale intende oggi il personaggio come il prodotto della funzione alfa del campo e della capacità di questo di operare sequenze di trasformazioni oniriche promuovendo lo sviluppo delle funzioni per sentire, pensare e sognare.
Presupposti teorici
L’utilizzo del personaggio come concetto avente una specificità psicoanalitica ha origini più recenti rispetto agli inizi della psicoanalisi e presuppone a monte una teorizzazione sul funzionamento della mente. A questo proposito Bion (1962) ipotizza l’esistenza di un apparato per pensare dotato di funzioni che consentono di poter sognare le emozioni grezze, in gergo elementi beta, che dall’esterno e dall’interno bombardano la nostra mente e trasformarle in personaggi e narrazioni. Lo sviluppo di queste funzioni si costituisce come fattore terapeutico in psicoanalisi, (Ferro 2002).
Modello di riferimento
Il modello all’interno del quale viene utilizzato oggi il concetto di personaggio è quello di Campo con una forte accentuazione sulle sue potenzialità narratologiche e trasformative all’interno del quale i personaggi sono intesi tutti come sue funzioni. Questo presuppone che l’analista escluda dal suo vertice la dimensione Storica e Reale del personaggio, dimensione che dovrà collassare dando spazio a quella onirica. Per intenderci, in questo modello ogni persona (quel suo collega…) attraverso un processo di deconcretizzazione é trasformata in personaggio e ogni fatto (…è stato molto comprensivo con mia sorella.) é trasformato in una narrazione che attraverso processi di decostruzione ne porterà di nuove e imprevedibili, capaci di contenere diversi livelli rappresentabili come luoghi del campo, le Storie, i mondi interni, il transfert, la relazione analista/paziente, la meteorologia del campo. L’interesse dell’analista orientato a questo modello a questo punto sarà quello di conoscere il personaggio (collega) della seduta, di favorire lo sviluppo del suo racconto la dove trova ostacolo, di cogliere quali emozioni prima silenti veicola e quali informazioni ci darà sulla qualità della nostra interazione e del campo in cui analista e paziente sono immersi. Il campo assume così la funzione di una sorta di sala d’attesa per consentire da una parte la graduale e sostenibile trasformazione del personaggio attraverso ulteriori narrazioni emotivo-affettive sempre meno costose per il sé e, dall’altra, lo sviluppo delle funzioni per pensare, sentire e sognare, vero scopo dell’analisi.
Sintesi storica e sviluppi attuali
Sappiamo che la dimensione narrativa è costitutiva delle origini della psicoanalisi in quanto legate al mito di Edipo. In psicoanalisi troviamo il termine, non il concetto, personaggio già in Freud, basti ricordare Personaggi psicopatici sulla scena (1905), dove è comunque evidente la finalità metapsicologica dell’interesse per il teatro. Freud, mosso dalla ricerca di una verità ricostruttiva, assegna al Personaggio uno statuto Storico, Referenziale esterno e Simbolico. Accade quindi che il testo finzionale del teatro psicoanalitico (Petrella 2011) arrivi a trasformarsi in un fatto accertato e il personaggio in una persona reale. Ad esempio la madre respingente riattualizzatasi nel transfert diventa, dopo l’interpretazione, la madre reale incapace di aver fatto posto alle richieste affettive del bambino che il paziente era. Non c’è ancora spazio per un analista che nell’hic et nunc della seduta si è fatto convesso alle richieste del paziente, tanto meno per una ipotesi di impermeabilizzazione del campo alle identificazioni proiettive crociate tra analista e paziente che rimangono non accolte. Del resto Freud non poteva ancora avere accesso a questi sviluppi teorici.
Nel modello kleiniano il personaggio è inteso come l’esplicitazione di rapporti tra oggetti interni i cui ruoli sono però definiti a priori e fanno capo alle fantasie inconsce del paziente. Dal punto di vista dell’utilizzo del personaggio è evidente ancora l’ottica unipersonale. Il personaggio qui è lontano dal poter essere considerato una co-costruzione della coppia analista paziente che può ambire ad una sorta di vita indipendente in quel motore di trasformazioni che è il campo. Merita tuttavia di essere segnalato il contributo che la Klein ha dato allo sviluppo del concetto di personaggio attraverso l’importante lavoro del 1929 La personificazione nel gioco infantile. L’apparizione in scena della “mamma fata” è considerata in questa teorizzazione una modificazione del rapporto del paziente con il suo Super-io, inteso come il personaggio a cui la Klein guarda, nel verso di una minore persecutorietà.
Lo studio da parte di alcuni psicoanalisti italiani delle teorizzazioni e dei concetti che la Narratologia e la Semeiotica hanno sviluppato intorno al testo e al personaggio letterari ha consentito l’applicazione di questi anche al dialogo tra analista e paziente in seduta. Questo ha prodotto in buona parte, dopo la rivoluzione introdotta dal pensiero bioniano, la svolta verso una concezione del testo e dei personaggi della seduta come opera aperta (Eco1962) in continua costruzione attraverso una costante cooperazione narrativa della coppia fino ad una indistinguibilità di appartenenza del testo all’uno o all’altro.
Corrao (1987, 1991) nel suo scritto Il narrativo come categoria psicoanalitica utilizza il termine narrativo come concetto astratto che partecipa della composizione di un campo tridimensionale costituito dalle dimensioni del Fantastico (Immaginario), del Semiotico (Simbolico) e del Narrativo (Reale) riscontrando in ciò la similitudine col sogno e con altri scritti freudiani come le note Storie cliniche, attribuendo a tutte la ricchezza di una struttura narratologica. In particolare del Caso di Dora (Freud 1901) afferma trattasi di una “trasformazione narratologica” ponendo così il suo accento sul modello trasformazionale del pensiero (Bion 1965). Corrao segnala in oltre l’interesse di C. Segre (1984) alla dimensione del narrativo in psicoanalisi come esempio di un ponte disciplinare tra campo semeiotico, letterario e narratologico e letteratura psicoanalitica.
Nel 1992 Ferro nel suo primo libro dal titolo La tecnica nella psicoanalisi infantile tratta già in modo chiaro questo tema, collegandolo in modo forte ai presupposti narratologici. Diversamente da Corrao, seppure in forte consonanza, Ferro (1996) parla di “narrazioni trasformative” ponendo l’accento più sulla potenzialità che le narrazioni hanno in sé di operare trasformazioni. Bezoari e Ferro (1992, 1997) danno un ulteriore apporto all’uso del personaggio in seduta introducendo i concetti di “aggregati funzionali” e di “ologramma affettivo”. Per “aggregati funzionali” essi intendono gli elementi protosimbolici frutto dei processi trasformativi della coppia analitica, che permettono una visione condivisa di aspetti del campo emotivo non altrimenti rappresentabili; per ologramma intendono la trasformazione dell’immagine onirica in immagini tridimensionali che prendono corpo nello spazio intersoggettivo. Civitarese (2008) espande questo concetto affermando che in una realtà virtuale le immagini olografiche diventano dinamiche e integrano la quarta dimensione della temporalità.
Troviamo in Ferro (2014) la più recente definizione di personaggi intesi come funzione del campo dei quali viene fatto il casting allo scopo di narrare quanto questo ha necessità di essere espresso in quel momento e oscurando ogni corrispondenza con una realtà esterna alla seduta o storica.
Casting, Derivati Narrativi e Invariante
I concetti di Casting (Ferro 2014; Collovà 2011) e di Derivati Narrativi (Ferro 2014) sono con evidenza legati a quello di personaggio (Ferro 2010). Meno evidente potrebbe essere il legame col concetto di Invariante.
Il concetto di Invariante derivante dal modello trasformazionale di Bion (1965) assume una sua utilità nel rapporto col personaggio in quanto consente di poter identificare, attraverso il riconoscimento di un elemento costante, come il personaggio o una singola narrazione si sono trasformati nel corso di una seduta e dell’analisi.
Primo incontro con un paziente: «Un suo collega mi ha detto che di stoffa ce n’è, ma è come se fosse formata da tante isole».
Termine dell’analisi: «Ho visitato la Croazia, una marea di isole collegate da un continuo via vai tra loro e la terra ferma». Una estrema sintesi di una trasformazione democratica della mente. L’invariante presa in considerazione in questo caso è isole, assunte come aspetti di sé prima non collegati o aspetti del campo che possono adesso dialogare.
L’arruolamento dei personaggi definito per l’appunto casting si compie attraverso il dialogare inconscio delle menti dell’analista e del paziente ed è in rapporto alla loro condizione mentale di maggiore o minore permeabilità.Da questo vertice è possibile affermare che la costituzione e lo sviluppo della funzione di casting é uno degli scopi dell’analisi. Se volessimo pensare a un precursore di tale funzione potremmo pensare a ciò che Ferro, in una accezione fuori campo, ha chiamato la costituzione di un narratore interno (1996).
Il Derivato Narrativo (DN) é la risposta ad un movimento emotivo nel campo che trova una sua formula espressiva a partire da una sequenza di elementi alfa. La tipologia dei DN può essere quella ludica, grafica, verbale, motoria e somatica. Queste tipologie possono avere in oltre una variabilità tematica, ossia essere espresse attraverso un racconto d’infanzia, sessuale, filmico, del romanzo familiare ecc… . Ovviamente la voce narrante sarà quella del personaggio di turno. Un esempio potrebbe essere quello di un racconto western che può essere giocato, disegnato o espresso verbalmente. Spesso nella terapia con bambini queste diverse modalità espressive s’intrecciano pur mantenendo un loro filo narrativo. E’ il caso dello sviluppo del DN secondo un asse delle varietà tematiche che si susseguono nel corso della seduta. All’opposto può accadere che lo sviluppo del DN sia monotematico per l’intera seduta, come il passare da un racconto del romanzo familiare ad un altro.
La funzione del DN è quella di raccogliere ansie e angosce di vario genere e gravità, vissute su un piano sintomatologico, in narrazioni capaci di dare loro un contenimento. Il nostro inconscio, afferma Grotstein (2010), porta in se una tendenza innata alla ricerca di narrazioni che convertano gli eventi in entrata, sia dal mondo interno che dal mondo esterno, in esperienze personali.
La capacità di produrre personaggi e DN in quantità e varietà, si traduce dunque in una minore espressione evacuativa delle emozioni con conseguente riduzione della dimensione sintomatologica.
Bibliografia del testo
Bezoari M. Ferro A. (1992), Percorsi bi-personali dell’analisi. Dal gioco delle parti alle trasformazioni di coppia, in Nissim Momigliano L., Robutti A. (a cura di), L’esperienza condivisa, Cortina, Milano.
Bezoari M. Ferro A. (1997), Il sogno all’interno di una teoria del campo: aggregati funzionali e narrazioni, in Gaburri E. (a cura di), Emozione e interpretazione, Bollati Boringhieri, Torino.
Bion W. R. (1962) Per una teoria del pensiero. In: Apprendere dall’esperienza. Armando, Roma, 1972.
Bion W. R. (1965), Trasformazioni. Il passaggio dall’apprendimento alla crescita, Armando, Roma 1973.
Civitarese G. (2008), L’intima stanza. Borla, Roma.
Civitarese G. (2011), La violenza delle emozioni. Bion e la psicoanalisi post-bioniana, Cortina, Milano.
Collovà M. (2011), Con stile: il vero giallo in analisi, in Ferro A., Civitarese G., Collovà M., Foresti G., Mazzacane F., Molinari E., Politi P., Psicoanalisi in giallo. L’analista come detective. Raffaello Cortina Editore, Milano.
Corrao F. (1987), Il narrativo come categoria psicoanalitica, in Orme, vol. I. Cortina, Milano.
Corrao F. (1991), Trasformazioni narrative, in Orme, vol I. Cortina Milano.
Eco U. (1962), Opera aperta, Bompiani, Milano.
Ferro A. (1992), La tecnica nella psicoanalisi infantile, Cortina, Milano.
Ferro A. (1996), Nella stanza d’analisi. Emozioni, racconti, trasformazioni, Cortina, Milano.
Ferro A. (2002), Fattori di malattia fattori di guarigione. Cortina, Milano.
Ferro A. (2010), Tormenti di anime. Passioni, sintomi, sogni. Cortina, Milano.
Ferro. A. (2014), Nelle viscere della mente. Cortina, Milano.
Freud S. (1905), Personaggi psicopatici sulla scena, in Opere, 5: 23 1.
Freud S. (1901), Frammento di un’analisi d’isteria (Caso clinico di Dora), in Opere, 4: 354.
Grotstein J. (2007), Un raggio d’intensa oscurità, tr. it. Cortina, Milano (2010).
Klein M. (1929), La personificazione nel gioco infantile. Tr. It. In: Scritti 1921-1958. Boringhieri, Torino 1978.
Petrella F. (2011), La mente come teatro. Psicoanalisi, Mito e Rappresentazione. Edi-ermes, Milano.
Segre C. (1984), Teatro e romanzo. Einaudi, Torino.
Fotografia tratta da: Gottshall J. (2012), L’istinto di narrare. Come le storie ci hanno reso umani, Bollati Boringhieri, Torino 2014.
Bibliografia per consultazione
Arrigoni, Barbieri (1998), Narrazioni e psicoanalisi, Cortina, Milano.
Bezoari M., Reverie, link Spipedia.
Corrao F. (1986), Il concetto di campo come modello teorico, in Orme, vol I. Cortina Milano
Eco U. (1975), Trattato di semeiotica generale. Bompiani, Milano.
Eco U. (1979), Lector in fabula. Bompiani, Milano.
Eco U. (1990), I limiti dell’interpretazione. Bompiani, Milano.
Ferro A. (1992), Due autori in cerca di personaggi: la Relazione, il Campo, la Storia. In Rivista di Psicoanalisi, 38, pp. 44-91.
Ferro A. (1999), I personaggi in letteratura e nella stanza d’analisi, in La psicoanalisi come letteratura e terapia. Cortina, Milano.
Ferro A. (2004), Psicoanalisi e narrazione: un modello della mente e della cura. Cortina, Milano.
Ferro A. (2009), Trasformazioni in sogno e personaggi nel campo psicoanalitico. Rivista di Psicoanalisi, 55:395-420.
Ferro, Basile (2006), Il campo analitico. Tr. it. Borla, Roma, (2009).
Ferro A., Mazzacane F., Varrani E. (2015), Nel gioco analitico. Lo sviluppo della creatività in psicoanalisi. Da Freud a Queneau. Mimesis, Milano.
Petrella F. (2011) La mente come teatro. Psicoanalisi, Mito e Rappresentazione. Edi-ermes, Milano.
Ponsi M., Enactment, link Spipedia.
Riolo F. (1997), Il modello di campo in psicoanalisi, in E. Gaburri, (a cura di ), Emozione e interpretazione, psicoanalisi del campo emotivo. Bollati, Boringhieri, Torino.
Settembre 2015
Personalità “come se”

Magritte-Decalcomanía
A cura di Luisa Masina
Il concetto di personalità “come se” fu coniato dalla psicoanalista Helene Deutsch, nata nel 1884 in Galizia. Ella fu analizzata da Freud e divenne poi membro della Società Psicoanalitica di Vienna. Nel 1933 si trasferì in America. Morì a Cambridge nel 1982.
Presentò il concetto di “personalità come se” per la prima volta davanti alla Società Psicoanalitica di Vienna nel 1934 e le sue teorizzazioni in proposito vennero poi pubblicate nel 1942, in uno scritto dal titolo “Forme di disturbi emotivi e loro rapporti con la schizofrenia”.
Helene Deutsch raggiunse la notorietà grazie ai suoi scritti sulla psicologia femminile (The psychology of women, 1945), ma la “personalità come se”, costituisce il suo contributo clinico-teorico più noto.
Questo concetto assunse, infatti, un ruolo di rilievo nel pensiero psicoanalitico e fu seguito da numerose pubblicazioni sull’argomento; nel 1965 gli fu dedicato un panel speciale al Congresso dell’Associazione Psicoanalitica Americana.
La Deutsch, secondo Paul Roazen (1983) interessandosi alle “personalità come se”, “ cercava di descrivere un’affettività contraffatta che non era né nevrotica né psicotica. Solo successivamente fu introdotto in letteratura il concetto di personalità borderline.
L’Autrice era partita dalla descrizione di una patologia rara per giungere a descrivere un fenomeno diffuso in generale fra le persone: infatti, per quanto lo ritenesse di riscontro eccezionale e di difficile diagnosi, al tempo stesso era convinta che fossero frequenti e universali, transitorie esperienze “come se”.
Questa osservazione appare particolarmente significativa e attuale, in quanto orientata a sfumare i confini dogmatici fra patologia e “normalità” e tendente alla comprensione di stati mentali transitori esperenzialmente vicini a condizioni psicopatologiche, ma non esclusivamente identificabili con esse.
Secondo la Deutsch, le personalità “come se” sono caratterizzate dalla loro capacità di suscitare nell’osservatore “l’impressione inevitabile che l’intero loro modo di essere di fronte alla vita abbia qualcosa che manca di genuinità, e tuttavia, esso sia “come se fosse normale”. I pazienti in questione danno un’impressione di “completa normalità”, che si accompagna alla sensazione che “manchi” qualcosa, in particolare vero calore e veri sentimenti, anche se apparentemente essi coltivano rapporti affettivi e di amicizia ricchi e variegati.
L’Autrice indica con la definizione di “personalità come se” disturbi affini alla depersonalizzazione, ma da questa distinguibili in quanto non percepiti dai pazienti, descritti come “inconsapevoli della loro assenza di risposte e di legami affettivi normali”. Il disturbo viene avvertito, invece, da chi li circonda o emerge in corso di trattamento analitico; può avere un andamento transitorio o fluttuante, oppure può manifestarsi in modo stabile e costante.
In altri termini, si può dire che nei casi di depersonalizzazione, il disturbo viene vissuto come “intrapersonale” (“Sono cambiato, non riesco più a provare nulla. Tutto mi sembra irreale”) o viene proiettato sul mondo esterno che appare strano, sfumato, irreale; al contrario nel caso delle personalità “come se”, è chi si trova a relazionarsi con esse che (come Helene Deutsch scriveva) “prima o poi esclama: “Qui c’è qualcosa che non va”.
Si tratta di persone con comportamento che non si discosta dalla norma, con capacità mentali integre, sovente intellettualmente dotate e con un’espressività emotiva che “sembra” adeguata. Helene Deutsch utilizza nel suo articolo l’aggettivo “impalpabile” per descrivere il quid che caratterizza queste personalità e che viene colto anche dall’osservatore profano che con esse si trova ad interagire. Così come nell’estrinsecazione della creatività compiono un lavoro dignitoso di copia di un prototipo, senza spunti originali, anche nelle relazioni affettive queste personalità esprimono le emozioni in modo “ puramente formale” e ogni esperienza interna è loro “completamente preclusa”.
Questi individui si caratterizzano anche per una disposizione passiva verso l’ambiente ed una capacità di modellarsi alle aspettative nei loro confronti, tanto da risultare immediatamente gratificanti per il partner, ma ben presto deludenti, a causa “dell’atmosfera emozionale vuota e convenzionale” che inevitabilmente instaurano.
Le personalità “come se” hanno reazioni con caratteristiche di inautenticità agli abbandoni, oppure non presentano reazioni affettive e solitamente sostituiscono piuttosto rapidamente il loro oggetto d’amore.
Lo stesso tipo di funzionamento si può osservare anche nell’ambito degli ideali e delle convinzioni (politiche, etiche, religiose, ecc…), che vengono facilmente e rapidamente rimpiazzate da altre, a seconda di occasionali identificazioni con persone diverse. Pertanto, è anche possibile che personalità “come se”vengano attratte da atti criminosi.
Queste personalità, infatti, sono esposte ad una facile suggestionabilità (differente da quella presente nell’isteria), che in loro risulta dalla passività e dalla “tendenza automatica all’identificazione”.
Altro tratto distintivo delle personalità “come se” è il mascheramento dell’aggressività ad opera della passività, che conferisce loro “un’aria di artificiosa bontà”, di natura quanto mai instabile.
Per quanto riguarda la diagnosi differenziale, il problema si pone, come già descritto, con gli stati di depersonalizzazione, ed inoltre con i soggetti repressi, la cui freddezza è il risultato di una rimozione, mentre nelle personalità “come se”vi è una vera e propria carenza di investimento oggettuale.
Nell’isteria, le identificazioni con gli oggetti sono accompagnate da intenso investimento libidico, a differenza di quanto avviene nelle personalità “come se”. Negli isterici la rimozione dell’affetto comporta la liberazione dell’ansia e permette di uscire dal conflitto, mentre nelle personalità “come se” è presente una carenza precoce dello sviluppo dell’affetto, che riduce la conflittualità interna e implica un impoverimento globale della personalità.
Nei soggetti narcisistici, poi, il blocco dell’affettività è conseguenza della rimozione dei sentimenti, mentre nelle personalità “come se”vi è un tentativo di simulazione dell’esperienza affettiva, che non è stata rimossa, ma che è, invece, carente.
L’Autrice individua un’analogia fra situazioni “come se” e certi stati che si verificano durante la pubertà, che ella definisce “schizoidi”, suscettibili di evoluzioni patologiche o di remissione ad una situazione di “normalità”.
Infine Helene Deutsch prende in considerazione le correlazioni fra questo tipo di pazienti e gli psicotici, ai quali sono accomunati dal narcisismo e dalla povertà di rapporti oggettuali e dai quali si distinguono, a suo parere “fondamentalmente perché il giudizio di realtà appare conservato”. Ella aggiunge di aver osservato come la schizofrenia attraversi una fase “come se” prima di esprimersi in senso delirante, tanto che definisce queste personalità come “condizioni pre-psicotiche”. Tuttavia, pur riconoscendo lo stretto legame fra le personalità “come se” e la schizofrenia, conclude che non le è chiaro se i disturbi emotivi da lei descritti “implichino una disposizione alla schizofrenia o siano essi stessi sintomi rudimentali di schizofrenia”.
A proposito della genesi di questo tipo di personalità, la Deutsch sostiene che il bambino, per essere in grado di sviluppare una normale vita emotiva, debba realmente sperimentare il calore del corpo materno e la corrente libidica dei genitori che fluisce nella costellazione edipica, cosa che ritiene essere mancata in questi pazienti, che, quindi, non sarebbero in grado di sviluppare un normale complesso edipico (Roazen, 1983.)
A questo proposito l’Autrice riporta un caso clinico estremo, ma assai chiarificatore, in cui i genitori non avevano offerto alla paziente nulla più che la loro presenza, senza mettersi in alcun modo in gioco nella relazione con lei.
La costituzione del Super Io, quindi, nelle personalità “come se” è carente a causa dell’inconsistenza della costellazione edipica; del pari sono vacillanti e instabili le identificazioni, che avvengono con oggetti esterni, anziché con quelli interni, come esito del superamento del complesso edipico.
La debole struttura superegoica, la tendenza alla passività e l’identificazione prevalente con oggetti esterni rendono ragione di quella caratteristica delle personalità “come se” che Helene Deutsch suggestivamente definisce “d’ombra”.
Bibliografia
Deutsch Helene Psicologia della donna (Psychologie der Frau, 1948-54), prefazione di Emilio Servadio, trad. di Isabella Daninos-Lorenzini, 2 voll. (I. L’adolescenza, II. La donna adulta e madre), Boringhieri, Torino 1957.
Deutsch Helene Psicoanalisi delle nevrosi (Neuroses and Character Types, 1965), trad. di Aldo Durante, Newton Compton, Roma 1978.
Fenichel O. Trattato di psicoanalisi delle Nevrosi e delle Psicosi, Astrolabio, Roma.
Heller-Roazen D. (2007) Il tatto interno. Archeologia di una sensazione, Quodlibet, 2013.
Il sentimento assente, trad. di Fabiano Bassi (con scritti di Helene Deutsch, Paul Roazen e Gregory Zilboorg), Bollati Boringhieri, Torino 1992.
Rycroft C. Dizionario critico di psicoanalisi, Astrolabio, Roma, 1970.
Maggio 2015
Perturbante (Il)

dal film Shining di Stanley Kubrick
a cura di Angelo Moroni
Il concetto di “Perturbante” (introdotto in ambito psicologico per la prima volta dallo psichiatra tedesco Ernst Jentsch nel 1906) è sviluppato da Freud nel suo breve ma denso saggio del 1919 dal titolo omonimo (“Il Perturbante”, in tedesco: “Das Unheimlich”). A questo concetto Freud aveva già fatto cenno in una breve nota a piè pagina di “Totem e Tabù”(1912-13, pag.92), parlando del “modo di pensare animistico”. Il significato di tale termine ricade sotto l’ombrello semantico dello “spaventoso”, del “terrifico”, e tende a coincidere con tutto ciò che ci disgusta, ci offende, ci spaventa, dando così una forma ad un’esperienza emotiva che fa traballare momentaneamente le nostre certezze acquisite, le nostre consuete categorie di interpretazione del mondo. L’interesse di Freud per quest’area dell’esperienza umana si focalizza, nel suo saggio del 1919, in particolare intorno a quelle produzioni artistiche e letterarie che maggiormente fanno leva sull’evocazione del “soprannaturale” e dello spaventoso per coinvolgere il lettore/fruitore e condurlo verso un’esperienza emotiva micro-traumatica nella quale l’affetto principalmente indotto è appunto quello della paura. Freud riprende la teorizzazione di Jentsch, il quale sostiene che tale modalità drammaturgico/retorica presente in alcune opere letterarie, si fonda essenzialmente sull’espediente, da parte del romanziere, di porre il lettore di fronte a una sorta di paradosso cognitivo, nel quale egli si trova impossibilitato a decidere se alcuni personaggi della storia siano oggetti animati o inanimati, esseri viventi oppure cose senza vita. Freud, pur ponendosi sulla linea concettuale di Jentsch, estende la lettura del fenomeno in chiave psicoanalitica, prendendo anch’egli, come aveva fatto Jentsch, come esempio di analisi critica il racconto di E T.A. Hoffmann, “Il mago sabbiolino” (1815).
Questo racconto incluso nella raccolta “I notturni”, viene interpretato da Freud come rimando letterario all’angoscia infantile di castrazione, poiché mette in scena il mostruoso personaggio del Mago Sabbiolino, entità maligna capace di cavare gli occhi ai bambini che non vogliono dormire, nonché di darli in pasto ai suoi figli, a loro volta esseri mostruosi dotati di becchi curvi.
La dialettica “animato/inanimato” è quindi posta in secondo piano da Freud rispetto a Jentsch, e non è vista come primum movens dell’affetto disturbante.
A partire dall’analisi del racconto romantico di Hoffmann, Freud costruisce invece una sua teoria del Perturbante riconducendo tale fenomeno emotivo all’azione della rimozione, o per meglio dire del “ritorno del rimosso”. Attraverso un’accurata indagine filologica della parola “Unheimlich” (Perturbante), che in tedesco significa “non familiare, estraneo, non usuale”, Freud, riprendendo a tale proposito anche la teorizzazione di Schelling, sottolinea tuttavia nel suo opposto, “Heimlich” il significato collaterale di “tenuto nascosto, celato, segreto”, oltre che il significato più consueto di “familiare”o “intimo”. Se l’”heimlich” è ciò che è familiare ma “tenuto nascosto”-rimosso, l’”Unheimilch” è dunque lo svelamento del rimosso, e in ciò stesso risiede la sua natura traumatica, ansiogena e disturbante.
In questa prospettiva la particolare sensazione di perturbamento (unheimlichkeit) che proviamo di fronte a certe opere estetiche particolarmente drammatiche e stranianti, non è altro se non una sorta di teoria traumatica provvisoria, ovvero il tentativo, da parte del lettore/fruitore dell’opera, di costruire una narrazione contenitiva di propri sentimenti rimossi che ritornano improvvisamente quando è posto di fronte ad una rappresentazione artistica che genera in lui inquietudine. Ancora una volta, sembra rammentarci Freud, “L’Io non è padrone in casa propria”: ciò che ci spaventa di un’opera letteraria “perturbante” è cioè la sua capacità di evocare in noi ciò che sentiamo come più familiare, conosciuto dentro noi, ma che è allo stesso tempo “tenuto nascosto” (rimosso/negato): questo “familiare” (heimlich) è costituito da desideri, affetti ed angosce risalenti alla nostra infanzia, e proprio per questo racchiude in sé anche ciò che più ci terrorizza (perché pensavamo di averlo ormai superato). Il prefisso -Un è per converso il segno distintivo della rimozione.
In altre parole l’opera d’arte Perturbante estrae evocativamente, per usare una metafora, gli scheletri dagli armadi inconsci del fruitore dell’opera, ma mentre li estrae allo stesso tempo li significa, cioè integra familiarità con estraneità, mettendo in scena l’angoscia di cui i personaggi e i racconti perturbanti sono intrisi. Come scrive Francesco Conrotto (2000) parlando del concetto di trauma nell’ambito della teoria psicoanalitica: “con il termine trauma si intende mancanza o rottura di senso. Pertanto trauma e rappresentazione sono inversi reciproci, mentre la teoria traumatica è la rappresentazione della mancanza di rappresentazione” (Conrotto, 2000, pag. 2000). Il Perturbante freudianamente inteso agisce proprio a questo livello, come teoria traumatica, cioè come tentativo dell’Io di creare una “formazione di compromesso”, per “darsi una ragione”, per tollerare l’angoscia che invade i suoi confini, e per tentare di ristabilire la propria omeostasi narcisistica.
Per illustrare le sue tesi attraverso un esempio che richiama fortemente in causa il narcisismo e la sua messa in crisi nell’esperienza del Perturbante, Freud, nel suo saggio del 1919 affronta, tra gli altri, anche il tema del Doppio, che riprende da un lavoro di Otto Rank del 1914 (“Der Doppelgänger”). Secondo Freud la percezione di un “doppio” o “sosia” da parte del soggetto, promuove una regressione a epoche primitive dell’evoluzione psichica, nelle quali non è ancora stata tracciata una netta separazione tra i confini dell’Io e quelli della realtà esterna e dell’altro. La percezione del Doppio assicurava dunque una sorta di protezione illusoria rispetto alla paura che l’Io fosse distrutto dalla sua stessa, originaria, strutturale impotenza. Superata questa epoca (infantile), il Doppio può ritornare sotto forma di sensazione perturbante perché evoca proprio quella paura della morte che un tempo l’illusione del Sosia riusciva a scongiurare.
In tempi più recenti la tematica del Perturbante è stata ulteriormente sviluppata da Autori postfreudiani secondo declinazioni multiformi che ne hanno ampliato molto fruttuosamente le possibilità interpretative. Bion nel suo lavoro “Il Gemello immaginario”, letto alla Società Psicoanalitica britannica nel 1950, riprendendo indirettamente il tema del Doppio, descrive una fantasia gemellare di un suo paziente come rappresentazione inquietante di parti scisse e sottratte all’analisi, parti che ritornano come imprevista turbolenza durante il lavoro analitico. Bion introduce anche un interessante confronto tra il meccanismo della “personificazione” di emozioni segrete, non ancora sperimentate, mediata dalla figura disturbante del “gemello”, e il processo di simbolizzazione, cioè il processo di evoluzione e crescita del pensiero. Se per Freud il Perturbante era ciò che abbiamo definito una teoria traumatica provvisoria, da una prospettiva bioniana, il Perturbante potrebbe essere descritto come un effetto dell’impatto degli elementi β sulle nostre “barriere di contatto” emotive. Gli Elementi β, secondo Bion sono stimoli traumatici di varia intensità e natura (emotiva, sensoriale, affettiva), che colpiscono le nostre frontiere emotive mentali, le nostre barriere paraeccitatorie, le quali servono a mettere al riparo la nostra omeastasi somato-psichica, il nostro equilibrio mentale. Tale barriera possiamo immaginarcela come le ciglia dei nostri occhi, che si chiudono per ripararci dalla polvere, in una giornata di vento. Quanto la barriera viene infranta da qualche tipo di elemento β, ecco che tuttavia entra in scena l’elemento α, cioè un’innata capacità immaginativo-emotiva che ha lo scopo di ricucire le rotture provocate da stimoli β disturbanti. Alfa è una capacità che potremmo definire “poetica”, “sognante”, produttrice di senso, che ci è stata trasmessa dalla mente e dalla dedizione di chi si è preso cura di noi, subito dopo la nostra nascita. E’ quindi una funzione curativo-trasformativo materna. L’effetto perturbante è dunque, secondo il modello di Bion, rappresentabile come il tentativo, riuscito e meno, da parte della funzione α del soggetto, di ricostruire una “barriera di contatto” momentaneamente danneggiata da ciò che la perturba.
Per quanto riguarda la scuola kleiniana è utile qui ricordare anche il recente lavoro di Kanciper (2000) su Doppio e Perturbante nella loro profonda incidenza all’interno del rapporto fraterno. Secondo Kanciper il legame fraterno si fonda infatti su uno sdoppiamento narcisistico molto simile a quello descritto da Freud nel suo saggio del 1919: attraverso tale sdoppiamento, insieme familiare e inquietante, i fratelli sono legati l’uno all’altro, ma anche rivali, poiché l’uno per l’altro rappresentano quella “parte eccedente” che minaccia l’unicità dell’Io e il suo narcisismo. La fiaba di “Hansel e Gretel” riportata dai Fratelli Grimm cerca di risolvere tale radicale conflittualità, spostando il Perturbante sulla strega. Il punto di vista kleiniano interpreta quindi, in questo caso, l’effetto perturbante come proiezione sull’opera letteraria di una avidità orale narcisistico-primaria che distrugge l’oggetto mediante un’alleanza complementare tra due fratelli (Hansel e Gretel).
Su una linea interpretativa psicoanalitica del Perturbante che cerca di integrare il modello kleiniano-bioniano con quello winnicottiano, troviamo più recentemente alcune interessanti riflessioni di Christopher Bollas, che descrive certe sensazioni di turbamento prodotte nel fruitore da “oggetti artistici”, come risultato dell’evocazione, sul piano emotivo profondo, di un repentino e violento capovolgimento del rapporto tra caregiver e bambino: un capovolgimento che tradisce in modo radicale le aspettative e i bisogni di chi, appunto, ha più bisogno (il bambino). Tali “oggetti evocativi” perturbanti (Bollas, 2009), soprattutto nel loro porsi come oggetti reali, culturali, collettivi rispecchiano la natura inconscia di esperienze e modi di essere che un tempo abbiamo conosciuto ma non ancora pensato (il cosiddetto “conosciuto non pensato”, Bollas, 1987: pensiamo ad esempio, oltre alla Letteratura anche a quelle opere cinematografiche costruite su sceneggiature con sviluppo drammaturgico perturbante).
Anche in Italia molti psicoanalisti si sono occupati del tema del Doppio, in particolare Enzo Funari che ha curato tra gli altri il volume “Il Doppio. Tra patologia e necessità” (1986), contenente importanti contributi e approfondimenti tra cui ricordiamo emblematicamente quelli di Fausto Petrella ed Eugenio Gaburri.
In definitiva la fruizione di un’opera letteraria, pittorica, cinematografica, è un’esperienza cognitiva, emotiva e sensoriale che ricostruisce un confine narcisistico che il soggetto interpreta come “frontiera familiare” (heimlich). Tutto ciò che definiamo Perturbante è tutto ciò che si muove in una direzione tendenzialmente opposta, cioè verso la rappresentazione di un’abolizione di tale frontiera identitaria, verso il “burrone’ di un’angoscia catastrofica di annichilimento. Il Perturbante, come esperienza estetica, sembra perciò condensare questo duplice movimento intrinseco alle parti più primitive della mente del soggetto: da una parte evoca la morte dell’Io mediante una paventata-evocata frantumazione dei suoi confini; dall’altra genera significazione, cioè un nuovo confine psichico, attraverso il lavoro della raffigurabilità emotivo-immaginativa (funzione α). Il valore culturale, “transizionale” (Winnicott, 1971) del Perturbante, sembra cioè consistere in questa sua potenzialità continuamente decostruente, e insieme costruttiva, di un “confine”, di uno spazio mentale e culturale. Infatti, Il Perturbante si muove sempre sul confine della “rottura del senso”, e di questo confine fa tuttavia il suo luogo d’elezione ed esplorazione. In questa prospettiva possiamo notare che tra i maggiori fruitori dell’arte perturbante (in particolare il Cinema di genere “horror”) troviamo molti adolescenti: l’adolescenza è infatti una fase di sviluppo rivoluzionaria, che investe l’identità dell’individuo e appunto i suoi confini. L’arte perturbante attrae narcisisticamente gli adolescenti, “sedotti” da un tipo di opera fantastica che mette in scena angosce e insieme nostalgie per un’onnipotenza (infantile) perduta. Il genere cinematografico perturbante (“horror”) può fornire all’adolescente una cornice rappresentativo-narrativa che “contiene” gli effetti traumatici dei cambiamenti esistenziali che sta vivendo. Così come il bambino può avvicinarsi alle proprie emozioni attraverso il gioco, o attraverso la fiaba, allo stesso modo l’adolescente, attraverso l’opera perturbante, può avvicinarsi e pensare al dramma identitario che sta vivendo, utilizzando un terreno artistico-transizionale, uno “spazio potenziale” (Winnicott, 1971), come può essere appunto quello rappresentato dall’opera cinematografica. Dal punto di vista del fruitore dell’opera d’arte perturbante, possiamo infatti considerare i film horror come “fiabe per adolescenti” (si veda, ad esempio, significativamente, il film “The Blair Witch Project”, di Daniel Myric e Eduardo Sanchez, 1999, vera e propria fiaba horror, con tanto di strega che terrorizza alcuni ragazzi che fanno camping nel bosco, come degli Hansel e Gretel dei giorni nostri).
Il cinema horror possiede inoltre, all’interno della sua struttura drammaturgica di base, quelli che potremmo definire degli “isomorfismi narrativi” con il difficile e doloroso processo di costruzione identitaria in adolescenza. Si tratta di “isomorfismi” che rappresentano molto bene, ma “a distanza di sicurezza”, cioè sullo schermo, il “cambiamento catastrofico” adolescenziale, nonché le variegate sfumature del tema dell’inquietante Doppio narcisistico, sia libidico che distruttivo (si veda in questo caso il film “Heavenly Creatures”, di Peter Jackson, 1994, nel quale il tema del Doppio narcisistico fraterno-amicale in adolescenza è reso attraverso modalità molto suggestive e pregnanti).
Sul versante dello sviluppo della letteratura perturbante, aldilà del freudiano “Mago Sabbiolino”, è possibile individuare una linea storico-letteraria specifica, che va da E.T.A. Hoffman a Edgar Allan Poe (“Racconti del Terrore” – 1832-1849), fino a H.P. Lovecraft (vedi ad esempio “Le montagne della follia”-1931), per giungere a Stephen King (vedi, tra i suoi romanzi più noti, “Shining” – 1977, da cui è stato tratto il film omonimo, diretto da Stanley Kubrick nel 1980).
Per concludere ricordiamo in Italia il critico letterario Francesco Orlando, che ha dato grande spazio all’applicazione della teoria freudiana in letteratura, attraverso un’analisi approfondita del tema del “soprannaturale” letterario. Gli studi di Orlando, oltre a Freud fanno riferimento alle teorie di Ignacio Matte Blanco sulla bi-logica dell’Inconscio. Secondo Orlando, che riprende lo scritto di Freud “Il poeta e la fantasia” (1907), lo spazio immaginario che viene aperto dalla letteratura, in particolare perturbante, è lo spazio di una “formazione di compromesso”, cioè un fenomeno semiotico-linguistico che integra due forze psichiche in conflitto tra loro, ma che diventano produttrici di senso proprio a causa della loro collisione. Come il sogno, il lapsus, il gioco infantile, anche la letteratura mette in scena le componenti emotive interne dell’Autore, “personificate” nei personaggi costruiti da una narrazione letteraria che evoca/attiva nel lettore le proprie identificazioni soggettive.
Bibliografia
Bion, W. R. (1970), Il gemello immaginario, in Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico, Armando, Roma (2002)
Bollas, C. (1996), Cracking Up. Il lavoro dell’inconscio, Raffaello Cortina, Milano.
Bollas, C. (2009), Il mondo dell’oggetto evocativo, Astrolabio, Roma.
Conrotto, F. (2000) Tra il sapere e la cura. Un itinerario freudiano. Franco Angeli, Milano.
Jentsch, E. (1906), Zur Psychologie Des Unheimlichen, Kessinger Publising, Whitefish USA, 2010.
Freud, S. (1907), Il poeta e la fantasia O.S.F. 5
Freud, S. (1919), Il Perturbante O.S.F. 9
Freud, S. (1912-13),Totem e Tabù O.S.F. 7
Funari, E. (a cura di) (1986), Il Doppio. Tra patologia e necessità, Raffaello Cortina, Milano.
Hoffmann, E.T.A. (1816-1817), Racconti notturni, Einaudi, Torino, 2005.
Kanciper, L. (2000), Il confronto generazionale, Franco Angeli, Milano.
King, S. (1977), Shining, Bompiani, Milano, 2014.
Kanciper, L. (2008), Il complesso fraterno. Studio psicoanalitico, Borla, Roma.
Lovecraft, H.P. (1931), Le montagne della follia, Newton Compton, 2010.
Orlando, F. (1982), Illuminismo, barocco e retorica freudiana, Einaudi, Torino.
Orlando, F. (1987), Per una teoria freudiana della letteratura, Einaudi, Torino.
Rank, O. (1914), Il Doppio, SE, Milano, 2001.
Matte Blanco, I. (2000), L’inconscio come insiemi infiniti, Einaudi, Torino.
Poe, E.A. (2011), Racconti del terrore, Mondadori, Milano, 2011.
Winnicott (1971) Gioco e realtà, Armando, Roma, 2006.
Filmografia
“Heavenly Creatures” (Nuova Zelanda, Germania, 1994). Regia di Peter Jackson. Sceneggiatura di Fran Walsh e Peter Jackson. Produzione: WingNut Films, New Zealand Film Commission, Fontana Productions.
“Te Blair Witch Project- Il mistero della strega di Blair” (USA, 1999). Regia di Daniel Myrick e Eduardo Sànchez. Sceneggiatura di Daniel Myrick e Eduardo Sànchez. Produzione: Haxan Films.
“The Shining” (UK, USA, 1980). Regia di Stanley Kubrick.Sceneggiatura di Stephen King, Stanley Kubrick e Diane Johnson. Produzione: Warner Bros., Hawk Films, Peregrine.
Giugno 2014
Perversione relazionale

J.KOONS, 1990
A cura di Giangaetano Bartolomei e Rossella Vaccaro
Probabilmente l’espressione “perversione relazionale” è stata introdotta nel lessico psicoanalitico italiano da Anna Maria Pandolfi, nel suo contributo,”Le perversioni relazionali nella coppia e nella famiglia”, presentato a un convegno internazionale, svoltosi a Verona nel 1999.
Qualche anno dopo, Sandra Filippini, riconoscendo il suo debito, quantomeno lessicale, verso A. M. Pandolfi, ha ripreso questa espressione, connotandola e arricchendola in modo nuovo e adoperandola come concetto-base del suo saggio Relazioni perverse – La violenza psicologica nella coppia (2005). A questo saggio hanno fatto seguito, da parte di Sandra Filippini, altri contributi, nella forma di relazioni o interventi a convegni. Di particolare rilievo la sua relazione, del 2 febbraio 2007, intitolata “Quando la coppia non funziona. Conflitto o violenza?”, svolta a un convegno, organizzato da un’associazione di avvocati fiorentini, intorno al tema “Conflitto e violenza intrafamiliare”.
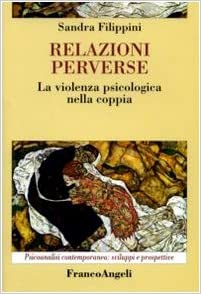
Secondo Sandra Filippini, della quale qui di seguito riassumiamo le tesi più importanti, il maltrattamento psicologico può essere definito “perversione relazionale” quando contiene certe caratteristiche psicodinamiche. Si tratta di una modalità particolare (patologica) di interazione nella coppia dove uno dei due partner (denominato ‘perpetratore’) mette in atto una serie di comportamenti finalizzati a controllare, dominare e sottomettere l’altro, trattandolo non più come un essere umano ma come una cosa.
Va subito aggiunto che il perpetratore può svolgere la propria azione perversa e pervertitrice solo grazie a una sistematica alterazione della verità (delle emozioni, dei sentimenti, delle situazioni, dei fatti eccetera, riguardanti la coppia o soltanto la vittima), alterazione della verità che viene, per così dire,‘imposta’ alla vittima, la cui mente è stata preliminarmente, nella fase di formazione della coppia, ‘colonizzata’ dal perpetratore. La vittima viene manipolata al punto da accettare come vera la rappresentazione falsificata di sé stessa e, in generale, della realtà, impostale dal perpetratore allo scopo di dominarla e di farle subire i propri maltrattamenti e le proprie violenze psicologici.
Spesso l’inizio di una relazione con un partner narcisista è, per la donna, molto gratificante. Il narcisista, infatti, finché ha bisogno di entrare in possesso della donna, è capace di essere molto affascinante (pensiamo al personaggio di Don Giovanni). Lei è molto coinvolta e ha la sensazione di vivere il rapporto più importante della sua vita. In questa fase la donna, com’è normale, è particolarmente esposta; ed è proprio in questo momento che si realizza la prima tappa della vittimizzazione: l’effrazione, come viene chiamata da chi si occupa di maltrattamento. L’effrazione consiste in una sorta di colonizzazione della mente dell’altro, come se il perpetratore prendesse possesso della mente della donna instillando in quest’ultima l’idea che lui sa, più e meglio di lei, che cosa veramente lei vuole, di che cosa veramente lei ha bisogno. A questo punto, la vittima sta cominciando ad abdicare al proprio senso critico, perciò, quando il vero e proprio maltrattamento comincia a manifestarsi, lei non è in grado di riconoscerlo. La perdita della capacità di effettuare un sicuro esame della realtà è, infatti, una delle conseguenze della relazione con un narcisista perverso, ed una delle più dolorose. La donna cade, dunque, vittima di un inganno o più precisamente cade dentro una rete dalla quale spesso non potrà più uscire perché il suo partner riuscirà a persuaderla che solo lui è in grado di darle una rappresentazione corretta di lei stessa e del mondo circostante. Con il termine gaslight, titolo di un film inglese, da cui gaslighter, Sandra Filippini indica “comportamenti messi in atto allo scopo di far sì che una persona dubiti di se stessa e dei suoi giudizi di realtà, che cominci a sentirsi confusa o a temere di stare impazzendo. Esso va distinto dal dubbio e dalla ruminazione ossessivi, che non sono dovuti alla presenza di un gaslighter” (2005, 34).

Ma come inizia una storia di maltrattamento psicologico? E’ essenziale e fatale che la donna s’imbatta in un narcisista perverso, nel quale, come si sa, il tratto narcisistico si caratterizza per l’indifferenza alla relazione, se non in quanto e fin tanto che gli dia lustro o comunque alimenti la ‘grandezza’ del suo Io, mentre iltratto perverso si caratterizza per l’indifferenzaper la persona dell’altro, per la mancanza di empatia, per il tentativo costante di trasformare la relazione con l’altro in relazione di potere, nel disconoscere, dell’altro, l’umanità e nell’usarlo a proprio piacere: nel deumanizzare l’altro. Il perverso prova piacere – un senso di trionfo – nel controllare l’altro, nell’obbligarlo a fare, attraverso la manipolazione e la minaccia di un ricatto (psicologico), quello che l’altro non vorrebbe fare: “Nella relazione narcisistico – perversa l’oggetto viene usato con la finalità di mantenere il sé coeso, ma ciò avviene con mezzi che vanno oltre l’uso dell’oggetto come supporto e specchio del proprio sé grandioso. Il rifornimento narcisistico nella relazione narcisistico – perversa si effettua, in altre parole, con un surplus di danneggiamento e di manipolazione nei confronti dell’oggetto perché entrano in gioco i mezzi tipici della perversione e cioè il diniego e la scissione messi in atto con il piacere specifico di umiliare e distruggere, oltre a quella peculiare capacità, tipica della perversione, di alterare la realtà. Il narcisista perverso è “narcisista” in quanto lavora per mantenere la propria autostima ed è “perverso” in quanto fa pagare ad altri il prezzo della difesa dal collasso del sé” (M. Ponsi, 2003, in www.spi-Firenze.it).
La donna, così, si isola: rimane sola con il perpetratore, alla mercé del suo giudizio. Nascondendo ciò che realmente accade fra loro, finisce con il proteggere il partner che la maltratta; ma soprattutto, la donna ha paura. Teme il rimprovero, la battuta sarcastica, la minaccia espressa a bassa voce e in tono cupo, oppure gridata durante un’esplosione di collera. Fa di tutto per rabbonire il compagno, ogni suo sforzo va in questa direzione. Farebbe qualunque cosa pur di strappargli un sorriso, un cenno di assenso, un’approvazione.
Esiste – si chiede Sandra Filippini – uno specifico profilo di personalità della vittima designata, nello stesso modo in cui si può tracciare un profilo del perpetratore? Probabilmente no. Quello del diventare vittima è un percorso che molte donne potrebbero fare e non fanno perché non hanno incontrato un perpetratore, oppure che molte donne fanno quando incontrano un perpetratore, ma che, se riescono a lasciarlo, possono non ripetere più nella vita.
Una volta attratte nelle spire di una relazione perversa, le donne annaspano per molto tempo senza riuscire a uscirne. Quali sono le ragioni di questa lunga permanenza in un rapporto che fa soffrire? Non è chiaro se questo dipenda dalle caratteristiche della perversione relazionale, oppure da un profilo di personalità precedentemente stabilito e identificabile, e ciò costituisce una questione che ammette multipli livelli di risposta. Fin qui il nocciolo del pensiero di Sandra Filippini.
Ruth Stein (2005), ma non solo lei, parla di un “patto perverso” che legherebbe i due membri della coppia perversa. Ma, invece, nel caso della “perversione relazionale”, descritta da Sandra Filippini ( e questo va sottolineato energicamente) non esiste alcuna “coppia perversa”, non esiste alcun tacito patto tra vittima e perpetratore, e nessuna complicità sotterranea: piuttosto, esiste una strategia perversa di inganno e di sopraffazione, messa in atto dal perpetratore dopo avere, in vari modi e in varie forme, “sedotto” la vittima e privata della sua autonomia e della sua autostima.
Mario Rossi Monti, al termine della sua recensione del saggio della Filippini, ci ricorda una tesi fondamentale della Filippini stessa, e cioè che “adottare l’ipotesi della collusione equivale ad assumere un atteggiamento di sospetto e di colpevolizzazione nei confronti della vittima, rendendo inefficace la relazione terapeutica”. Viceversa, la relazione è perversa in primo luogo poiché il partner perverso perverte la relazione, attaccando nella vittima la capacità di pensare e mettendola fuori uso mediante un’opera di sistematico décervelage, per usare l’espressione di Racamier (1992). “Al di là delle intenzioni che l’Autrice esplicita – conclude Mario Rossi Monti – queste considerazioni sollevano una serie di problemi di grande rilevanza. Solo due accenni: (1) problemi di carattere epistemologico relativi al frequente ricorso da parte della psicoanalisi a ‘pseudo-spiegazioni’[…]; (2) problemi di carattere teorico-clinico relativi all’ adozione di una prospettiva ‘disposizionale’ per il perpetratore del maltrattamento (che sarebbe caratterizzato da un particolare assetto patologico di personalità) e viceversa di una prospettiva ‘situazionale’ per la vittima, nella quale conta più la situazione che non le caratteristiche della persona”(Rossi Monti, 2007).
Nancy Mc Williams, nel suo La diagnosi psicoanalitica (2011), descrive il masochismo a vari livelli e con diverse sfumature (2011, 303-325) distinguendo il masochismo nella sfera sessuale dell’individuo dal masochismo come stile di attaccamento, sostenendo che quest’ultimo struttura le personalità autodistruttive che, sottomettendosi ai loro aguzzini, annullano sé stesse nella speranza di essere amate. Quindi masochismo non per amore e piacere della sofferenza, ma sopportazione della violenza come mezzo che “giustifica” il raggiungimento di uno scopo senza il quale non è possibile sopravvivere: “La donna che si comporta in modo masochistico tollera il dolore e la sofferenza nella speranza, cosciente o inconscia, di un qualche bene maggiore come se il proprio benessere in definitiva dipendesse dalla sua capacità di sopportare i maltrattamenti” (2011, 305). Sandra Filippini ha invece sostenuto che l’uso del termine masochismo deve essere esclusivamente applicato alla sfera della sessualità: “Se molte formulazioni psicoanalitiche sono mal definite, quella di masochismo è anche fuorviante, perché troppo moralisticamente compromessa, troppo legata a giudizi di valore. In questo caso tali giudizi sono doppiamente pericolosi, perché l’argomento che la donna rimane con il compagno maltrattante perché lo vuole è l’argomento del maltrattante stesso (e a volte anche dello psicoterapeuta cui la donna alla fine si rivolge). Se parliamo d’intenzionalità inconscia, potremmo essere tentati di affermare che, se la donna subisce, è perché con una parte di sé lo vuole, ma nemmeno quest’affermazione coglie la sostanza del problema. Come sto cercando di dimostrare, è proprio la situazione di maltrattamento a legare la donna all’uomo che la maltratta, attraverso le strategie di coping che tale situazione le impone di adottare, attraverso l’isolamento e la deformazione della realtà” (S. Filippini, 2005, 72; G. Bartolomei, S. Filippini, 2001). Osserva Benedetta Guerrini Degl’ Innocenti (2011): “La coppia è̀ una situazione esemplare in cui si ha la presenza reale, concreta dell’altro come modello, oggetto, soccorritore, nemico. Alcune di queste cose, o tutte insieme[…]. È proprio il legame che diventa il nuovo soggetto psicopatologico: un’organizzazione psicopatologica transpersonale costituita da ambiti di condivisione inconscia che, una volta entrati in risonanza e trasformati in un nuovo soggetto, sono inscindibili dall’apporto delle persone che interagiscono[…]. Il maltrattamento psicologico si radica in un contesto relazionale patologico che solo recentemente è diventato oggetto di riflessione e che, per le sue peculiari caratteristiche, sfugge alle possibilità di lettura offerte dalle concettualizzazioni tradizionali”.
Il principale intento di Sandra Filippini è stato pertanto quello di affrancare la donna maltrattata da un giudizio che la rappresenta come vittima compiacente, dove il terapeuta, e non solo, scambia gli effetti con le cause (la debolezza della vittima, la sua incapacità di reagire è la conseguenza di una prolungata situazione di abuso, non è il motivo scatenante di questa situazione).Stefania Nicasi, nel suo commento al caso clinico di A.“Lavorare con la complessa combinazione delle dinamiche paranoide e masochistica: un caso clinico” presentato da Nancy Mc Williams nella Giornata di Studio “Lo spettro della follia – diagnosi e storie cliniche” (Firenze, 17 settembre 2016), osserva, tra l’altro, quanto segue: “Sandra propendeva pertanto per una diagnosi situazionale piuttosto che disposizionale: la vittima è resa tale dalla situazione che vive e non dalla sua personalità. Pensava, viceversa, che il maltrattante, il perpetratore, avesse uno specifico profilo personologico e stile relazionale. Del resto, un’impressionante mole di studi di psicologia sociale ha ampiamente documentato l’esistenza di specifiche ‘strategie di vittimizzazione’. Sandra Filippini riconosceva che, nella maggior parte dei casi osservati, la vittima aveva una storia infantile traumatica, ma si rifiutava di disegnarne un profilo: in fondo, questo non avrebbe fatto altro che spostare indietro nel tempo la ‘colpa’ di avere subito. L’operazione compiuta da Sandra Filippini è stata salutare: era urgente e andava fatta, specie nel mondo psicoanalitico. Tuttavia credo che, se Sandra avesse potuto seguitare il suo studio, oggi sarebbe disponibile a un confronto più disteso con Nancy Mc Williams, autrice da lei molto apprezzata. Forse avrebbe potuto accettare una formulazione del tipo: il fatto che le vittime non provino piacere nel subire non significa che non ne ricavino un guadagno narcisistico e relazionale. Questo, se ho capito, è il terreno nel quale si spinge Nancy Mc Williams che non usa la diagnosi di personalità autodistruttiva come un verdetto ma come un’ipotesi guida con la quale ricostruire e comprendere la storia del formarsi di un tratto di personalità e di una modalità di stare con l’altro che possono essere modificati a caro prezzo ma con sicuro vantaggio per il paziente”.
Come si vede, il tema di un profilo di personalità specifico delle “vittime” rimane cruciale, così come il riferimento ai traumi infantili subiti, come fattori predisponenti alla creazione di una relazione perversa, nella quale svolgere il ruolo di vittima. D’altro canto, l’osservazione di un cospicuo numero di casi sembra suggerire che NON ogni donna è a rischio di diventare vittima di un “perpetratore”, anche perché alcune donne che si sono imbattute in un potenziale “perpetratore”, hanno prontamente interrotto la relazione, disgustate dalla sua personalità. Insomma, a ogni donna può accadere di incontrare questo tipo patologico, ma soltanto alcune sono esposte al rischio di entrare con lui in una relazione perversa, nella quale saranno vittime.
Forse non sarebbe uno sforzo inutile quello di tentare di tracciare i tratti principali di un profilo di personalità delle potenziali “vittime”. E tale profilo dovrebbe far riferimento, come fattore caratterizzante, al contesto affettivo in cui la vittima è stata allevata e ai probabili eventi traumatici che hanno segnato le sue relazioni primarie. In altre parole si potrebbe formulare l’ipotesi che esista un “tipo” di donna che, se avesse la sventura di imbattersi in un “perpetratore”, sarebbe più suscettibile di altre di diventarne la vittima. Donne, pertanto, certamente più a rischio, nelle quali il fallimento del compito evolutivo dell’oggetto primario è stato causa di traumatiche sofferenze non curate e la cui regia difensiva può produrre dipendenza, paura della solitudine e terrore dell’abbandono. Questa ipotesi, però, esclude che le vittime ricavino dalla relazione perversa un guadagno narcisistico e relazionale, come, invece, sembra supporre la Mc Williams. Pare, insomma, che molti psicoanalisti siano a tal punto attaccati al principio, quasi metafisico, del “vantaggio secondario” da non poter ammettere l’esistenza di una relazione in cui la vittima ricavi soltanto danni psichici (e talora anche fisici). Come se, ad ogni costo, nell’interpretare il senso degli atteggiamenti e dei comportamenti umani fosse obbligatorio rintracciare un piacere o manifesto o latente. In questo modo, tuttavia, è il concetto stesso di “vittima”, nella pienezza del suo significato, a essere rifiutato. In ogni caso, la scelta tra le due opzioni interpretative or ora accennate ha un impatto immediato e decisivo sulla possibilità e sulla modalità di un trattamento psicoterapeutico della “vittima”. La “tradizione psicoanalitica”, ma anche una certa pigrizia mentale, ci indurrebbe a mostrare alle nostre pazienti il “vantaggio” (inconscio ma potente) che traggono anche dal ruolo di vittima in una relazione perversa. Ma è una sfida, che dovremmo avere il coraggio di raccogliere, quella di immaginare, invece, in che modo prenderci cura e ‘curare’ una vittima allo stato puro (non molto dissimile da un bambino vittima di un genitore sadico), per aiutarla a sottrarsi al suo perpetratore. Proviamo a escludere che la futura vittima vada inconsciamente alla ricerca del suo aguzzino (così come lo ha descritto la Filippini), proviamo a immaginare che diventi “vittima” non per ottenere qualcosa, ma perché soffre di importanti mancanze affettive ed è carente di qualche strumento di insight e/o di comprensione empatica (cioè di comprensione immediata e intuitiva della personalità e degli intenti nascosti del suo carnefice), e vediamo se e come possiamo aiutarla a salvarsi con gli strumenti di cui disponiamo. Si capisce che una psicoterapia centrata sui “buchi” di una personalità è più difficile, meno prevedibile e meno routinaria di una psicoterapia centrata su conflitti, difese, desideri inconsci eccetera, ma può darsi che in taluni casi sia l’unica via da tentare e anche, spesso, da inventare.
Dicembre, 2016
BIBLIOGRAFIA
Bartolomei G., Filippini S. La perversione sadomasochistica: l’oggetto e le teorie (Sadomasochistic perversion: objet and teorie) Int.J.Psychoanal. 82, 5, 1023-1027.
Filippini S. (2005). Relazioni perverse. Milano, Franco Angeli.
Filippini S. (2005a). Perverse relationships: the perspective of the perpetrator. Int. J. Psycho-Anal., 86, 3, 755-774.
Guerrini Degl’Innocenti B. (2011). Attaccamenti perversi (vedi http://www.spiweb.it/psiche_rivista/Psiche/home.htm).
Mc Williams N. (1994). La diagnosi psicoanalitica, Struttura della personalità e processo clinico. Astrolabio, 1999.
Mc Williams (2011). La diagnosi psicoanalitica. Roma, Astrolabio.
Nicasi S. (2017). Commento al caso clinico di A.,“Lavorare con la complessa combinazione delle dinamiche paranoide e masochistica: un caso clinico”presentato da Nancy McWilliams nella Giornata di Studio “Lo spettro della follia – diagnosi e storie cliniche” (vedi http://www.spi- firenze.it/archivio.html).
Pandolfi A. M. (1999). Le perversioni relazionali nella coppia e nella famiglia. Presentato al Convegno Internazionale CePR «Lo psicoanalista con e senza divano. Individui, famiglie, istituzioni fra psicosi e perversioni”. Verona, 12-13 novembre 1999.
Ponsi M., Filippini S. (2003). “Narcisismo e perversione relazionale”. Relazione tenuta al seminario: “Profili clinici del narcisismo”, Convitto della Calza, Firenze, 22 febbraio 2003 (vedi http://www.spi- firenze.it/archivio.html).
Ponsi M. (2003). Narcisismo e perversione relazionale (vedi http://www.spi- firenze.it/archivio.html).
Ponsi M. (2008). Dialogando con Sandra. Considerazioni intorno a “Relazioni Perverse”(vedi http://www.spi- firenze.it/archivio.html).
Racamier P.-C.,Pensée perverse & décervelage (1991-1992) in Secrets de famille et pensée perverse, in Revue de psychanalyse familiale et groupale, Éditions Collège de Psychanalyse, Paris,1992.
Rossi Monti M. (2007) recensione di S.Filippini, Relazioni Perverse. La violenza psicologica nella coppia, in “Rivista di Psicoanal., 53:554-557.
Stein R. (2005), “Why perversion? False love and perverse act”, in Int. J. Psychoanal., 86, 3, 775-800.
Dossier:
Perversioni sessuali

Dal film Venere in pelliccia di R. Polanski
A cura di Franco De Masi
Nel dibattito che si è andato sviluppando in questi ultimi anni, il termine “perverso”, che è stato già cancellato dalla nosografia psichiatrica, tende a scomparire anche dal linguaggio psicoanalitico.
Nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM) non si parla più di perversione ma di “parafilie”.
Le “parafilie” comprendono tutte le perversioni tradizionali quali il feticismo, il travestitismo, l’esibizionismo, il voyeurismo, la pedofilia, il sadomasochismo, etc.
Il termine “parafilia” è neutro e, diversamente da “perversione”, è sprovvisto di connotazioni morali, quindi lontano dal sospetto di voler etichettare i diversi come malvagi o spregevoli.
Nonostante la commistione di pregiudizi morali che il termine comporta, preferisco parlare di perversione. Mi sento molto vicino a Stoller (1985) per il quale l’azione è perversa quando l’eccitazione erotica dipende dalla sensazione che l’individuo ha di commettere peccato.
La nozione di peccato è centrale nella perversione perchè sottolinea la percezione soggettiva dell’azione trasgressiva da cui nasce il piacere. Il desiderio di trasgredire l’ordine morale, di umiliare, di sovvertire o di essere crudele, che sono avvertiti come “naturali” nel singolo perverso, costituiscono l’unico immaginario sessuale possibile(De Masi,1999).
Si possono sintetizzare due periodi nello studio e nella concettualizzazione della perversione.
Il primo riguarda il contributo fondamentale di quegli studiosi che hanno fondato la moderna sessuologia, tra cui spicca Krafft Ebing.
Lo studio della sessualità deviante ha avuto inizio alla fine del secolo scorso con la pubblicazione della prima edizione del suo voluminoso trattato “Psychopatia Sexualis” (1886), in cui le aberrazioni sessuali sono considerate per la prima volta oggetto di studio psichiatrico. Per Kraft-Ebing la scelta della perversione è sempre latente anche quando è possibile documentare la sua insorgenza in episodi dell’infanzia. Krafft-Ebing crede, infatti, che un accadimento dell’infanzia, come ad esempio l’eccitamento di essere picchiato del piccolo Rousseau (citato anche da Freud), sia solo un fattore secondario nell’eziologia del masochismo, l’occasione per il suo emergere piuttosto che la sua causa.
I “Tre Saggi sulla Teoria della Sessualità” (1905) di Freud contengono molti passaggi che parafrasano alcune delle generalizzazioni proprie di Krafft-Ebing: la continuità tra il normale e il patologico, l’ubiquità dell’influenza della sessualità nel comportamento e nel pensiero umano, la compresenza di livelli primitivi e adulti di sessualità. Krafft-Ebing sottolinea l’importanza delle prime esperienze sessuali infantili per lo sviluppo della sessualità perversa, e intuisce che le fantasie masturbatorie a carattere deviante nell’infanzia sono il serbatoio dello sviluppo della perversione in età adulta.
Il secondo periodo è caratterizzato dalla prospettiva di comprensione dinamica aperta da Freud. Considerando gli aspetti perversi come uno sviluppo di livelli primitivi dello sviluppo sessuale normale Freud ha contribuito a superare una delle preclusioni ideologiche e morali del disturbo che fino ad allora avevano caratterizzato l’approccio medico alla perversione
L’apertura freudiana alla concettualizzazione della perversione non esaurisce tuttavia la complessità del problema. Come vedremo più avanti, esiste nell’indagine psicoanalitica una polarità per cui , mentre l’estensione del concetto di pulsione sessuale porta a negare le differenze tra comportamenti normali e patologici, l’eccessiva dimensione psicologica, come avviene nelle teorie relazionali contemporanee, oscura la specificità e l’autonomia della sfera sessuale perversa.
Un metodo idoneo e abitualmente adottato nello studio psicoanalitico della perversione è quello che la confronta con la relazione d’amore che accompagna gli scambi sessuali tra i partners. Questo tipo di sessualità caratterizza quelle persone considerate mature o ben integrate, che ricercano il piacere sessuale all’interno di una relazione di amore e di tenerezza. La sessualità in questi casi non è impulsiva e riesce ad essere dilazionata sino a quando non si creano le condizioni per un rapporto intimo: il piacere deriva dal godimento offerto al partner e da quello ricercato per sé.
L’amore relazionale consiste, in altre parole, in un incontro armonioso ed equilibrato, tra ricerca di gratificazione personale e senso altruistico di attenzione e di rispetto per il piacere dell’altro. In altre situazioni l’impulso sessuale esige invece un soddisfacimento immediato, con ciò rivelando una disgiunzione tra sessualità e amore. Questo processo di disgiunzione è abbastanza comune nella sessualità ordinaria, dove si riscontra anche una certa oscillazione tra le due posizioni, l’amore tenero e quello sessuale puro, che è fisiologica nella vita di tutti, a conferma che la sessualità e l’orgasmo sono componenti variabili e indipendenti dall’amore. Dall’amore tenero e appassionato a quello inteso come puro appagamento e gratificazione sessuale si passa poi alla sessualità dominata da componenti aggressive, all’universo sessuale sadico. La sessualità deviante appartiene al mondo dell’eccitazione e della pornografia e ha le sue radici nella fantasia aggressiva e di possesso.
Per la psicoanalisi in ogni perversione c’è un processo di degradazione dell’oggetto d’amore, che trasforma la persona in una cosa. Nel feticismo, ad esempio, l’oggetto concreto, che sta al posto di un oggetto umano, diventa il veicolo per l’immaginazione sessuale.
Questo processo avviene in modo estremo e conseguente nella perversione che poggia su un immaginario in cui il simbolico e l’emotivo sono esiliati e propone, più di queste, una configurazione intransigente del piacere del possesso e del dominio. Ad esempio il sadomasochista deve distruggere l’umanità dell’oggetto e asservirlo per poterne godere. La deumanizzazione è conseguenza del principio del potere; l’oggetto, per essere fruibile, deve diventare una cosa.
L’ insieme delle teorie psicoanalitiche attuali sulla perversione si situa su tre posizioni fondamentali che ora elenco:
A) Gli autori che appartengono al primo gruppo, che possiamo chiamare modello 1, considerano la perversione come una deviazione del comportamento sessuale mettendo l’accento su un disturbo della sessualità. Tali teorie seguono le ipotesi di Freud sulla sessualità infantile e sul ruolo della sessualità nello sviluppo umano. Il modello psicosessuale, fedele agli enunciati di Freud, vede nella perversione lo spaccato e la cristallizzazione delle tensioni libidiche e aggressive che caratterizzano lo sviluppo della sessualità umana. Il contributo di Janine Chasseguet-Smirgel rappresenta il più moderno e coerente sviluppo di tale prospettiva teorica.
L’Autrice (1985) descrive il pervertimento della realtà ottenuto tramite la negazione delle differenze tra i sessi e tra le generazioni: nella perversione la realtà psichica viene sminuzzata e mescolata, come le feci, per cui tutte le differenze si aboliscono, incluse quella tra buono e cattivo. Tipica della perversione è la creazione di un mondo ideale dove, oltre alla negazione delle differenze sessuali e delle generazioni, c’è la convinzione dell’ assenza della separazione, del tempo e della morte.
B) Il secondo gruppo, modello 2, mette l’accento sulla funzione difensiva della sessualità considerando centrali per la comprensione della perversione le angosce che minacciano l’identità personale. A questa posizione appartengono autori, come ad esempio Masud Khan, che si richiamano al pensiero di Winnicott e altri, come gli psicoanalisti nordamericani, che seguono le teorie di Kohut.Per quest’ ultimo autore la perversione è una relazione oggettuale narcisistica, potenzialmente diretta verso forme più integre di strutturazione del Sé. Alcuni autori di questo gruppo parlano di interferenza traumatica nello sviluppo della perversione. I microtraumi infantili, quelli cui fa riferimento Khan (1979) con il concetto di trauma cumulativo, possono contribuire a creare alcune aree caratteriali di tipo narcisistico e autoerotico che, secondo l’autore, diventano specifici per lo sviluppo della perversione in età adulta.
C) Altre correnti di pensiero di ispirazione kleiniana, che raggruppo nel modello 3, considerano la perversione una sessualizzazione del potere e della crudeltà, che si struttura come un’organizzazione psicopatologica della personalità. L’amore sessuale, che realizza l’unione del piacere e della cura per l’oggetto, viene distinto dall’eccitamento perverso che nasce dal trionfo sull’altro e dal piacere della distruzione. La crudeltà ha un ruolo preminente e la sessualità è un appagamento, un trionfo sessualizzato. I più importanti analisti che appartengono a quest’ area di pensiero sono Meltzer e Rosenfeld.
H. Rosenfeld(1988) e D. Meltzer (1973), si concentrano sulle relazioni perverse tra parti della personalità nelle organizzazioni patologiche. In queste ultime, nuclei narcisistici distruttivi (che nei sogni vengono rappresentati come gangs delinquenziali) prendono il comando e tengono in loro potere le parti sane, di cui ottengono una sottomissione consenziente .
Lo stato psichico in queste circostanze viene a configurarsi come un incontro tra parti della personalità simile a quello riscontrabile nella sessualità sado-masochistica. Queste parti distruttive offrono spesso un ritiro o un rifugio ricco di qualità narcisistiche, che procura sollievo dall’angoscia e dal dolore, ma che costituisce più spesso una struttura perversa che cattura le altre parti del Sè.
Altri autori ritengono che le perversioni dipendano da un “ritiro” infantile conseguente alla lontananza emotiva dei genitori; su questa linea interpretativa si inserisce il caso descritto da Betty Joseph (1982) nel lavoro Addiction to near death.
Esiste una continuità straordinaria tra i primi “giochi” infantili e la realizzazione della perversione adulta. Quando si ha in analisi un paziente perverso è possibile ricostruire la fantasia originaria di accesso alla perversione: una fantasia complessa, che non si esaurisce nel comportamento crudele, ma rimanda, attraverso l’immaginario sessuale, alla specifica relazione d’oggetto della perversione. Il ruolo dell’immaginazione spiega la centralità della funzione visiva nella costruzione della scena perversa e l’importanza della componente estetico-voyeuristica. Il guardare come mezzo per catturare e incorporare l’altro, l’essere guardati o il ferire lo sguardo nell’esibizionismo, il concentrarsi eccitato sugli organi sessuali nella pornografia fanno parte dello scenario immaginario necessario alla perversione.
Uso il termine di “immaginazione” come fantasia cosciente ad occhi aperti, come l’aveva intesa Freud e come l’aveva descritta Anna Freud nel lavoro “Fantasie di percosse e sogni ad occhi aperti” del 1922, con un significato tuttavia più pregnante, di mondo a sé costituito dall’immaginazione.
Nella perversione gli oggetti vivono solo in quanto realizzano il compito assegnato dall’ immaginazione; l’incontro sessuale è la ripetizione di quanto è stato pre-pensato e immaginato, con poca spontaneità e nessuna libertà. Da questi elementi deriva per l’osservatore esterno l’aspetto deumanizzato e ripetitivo degli atti perversi.
Attraverso la relazione con il partner creato nell’immaginazione il perverso realizza la propria fantasia onnipotente: per raggiungere il piacere deve creare una nuova realtà. Se il partner fosse sentito vivo e indipendente non potrebbero esserci la libertà e l’onnipotenza della fantasia; un partner vero, con proprie esigenze e bisogni, è un limite all’immaginazione e, come tale, diminuisce l’eccitamento. Nella teoria psicoanalitica esistono costruzioni molteplici e complesse per spiegare il significato della sessualità, in particolare di quelle forme che non esprimono una sessualità relazionale.
La distinzione tra sessualità e sessualizzazione ci aiuta a comprendere un altro elemento importante della perversione sado-masochista, che sta anche per il carattere speciale che assume il piacere. Freud si era riferito a questo aspetto parlando di idealizzazione della pulsione. Quando Freud (1919) parla di bambini che molto presto, all’età di 4-5 anni, sviluppano una fantasia capace di indurre piacere sessuale, ci dice che l’orgasmo sessuale può essere un fatto mentale che precede nel tempo l’azione reale della masturbazione.
Per definire il tipo di orgasmo che il masochista raggiunge Sacher-Masoch, nel famoso romanzo “Venere in pelliccia”, usa il termine “übersinnlich”.Questo vocabolo tedesco significa sia soprasensibile sia sovrasensuale (il traduttore italiano usa opportunamente il termine sovrasensuale) che, in tutte le sue accezioni e sfumature, descrive un piacere sensuale speciale che travalica i limiti della percezione e della sensibilità ordinari. Già Kraft-Ebing aveva notato che le persone destinate alla perversione sarebbero sessualmente ipereccitabili e avrebbero una predisposizione all'”estasi sessuale”.
Questa notazione è molto importante e aiuta a concepire la perversione come uno stato mentale in cui la sessualità contribuisce a creare uno stato di dipendenza
Tutto ciò porterebbe a considerare le perversioni sessuali come appartenenti ad un’area mentale affine a quella delle tossicomanie; infatti esprimerebbero una dipendenza o una schiavitù da una droga mentale di tipo sessuale, simile alla dipendenza da alcool o da stupefacenti.
Heinz Kohut è forse il primo tra i pochi analisti che hanno sottolineato la somiglianza tra il piacere perverso e quello derivante dalle droghe. Nella prima lezione all’Istituto di Chicago (1996) ci dice che la persona è spinta verso la perversione con la stessa intensità con cui un individuo dipende da una droga e sperimenta un piacere dello stesso tipo. In seguito Meltzer (1973) apparenta le perversioni alle tossicomanie. La perversione può essere definita come una tecnica di eccitamento mentale che nasce nell’isolamento e si coltiva nell’immaginazione e che non include alcun elemento relazionale e che è ricercato per se stesso. Il piacere sessuale è ottenuto mediante specifiche rappresentazioni mentali legate all’idea di dominare e possedere una persona o, al contrario, di essere dominati e posseduti.
Per tutte le perversioni esiste una fantasia che si prepara nell’infanzia, un nucleo attorno a cui, in modo sempre più esclusivo, il soggetto prepara i movimenti immaginativi che portano all’orgasmo.
Di qui l’importanza che assume nella perversione la sessualità infantile, un concetto a sua volta complesso e irto di contraddizioni. Senza voler negare il ruolo svolto dalla sensualità e dalla ricerca del piacere nell’infanzia, è opportuno distinguere la sessualità nel bambino dal bambino sessualizzato.
L’esperienza della sessualizzazione consiste in una tecnica di trasformazione delle percezioni capace di ottenere un tipo particolare di piacere orgasmico. E’ un piacere che nasce da una sessualità anti-relazionale, un’ espansione della mente provocata dall’immaginazione. Il bambino può ricorrere alla sessualizzazione in seguito a una facilitazione ambientale, quando ad esempio è stimolato da attenzioni erotiche di adulti, oppure per una particolare eccitabilità personale.
Si tratta comunque di un ritiro precoce, un rifugio psichico (Steiner 1993), in cui il piacere sessualizzato ottenuto con tecniche masturbatorie diventa il polo di sviluppo e di attrazione. Nella perversione la forza del carattere viene indebolita sin dai primi anni dalla sottomissione al piacere e il bambino, di conseguenza, non sviluppa rabbia vitale nei confronti degli oggetti cattivi, ma li teme e li idoleggia. La parte della personalità che si nutre di fantasie perverse convive consapevolmente con quella che rimane in contatto con il mondo affettivo.
Questo spiegherebbe un aspetto abbastanza costante nei pazienti perversi. Essi hanno spesso dissociato l’aggressività vitale, che è stata immessa, nella fantasia perversa al punto tale che essi hanno poca capacità di affrontare le difficoltà della vita con giuste difese. Essi sono tendenzialmente passivi perché vivono in una condizione di fantasia appagante e piacevole.
Poiché le perversioni sessuali strutturate escludono la percezione della sofferenza e si presentano come una ricerca egosintonica del piacere, difficilmente determinano una richiesta di terapia contrariamente a quanto si verifica nelle patologie borderline con acting perversi, in cui la sofferenza e l’angoscia sono in primo piano.
Per questo motivo questi pazienti chiedono una terapia solo quando temono che la loro perversione possa esporli a pericoli o a sanzioni giuridiche. Nel caso in cui essi diventano angosciati perché percepiscono che il nucleo perverso sta per dominare la parte sana della personalità allora possono chiedere un aiuto e l’analisi in questo caso può rivelarsi fruttuosa.
Chasseguet-Smirgel J. Creativity ad Perversion, Free Association Books, London 1985 (trad. it. Creatività e perversione, Cortina, Milano 1987)
De Masi F. La perversione sado-masochistica. L’oggetto e le teorie. Bollati Boringhieri, Torino 1999
Freud A. Fantasie di percosse e sogni ad occhi aperti. (1922) Vol. I Opere Bollati Boringhieri
Freud S. Tre saggi sulla teoria sessuale (1905) Vol. 4 edizione Boringhieri Opere
Un bambino viene picchiato (1919) Vol 8 edizione Boringhieri Opere
Joseph B. A Clinical contribution to the Analysis of Perversion, Int. J. Psycho-Anal. vol.52, 441-49 (1971)
Khan M.M.R. Alienation in Perversion, Hogarth Press, London 1979 (trad. it. Le figure della perversione, Boringhieri,Torino1982)
Kohut H., The Chicago Institute Lectures, Analytic Press, Hillsdale 1996 (trad. it. Lezioni di tecnica analitica. Le conferenze dell’istituto di Chicago, Astrolabio, Roma 1997)
Kraft-Ebing R. von, Psychopatia Sexualis Putman’s Sons, New York 1965.
Meltzer D. Sexual State of the Mind, Clunie Press, Perthshire 1973 ( trad.it. Stati sessuali della mente, Armando, Roma 1973)
Rosenfeld H. On Masochism. A Theoretical and Clinical Approach. In Glick R. A.and Meyers D. I. (cura di) Masochism. Current Psychoanalytic Perspectives, Analytic Press, Hillsdale, 1988.
Sacher-Masoch L. von, Venere in pelliccia (1875) Bompiani, Mlano 1977.
Steiner J. Psychic Retreats, Pathological Organitations in Psychotic, Neurotic and Borderline Patients, Tavistock, London 1993 ( trad. it. I rifugi della mente, Bollati Boringhieri,Torino 1996)
Piacere
A cura di Andrea Scardovi
Piacere (Il)
Introduzione
Tematicamente il piacere attraversa l’opera freudiana dai suoi inizi sino agli ultimi scritti, ed è presente nella riflessione di diversi autori successivi a Freud. Allo stesso tempo esso rappresenta una voce tendenzialmente implicita della letteratura, e a tutt’oggi una definizione del piacere, inteso psicoanaliticamente, non esiste. La mancanza di una definizione del piacere si accompagna alla complessità del pensiero di Freud su questo tema, e corrisponde ad un problema conoscitivo già evocato dal Filebo di Platone. In questo dialogo Socrate afferma che chi provi in qualsiasi maniera un qualsiasi godimento gode sempre realmente, anche se di ciò che non esiste o non è mai esistito. Anche se ci pensiamo ciecamente orientati al conseguimento del piacere, riconosceremo facilmente che l’uomo ricerca quel che per lui è un piacere, e non qualcosa di ratificabile o oggettivabile come tale. Come ha notato recentemente Bencivenga (2012), il piacere non è falsificabile. Quando ne facciamo materia di studio rischiamo dunque di collocarlo in uno spazio pubblico, oggettivato; di fraintendere la sua natura intra-personale che per lo psicoanalista rimanda direttamente alla realtà psichica.
Il piacere nel pensiero di Freud
L’accezione freudiana del piacere prende forma in continuità con il pensiero di Fechner, ai cui studi neurofisiologici Freud si ispirò in modo ampio e dichiarato. Fechner (1848) aveva enunciato un “principio di piacere dell’azione”, con cui intendeva segnalare che i nostri atti sono determinati dal piacere e dal dispiacere procurati dalle rappresentazioni che intervengono al momento dell’azione da compiere. Come indicato da Laplanche e Pontalis (1967), questa accezione non intendeva tanto considerare il piacere come finalità dell’azione umana; metteva in luce piuttosto la natura automatica delle motivazioni che entrano in gioco nelle nostre scelte, avvicinando il problema delle loro ragioni inconsce. Similmente, Freud colloca il piacere in una posizione centrale all’interno della propria costruzione teorica e arriva a farne uno dei principi che regolano il funzionamento dell’apparato psichico, ma l’importanza della ricerca del piacere e dell’evitamento del dispiacere nella teoria freudiana non va confusa con una visione edonistica dell’individuo.
La teoria psicoanalitica cerca di radicare la pensabilità del piacere in termini di funzionamento psichico, individuandone gli aspetti economici e sforzandosi al tempo stesso di coglierne gli elementi dinamici. Da un punto di vista economico l’apparato psichico freudiano appare regolato dalla tendenza alla scarica della tensione, vissuta come spiacevole perché turbativa della quiete. In quest’ottica il piacere corrisponde alla sensazione della scarica verso l’esterno dell’energia apportata dalle sollecitazioni a cui l’individuo è esposto sia dall’esterno che al proprio interno. Tuttavia la riflessione su questi aspetti economici del funzionamento psichico ha conosciuto diverse articolazioni nell’arco dell’opera di Freud. Se in alcuni passaggi dei suoi scritti l’idea del piacere viene sovrapposta alla scarica della tensione, nell’insieme della sua teorizzazione l’apparato psichico tende a ripristinare lo stato di quiete turbato dalle sollecitazioni pulsionali in virtù di un principio distinto da quello del piacere: il principio di costanza. Il principio di costanza esprime la tendenza a risolvere le tensioni procurate dalle sollecitazioni a cui l’organismo è esposto, nella sua natura di essere irriducibilmente vivente. È un principio che contiene la sua implicita insoddisfabilità. Come Freud segnala sin dal “Progetto di una Psicologia” (1895), nel momento in cui una scarica avviene con completezza la percezione del suo realizzarsi costituisce una nuova sensazione, divenendo cosi fonte di ulteriore tensione e di nuove necessità di scarica. Il principio di piacere nasce da questa impossibilità di risolvere esaustivamente la tensione che si vorrebbe scaricare. La tendenza dell’organismo a ricercare il piacere e ad evitare il dispiacere non rappresenta dunque un giudizio sul carattere edonistico della natura umana; segnala piuttosto il suo legame costitutivo con qualcosa di insaturo e irrisolvibile, che mette in luce l’inquietudine a cui l’individuo è esposto, per sua natura.
In “Al di là del principio del piacere”, il famoso saggio del 1920, il piacere consiste della sensazione di sollievo procurata dalla scarica, ma non viene propriamente identificato con quest’ultima. Soprattutto non è la ricerca del piacere la causa della sofferenza psichica, ma la presenza di altre forze più potenti, primarie e elementari che intervengono nella coazione a ripetere e possono portare ad un uso, questo sì edonistico, del piacere. Come dirà Lacan (1971) la pulsione di morte è “iperedonista”; rivolta cioè a un godimento inteso come fattore di morte, e non di vita. D’altra parte è una evidenza dell’esperienza, non soltanto di quella clinica, che nei fantasmi inconsci la sofferenza possa rappresentare una sorta di piacere irrinunciabile. Con l’ipotesi di una coazione a ripetere in grado di oltrepassare il dominio del principio del piacere, il piacere non rappresenta più un oggetto teleologico; non è più pensato come solo scopo delle azioni umane, e diviene esso stesso oggetto di inibizione, timore, difficoltà. La tendenza della vita psichica a ridurre, mantenere costante o sopprimere la tensione interna prodotta dagli stimoli trova espressione nel principio di piacere, ma questo principio viene ora descritto come una tendenza che opera al servizio di una funzione, con cui non può più, propriamente, essere identificato. In sostanza Freud avvia in questo lavoro del 1920 un passaggio teorico complesso, che rimane però relativamente incompiuto. Da un lato esplora la possibilità di pensare il piacere come modificazione della grandezza della carica energetica entro una data unità di tempo, non più come scarica di una quantità; il piacere viene accostato ad una sorta di ritmo, una qualità temporale che riflette il modo in cui le sensazioni di piacere e dispiacere trovano modo di bilanciarsi nella loro alternanza. Dall’altro permane in questo saggio una sovrapposizione fra principio di costanza e principio di piacere, che se venisse considerata senza individuare la possibile articolazione fra le forze in gioco – quelle legate alla scarica, alla distruttività e alla coazione a ripetere, rispetto a quelle vicine al piacere e al principio che ne sancisce l’importanza – collocherebbe questo stesso principio al di qua di ogni dinamica, finendo per identificarlo con la ricerca di una scarica definitiva e sovrapponendo così la ricerca del piacere alla pulsione di morte. Nel 1924 (“Il problema economico del masochismo”) Freud afferma di poter risolvere questa sovrapposizione e arriva a compiere un importante passaggio differenziativo, che non a caso verrà messo in luce in particolare da Loewald, nel suo studio sulla sublimazione (1988). Questo scritto di Freud si apre con la dichiarazione esplicita di voler superare le confusioni rimaste irrisolte in “Al di là del principio del piacere”, e presenta un’articolazione dinamica del rapporto fra principio di costanza, principio di piacere e principio di realtà, che appare essenziale per la comprensione del piacere psicoanalitico. Il principio di piacere viene ora considerato come una modificazione del principio di costanza, come elemento di una trasformazione che interviene quando l’individuo, non potendo realizzare una scarica esaustiva, incontra nell’ambiente una qualità che gli consente di accedere alla capacità di dilazionare nel tempo l’urgenza, altrimenti inderogabile, della scarica. In presenza della possibilità di un piacere sufficiente, e sufficientemente qualitativo, l’individuo sperimenta la possibilità di accedere al principio di realtà, che viene a consistere della capacità di dilazionare la scarica nel tempo. Ciascun principio si propone ora uno scopo distinto, che contribuisce alla sua definizione. Il principio di costanza persegue la diminuzione quantitativa della pressione dello stimolo. Il principio di piacere la reperibilità di una caratteristica qualitativa dello stimolo. Il principio di realtà la capacità di dilazione temporale della scarica dello stimolo, con la conseguente tollerabilità della tensione spiacevole. In ragione di questa nuova accezione, conclude Freud, non si può più respingere la definizione del principio di piacere come custode della nostra vita. Dopo un complesso itinerario speculativo il piacere viene a rappresentare una qualità essenzialmente dinamica che consente di accedere al principio di realtà, e sembra costituire un elemento sostanziale di quella possibile trasformazione della quantità in qualità di cui il funzionamento dell’apparato psichico consiste. L’accenno di Freud al concetto di ritmo, di variazione nel tempo delle sensazioni di piacere e dispiacere, introduce inoltre il problema del rapporto fra piacere e temporalità, un tema che troverà sviluppo specifico nella riflessione di alcuni autori post-freudiani.
APPROFONDIMENTI
Nel suo libro “I destini del piacere” (1979) P. Aulagnier si pone una domanda centrale per la riflessione psicoanalitica su questo tema. Quale è, si chiede Aulagnier, il premio di piacere che permette all’Io di investire uno scorrere del tempo che lo conduce verso la morte? Che gli consente cioè di vivere, di “abitare” la temporalità dell’esperienza? Riprendendo implicitamente le riflessioni freudiane che abbiamo considerato, Aulagnier indica che perché il tempo risulti abitabile, senza dover sottostare alla necessità di una scarica immediata della tensione, occorre che ci sia la “promessa” di un piacere possibile. Essa individua l’oggetto di questa promessa nel piacere fornito dall’identità fra la parola e la cosa. Più precisamente: dalla sensazione della possibile corrispondenza fra rappresentazione di parola e rappresentazione di cosa. Il pensiero di Aulagnier sembra indicare che perché il soggetto sviluppi una continuità del senso di sé, è necessario che senta di poter trovare una conferma al legame fra le parole e le cose a cui lo svolgersi della propria esperienza lo espone, in particolare nella relazione con il genitore e, in senso lato, con il caregiver, che Aulagnier chiama appunto il ‘portaparola’. Similmente, laddove si sia creata una discontinuità, come accade nelle situazioni psicopatologiche, perché il soggetto possa ricominciare a vivere la sua temporalità occorre che egli disponga della possibilità di ripartire da un legame confermativo fra le rappresentazioni di parola e le rappresentazioni di cosa che incontra nella sua esperienza con il curante. La sensazione di questa possibile corrispondenza rappresenta per l’individuo una fonte di piacere soggettivante, un fondamentale piacere auto-riconoscitivo che assume valore di elemento evolutivo sostanziale. Si tratta di quello che possiamo intendere come un piacere confermativo dell’oggetto e di se stessi, che ha a che fare con il possibile piacere del Sé; che rimanda cioè alla possibilità di sentire autenticamente di esserci, a quella possibilità di “sentirsi reali” di cui Winnicott ha parlato in diversi passaggi della sua teorizzazione.
Da un lato sappiamo che per questo autore non è la soddisfazione istintuale che fa sentire al bambino di esistere, che rende la vita reale e degna di essere vissuta. Nell’area del gioco e dei fenomeni transizionali la soddisfazione attiene, infatti, alla capacità di creare legami con gli oggetti, più che all’attività diretta della pulsione che spinga verso il proprio soddisfacimento. Allo stesso tempo Winnicott sottolinea con forza come questi fenomeni possono avere straordinaria intensità e segnala che in essi potrebbe essere in gioco un piacere senza acme, distinto da quello modellato sulla localizzazione e sull’orgasmo (1968). Si tratta di un piacere che non conosce picco e detumescenza, come ha notato Recalcati (2012), ma piuttosto onde lunghe, oscillazioni, fenomeni infinitamente variabili non assimilabili alla forma stereotipata della scarica. L’idea winnicottiana di piacere, apparentemente distante dalla metapsicologia, risulta prossima al piacere qualitativo che abbiamo visto emergere nel pensiero di Freud, e sembra trovare una significativa applicabilità alla pratica clinica. Nel suo famoso lavoro sull’uso di un oggetto (1969) Winnicott sostiene che perché un’analisi non divenga interminabile, perché ci sia in essa la soddisfazione dell’autenticità, occorre che si compia il passaggio che porta dalla relazione con l’oggetto sino alla capacità di usare l’oggetto. Significativamente, le parole con cui illustrerà questo passaggio rimandano esplicitamente alla gioia, al godimento del paziente che abbia potuto realizzarlo, ma anche alla gioia e al godimento dell’analista che sia divenuto capace di lasciare che esso avvenga.
L’analista che sia troppo occupato a utilizzare il contenuto del gioco rischia di non cogliere il valore del gioco come cosa in sé, a partire dall’importanza del piacere e della gioia che il bambino sperimenta in esso (1970). Ma occorre che lo stesso psicoanalista metta in campo la propria capacità di provare piacere, di essere nell’esperienza in modo vivo e sensibile, non schermato da una conoscenza distanziante che confonderebbe l’importanza dell’astinenza con una astensione in realtà difensiva. Come ha scritto Phillips (1988), Winnicott è l’autore che più di ogni altro ha parlato esplicitamente del piacere che provava nel lavorare con i propri pazienti, e in questo senso ha fornito un contributo fondamentale perché sia possibile considerare i processi generativi del campo analitico, arrivando a pensare il piacere, sia quello del paziente che quello dell’analista, come un elemento costitutivo del lavoro che li coinvolge.
Non è probabilmente un caso che questa accezione di un piacere non identificato con la scarica abbia preso forma nell’esperienza del lavoro clinico con i bambini. Nella letteratura più recente è infatti proprio l’infant research a fornire nuovi spunti relativi alla comprensione dell’importanza del piacere e della natura non edonistica, ma certamente edonica, dello psichico. Anche l’intreccio con le neuroscienze, sempre più impegnate nell’approfondimento dei meccanismi appetitivi e della dimensione edonica dell’esperienza (Bloom, 2010; Tommasello 2011; Music, 2011; Ansermet e Magistretti, 2012; Wallenstein, 2012), sta portando diversi autori a valorizzare l’attenzione al piacere nel processo terapeutico. Come ha scritto Music (2011, 2013), una parte della letteratura psicoanalitica ha trascurato una serie di emozioni, e fra queste il godimento, il piacere, l’eccitazione – non già intesa come sinonimo di ipomaniacalità; la vitalità, la gioia. In Music la partecipazione attiva alla vita sociale diventa un esperienza di gioiosità della comunicazione con l’esterno, e non solo una regolazione emozionale o il contenimento del dolore psichico. Non a caso i bambini trascurati raramente mostrano la capacità di provare questo tipo di godimento.
Si pone qui il problema del positivo, del modo in cui, cioè, la teoria psicoanalitica rende pensabile la fisiologia di ciò che accade psichicamente, e inter-psichicamente, nella pratica clinica.
In una lettera a Ferenczi, citata in Jones, Freud (1928) scrisse che il positivo avrebbe meritato maggiore attenzione nella sua teorizzazione, e che egli aveva lasciato al tatto degli analisti ciò che di positivo si dovrebbe fare, ma che il risultato era stato che gli analisti più docili non avevano afferrato l’elasticità delle regole che aveva proposto, trattandole come fossero altrettanti tabù. Aggiunse che un giorno tutto questo avrebbe dovuto essere rivisto, senza però trascurare le regole e le condizioni di cui aveva parlato, che rendono possibile il lavoro analitico.
La capacità dello psicoanalista di muoversi fra le regole della cura e la possibilità di immergersi con sufficiente libertà nel piacere dell’area preconscia, indagando e mettendo in luce la fisiologia di quello che può intervenire nel campo analitico, sembra rappresentare una qualità essenziale dei più recenti contributi della psicoanalisi italiana. A partire da una radicata continuità con la metapsicologia freudiana, i lavori di Semi dedicati allo studio della coscienza in psicoanalisi e all’approfondimento del metodo delle libere associazioni (2003; 2011); gli studi di Conrotto, centrati sulla definibilità epistemologica della natura esperienziale del processo analitico, e dei limiti conoscitivi sulla cui consapevolezza esso si istituisce e si articola libidicamente (2010); i contributi di Ambrosiano e Gaburri, che hanno ripreso il pensiero di Loewald sulla sublimazione e valorizzato gli aspetti della “spinta a esistere” nel lavoro analitico (2008, 2013); il pensiero di Ferro e della scuola di Pavia, capace di dare forme e consistenza alle potenzialità generative del campo e alla capacità della coppia analitica di sognare e comunicarsi quanto va accadendo fra loro (2002; 2013); sino alla teoria dell’interpsichico, sviluppata recentemente da Bolognini (2008); costituiscono gli elementi di un pensiero composito, ma attento a valorizzare gli aspetti del positivo essenziali alla pratica analitica e alla sua stringente attualità.
Questi contributi avviano a pensare la fisiologia degli scambi fra analista e paziente, e il piacere che può intervenire in essi, in una prospettiva che va oltre la retorica della relazione, perchè approfondisce radici e modalità del contatto psicoanalitico, ricollocando nell’accezione freudiana della sessualità le teorie, in prevalenza francesi e nordamericane, che hanno studiato l’interazione fra i membri della coppia analitica. In particolare, il concetto di equivalenza (Bolognini, 2008) mette in correlazione lo scambio interpsichico che può avvenire in analisi con lo scambio intercorporeo fra le mucose – da quello della suzione di allattamento, alle interazioni comunicative che si realizzano grazie agli organi di senso, sino all’incontro e all’accoppiamento genitale – e radica nel corporeo e nella sessualità la possibilità di pensare qualità che trascendono le proprietà individuali.
Dicembre 2013
BIBLIOGRAFIA
Ambrosiano L., Gaburri E., “La spinta a esistere. Note cliniche sulla sessualità oggi”. Roma, Borla. (2008).
Ambrosiano L., “Sublimazione”. Voce in Spipedia, www.spiweb.it , 2013.
Ansermet F., Magistretti P., “Gli enigmi del piacere”, Bollati Boringhieri, Torino, 2012
Aulagnier P. “Les Destins du Plaisir. Alienation – Amour – Passion”, 1979, PUF, Paris. Ed it. “I Destini del Piacere”, trad. it. di A. Lucchetti, 2002, La Biblioteca, Bari – Roma
Bencivenga E. “Il piacere. Indagine filosofica”. Ed Laterza, Roma – Bari, 2012, p. 5
Bolognini S., “Passaggi segreti, teoria dell’interpsichico”. Bollati Boringhieri, Torino, 2008
Bloom P., “La scienza del piacere. L’irresistibile attrazione verso il cibo, l’arte, l’amore”. Il Saggiatore, Milano, 2010
Conrotto F., “Per una teoria psicoanalitica della conoscenza”. Franco Angeli, 2010
Fechner G.T. “Uber der Lustprinzip des Handelns”, Zeitschrift fur philosophie und philosophische Kritik” Halle, a) 1-30 e 163-194, – b) 11. 1848.
Lacan J., “Seminario XVIII”. Einaudi, Torino, 1971
Laplanche J. e Pontalis J.B. “Enciclopedia della Psicoanalisi”, Laterza, Bari, 1968, p. 414
Ferro A., “Fattori di malattia, fattori di guarigione”. R. Cortina ed., Milano, 2002
Ferro A., “Psicoanalisi oggi”, a cura di, Carocci Editore, Roma. 2013
Freud S.,” Progetto di una Psicologia”, 1895, OSF, vol. 2, Boringhieri, Torino
Freud S., Al di là del Principio del Piacere, 1920, OSF vol. 9, Boringhieri, Torino
Freud S., “Il Problema economico del masochismo”, 1924, OSF, vol. 10, Boringhieri, Torino
Freud S., Lettera a Ferenczi del 4 gennaio 1928, cit. in Jones, op. cit.,“Vita e opere di Freud. 2. Gli anni della maturità 1901-1919” p. 297-298. Il Saggiatore, 1962.
Loewald Hans W., “La Sublimazione. Ricerche di psicoanalisi teorica”. 1988. Boringhieri, Torino, 1992
Music G., “Trascurare la trascuratezza: il contributo di neuroscienze, teoria dell’attaccamento e psicologia evolutiva allo sviluppo della tecnica psicoanalitica”. In Busato Barbaglio C. e Mondello M.L., a cura di, “Nuovi Assetti della Clinica Psicoanalitica in età evolutiva”, Quaderni di Psicoterapia Infantile, 62, Borla, Roma, 2011
Music G. “Nature Culturali. Attaccamento e sviluppo socioculturale, emozionale, cerebrale del bambino”. Borla, Roma, 2013
Wallenstein G. (2009) “L’istinto del piacere”. Edizioni Dedalo, Bari, 2011
Tommasello M., “Altruisti nati. Perché cooperiamo fin da piccoli”. Bollati Boringhieri, Torino, 2010
Phillips A., (1988) “Winnicott, Una biografia intellettuale”. Armando ed., Roma, 1995
Platone, “Filebo”, a cura di M. Migliori, Bompiani, Milano 2006
Recalcati M., “Jacques Lacan. Desiderio, godimento e soggettivazione”. p. 569, R. Cortina, Milano, 2012
Semi A.A., “La coscienza in psicoanalisi”. R. Cortina ed.,Milano, 2003
Semi A.A., “Il metodo delle libere associazioni”. R. Cortina ed., Milano, 2011
Winnicott D.W., “The use of an object”, International Journal of Psycho-Analysis (1969), 50:, 711-716. Nuova traduzione di A. Novelletto, Psychomedia, Anno I, n. 1, Gennaio 2001
Winnicott, D.W., “Playing, Its theoretical status in the clinical situation”, 1968, Int. J., 49. Trad. it. In Gioco e realtà, op. cit., cap. terzo, p. 71
Winnicott, D.W., “Gioco e Realtà”, Armando ed., Roma, 1970
Preadolescenza

W-Eggleston-1972
Preadolescenza
a cura di Francesco Mancuso
La Preadolescenza si riferisce all’intervallo compreso tra i 10-13 anni, è un luogo, un passaggio trasformativo e diremmo transizionale che ha delle caratteristiche particolari e che può dare la possibilità al soggetto di esprimere le sue qualità, le sue risorse creative, ma anche i suoi impedimenti, i limiti e i rischi insiti in questo transito. Il soggetto non ne uscirà così come vi è entrato. Generalmente, siamo più attratti dalle trasformazioni somatiche e comportamentali della Preadolescenza più che da quelle psichiche.
Negli scritti teorico-clinici sull’età evolutiva e nella teoria e nella clinica psicoanalitica (Mancuso, 2021), la Preadolescenza tende a sfumare tra l’Infanzia e l’Adolescenza, così come troviamo la stessa tendenza, ovvero sfumare la preadolescenza, nella famiglia e nella società. E’ utile, invece, inserire la Preadolescenza, proprio per la specificità ed unicità dei fenomeni clinici, in una sua cornice teorica, idonea a descrivere i fenomeni emergenti, anche in linea con il famoso “secondo tempo” dello sviluppo psicosessuale di freudiana memoria.
Campanile (2003) ritiene il concetto di Preadolescenza alla stregua di un artificio che tuttavia ha l’utilità di “isolarla” per le sue importanti implicazioni sul piano teorico. Goisis (1999) considera la preadolescenza come un momento con caratteristiche specifiche, essa rappresenta il “non più” rispetto all’infanzia e il “non ancora” rispetto all’adolescenza”.
Il preadolescente esalta la condizione angosciosa della transizionalità. Viversi in transizione equivale a viversi senza una “definizione”, per cui si tende a preferire l’area dell’essere già… all’area del divenire. Proprio per sfuggire a questa angosciosa condizione molti dei protagonisti (ragazzi e genitori) tendono a comportarsi come se i bambini fossero “adolescenti” prima di essere pubescenti. Mettersi nell’assetto mentale di considerare un preadolescente come già adolescente trascura e oscura la componente giocosa e sognante che ricorda l’esperienza infantile del gattonamento dove l’euforia per lo spostamento in autonomia spesso vira repentinamente in un sentimento di spaesamento e ritiro o ritorno verso l’orbita genitoriale.
Un altro elemento importante che spesso viene trascurato in questa transizione è la dimensione della reciprocità. Il processo di separazione ed individuazione che prende avvio in Preadolescenza, non va inteso come un immediato “svincolo” dei figli dai genitori e, in quanto punto d’arrivo, rappresenta un compito evolutivo che coinvolge l’intero nucleo che si trova a vivere la transizione.
Come adulti, educatori o terapeuti, è decisivo sintonizzarsi con la “transizione”, concentrata in poco tempo ma che può sembrare interminabile. La transizionalità non va scambiata per staticità, poiché essa non avviene senza un lavoro psichico.
Forse mai come in quest’epoca domina lo scontro tra la natura e la cultura. Il preadolescente è difficilmente definibile, perché questo periodo evolve velocemente e riflette la rapidità dei cambiamenti sociali e culturali che egli assorbe con rapidità impressionante.
Se da una parte egli tende a uniformarsi alle “pressioni” culturali (famiglia e società) che lo spingono in avanti, dall’altra – come la neurobiologia moderna ci segnala- molte delle sue aspirazioni, in generale legate a pretese di autonomie decisionali e ad adesioni a modelli trasmessi dai media sono spesso frenate dall’immaturità dei processi di sviluppo cerebrali che si consolidano con l’avanzare dell’età. Spesso le condotte del preadolescente imprevedibili ed impacciate sono dovute a questa condizione di trovarsi alla confluenza di opposte correnti motivazionali e maturative. Il risultato è che spesso egli appare come una “caricatura” dell’adolescente, ma anche una “caricatura” dell’ex bambino.
Il bambino all’interno della sua latenza ci aveva abituati ad una certa stabilità della condizione infantile che ora si trasforma in turbolenza, anche per l’attesa di un segnale (pubertà) che arriva/non arriva e che produce ambivalenza nei genitori. Proprio per la tensione dominante, si ha la tendenza alla riduzione della durata del periodo e il preadolescente è presto assorbito, risucchiato dalle tematiche e dagli atteggiamenti adolescenziali. E’ un periodo in cui tutti sono a disagio e non si vede l’ora di passare oltre. Per questo, ci troviamo ad assistere ad un vero e proprio “furto della preadolescenza” da parte di agenzie culturali, ma anche da parte di molti genitori, che espropriano questo periodo dei loro figli del valore maturativo dell’attesa e della transizione. In ogni caso muta radicalmente il contatto con il soggetto preadolescente rispetto al soggetto bambino, il contatto è sempre più labile con le figure parentali e soprattutto è lui a deciderlo.
La visione del corpo, o di quanto gli sta accadendo, è per il preadolescente ancora troppo legata all’area infantile. Il corpo è il concreto e privilegiato strumento di comunicazione implicita e le verità affettive, che esso comincia a veicolare sono ancora misteriose. Il preadolescente vive la “sorpresa” puberale ma non sa bene come trattarla, sorpresa che talvolta può prendere la configurazione di un trauma. I tempi psichici sono più dilatati e il lavoro di elaborazione ed integrazione forse va considerato in più fasi:
– Quello che succede al preadolescente richiama l’immagine dell’intrusione traumatica sotto forma di cariche emozionali-pulsionali-ormonali che scuotono.
– Questa condizione esige il fare ricorso alle modalità di reagire ad analoghe situazioni “traumatiche” vissute in passato (richiami infantili ai mutamenti evolutivi ed ambientali).
– Il preadolescente percepisce la “mutazione” tanto attesa-temuta e ricorre ad una “appropriazione narcisistica” delle nuove conquiste, che spesso lo mette nella condizione di percepire lo scarto tra l’attesa ideale e la realtà; dunque deve ricorrere alle sue modalità “conosciute” di reagire allo scarto
– Tutto ciò prima di avviarsi ad un lavoro di lutto e di integrazione vera e propria più tipici dell’adolescenza.
Ph. Gutton (1991) attribuisce grande importanza al periodo puberale e con formula sintetica ma efficace evidenzia che la pubertà rappresenta per il corpo ciò che il pubertario rappresenta per la psiche. Penso che in Preadolescenza avvenga nel corpo e inizi nella mente quella transizione dalla pubertà, come evento fisico, al processo del pubertario, come evento psichico e cognitivo.
Stiamo dunque passando da una condizione di relativa tranquillità e stabilità (latenza), necessarie per lo sviluppo intellettivo e sociale del bambino, ad una condizione che sconvolgerà sensibilmente questo equilibrio. Anche per il corpo come per la mente avviene un accrescimento staturo-ponderale normalmente non alterato da stati di malattie che ne modificano la linea naturale dello sviluppo. In Preadolescenza è possibile confrontarsi con l’anticipazione di certe tematiche e patologie dell’adolescenza; ma anche prendere atto del prolungamento di certe manifestazioni infantili o della rivelazione di disturbi infantili che erano mascherati.
Mi sto avvicinando al tentativo di affrontare sia alcuni dei pericoli che incombono sul preadolescente in quella “mutazione” che ragazzi e ragazze stanno transitando, ma anche i tentativi di soluzioni più o meno patologiche che essi sono in grado di trovare.
Se finora, in condizioni di sviluppo normale, Edipo e Narciso avevano convissuto e si erano spalleggiati a vicenda, ritengo che la pubertà possa segnare un momento decisivo relativo ai possibili differenti percorsi. La pubertà diventa un “trauma” che genera una dissociazione funzionale a livello delle dinamiche interne.
Ecco che allora alla pubertà avvengono due serie di fenomeni che possono trovare un equilibrio oppure svilupparsi secondo linee differenti. Ad analoghe manifestazioni sintomatiche, sia per le ragazze che per i ragazzi, corrispondono origini ed evoluzioni differenti.
Una prima serie riguarda l’impatto di “Edipo” con quel corpo, impatto traumatico per quanto desiderato, come ampiamente descritto da molti autori tra cui A. Freud (1949) e P. Blos (1958; 1962).
La seconda serie di fenomeni riguarda l’impatto del corpo puberale con l’ologramma ideale di Sé che “Narciso” aveva da tempo anticipato e costruito.
E’ indubbio che la strada che attende Edipo, una volta “dotato” dell’attrezzatura biologica necessaria, è ricca di insidie attratto, come potrebbe essere da una parte dalle tendenze “incestuose”, dall’altra dalle necessarie ed avventurose imprese “parricide” (tematiche della separazione-individuazione).
Tutte queste realtà “conflittuali”, se a predominare è Narciso, possono essere by-passate (come soluzione difensiva). Altra possibile evoluzione è quella di confidare nella creazione fantastica di una realtà alternativa in cui viene mantenuta intatta l’onnipotenza della bisessualità trasferita in qualche galassia virtuale o da super eroe da videogioco.
Possiamo, dunque, ipotizzare di organizzare le problematiche e le manifestazioni sintomatiche riscontrate in Preadolescenza secondo che prevalga l’area edipica o l’area narcisistica. Abbiamo quindi la tematica del “conflitto” oppure quella dello “scarto” insanabile e mortificante. In altre parole se nell’area prevalentemente edipica il dilemma angosciante riguarda come, con le nuove dotazioni, affrontare il desiderio di “esplorare il mondo” (io ne ho il diritto o no?), nella dimensione prevalentemente narcisistica il giovane soggetto si scontra con l’inesorabile dubbio sulla sua insufficiente dotazione (fisica, mentale e cognitiva) a realizzare il progetto (ne sarò capace o no?).
Alla condizione traumatica del processo puberale, l’organismo risponde con le modalità e gli strumenti che ha utilizzato in passato in analoghe circostanze traumatogene, che possono interessare l’area:
- somatica (conversiva),
- mentale (fobie più o meno invalidanti, inibizione intellettiva, ritiro, maniacalità)
- comportamentale (ADHD, DOC o fobico–ossessivo, tossicofilia, attacchi al corpo, …).
Molte di queste forme possono essere definite di “transizione” proprio per la loro struttura ed evoluzione, ma possono essere i primi segnali di una patologia in adolescenza.
Nella stesura di questa scheda rimangono “scoperte” almeno due aree importanti. Prima di tutto l’area del particolare e specifico assetto terapeutico nel lavoro con questi giovani pazienti. Altra area “scoperta” riguarda la dimensione dei genitori visti sia come agenti in sofferenza con e per il figlio -che quindi chiedono aiuto primariamente per il figlio- ma anche nella condizione di chiedere aiuto per loro. Il momento che si concretizza con la richiesta di un intervento è per i genitori particolarmente delicato per il loro equilibrio, avendo vissuto l’esplosione interna di un malessere ri-acceso dalla Preadolescenza del figlio. Senza contare che la Preadolescenza rappresenta normalmente l’ultima tappa evolutiva del soggetto in cui i genitori hanno ancora una funzione determinante nel processo di individuazione e nel percorso terapeutico.
Bibliografia
Blos P. (1958), Preadolescent drive organization. Journal of the American Psychoanalytic Association, 6:, 47-56, 1958, Trad. It. L’organizzazione istintuale preadolescente, Trad. di Arnaldo Novelletto, Adolescenza e Psicoanalisi, Anno II – N° 1 – Gennaio 2002
Blos P. (1962), L’adolescenza. Un’interpretazione psicoanalitica. Franco Angeli, Milano, 1983.
Campanile P. (2003) Soggettivizzazione e “costruzione” della preadolescenza. Riv. di Psic., 1, 73-96.
Freud A. (1949), Alcune difficoltà nel rapporto del preadolescente con i genitori. Opere, Vol. II. Boringhieri, Torino, pp. 467-475.
Goisis R. (1999), A proposito di genitori e di preadolescenza. Appunti e considerazioni cliniche preliminari, Quaderno dell’istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente , vol. 11, pp. 17-25
Gutton Ph. (1991), Le pubertaire. PUF, Paris.
Mancuso F. (2021), Passaggio in preadolescenza: rischi e risorse creative. Quaderno dell’istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente, vol. 53, 2021.
Psiche -Soma
A cura di Ersilia Cassani
La parola psiche-soma è stata creata da Winnicott congiungendo graficamente i due termini inglesi psyche e soma. Secondo l’Oxford Dictionary il primo significato di psyche è anima, mente o spirito ed il secondo è un nome proprio: Psyche è la personificazione dell’anima come una donna o a volte come una farfalla; l’etimo è greco e significa respiro, vita e anima. Dunque, il suo senso riguarda la vita mentale e nella sua radice ci sono rimandi al corpo vivo: il respiro, la vitalità, il movimento leggero. Nella definizione di soma rientrano sia le parti di un organismo che non sono le cellule riproduttive sia ciò che è distinto dall’anima, dalla mente o dalla psiche. Accanto alla definizione biologica il Somatics Systems Institute ha aggiunto una sfumatura di significato psicologico: il soma è la percezione interiore del proprio corpo. Pertanto, la parola soma ha un significato biologico e alla psiche si aggancia attraverso il vissuto interiore e adombrando l’idea di un corpo personale. I due termini psiche e soma si trovano in una relazione dialettica: nessuno può stare senza l’altro perché perde significato o si trasforma in qualche cosa di diverso. Attraverso il trattino di congiunzione Winnicott trasmette sinteticamente il significato di una mente incarnata nel corpo e di un corpo che è la persona.
Il concetto appartiene alla teoria dello sviluppo di Winnicott.
Secondo l’autore psiche-soma è la forma più primitiva della vita mentale, presente sin dai primi momenti dopo la nascita in modo discontinuo e poi progressivamente più stabile nelle diverse età della vita accanto ai prodotti più complessi del pensiero cosciente ed inconscio.
Sul piano fenomenologico si manifesta come la vitalità dell’individuo: il senso pieno della fame, quello della sazietà, il buon tono muscolare, la coordinazione motoria e così via esprimono la vita psichica della persona, che è primariamente il suo corpo vivo o, per meglio dire, il suo soma. Ben conosciute dagli psichiatri sono le dissociazioni patologiche tra psiche e soma che si hanno in alcune psicosi e nelle cosiddette malattie psicosomatiche; esistono anche dissociazioni fisiologiche come lo smarrimento nel tempo e nello spazio che può accompagnarsi ad un brusco risveglio. Sul piano dell’attività rappresentativa allo psiche-soma corrisponde l’elaborazione immaginativa del funzionamento corporeo al suo livello più semplice (1949, 1965).
Gli esempi fatti evidenziano che la psiche non risiede in un organo specifico, sebbene nel pensiero comune spesso sia posta nella testa. La sua tendenza ad abitare il corpo (e viceversa) è innata, tuttavia nei primi momenti della vita post-natale il bambino alterna momenti d’ integrazione psicosomatica a stati di non integrazione: solo dal punto di vista di un osservatore esterno è una unità, dall’interno è un complesso di fasi motorie e di percezioni sensoriali alternate a stati di riposo; alle prime corrisponde un’ integrazione temporanea della psiche nel corpo che manca negli stati di riposo. Inoltre, nelle fasi di dipendenza assoluta e poi relativa del bambino dalla madre (o da chi ne fa le veci) il processo di integrazione psicosomatica richiede una facilitazione ambientale, un attivo adattamento ai bisogni e ai ritmi del bambino attraverso le cure che, all’inizio, sono quelle fisiche emotivamente partecipate.
Winnicott pone particolare enfasi sullo stato psichico della madre che inserisce ripetutamente la mente nel corpo senza disturbare in modo non tollerabile la continuità di esistere del piccolo: egli scrive che nei primi momenti dopo la nascita del bambino la madre va incontro “quasi ad una malattia”, una regressione al proprio psiche-soma, che le permette d’identificarsi col piccolo, intuire e capire col corpo – dunque spontaneamente e preconsciamente – ciò che manca al bambino. Da questa prospettiva lo psiche-soma è la prima modalità di contatto tra la mamma ed il bambino.
Col passare delle settimane, la madre torna gradualmente come era prima, mentre il bambino crescendo sviluppa altre funzioni mentali (l’attenzione, la memoria, la catalogazione, eccetera) che fanno parte del pensiero razionale cosciente e gli consentono di capire e tollerare i fallimenti relativi della madre, senza usurparne le funzioni. Winnicott raccoglie le funzioni mentali del pensiero razionale cosciente sotto il termine mind, che si può rendere in italiano con intelletto. L’intelletto è distinto dallo psiche-soma, costituisce una funzione specializzata e, in condizioni di salute, non si sostituisce alla tessitura di legami tra lo psiche ed il soma, che prosegue nelle successive fasi di sviluppo e durante l’età adulta (1949, 1965), continuando ad essere il modo primario d’ incontro tra le persone.
Lo psiche-soma è la matrice concettuale dalla quale si sviluppano ulteriori caposaldi del pensiero di Winnicott. É la base della “personalization”, altro termine creato da Winnicott per descrivere il divenire una persona a partire dalla molteplicità delle esperienze corporee ed emotive vissute tra la madre ed il bambino. Detto in altro modo, al centro della persona che ciascuno sente di essere sta lo psiche-soma, che Winnicott chiama anche il vero sé per distinguerlo dal modo sociale di essere una persona che definisce, per contrapposizione, falso sé: il vero sé è inconscio e spontaneo – come il gesto spontaneo oppure il respiro; il falso sé è consapevole, disciplinato e compiacente. L’amore della mamma, che accetta incondizionatamente il suo bambino, fa dello psiche-soma un vero sé sano anche quando il bambino è malato, handicappato o deforme. Solo con il progressivo sviluppo intellettuale il bambino si renderà conto dei propri limiti senza che siano però compromesse le fondamenta della persona e dunque anche le possibilità psicoterapeutiche (1970, 1970). Lo psiche-soma sta anche alla base della creatività (1971): è col corpo vivo che l’individuo entra in contatto col mondo esterno in una forma personale, che successivamente diventerà la donazione di un significato personale al percepito.
Il concetto di psiche-soma ha delle ricadute sulla teoria della tecnica psicoanalitica: Winnicott suggerisce all’analista di accostarsi ai bisogni non pensati del paziente con lo psiche-soma e non con la conoscenza intellettuale delle teorie (1956). Egli pone dunque l’accento sulla necessità che l’analista condivida l’esperienza somatica ed emotiva come primo passo verso l’evoluzione della pensabilità.
Per quanto riguarda l’utilità clinica del concetto, lo psiche-soma aiuta ad accostarsi alle aree non pensate non solo dei pazienti più gravi (psicotici e gravi borderline) ma anche di coloro che appaiono ben adattati, con un forte investimento della vita intellettuale (mind) e che vivono un senso di inutilità o non si sentono esistere a causa di dissociazioni di vario grado tra la mente ed il corpo. Amplia il modo di guardare alle malattie psicosomatiche, le quali possono essere considerate non solo come espressione di una dissociazione tra la vita mentale e quella corporea, ma anche come un tentativo estremo di riconnettere psiche e soma attraverso il dolore e la malattia fisica (1964).
La mente primitiva e la centralità della sintonizzazione psicosomatica tra psicoanalista e paziente contribuiscono agli orientamenti attuali del pensiero psicoanalitico verso lo sviluppo della capacità di pensare più che sui contenuti psichici rimossi.
Bibliografia
Winnicott D. W. (1949). Mind and its Relation to the Psyche-Soma1, in Throught Paediatrics to Psycho-Analysis 1958. Trad. Ital. Dalla Pediatria alla Psicoanalisi. Martinelli . Firenze. 1975
Winnicott D.W. (1956). On Transference1. Int. J. Psycho-Anal., 37:386-388
Winnicott D.W. (1964). La malattia psicosomatica: aspetti positivi e negativi. In Psycho-Analytic Explorations 1989. Trad. Ital. Esplorazioni Psicoanalitiche. Cortina Editore. Milano 1995
Winnicott D.W. (1965). The Family and Individual Development. Trad. Ital. La famiglia e lo sviluppo dell’individuo. Armando Editore. Roma. 1968
Winnicott D.W. (1970). Le basi di sé nel corpo. In Psycho-Analytic Explorations 1989. Trad. Ital. Esplorazioni Psicoanalitiche. Cortina Editore. Milano. 1995
Winnicott D.W. (1970). Due ulteriori esempi clinici. In Psycho-Analytic Explorations 1989. Trad. Ital. Esplorazioni Psicoanalitiche. Cortina Editore. Milano. 1995.
Winnicott D.W. (1971). La creatività e le sue origini. In: Gioco e realtà. Armando Editore, Roma 1974.
Novembre 2016
Vedi anche in Report –Materiali:
Psicoanalisi delle psicosi
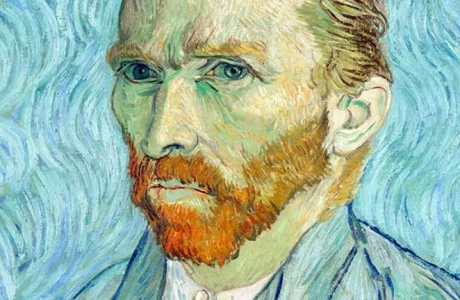
Vincent van Gogh
A cura di Gabriella Giustino
Sarebbe impossibile approfondire in questa sede i numerosi approcci ed autori psicoanalitici che si sono interessati di psicoanalisi delle psicosi. L’argomento è stato peraltro oggetto di un ampio dibattito e vi sono numerosi approfondimenti sul tema pubblicati su questo sito.
Mi limiterò pertanto a menzionare brevemente tre principali teorizzazioni psicoanalitiche sull’origine del processo psicotico:
– quella che individua la psicosi principalmente come conflitto tra l’Io e la realtà esterna (Freud 1923, 1924, Federn 1952).
– quella che pone l’accento sugli attacchi distruttivi e frammentanti rivolti contro la personalità (Klein 1935, 1946).
– quella che afferma che il funzionamento psicotico nasce dalla contrapposizione tra parte sana e parte psicotica della personalità (Bion 1957).
Come noto Freud considerava la psicosi non adatta al trattamento psicoanalitico.
Questo scetticismo terapeutico è ancora oggetto di dibattito nella nostra disciplina.
Mi pare tuttavia importante sottolineare alcuni criteri generali che possono essere utili nel trattamento psicoanalitico delle psicosi pur necessitando di ulteriori integrazioni.
Penso che l’assetto analitico da prediligere con i pazienti psicotici preveda:
– la necessità di lavorare in collaborazione con altri professionisti (anche per somministrare una terapia farmacologica).
– l’opportunità d’intervenire il più precocemente possibile.
– la necessità di avere in mente il carattere progressivo del processo psicotico.
Il tentativo dell’analista dovrebbe essere quello di stabilire innanzitutto una relazione di fiducia (alleanza terapeutica) col paziente in modo da rendere possibile, col tempo, di accedere ai contenuti mentali deliranti (che sono spesso dissociati o tenuti segreti), favorendo la comunicazione del funzionamento mentale psicotico e dei suoi sintomi (deliri, allucinazioni…).
Ciò consente di condividere col paziente le sue false credenze su di sé e sul mondo, ed è il primo passo per poi aiutarlo a sottrarsi al potere del nucleo delirante.
Se tutto ciò avviene con tatto e sensibilità,di solito emerge che il paziente era in una certa misura cosciente di questi processi mentali (cosciente ma non consapevole).
Insieme al procedere della fiducia nella relazione analitica aumenta la possibilità di comprendere i meccanismi psicopatologici che sottendono il processo psicotico aiutando il paziente ad individuare la parte psicotica e differenziarla dalla parte sana (stimolando la percezione del pericolo che il paziente corre quando la sua mente è sotto l’influsso della parte psicotica).
L’analista comincia dunque a funzionare come Io ausiliario del paziente.
I pazienti psicotici appaiono carenti di un inconscio (inteso in senso bioniano) che gli permetta di comprendere le emozioni proprie e degli altri: essi non sono in grado di usare le emozioni per costruire e comprendere la realtà psichica e sono carenti di un apparato psichico idoneo a simbolizzare (pensiero concreto).
L’approccio dialogico e interattivo dell’analista è quindi una condizione di base indispensabile per sostenere in modo costante le deboli risorse dell’Io dell’analizzando psicotico e per aiutare la sua mente a “pensare”.
BIBLIOGRAFIA
BION, W.R. (1957). Criteri differenziali tra personalità psicotica e non psicotica. In
BION, W.R. (1967).
FEDERN, P. (1952),Psicosi e Psicologia dell’Io. Boringhieri, Torino 1976.
FREUD, S. (1923). Nevrosi e psicosi. OSF, 9
FREUD, S. (1924). La perdita della realtà nelle nevrosi e nelle psicosi. OSF, 10.
KLEIN, M. (1935). Contributo alla psicogenesi degli stati maniaco-depressivi. In KLEIN, M. (1948-1958).Scritti 1921-1958. Boringhieri, Torino, 1978.
KLEIN, M. (1946). Note su alcuni meccanismi schizoidi. In KLEIN, M. (1948-1958). Scritti 1921-1958. Boringhieri, Torino, 1978.
KLEIN, M. (1946). Note su alcuni meccanismi schizoidi. In KLEIN, M. (1948-1958). Scritti 1921-1958. Boringhieri, Torino, 1978.
APPROFONDIMENTI
– Dibattito sulla Psicoanalisi delle psicosi a cura di F. Carnaroli e G. Giustino
Psicoanalisi e Psicoterapie Psicoanalitiche
A cura di Cristiano Rocchi con la collaborazione di Folco di Volo
In questo approfondimento cercheremo di offrire nel modo più chiaro possibile alcune informazioni e di descrivere il più semplicemente possibile che cosa sono la psicoanalisi e la psicoterapia psicoanalitica; entrambe si rivolgono sia agli adulti che al settore dell’infanzia e dell’adolescenza; a queste pagine introduttive generali sarà aggiunta in seguito una sezione specifica sulla psicoanalisi e sulle psicoterapie per l’infanzia e l’adolescenza. Già il “nostro” Sigmund Freud parlò a più riprese di psicoanalisi e psicoterapie: in Vie della terapia psicoanalitica (1918) per esempio sosteneva che «l’applicazione su vasta scala della nostra terapia ci obbligherà a legare in larga misura il puro oro dell’analisi con il bronzo (1) della suggestione […]. Ma quale che sia la forza che assumerà questa psicoterapia per il popolo, quali che siano gli elementi che la costituiranno, è sicuro che le sue componenti più efficaci e significative resteranno quelle mutuate dalla psicoanalisi rigorosa e aliena da ogni partito preso» ( p. 28 vol. IX, OSF Boringhieri, grassetto nostro). Ma prima di lui….
“Il grande errore compiuto da certi medici nel curare
gli esseri umani è quello di scindere la cura dell’anima
dalla cura del corpo”.– Platone, Carmide, V sec. A.C.
DEFINIZIONE DI PSICOTERAPIA
La parola “psicoterapia” è composta dalla congiunzione di due termini: psiche e terapia, nasce nel vocabolario verso la fine del secolo scorso ed indica una pratica medica antichissima. Probabilmente origina dalla cultura sciamanica risalente forse al Paleolitico, prosegue in quella della Grecia antica e della medicina misterica dell’età classica. Gorgia, sofista discepolo d’ Empedocle, sosteneva che la parola aveva il potere di eliminare la paura, tollerare il dolore,ispirare felicità e aumentare la compassione; Antifonte, suo contemporaneo (490 A.C. circa), usava la tecnica del dialogo per alleviare la sofferenza degli ammalati ( fuori Corinto, ove abitava, vicino all’agorà, mise un cartello in cui annunciava di essere in grado di curare i sofferenti tramite i propri discorsi). In ogni caso si può supporre che i greci avevano nei riguardi del potere curante della psicoterapia e della parola, conoscenze superiori a quelle dimostrate da Kraepelin e i suoi seguaci (Fine, 1982). Tornando alla nostra “parola composta” cerchiamo di comprenderne etimologia e significato.
-Psiche: insieme delle funzioni cerebrali, emotive, affettive e relazionali dell’individuo (in lingua greca psiche=anima)
-Terapia: branca della medicina relativa ai mezzi, le modalità, i provvedimenti adottati per alleviare e combattere i disturbi e le malattie
-Terapeuta: colui che esegue una prassi terapeutica, etimologicamente ( assistente, compagno, servitore). Nella Grecia classica, “terapeuti”, si chiamavano anche coloro che collaboravano con ancelle e coppieri a “servire” gli ospiti durante feste e banchetti.
Quindi si definisce come “psicoterapia” una cura, fondata sulla parola e nel rapporto tra paziente e terapeuta. Il termine “psico” è l’oggetto della terapia, il termine “terapia” la cura esercitata dal terapeuta, il termine “terapeuta”, colui che esercita la professione del curante, cioè di colui che è “al servizio”, “servitore del paziente”, nella ricerca del suo benessere psichico. Sullivan H. (1954) la descrive come “uno scambio verbale tra due individui in cui uno dei due è indicato come un esperto (terapeuta) e l’altro (paziente) come una persona in cerca d’ aiuto”; entrambi lavorano assieme per identificare i problemi caratteristici della vita del paziente con la speranza di ottenere un miglioramento e/o una modifica del disequilibrio psicologico. Fossi G.(1988) chiama la psicoterapia “un messaggio”; la struttura del messaggio è: “Io ti capisco; Io ti rispetto; Io desidero aiutarti”. La comprensione di chi ha a che fare con le persone sofferenti costituisce un tentativo di “comprendere” sentimenti, pensieri, azioni…; dalla relazione fra terapeuta e paziente nasce una cooperazione sociale di coinvolgimento, d’ interazione tra chi cerca aiuto (paziente) e chi accetta la responsabilità di offrirlo (terapeuta). Pazzagli A. e Benvenuti P.(2006) intendono per psicoterapia “… una conversazione che comporta l’ascoltare e il parlare alle persone in difficoltà con lo scopo di aiutarle a capire e a risolvere la loro situazione; il denominatore comune è rappresentato dal fatto che la psicoterapia è una terapia della mente che si attua con la mente: “La parola e l’attività mentale mettono in relazione significativa tra loro, a scopo terapeutico, il curante ed il curato”. Già Freud, nel 1904, riconosceva che la psicoterapia non era un metodo di cura moderno, al contrario, scriveva con forza: ”…. essa è la più antica terapia di cui la medicina si sia servita fino ai giorni nostri …”. Per Freud, i medici avrebbero dovuto saper riconoscere gli effetti psicoterapeutici delle loro cure, tanto che, sempre nel 1904, egli ammoniva così i componenti il Collegio dei Medici di Vienna ricordando loro che: “ Noi tutti medici, voi stessi, esercitiamo costantemente la psicoterapia, sebbene spesso non intenzionalmente …. E’ dannoso lasciar così interamente nelle mani del paziente il fattore psichico, nell’azione che esercitate su di lui”. Con queste parole di avvertimento, il padre della psicoanalisi, raccomandava ai suoi ascoltatori d’esercitare un’influenza mentale verso tutti quegli ammalati che ne necessitavano e che ne avrebbero tratto sicuro vantaggio. In sintesi si definisce psicoterapia individuale un trattamento caratterizzato fondamentalmente da questi cinque aspetti:
-Interazione significativa tra due persone
– Interazione soprattutto verbale
– Una persona cerca aiuto e l’altra è l’esperto che lo fornisce
– Scopo dell’interazione è recuperare quegli schemi ideativi, affettivi, comportamentali riferibili a chi soffre ed è in cerca di aiuto e che sono all’origine dei sintomi presentati e del disagio esistenziale manifestato
– Colui che richiede aiuto si aspetta sostegno e cambiamento dal terapeuta prescelto
IL SETTING E LA RELAZIONE PSICOANALITICA
La teoria psicoanalitica classica descrive essenzialmente un funzionamento intrapsichico, anche se è dedotta da una relazione intersoggettiva in un dato setting.
Con setting, termine anglofono che oramai è il più utilizzato nella letteratura psicoanalitica, anche se gli psicoanalisti francofoni preferiscono utilizzare cadre e negli scritti in lingua spagnola si trova spesso encuadro, intendiamo un insieme di fattori comprendenti le determinanti socioculturali della cura ed alcuni parametri più o meno fissi come il luogo, la frequenza e la durata delle sedute, etc. Si tratta di una nozione complessa, confine che separa lo spazio della cura dallo spazio sociale e delimita così un’area privilegiata in cui gli atti compiuti, le parole scambiate, ed anche, se non soprattutto quelle non scambiate, (i silenzi) assumono un valore terapeutico.
La relazione intersoggettiva definisce gli scambi tra lo psicoanalista ed il paziente e s’inscrive all’interno del setting, che possiamo assumere occupi una posizione gerarchicamente superiore nel senso che il setting si impone in un certo senso sui due partner (basti pensare al tempo della seduta, che è prefissato ed è indipendente, salvo eccezioni, dalla volontà della coppia analitica); anche se come ammoniva Freud stesso “si tratta di regole di un giuoco destinate ad acquistare importanza dal piano del giuoco nel suo complesso” (1913, OSF, vol. 7, pp. 333 ). Potremmo ancora dire che il setting definisce un campo di forza a cui sono sottomessi tanto l’analista che il paziente e quindi la loro relazione.
La relazione terapeutica è come un insieme in continua interazione in cui ciascuno degli interlocutori influenza l’altro (principio di azione e retroazione). L’ “azione” è dunque l’influenza esercitata da un soggetto sull’altro.
Quindi sarà di capitale importanza comprendere all’interno del setting e della relazione analitica i seguenti tre punti (v. Gillieron):
- Il passaggio dalla realtà intersoggettiva alla realtà intrasoggettiva
- L’incontro del sogno e della realtà fattuale (rapporti tra interazioni reali e fantasmi)
- La situazione del transfert nella relazione intersoggettiva
La terapia psicoanalitica, oltre ad essere una cura, è anche un “codice di lettura esistenziale”, quindi una forma cognitiva. Secondo noi non è né sostenibile, né conveniente, operare una contrapposizione netta tra queste due modalità di “miglioramento” dell’esistenza psicofisica dell’essere umano -la terapia e la conoscenza; senz’altro tutti gli psicoanalisti trovano un common ground nell’idea che la CURA psicoanalitica passa attraverso: a) l’andare oltre categorie del pensabile conosciute; b) il percorrere strade psichiche sconosciute; c) il “rendere pensabile il conosciuto non pensato” (Bollas). I mezzi, le vie per far ciò sono molti e tra questi senz’altro c’è il metodo delle libere associazioni, peculiarità del trattamento psicoanalitico, anche se sappiamo che per realizzarlo occorre che una salda e ben embricata relazione analitica tra paziente ed analista sia prima costituita. Ed è proprio in questa articolazione tra spinta verso la guarigione (terapia) e superamento delle categorie del pensiero conscio (la conoscenza del non pensato) che sta una e forse la principale delle caratteristiche distintive della PSICOANALISI.
PSICOTERAPIE PSICOANALITICHE
Nei trattamenti ad orientamento psicoanalitico ci spostiamo dai trattamenti di tipo supportivo (sostegno) e giungiamo ai trattamenti di tipo espressivo(esplorazione), entrambi caratterizzati da tecniche e modalità di intervento specifiche e diverse; si viene così a costituire una vasta area di tipologie d’intervento che dagli anni ’50 in poi ha consentito al mondo della psicoanalisi, da una parte, di ampliare il numero di coloro che potevano usufruire dei benefici delle tecniche di derivazione psicoanalitica, dall’altra di affrontare ambiti psicopatologici fino ad allora inesplorati e non affrontabili usufruendo della sola tecnica psicoanalitica classica.
Le varie forme di psicoterapia psicoanalitica in fondo rappresentano solo varianti derivate dalla psicoanalisi che, pur avendo un background comune, se ne differenziano per il metodo, il procedimento, il setting, la durata del trattamento, la frequenza (maggiore o minore numero di incontri settimanali), lo scopo, il criterio di selezione; si spazia così dalla psicoterapia psicoanalitica di breve o di lunga durata, alla psicoterapia psicoanalitica di sostegno, dalla psicoterapia focale breve (Tavistock-Malan), la psicoterapia a tempo limitato (Boston University-Mann), la psicoterapia dinamica a breve termine (McGill-University), la psicoterapia a breve termine generatrice d’ansia (Harvard University-Sifneos), la psicoterapia interpersonale alla psicoterapia come intervento elettivo sulla crisi emozionale acuta. Al di là di questo lungo elenco, al di là delle varie modifiche strutturali, il fine di ogni psicoterapia psicoanalitica resta sempre identico: aiutare il paziente ad operare una maturazione del proprio Sé globale e di se stesso come persona (Langs R.1979).
Riportiamo di seguito il noto schema di Cawley R.H. (1987) che fornisce sia un’utile classificazione circa la preparazione e l’addestramento professionale del terapeuta, sia una scala riassuntiva semplice e chiara, antesignana della più recente elencazione del “continuum” espressivo-supportivo di Gabbard G.O. (1994).
Circa la figura del terapeuta, secondo Cawley la psicoterapia si può suddividere in tre tipi: di primo tipo è quella esercitata da ogni buon medico, psicologo, o altra figura professionale ed è implicita nell’arte del “curare”; essa comporta conoscenza del paziente, dei problemi che presenta, richiede capacità empatiche e di comunicazione. La psicoterapia di secondo tipo è esercitata da uno specialista in psichiatria e/o psicologia clinica e richiede capacità di comunicazione e di comprensione con pazienti affetti da tutti i generi e i gradi di patologia psichica; se durante l’attuazione di questo tipo secondo di psicoterapia si manifestano fenomeni di transfert si evita di analizzarli a fondo e si preferisce impiegarli solo allo scopo di incoraggiare un transfert moderatamente positivo al fine di rinforzare l’alleanza terapeutica. La psicoterapia di terzo tipo contiene le caratteristiche del primo e secondo tipo (compreso l’atteggiamento di rispetto, comprensione, accettazione) e ad esse aggiunge la concentrazione sulla relazione terapeuta-paziente e i principi di derivazione psicoanalitica classica: analisi del transfert, del controtransfert, interpretazione dei conflitti, esplorazione del mondo interno, regressione; viene praticata da clinici individualmente appositamente “allenati”, “preparati”, “supervisionati” da terapeuti particolarmente “esperti” e che, pur se già specialisti nel settore della psicopatologia, abbiano alle spalle una scuola e una preparazione specifica ed ulteriormente specialistica nella conduzione del tipo di trattamento che progettano di effettuare.Possiamo senz’altro dire che gli psicoanalisti SPI rientrano generalmente in questa terza categoria e che quindi i nostri trattamenti, che siano psicoanalisi in senso stretto o psicoterapie psicoanalitiche sono sempre effettuati da professionisti ottimamente preparati e competenti. Difatti il training psicoanalitico deve rispettare per le Società afferenti all’IPA, come la SPI, precisi e rigorosissimi criteri che di norma formano psicoanalisti che avendo un’alta competenza generale e specifica sono in grado di svolgere sia psicoanalisi stricto sensu che psicoterapie psicoanalitiche.
Quindi, per sintetizzare, quello che i nostri psicoanalisti SPI possono offrire è, oltre ad un trattamento psicoanalitico classico, vale a dire una psicoanalisi, una psicoterapia psicoanalitica.
PER SAPERNE DI PIU’
Per chi fosse ora interessato a saperne di più, nella parte seguente, dal titolo Discussione Critica, proporremo una disamina più tecnica su differenze e somiglianze tra psicoanalisi e psicoterapie psicoanalitiche, per poi terminare proponendo delle tavole riassuntive di cui una sinottica che hanno lo scopo di mettere in risalto anche graficamente tali differenze.
DISCUSSIONE CRITICA
Definire la psicoanalisi e distinguerla dalla psicoterapia psicoanalitica presentava già difficoltà nel 1953 al Congresso della American Psychoanalytic Association dove sembrò che si trovasse un accordo (vedi Rangell, 1954) su una definizione accettabile. S’ intendeva per psicoanalisi la terapia in cui era centrale l’analisi del transfert, mentre nella psicoterapia il transfert è gestito piuttosto che interpretato. Ad esempio v’è da osservare che da quando gli psicoterapeuti hanno preso ad analizzare il transfert e ad adottare tecniche analitiche in terapia con frequenza di una o due sedute settimanali (anche grazie alle supervisioni di psicoanalisti chiamati a svolgere questo compito), la distinzione tra psicoterapia e psicoanalisi si è ulteriormente sfumata.
Robert S. Wallerstein (1986), in merito ai risultati del Psychotherapy research project della Menninger Foundation, sottolineava che tutti gli approcci psicoterapeutici psicoanalitici erano fondati sulla comprensione, sull’ascolto psicoanalitico e «sull’ efficacia terapeutica di tecniche modificate» disponibili per il terapeuta.
Come si vede è molto difficile riuscire a fare una distinzione netta tra queste due forme -strettamente imparentate, come genitori e figli- di cura psichica. Arriviamo a Sandler (1982, p. 48) che addirittura usando una tautologia osserva che “ La psicoanalisi è ciò che gli psicoanalisti fanno nella loro attività professionale”! Sandler motiva la sua tesi con il fatto che senz’altro un bravo psicoanalista modifica in ogni caso almeno un poco la sua tecnica adeguandola al paziente. La conseguenza di questa tesi è che E questo a sua volta implica come lo psicoanalista si formi. Quel che rimane fondamentale è “ l’atteggiamento psicoanalitico” dell’analista. Noi siamo abbastanza d’accordo che in realtà l’atteggiamento psicoanalitico su cui, tra gli altri, ha scritto un interessantissimo testo Roy Schafer nel 1984, sia certamente una determinante della cure psicoanalitiche , ma ovviamente non porta acqua al mulino del differenziare la psicoanalisi dalle psicoterapie psicoanalitiche e serve a delimitare il campo: da una parte le terapie psicoanalitiche condotte da psicoanalisti, dall’altra quelle, psicoanalitiche o meno, condotte da terapeuti di formazione diversa (psicoanalisti formati in scuole non appartenenti all’IPA, psicoterapeuti psicoanalitici, lacaniani, junghiani, rogersiani, cognitivisti, comportamentisti, bioenergetisti, gestaltisti, e così via).
Dice Marilia Aisenstein, già presidente della SPP (Società Psicoanalitica di Parigi) “La psicoterapia psicoanalitica o psicoterapia derivata dalla psicoanalisi è, secondo me, una psicoanalisi condotta da una psicoanalista in circostanze ritenute sufficientemente complesse, tali da richiedere l’introduzione di parametri differenti….a seconda della struttura mentale del paziente e dell’esperienza e delle scelte teoriche dello psicoanalista , ci può essere una psicoterapia con il paziente sdraiato sul lettino cinque volte la settimana o psicoanalisi con il paziente seduto vis a vis. Personalmente vorrei che tutto il lavoro psicoanalitico fosse chiamato ‘psicoanalisi’, sia che la paziente sia seduta su una sedia davanti all’analista, sia che stia sdraiata sul lettino. Basta che sia chiarito il setting” (in Frisch e AA., 2001, tr.it. 2003 Borla, p. 70). Anche Paolo Migone, attento studioso della teoria della tecnica psicoanalitica, si situa in questo solco quando afferma (1989, cit. in idem, p. 140) che è un errore aver chiamato psicoterapia quella che era psicoterapia solo come tecnica ma era psicoanalisi come teoria.
Un doveroso accenno adesso ai cosiddetti parametri di K. Eissler. Eissler, psicoanalista austriaco poi trasferitosi a New York, il custode degli Archivi di Freud, cercò di dare una sistematizzazione teorica alle modificazioni che sempre più analisti andavano introducendo nel setting. Queste modificazioni erano state indotte, in parte, dalla maggiore gravità diagnostica dei pazienti a seguito dell’allargamento dell’applicazione della psicoanalisi e dall’enorme aumento dei pazienti che proprio in quel periodo, a cavallo degli anni ’50, bussavano alla porta degli studi degli psicoanalisti americani (lo widening scope di cui parlò Leo Stone nel 1954) , e in parte, con un movimento a feed-back tra teoria e clinica, a partire dalle nuove acquisizioni teoriche della Psicologia dell’Io. Eissler teorizzò, a scopo euristico, un “modello di tecnica di base” (basic model technique): questo era un modello ideale, difficilmente attuabile in pratica, in cui si supponeva che l’analista lavorasse con un paziente con un Io intatto, e in cui gli interventi si limitavano solamente all’interpretazione verbale, senza che le regole di base fossero modificate. In questo caso l’Io del paziente è talmente forte che riesce a tollerare ed elaborare i significati trasmessi dalle interpretazioni. Dato che ci si accorse presto, nella pratica analitica con pazienti difficili (inizialmente soprattutto fobici, schizofrenici, delinquenti, ecc.), che questa tecnica di base non poteva essere tollerata da tutti, divenne indispensabile modificarne vari aspetti. Eissler coniò così il termine “parametro di tecnica” per indicare una modificazione della tecnica resa necessaria dalle condizioni deficitarie dell’Io del paziente; queste modificazioni possono includere vari tipi di interventi diversi dall’interpretazione, quali ad esempio la rassicurazione, il consiglio, la posizione vis-à-vis e così via. Però secondo Eissler – e in questo consiste il suo principale contributo – una tecnica può essere chiamata ancora “psicoanalisi” quando sono soddisfatti i seguenti quattro criteri: 1) un parametro deve essere introdotto soltanto quando è dimostrato che la tecnica del modello di base non è sufficiente; 2) il parametro non deve mai oltrepassare il minimo inevitabile; 3) un parametro deve essere utilizzato soltanto quando esso porta, alla fine, alla propria autoeliminazione; in altri termini la fase finale del trattamento deve sempre procedere con parametro zero ; 4) l’effetto del parametro sulla relazione di traslazione non deve mai essere tale da non poter essere eliminato con l’interpretazione (pp. 54-56 ed. it. del 1981). Negli anni successivi è stato messo sempre più in discussione l’assunto di Eissler secondo il quale la basic model technique, cioè la tecnica di base, debba per forza essere caratterizzata dai criteri “estrinseci” stabiliti dalla tradizione classica (lettino, quattro sedute settimanali, ecc.). Una di queste voci critiche, sicuramente la più autorevole, fu quella dell’ultimo Merton Gill (1954) che insiste da una parte sulla diversità, dall’altra riconosce tra le due forme “un continuum”. Ricordiamo adesso il suo suggerimento quasi trent’anni dopo (1984), rispetto alla distinzione tra criteri “INTRINSECI” ed “ESTRINSECI”; essi non rappresentano “l’apriti sesamo” della differenziazione, rappresentano però dei vertici osservativi, seppure a volte in antagonismo o sovrapposizione reciproca, che aiutano a riflettere sul nostro operato.
INTRINSECI: -la neutralità dell’analista, -la centralità dell’analisi dell’analisi del transfert, – l’induzione della nevrosi di transfert regressiva e la risoluzione di essa con la sola, o almeno principalmente, tecnica dell’interpretazione.
ESTRINSECI: -sedute frequenti, -uso del divano, -un paziente relativamente ben strutturato (cioè che si pensa possa essere analizzabile), -uno psicoanalista sufficientemente ben preparato.
Concluderemo questa panoramica citando tre grandissimi nomi della psicoanalisi contemporanea Robert D. Hinshelwood, Otto Kernberg ed André Green. Il primo (in Frisch e AA,. 2001, tr.it. 2003 Borla, pag. 170) che per parlare del rapporto tra psicoanalisi a psicoterapie psicoanalitiche propone un’analogia con l’evoluzionismo: “E’ come quando ci poniamo la domanda: dove si trova esattamente il punto di partenza della specie umana da quella dei nostri antenati primati ?..Sembrerebbe che non ci sia una data precisa, e non ci potrà essere una data precisa perché c’è un continuum di diversità fra le due specie; ognuna di esse si è staccata gradualmente ed è andata per la propria strada, senza una separazione netta. Nondimeno il cambiamento continuo a lungo andare ha dato luogo ad una differenza qualitativamente definita. Dunque la domanda è: quando questo cambiamento quantitativo – come per esempio la dimensione del cervello, la posizione eretta o la postura, l’uso degli utensili e così via – è diventato sufficientemente percettibile come differenza qualitativa?.
Otto Kernberg: “Dal punto di vista concettuale, per indagare il rapporto fra psicoanalisi e psicoterapie occorre una definizione chiara dell’essenza della metodologia del trattamento psicoanalitico (ovvero della “tecnica psicoanalitica”), una definizione chiara del confine tra la psicoanalisi e la psicoterapia psicoanalitica e del confine che separa la psicoterapia psicoanalitica dalle altre forme di psicoterapia (“psicoterapie di sostegno”). Considerando l’attuale sviluppo di teorie psicoanalitiche alternative e delle corrispondenti impostazioni tecniche, è davvero possibile una definizione della psicoanalisi così esauriente da metterne appunto in risalto la differenza rispetto alla psicoterapia psicoanalitica ed alle psicoterapie di sostegno? ” (testo presentato il 15 agosto 1998 alla Società Psicoanalitica Uruguaiana (APU) a Montevideo, e il 19 agosto 1998 alla Società Psicoanalitica di Buenos Aires (APDEBA) a Buenos Aires).
André Green, grandissima mente psicoanalitica francese, recentemente scomparso, che ci dice “ Ecco quindi quello che voglio dire: che cosa fa sì che noi possiamo preferire una psicoanalisi o una psicoterapia? Innanzitutto abbiamo un ideale di funzionamento rappresentato dalla cura psicoanalitica, giacché questa si svolge in un ambiente neutrale e non presuppone un intervento dell’analista nella vita del paziente e neanche un suo desiderio di influenzare alcuni dei suoi sintomi manifesti. Noi quindi in via di principio preferiamo la cura analitica. …. Naturalmente spesso sentiamo dire che psicoterapia [psicoanalitica ndr] e psicoanalisi sono in fondo la stessa cosa, molti si chiedono perché vengono fatte queste distinzioni, e così via. Penso però che Otto Kernberg abbia ragione: bisogna distinguere il livello teorico da quello clinico. Otto ha perfettamente capito che il modello della cura psicoanalitica è un modello ideale, è l’ideale al quale tende lo psicoanalista. E se in seguito egli eserciterà la psicoterapia in tutte le sue varie forme, conserverà sempre questo modello ideale della psicoanalisi così come è stato concepito da Freud” ( discorso pronunciato al Convegno Internazionale “Dalla mente di Edipo al volto di Narciso?”, Torino, 7 dicembre 2008 in Psicoterapia e Scienze Umane, 2009, XLIII, 2: 215-234).
Come si diceva sopra termineremo questa presentazione presentando degli schemi che riteniamo possano aiutare chi si sta addentrando nella conoscenza della psicoanalisi sia come curioso, più o meno inesperto, che come persona che vuole approfondire le sue conoscenze in questo ambito, perché spinto dal suo istinto epistemofilico, come diciamo noi , l’istinto a conoscere, che tanto ha mosso e muove l’essere umano nella ricerca di ciò che c’è fuori di lui ed in lui. Offriamo quattro schemi ed una tavola sinottica; consapevoli di quanto queste schematizzazioni possano essere riduttive, ma anche convinti che possono rappresentare una sintesi sufficientemente buona del pensiero contemporaneo sulle differenze e le somiglianze tra psicoanalisi e psicoterapia psicoanalitica
OBIETTIVI COMUNI
Per ciò che riguarda gli obiettivi comuni tra i 2 tipi di trattamento, a seconda del caso in esame, tenuta considerazione della polifattorialità dei vari “contesti clinici” si elencano i seguenti singoli elementi:
a) “Ottimizzare”, per quanto possibile la frequenza la durata della cura;
b) “Favorire”la spinta verso foci esplorativi, la libertà di lasciarsi andare ad associare liberamente immagini, pensieri, fantasie, “Fornire”, ma non solo, interpretazioni transferali;
c) “Oscillare” tra i 2 estremi di interventi di interazione tesi da una parte ad offrire sostegno e dall’altra a prospettare punti di vista alternativi (Alessandrini M., Giannantonio M. 2012);
d) “Attenuare o eliminare la sintomatologia”;
e) “Sviluppare” la capacità introspettiva, la capacità di tolleranza, la capacità di accettarsi per quello che si è;
f) “Liberare” le energie spinte all’autoconservazione, l’autoaffermazione, l’autodeterminazione, l’assertività;
g) “Migliorare” l’adeguamento alla realtà, le relazioni interpersonali, la gioia di vivere.
FATTORI TERAPEUTICI SPECIFICI E ASPECIFICI
SPECIFICI- 1)Instaurazione, mantenimento ed uso adeguato del “setting”; 2)Condizione, lungo tutto il processo, di neutralità, privatezza, astinenza ed anonimia del terapeuta; 3)Attivazione, da parte del terapeuta di un atteggiamento affettivo premuroso, attento e disponibile assieme all’installazione dell’alleanza terapeutica (rispetto delle regole contrattate da parte del terapeuta e del paziente)
ASPECIFICI- 1)Bisogno di conoscere, di trovare spiegazioni; 2) Bisogno di amare ed esser amati;3)Bisogno di comunicare, di collaborare, di mantenere rapporti validi e duraturi; 4) Bisogno di fare progetti, di condividerli; 5) Bisogno di favorire idealizzazioni (Fossi G. 2006)
LIVELLI DI PSICOTERAPIA
Per ciò che riguarda i “livelli” di psicoterapia, Cawley ne indica formalmente tre gradi rispettivamente distinti in :superficiale (appoggio e consiglio), intermedio, profondo (esplorazione e analisi).
-SUPERFICIALE ( Appoggio e Consiglio) 1) scaricare i propri problemi confidandoli ad un ascoltatore comprensivo 2) discutere le proprie emozioni nell’ambito di un rapporto che fornisce appoggio 3) discutere problemi attuali con una persona che aiuta senza esprimere giudizi
-INTERMEDIO. 4)chiarire i problemi, la loro natura e la loro origine, nell’ambito di un rapporto più profondo 5) affrontare le difese
-PROFONDO (Esplorazione e Analisi) 6)interpretare motivazioni e fenomeni di transfert inconsci 7) ripetere,ricordare e ricostruire il passato 8) regredire ad un funzionamento meno adulto 9) risolvere i conflitti rivivendoli e rielaborandoli
INTERVENTI
Gabbard G.O. (1990, 1994) riporta a sua volta, più recentemente, un “continuum” di interventi divisi in sette categorie; lo schema è quello seguito dagli operatori impegnati da svariati anni nello studio e nella ricerca attuata alla Menninger Clinic negli USA. Stavolta, partendo dal polo “espressivo” (esplorativo)-(psicoterapia psicoanalitica) verso quello “supportivo” (di sostegno)-(psicoterapia di sostegno), semplificando al massimo, sono così gerarchicamente caratterizzati:
ESPRESSIVO —————————————————————————————————————————SUPPORTIVO
1)Interpretazione
2)Confronto
3)Chiarificazione
4)Incoraggiamento
5)Convalida
6)Consigli ed elogi
7)Conferma
INTERPRETAZIONE: nelle forme di trattamento più espressive è lo strumento di maggiore importanza, significa rendere conscio qualcosa che prima di essa era inconscio
CONFRONTO: si rivolge a qualcosa che il paziente non riesce ad accettare o che identifica l’evitamento oppure la minimizzazione della valenza comunicativa
CHIARIFICAZIONE: comporta una riformulazione delle parole del paziente per trasmettere un aspetto coerente circa quanto viene comunicato al terapeuta
INCORAGGIAMENTO ALL’ELABORAZIONE: Quasi al centro del “continuum” si tratta di una modalità né espressiva, né supportiva; usualmente consiste nella richiesta di informazioni circa un argomento sollevato dal paziente
CONVALIDA EMPATICA: tende a mostrare e a dimostrare la sintonia empatica del terapeuta con lo stato emotivo interno del paziente
CONSIGLI ED ELOGI: sia il consiglio che l’elogio prescrivono e rinforzano alcune attività e comportamenti del paziente al fine di fargli sperimentare le capacità di comprensione del terapeuta
CONFERMA: nelle forme più supportive si tratta di interventi semplici, brevi commenti, talora solo interiezioni del tipo …”già”,…”si”,…”capisco”…, suscettibili di ottenere grande impatto emotivo se forniti al momento ottimale
Tavola sinottica (da R. Langs, 1973-74, tr. it. 1979, Boringhieri) allegata
CONCLUDENDO
La conoscenza psicoanaliticamente intesa, desidera abbandonare il sapere usuale, il conscio, anche se come terapia fortifica la coscienza ed il sapere. La conoscenza psicoanalitica desidera andare oltre la rappresentazione, è attratta dall’irrappresentabile anche se come terapia vuole illuminare ogni angolo della rappresentazione. La conoscenza a cui tende la psicoanalisi frantuma il buon senso tramite la trasformazione continua dei significati, anche se come terapia tende a ricomporre il buon senso. La cura psicoanalitica continua pertanto a mantenere aperta la sfida al pensiero umano che tende a chiudersi, a non cambiare, a sclerotizzarsi, a mantenere inconscio il perturbante. Termineremo con una frase con cui W.R. Bion, psicoanalista britannico scomparso nel 1979, la cui cifra distintiva è stata il pensiero geniale ed originale, descrive con una sorta di paradosso l’incontro psicoanalitico :
“Quando due personalità si incontrano si crea una tempesta emotiva. Se fanno abbastanza contatto da essere consapevoli l’uno dell’altro o anche abbastanza da esserne inconsapevoli, la congiunzione di questi due individui produce uno stato emotivo e il disturbo che ne risulta non necessariamente ha da essere considerato come un miglioramento rispetto a prima nello stato delle cose. Ma visto che si sono incontrati e visto che la tempesta emotiva si è verificata, le due parti in gioco in questa tempesta possono decidere di cavarsela alla meno peggio in un brutto affare”.
(W.R. BION, 1979, Making the best of a Bad Job)
(1) In realtà nell’originale tedesco Freud parla di rame, Kupfer (v. Stud. Vol. Erg. p. 249); qui, come in altre parti dell’opera, la traduzione italiana è un po’ “accomodata”
Psicoanalisi infantile/modelli evolutivi
A cura di Amedeo Falci
Per modello evolutivo intendiamo il campo di indagine degli studi inerenti lo sviluppo infantile, dalle fasi precoci all’adolescenza. Sviluppo come criterio esplicativo dell’organizzazione complessiva della personalità. Sarebbe in realtà più corretto parlare di ‘modelli evolutivi’, per la pluralità dei campi di studio (psicoanalitico, cognitivo, psicosociale, psicolinguistico, etc.), e per la pluralità degli stessi modelli anche all’interno dell’area psicoanalitica.
Osservando dal punto di vista di una psicoanalisi attuale, sono state riconosciute le interazioni tra fattori biologici e fattori antropologici (culture, realtà familiari, disposizioni affettive e di accudimento degli adulti intorno al bambino, ed altro ancora). E proprio la considerazione di tale pluralità di fattori permette di rivedere e risistemare le classiche problematiche filosofiche connesse al tema dello sviluppo dell’essere umano e della mente. Innatismo o ambientalismo nella formazione dell’individuo, il bambino come tabula rasa sui cui tutta l’esperienza deve ancora essere incisa, o come essere impotente, incompetente e minus che deve essere ‘riempito’ e ‘formato’ dall’adulto. Il campo di indagine è, tra l’altro, confinante con l’area delle scienze biomediche (interazione tra fattori genetici ed acquisiti nella crescita infantile, sviluppo neurale, basi biologiche della differenziazione neuropsicologica). Dal punto di vista dell’evoluzione della mente, si tratta di capire quali siano i programmi, i processi e le strutture sottostanti che rimangono come invarianti ed assicurano pure una continuità nello sviluppo neuropsicologico dell’infanzia, di fronte ai complessi ed incalzanti mutamenti della crescita. In questo senso il concetto di fase evolutiva è stato essenziale per caratterizzare una suddivisione di livelli nelle organizzazioni dello sviluppo emozionale, cognitivo e relazionale del bambino. I criteri e le caratteristiche di tali fasi evolutive hanno presentato una grande variabilità a seconda delle diverse teorie dello sviluppo infantile.
La concezione psicoanalitica freudiana ha posto al centro dell’evoluzione psichica l’organizzazione inconscia delle spinte istintuali, delle pulsioni, dei desideri, ma anche degli stati di dolore ed angoscia nel bambino. Tale organizzazione istintuale è stata colta nelle sue dinamiche conflittuali sia rispetto ai valori sociali vigenti nell’ ambiente di crescita, sia rispetto alle stesse difese che la mente oppone alla forza delle pressioni istintuali innate. Tale ipotesi evolutiva ha avuto storicamente l’ indubbio merito di aver fornito un modello esplicativo “forte”, che ha reso possibile intanto una base teorica per le stesse teorizzazioni psicoanalitiche, e reciprocamente una più approfondita applicazione della psicoanalisi allo studio e alla terapia dei disturbi psichici dell’ infanzia e dell’ adolescenza.
Il valore euristico del modello evolutivo della psicoanalisi sta nella possibilità di rintracciare gli esiti psicopatologici nell’ individuo adulto nella storia e nelle variabilità dei primi rapporti del bambino con il mondo adulto, a partire dalle fasi più precoci della vita. Tale modello evolutivo può essere considerato come uno dei più fertili contributi offerti dalla psicoanalisi alle scienze umane e alle scienze psicologiche. Esso si è successivamente diffuso ad altri settori della ricerca clinica, stimolando un’ampia serie di ricerche nell’ambito di discipline scientifiche affini, ed ispirando un’enorme messe di ricerche nel settore dell’evoluzione psichica dei bambini.
Dopo un secolo di psicoanalisi, sono enormemente incrementate le conoscenze nell’ambito delle regolazioni affettive e dell’organizzazione cognitiva ed emozionale della prima infanzia. La tendenza dominante di tale mole di studi sembra confermare una grande e sorprendente competenza dei bambini, anche dalle prime settimane di vita, alle interazioni affettive e proto-sociali con gli adulti, confermando le intuizioni psicoanalitiche circa precursori dell’Io esistenti fin dalle fasi precoci. Nella ricerca psicoanalitica, le conoscenze sulle fasi iniziali dell’evoluzione mentale sono divenute quindi un ineliminabile supporto sia per l’affinamento e la verifica delle teorie psicoanalitiche, sia per più approfondite conoscenze sulle possibili origini di una molteplicità di disturbi psichici.
Tuttavia nel corso del tempo ci si è anche resi conto di molti aspetti problematici relativi ai modelli di sviluppo dell’infanzia. Già dalla stessa Anna Freud veniva l’intuizione che le fasi dello sviluppo libidico fossero inadeguate a rappresentare tutti gli aspetti dello sviluppo dei bambini, proponendo le linee evolutive come espressione di un raccordo tra i funzionamenti delle strutture psichiche, le tappe evolutive e le disponibilità dell’ambiente di crescita, arrivando fino al conseguimento dell’autonomia. Veniva in tal modo anticipato un nuovo filone della psicoanalisi molto più attento alle interazioni tra bambino ed ambiente umano di accudimento.
Anche la concezione rigida e deterministica di stadi di sviluppo lungo un asse unico – quello psicolibidico – è stata posta in crisi da altri settori di ricerca, a favore di una concezione di assi evolutivi multipli, secondo vari piani organizzativi bio-neuro-psicologici. L’intersezione e la regolazione tra tali assi ed i gradi ed i tempi delle fasi evolutive seguirebbero un andamento di frequenza probabilistica. Questo dato permette di cogliere più approfonditamente le pluralità di intrecci tra aspetti adattivi o disadattavi nella salute mentale degli individui, che non sempre seguono vie prevedibili. Ciò che conta sono le combinazioni e le possibilità integrative tra i vari assi di sviluppo, con la valutazione di aree disfunzionali e del loro grado di rischio psicopatologico nelle età successive. Gli esiti dello sviluppo vengono quindi adesso più modernamente visti come combinazione di fattori molteplici: i fattori di organizzazione neurobiologica individuale; i fattori di rischio evolutivo, tra cui i fattori traumatici; i fattori protettivi di ordine relazionale e contestuale; le potenzialità e le risorse dell’organizzazione mente del bambino.
La coesistenza di diversi modelli evolutivi del bambino evidentemente implica la necessità di criteri di verifica e validazione. Adesso possibili attraverso una serie di nuovi punti di riferimento. I modelli evolutivi psicoanalitici devono innanzitutto essere verificati con la loro validità retroattiva o predittiva nella clinica psicoanalitica. Ad es. la concezione di fasi orale ed anale, o, di una fase autistica normale, sono criteri evolutivi ancora validi per la clinica, e confermati dalla clinica? Altri criteri di verifica derivano dai dati della psicopatologia psichiatrica extra-analitica. Così come sono altresì di grande importanza, ed attualità, i dati relativi alle esperienze traumatiche ed ai suoi esiti sullo sviluppo infantile. Ancora di grande ausilio i confronti tra i modelli evolutivi psicoanalitici e gli studi su campioni di infanzia non-patologica osservata e studiata in certi contesti sociali (nursery, famiglie, scuole). Infine sono diventati contributi essenziali i dati provenienti dall’infant research, dagli studi sull’attaccamento e dalla neurobiologia dello sviluppo, perché permettono di confrontarci con (e di aggiornare) alcuni degli assunti fondamentali della psicoanalisi (tra i tanti: la precoce attivazione di precursori dell’Io già dai primi momenti dopo la nascita, la indifferibile tessitura relazionale tra il bambino ed il suo ambiente affettivo umano, la stretta connessione tra emozioni e conoscenze).
Non si tratta soltanto di un dibattito teorico, dal momento che nel campo della psicopatologia infantile ed adolescenziale siamo sempre più di fronte all’emergere di quadri clinici non del tutto comprensibili alla luce delle categorie psicoanalitiche “classiche” e che rimandano certamente a più sottili investigazioni delle complesse trame evolutive attraverso cui la mente si differenzia, si complessizza e si evolve.
Giugno 2014
Psicoanalisi infantile/Storia
A cura di Maria Rosa De Zordo
Un buon modo per conoscere la psicoanalisi infantile è ripercorrerne la storia dalle origini, ormai quasi un secolo fa, per ritrovare emotivamente l’entusiasmo, la fiducia, il coraggio con cui ci si avventurò ad esplorare la mente in fieri osservando e curando bambini e adolescenti.
Freud scoprì l’inconscio, elaborò il metodo, la teoria e la tecnica terapeutica che chiamò appunto psicoanalisi. I suoi pazienti erano adulti, ma mostrò come la mente adulta si formi ed evolva dalla nascita in poi. E si occupò anche di un bambino, il famoso piccolo Hans, che curò attraverso il padre.
Alcuni suoi allievi e soprattutto allieve (perché la psicoanalisi, e quella infantile in particolare, ebbero fin dall’inizio importanti e numerose figure femminili che accrebbero questa disciplina) si interessarono direttamente della psicologia infantile: nomi ben noti come la stessa figlia Anna Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott, per citare solo i più illustri capostipite.
Ricordare questi esordi, sia pure molto sommariamente, sollecita ancor oggi l’ammirazione per il lavoro approfondito, affettivamente intenso, con cui queste e questi pionieri tanto contributo portarono alla comprensione dell’infanzia e dell’adolescenza, non solo nel campo specifico della cura della sofferenza psichica, ma in maniera determinante nel rinnovare la psicologia genetica e la pedagogia. Spesso si cimentarono personalmente in esperienze pedagogiche, che aiutarono a capire la crescita del bambino dal punto di vista dei suoi bisogni, delle tappe maturative, delle sue relazioni e dell’interazione con l’ambiente. Aiutarono a capire il bambino sano, il bambino con disagio emozionale, il bambino malato, portando gradualmente ad autentici ribaltamenti nella pedagogia, nell’educazione, nella pediatria ambulatoriale ed ospedaliera (basti pensare alla riconosciuta importanza della madre o del genitore accanto al bambino ospedalizzato).
E in Italia? Anche noi abbiamo i nostri pionieri, o, forse meglio, anche in Italia soprattutto le nostre pioniere: persone davvero coraggiose come Marcella Balconi, Maria Elvira Berrini, Adda Corti.
E poi Lina Generali, Adriano Giannotti, Benedetto Bartoleschi, Pierandrea Lussana, Mauro Morra, solo per ricordare gli scomparsi, e… l’elenco potrebbe continuare, ma troppe figure importanti rischierebbero di essere tralasciate, perché la psicoanalisi infantile italiana ha storia e tradizioni che meritano rispetto e gratitudine per le generazioni e i colleghi che hanno preparato e facilitato il lavoro attuale.
In Italia l’attenzione psicoanalitica ai bisogni del bambino comincia verso la fine degli anni ’50, prendendo avvio proprio nei nascenti servizi del tempo dedicati all’età evolutiva, talvolta con la collaborazione generosa di professionisti di discipline affini, ma talvolta incontrando difficoltà e incomprensioni. Tuttavia il coraggio, la fiducia di essere sulla strada giusta, l’impegno non vennero mai meno, corroborati da esperienze, studio, formazione personale faticosi, spesso lunghi viaggi per avvicinare all’estero chi era andato più avanti nel campo. E furono così sollecitati significativi rinnovamenti nella comprensione dell’infanzia e nelle istituzioni che di questa si occupavano e si occupano.
Perché è importante sottolineare che la psicoanalisi infantile non ha mai trascurato di vedere il bambino nel contesto del suo ambiente familiare, scolastico, sociale, ben consapevole che la mente e la crescita psicologica si sviluppano appunto nel contesto delle relazioni affettive fondamentali, a partire dalla relazione con la persona che fin dall’inizio si prende cura del neonato inerme, abitualmente la madre, anche se oggi si preferisce usare il termine caregiver (chi offre e si prende cura).
Che cos’è dunque la psicoanalisi infantile? Si potrebbe semplicemente rispondere che è la terapia psicoanalitica applicata ai bambini e agli adolescenti? Sì, ma non sarebbe sufficiente. Sono subito evidenti alcune difficoltà e differenze.
L’impiego della parola che caratterizza l’analisi degli adulti (che la prima paziente di Freud definì appunto talk therapy/terapia della parola), incontra con i bambini, tanto più piccoli essi sono, caratteristiche dello sviluppo linguistico legate all’età: i bambini si esprimono preferenzialmente attraverso gioco e/o disegno. Inoltre, con bambini molto piccoli, è talora impossibile prescindere dalla presenza del/dei genitore/i. In ogni caso il “cucciolo umano” abbisogna di un lungo periodo di accudimento da parte degli adulti: genitori, educatori… Già queste considerazioni ci mettono di fronte alla peculiarità del lavoro in età evolutiva, che è appunto il processo evolutivo, di crescita, di maturazione e l’attenzione al contesto ambientale.
Se l’ascolto psicoanalitico si caratterizza per il suo volgersi alla persona, alla comprensione del disagio segnalato all’interno delle dinamiche affettive di quella persona che avverte in sé un malessere, questo è altrettanto vero per il bambino.
I bambini non chiedono direttamente un aiuto psicologico, tuttavia è sorprendente accorgersi di come un bambino, anche molto piccolo, possa essere capace di comunicare al terapeuta, insieme al quale si trova, e di sviluppare la fiducia di sentirsi compreso.
Sono i genitori ad avvertire un problema, talvolta per un suggerimento degli insegnanti, del pediatra. Sono i genitori che in primo luogo chiedono di essere aiutati a capire che cosa sta succedendo nel loro bambino: il lavoro psicoanalitico con loro consiste nel ritrovare emotivamente un bambino, del cui comportamento possano evitare fraintendimenti nella comprensione, della cui eventuale sofferenza possano cogliere il significato, con cui possano relazionarsi in maniera più completa, arricchita di un nuovo sguardo.
E nell’incontro con il bambino, l’attenzione psicoanalitica, pur non ignorando il problema specifico o il sintomo, guarda al bambino nel suo insieme, all’armonia o disarmonia del suo sviluppo affettivo e cognitivo, dei suoi processi maturativi, delle varie aree in cui si esprime la sua persona.
Può essere che il bambino stia attraversando con qualche esitazione una tappa evolutiva di particolare impegno, oppure esprima un disagio legato a particolari contingenze ambientali. Ma può essere che il bambino esprima difficoltà più strutturate, che richiedono un intervento terapeutico prolungato.
Il progetto terapeutico psicoanalitico tiene conto del processo maturativo e di come il bambino lo sta o non sta affrontando, inoltre della disponibilità a comprendere ciò in modo più profondo da parte dei suoi genitori. Pertanto il progetto terapeutico, se opportuno, viene proposto sulla base di queste considerazioni, ha lo scopo principale di aiutare il bambino a riprendere e a ricollocarsi adeguatamente nel percorso di crescita appropriato alla sua età. Ciò può comportare interventi più brevi nel tempo, frequenza settimanale di sedute, o trattamenti più intensivi, con più sedute settimanali, prolungati. Secondo le situazioni, sono diverse ma indispensabili, le forme di collaborazione con i genitori e di intervento modulato con loro e/o con il figlio.
La cura del bambino e delle sue relazioni, fin dagli albori, dalla vita intrauterina, è dunque l’espressione principale della psicoanalisi infantile. Ma altri ambiti vanno ricordati, che contribuiscono ad approfondire la psicologia psicoanalitica dell’età evolutiva, e ne vedono l’applicazione. Ne ricordiamo alcuni:
Osservazione infantile, meglio nota come infant observation: è l’osservazione diretta dell’interazione tra neonato/lattante e genitori, in primo luogo la madre, nel primo o primi due anni di vita. Spesso si arricchisce dell’osservazione del bambino nel periodo della scuola materna, portando l’attenzione sull’interazione con educatori e pari. Recentemente questo metodo è stato esteso all’osservazione delle trasformazioni emotive che accompagnano la gravidanza, il periodo postnatale e che caratterizzano la cosiddetta “maternità interiore”.
La ricerca in campo evolutivo nei suoi due importanti filoni: l’Infant Research e la Teoria dell’attaccamento, hanno evidenziato impensabili competenze del bambino fin dalle sue prime ore di vita e hanno dimostrato che lo sviluppo mentale del bambino non può che compiersi all’interno delle relazioni per lui più significative, a partire naturalmente dai suoi genitori. Vi sono diversi altri ambiti di ricerca con campi ed aree di interesse affini, come le neuroscienze e lo studio dello sviluppo cognitivo, la psicoanalisi della coppia e della famiglia.
Le applicazioni della psicoanalisi infantile ad ambiti attinenti alla crescita e cura del bambino vanno dall’ambito educativo a quello sanitario, a quello giuridico, attraverso:
– Collaborazione con operatori che operano nel Servizio Sanitario Nazionale, attraverso consulenze, seminari clinici, di aggiornamento, supervisioni, rivolti a specifici professionisti o a équipes (ginecologi, pediatri, psicologi, assistenti sociali).
– Gruppi di lavoro con genitori in difficoltà e incertezze nello svolgere la loro funzione, ma anche gruppi più impegnativi, terapeutici con genitori di bambini problematici, disabili, che impegnano in maniera spesso molto gravosa la cura concreta e affettiva del figlio.
– Collaborazioni con il personale educativo di Nidi e Scuole Materne, nonché con insegnanti della scuola dell’obbligo.
– Collaborazione con il Tribunale ordinario e dei minori: si tratta di un lavoro particolarmente delicato, dove la consulenza può riguardare problemi di affido in seguito a separazione o divorzio, problemi di allontanamento dalla famiglia in casi di particolare gravità affettiva ambientale, o di approfondimento della situazione emotiva di bambini che hanno sofferto violenza o abuso.
– Insegnamento universitario: colleghi analisti hanno a vario titolo incarichi di docenza presso l’Università.
– La terapia psicoanalitica dei bambini nella sua formula classica, a elevata frequenza settimanale, anche se non sempre perseguibile in prima istanza, resta per noi una fonte unica e inesauribile di osservazione, che permette di affrontare i compiti sopramenzionati da un punto di vista del tutto speciale.
Ognuno degli undici Centri della Società Psicoanalitica Italiana operanti su territorio nazionale ha variamente organizzato disponibilità di psicoanalisti alla consultazione e al trattamento di bambini e adolescenti e forme varie di attività scientifica, di formazione e di “apertura” verso la “società civile” che sono consultabili presso i siti web dei Centri.
Bibliografia
Aliprandi M.T., Pati A.M. (1999). L’alba della psicoanalisi infantile. Feltrinelli, Milano.
Algini M.L. (2007). Sulla storia della psicoanalisi infantile in Italia. Quaderni di Psicoterapia Infantile n.55. Borla, Roma.
Giugno 2014
Psicoanalisi relazionale
A cura di Cristiano Rocchi 2013
La Prospettiva Relazionale in psicoanalisi si fonda sul tentativo di integrare idee prese da una vasta gamma di scuole di pensiero psicoanalitico contemporaneo, tra cui la teoria delle relazioni oggettuali, la psicologia del sé, la psicoanalisi interpersonale, la teoria neo-kleiniana. Orientamento relazionale come insieme organizzatore di diverse teorie è il nome proposto da Greenberg e Mitchell nel loro libro “Le relazioni oggettuali nella teoria psicoanalitica”(1983), testo assolutamente fondamentale, che insieme con l’altro scritto da Mitchell in solitaria (“Gli orientamenti relazionali in psicoanalisi. Per un modello integrato”, 1988), costituisce una sorta di bibbia per coloro che sono interessati a comprendere a fondo e senza pregiudizi le basi teorico tecniche di questo prospettiva. In questi testi, oltreché portare una critica argomentata e puntuale alla teoria monadica della mente, Mitchell pone una questione di fondo: o consideriamo il significato psicologico intrinseco e applicato solo successivamente al campo relazionale, oppure lo consideriamo negoziato attraverso l’interazione. Da qui si dipaneranno fili che condurranno alla lettura, attraverso la lente della psicoanalisi relazionale, di molteplici concetti psicoanalitici e fenomeni quali il narcisismo, le pulsioni, la prima infanzia, la sessualità.
Presenterò in questa scheda i principali concetti che stanno alla base di questo orientamento, che è senz’altro uno dei principali nella panoramica attuale della psicoanalisi, lasciando all’approfondimento (che in seguito sarà aggiunto) il compito di offrire al lettore interessato a vedere oltre la panoramica, una serie di informazioni sulla clinica , sulla tecnica e sulla teoria.
Tale presentazione ha anche lo scopo di sgombrare il campo da pregiudizi circa la presunta non profondità e la scarsa attenzione all’introspezione ed ai processi inconsci nella prospettiva relazionale in psicoanalisi.
Mi preme sottolineare che, anche se non verrà citato in questa scheda, (se non nella bibliografia acclusa) il capostipite dell’orientamento psicoanalitico relazionale è senz’altro da considerarsi Sándor Ferenczi. Tutti i suoi scritti, ma in particolare quelli successivi al ’20, contengono in nuce pressoché tutto ciò che poi sarà sviluppato anni dopo negli ambiti interpersonalisti, intersoggettivisti, relazionalisti. Insieme con lui, va citato, come relazionalista ante litteram, Benjamin Wolstein, autore nel ’59 del bellissimo “Countertranference”, mai tradotto in taliano, purtroppo.
Scrivevo nel 2003, riferendomi al mutamento in corso nella psicoanalisi, che il cambiamento che considero fondamentale nella teoria e nella pratica psicoanalitiche non è tanto quello, diciamo così, interno alla psicoanalisi stessa, rappresentato dal passaggio dal modello pulsionale al modello relazionale, quanto le conseguenze a valanga del passaggio -peraltro ancora in corso- da un modello positivista ad uno costruttivista [1] Costruttivismo (Jones 1975): La concezione secondo la quale ciò di cui facciamo esperienza non è un mondo totalmente indipendente da noi, ma un mondo al quale l’attività della mente attribuisce determinate caratteristiche nella epistemologia moderna. Infatti I. Hoffmann (2000) ci dice che il paradigma cambia solo quando l’idea del coinvolgimento personale dell’analista si sposa con una posizione epistemologica costruttivista o prospettivista. Solo grazie a questa integrazione viene presa totalmente in conto l’ idea della partecipazione personale dell’analista al processo. Ciò significa che la partecipazione personale dell’analista al processo, ha un effetto costante su ciò che egli comprende di se stesso e del paziente nell’interazione. Il presupposto generale di questo modello è che la comprensione dell’analista è sempre una funzione della sua prospettiva del momento. Inoltre la partecipazione dell’analista implica tutti i livelli della sua personalità e deve includere anche fattori inconsci, oltre che coscienti.
Questa la cornice epistemologica; vediamo ora quali elementi inserire in questa cornice.
Innanzitutto il campo oggetto di indagine, intersoggettivo: B. Wolstein (1959) ci dice che l’ambito della investigazione psicoanalitica diventa ora il campo esperienziale nella sua totalità piuttosto che il solo paziente; difatti la teoria relazionale, come quella interpersonale, colloca il punto maggiore del suo interesse sulle relazioni interpersonali reali ed immaginate.
Siamo in un campo intersoggettivo: l’altro -dice J. Benjamin (1988)- deve essere riconosciuto come un soggetto altro, perché il sé realizzi l’esperienza della propria soggettività alla sua presenza; noi abbiamo bisogno di riconoscimento ed abbiamo la capacità di riconoscere gli altri ed in questi due punti risiede la possibilità per ciascuno di essere riconosciuto, cognitivamente ed affettivamente.
Potremmo così dire che nella prospettiva relazionale là dove c’era l’oggetto, ci sono i soggetti.
Altra importante dimensione: la persona e la personalità dell’analista:JR Greenberg (1986) ci dice che non è possibile evitare il coinvolgimento dell’analista perché la sua partecipazione non è una scelta e che la tecnica consiste casomai nello specificare come dovrebbe partecipare. Mentre Mitchell (1977) ci avverte che la comprensione da parte dell’analista del punto di vista del paziente è sempre mediata dal punto di vista dell’analista. E già Racker, nel 1957, osservava che l’analisi è una interazione tra due personalità ed ognuna di queste due personalità reagisce ad ogni accadimento nel contesto della situazione analitica.
Nei modelli classici sulla scena terapeutica sembra esserci un solo attore, il paziente, osservato con attenzione e partecipazione da un’altra persona, il terapeuta, che si costituisce come uno schermo quanto più neutrale e come un interprete non direttamente partecipante. Nel modello interpersonale la scena della cura è calcata da due attori. Tutti gli orientamenti interpersonalisti e post-interpersonalisti riconoscono la presenza del terapeuta come attivamente interagente con il paziente, pur differenziandosi tra quelli che, più sullivanianamente, lo vedono come “osservatore che anche partecipa” e gli interpersonalisti più intersoggettivisti (quali Stolorow, Atwood e Brandchaft, 1994, e Beebe e Lachmann, 2002), che considerano il terapeuta come “partecipante che anche osserva”, nel suo incessante interagire con il paziente -declinato in base alla sua personalità- durante l’andamento nel tempo della relazione di cura.
Nel momento poi in cui si incrociano l’importanza data alla persona dell’analista e quella conferita al qui ed ora, abbiamo che, come ci propone L. Aron (2004), l’idea centrale è che i desideri ed i conflitti apparentemente infantili che si rivelano nelle associazioni del paziente non sono soltanto o principalmente i resti del passato imposti artificialmente nel campo terapeutico ma sono invece riflessi delle interazioni reali con quello specifico singolo analista: la personalità dell’analista influenza non soltanto l’alleanza terapeutica o la cosiddetta relazione reale, ma anche la natura dello stesso transfert. Per cui, nell’ottica relazionale l’impatto dell’analista deve essere sistematicamente esaminato come parte intrinseca del transfert.
Infine l’importanza data alla prospettiva del paziente sull’interazione psicoanalitica: se si prende seriamente in conto che all’interno della diade psicoanalitica ci sono due soggettività separate, occorre considerare che sia poco credibile che una di esse “a causa del” transfert distorca la realtà ed un’altra invece sia in grado di valutare “oggettivamente” tale realtà; si propone piuttosto l’idea che ciascuna di esse possa avere una plausibile prospettiva sulla realtà clinica, se pur all’interno di una situazione asimmetrica che prevede tra l’altro anche una chiara distinzione dei ruoli. Inoltre in conseguenza di quella che Aron chiama “Mutual generation of data” (mutua generazione dei dati da parte di analista e paziente) abbiamo che le scelte dell’analista sono determinate anche da dati che essa stessa produce e che seleziona, per cui la raccolta dei dati relativi all’esperienza del paziente è inevitabilmente condizionata da qualità soggettive presenti nel campo.
Tutti i punti citati ed ancora altri saranno ripresi ed ampliati nella sezione di approfondimento che seguirà.
Bibliografia
Aron, L. (2004). Menti che si incontrano. tr.it. Cortina, Milano.
Ferenczi, S. (1932). Diario Clinico tr. it. Cortina , Milano 1988.
Fosshage, J.L (2004) I rapporti tra la psicologia del sé e la psicoanalisi relazionale, in Ricerca Psicoanalitica n.° 2 .
Gill, M. (1996). Psicoanalisi in transizione, tr. it. Cortina 1996.
Greenberg, J.R.,Mitchell, S.A. (1983). trad. it. Le relazioni oggettuali nella teoria psicoanalitica,Il Mulino, Bologna 1986.
Hoffmann, I.Z.(2000) Rituale e spontaneità, tr. it. Astrolabio, Roma.
Mitchell , S. A.(1988) Gli orientamenti relazionali in psicoanalisi. Per un modello integrato, tr.it. Bollati Boringhieri, Torino 1993.
Perlman Frederic and Jay Frankel J.(2009). Relational Psychoanalysis: A Review, Institute for Psychoanalytic Training and Research New York, USA.
Rocchi, C., Mind the Gap, presentato al Congresso F.E.P. Sorrento 2003.
Wolstein, B. (1959) Countertransference, Grune & Stratton, NY.
Psicosi (La)
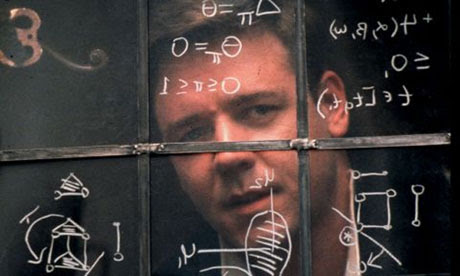
dal film A beautiful mind di Ron Howard
A cura di Alberto Siracusano con la collaborazione di Michele Ribolsi
Se il termine “nevrosi” viene introdotto nel 1769 da William Cullen, il termine “psicosi” è stato coniato successivamente da Ernst von Feuchtersleben, scrittore e sottosegretario all’istruzione austriaco (Vienna, 1806 –1849), con il significato generale di “malattia mentale” o “follia”, ovvero una condizione caratterizzata da perdita di contatto con la realtà, disturbi delle percezioni, del pensiero e del linguaggio, dell’affettività e delle funzioni cognitive. È interessante notare come il termine nevrosi sia più antico di quello di psicosi. Risulta difficile definire questi due concetti senza tenere conto l’uno dell’altro: entrambi si definiscono per contrapposizione, attraverso una relazione di contrasto. Curiosamente, all’inizio la “nevrosi” veniva definita come “malattia dei nervi”, ovvero un disturbo primitivamente legato ad una disfunzione organica, mentre la psicosi era definita come un disturbo funzionale dell’immaginario (1). Tale relazione si invertirà successivamente. Nel Dictionnaire Encyclopédique des Sciences Médicales del 1877 non compare il termine psicosi ma quello di folie (l’autore dell’articolo era Cotard), ma già nel 1882 Magnan identificava le “follie propriamente dette psicosi”, cioè turbe psichiatriche che si manifestano con delirio, mania, melanconia. È del 1848, invece, la prima definizione del concetto di “psicosi unica” (Einheitpsychose) elaborato da Wilhelm Griesinger (1817-1868) per definire i disturbi psichici all’interno di un continuum psicopatologico unitario. Tale concetto è stato successivamente ripreso da Karl Menninger, il quale, nel 1958, notava come “invece di porre così tanta enfasi sui differenti tipi di malattie, dovremmo pensare alla malattia mentale come essenzialmente unica in qualità, ma piuttosto diversa in quantità”.
Kraepelin e Bleuler hanno compiuto numerosi sforzi nel tentativo di fornire una classificazione sistematica della psicosi sulla base di una osservazione clinica psichiatrica longitudinale. Emil Krapelin (Neustrelitz, 1856 – 1926) in una conferenza alla Clinica Psichiatrica di Heidelberg il 27 Novembre 1898 definì il concetto di “Dementia Praecox” come un unico quadro clinico ad esordio precoce ed esito con grave deterioramento delle funzioni cognitive e comprendente tre forme: l’ebefrenia di Hecker, la catatonia di Kahlbaum, la dementia paranoides, isolata dallo stesso Kraepelin. Pochi anni dopo lo psichiatra svizzero Eugen Bleuler (1857-1939) riformulò il concetto kraepeliniano di Dementia Praecox in quello di schizein – phren (dal greco “mente divisa”), schizofrenia (2). Da allora il concetto di schizofrenia si è legato a quello di psicosi, finendo col divenire in molti casi sinonimo. Attualmente, il DSM-5 parla di “Disturbi dello Spettro Schizofrenico” e “altri disturbi psicotici”, utilizzando il termine “psicotico” per definire manifestazioni deliranti o allucinatorie in quadri clinici diversi dalla schizofrenia propriamente detta (3).
In ambito psicoanalitico, Victor Tausk (1919) nel suo lavoro sulla “macchina influenzatrice” analizza in un caso di schizofrenia paranoide la struttura del delirio allucinatorio. L’intuizione di Tausk riguarda la possibilità che le differenti parti della macchina rappresentino diverse parti del corpo del paziente: la “macchina influenzatrice” è la proiezione del mondo interno del paziente e contemporaneamente lo strumento che influenza referenzialmente la vita psichica del soggetto. A partire da Sigmund Freud (Freiberg, 1856 – 1939), la psicoanalisi ha interpretato la psicosi come una rottura dell’Io con la realtà esterna: l’Io ritorna al suo stato originario indifferenziato, vale a dire si dissolve interamente o parzialmente nell’Es che non ha conoscenza degli oggetti e della realtà (4). Freud in particolare ha sviluppato le proprie teorie utilizzando le “Memorie di un malato di nervi” pubblicate nel 1903 da Daniel Paul Schreber (5), presidente della Corte di Appello di Dresda e da cui nacque il lavoro di Freud “Osservazioni psicoanalitiche su un caso di paranoia (dementia paranoides) descritto autobiograficamente” (6). Freud ha fatto diventare Schreber “il primo paziente psicotico” della storia della psicoanalisi e, grato di questo, lo definì, neppure troppo ironicamente, “professore di psichiatria e direttore di clinica” (lettera a Jung, 22 aprile 1910). A partire dalla famosa espressione contenuta nelle Memorie “Sarebbe davvero bello essere una donna che soggiace alla copula”, Freud ipotizzò che alla base della psicosi del Presidente Schreber ci fosse un rigetto delle sue tendenze omosessuali mediante la negazione e la proiezione. La scissione dalla realtà esterna e il crollo dell’Io trovano il proprio corollario nella regressione ad un antico livello narcisistico. Abraham (Berlino, 1877 – 1925) sottolineò a questo riguardo che la differenza fondamentale tra nevrosi e psicosi risiede nel fatto che nel processo di allontanamento dalla realtà siano preservate le rappresentazioni dell’oggetto oppure no, laddove nella psicosi il ritiro della libido dagli oggetti è marcatamente più diffuso. In tempi più recenti, Racamier (1924-1996) ha ripreso questo concetto sottolineando come “in ogni psicotico imperversa il conflitto tra l’attrazione verso l’oggetto ed il mondo e l’attrazione narcisistica”. “L’oggetto”, continua Racamier, “è il vero nemico per uno psicotico per il solo fatto di essere investito: il pericolo è quello di essere aspirato e assorbito dentro l’oggetto”. Melanie Klein (Vienna, 1882 – 1960) teorizzò le psicosi come legate alla caduta nella posizione schizoparanoide della prima infanzia, nella quale si identificano due meccanismi caratteristici, la scissione e la identificazione proiettiva (7). A partire dagli scritti di Melanie Klein oltre che di Freud, Wilfred Ruprecht Bion (Muttra, 1897 – 1979) ha formulato l’ipotesi di un “apparato per pensare”, in grado di determinare la trasformazione di elementi beta, ossia esperienze sensoriali grezze non metabolizzate, in elementi alfa, elementi di esperienza che possono essere collegati l’uno all’altro nei processi di pensiero conscio ed inconscio e nei sogni. Se questa trasformazione non si verifica, si ha lo sviluppo della psicosi (8). Uno degli aspetti più interessanti del discorso psicoanalitico sulla psicosi deriva dagli scritti di Paul Federn (1871-1950) nei quali l’autore affronta il problema centrale della possibilità che il soggetto psicotico sia capace o meno di sviluppare il transfert e conseguentemente di accedere alla cura analitica. A partire dal secondo dopoguerra, la letteratura psicoanalitica della psicosi è diventata vastissima e numerosi sono gli autori che se ne sono occupati; tra gli altri ricordiamo: Jacques Lacan, Ignacio Matte Blanco, Herbert Rosenfeld, Harold Searles, Paul-Claude Racamier, Piera Aulagnier-Castoriadis, Salomon Resnik, Gaetano Benedetti, André Green, Donald Winnicott, Hanna Segal. Già Bion aveva rivelato come la mente di un soggetto transita costantemente tra le posizioni schizoparanoide e depressiva. A questo riguardo Rosenfeld (1965) ha operato una distinzione tra lo “stato psicotico” (che corrisponderebbe ad una visione dinamico-globale del processo) e il “nucleo o personalità psicotica”, più statico nel tempo. Anche J. Lacan a partire dagli anni ’70 ha tentato di operare un superamento della rigida distinzione tra nevrosi e psicosi, attraverso l’elaborazione della clinica dei “nodi borromei”, per la quale la struttura psichica di un soggetto e il suo conseguente rapporto con la realtà è piuttosto dato da un annodamento corretto dei tre registri (simbolico, immaginario e reale) ad opera di un quarto, il “nome del padre”, o di una sua supplenza (9). Ancora più recentemente, è stata ipotizzata la presenza di “momenti psicotici” anche nella cura di soggetti nevrotici (10), rigettando di fatto l’equazione tra episodi deliranti/allucinatori e psicosi. Al riguardo, Piera Aulagnier ha identificato la presenza di momenti psicotici come una “zona sinistrata” all’interno della sfera psichica di un soggetto. Sulla scia di riflessioni winnicottiane, Roussillon (2011) ha parlato di “soluzione psicotica” come di una “organizzazione difensiva che mira a proteggere da un’angoscia disorganizzatrice” connessa ad una esperienza di “terrore agonico inelaborato” (10).
Negli ultimi anni, infine, la ricerca psicoanalitica si è interessata sempre più ad una categoria di pazienti che non rientrano nei parametri rigidi delle nevrosi o delle psicosi, secondo quanto stabilito da Freud in poi. Nella letteratura questi pazienti prendono la denominazione di casi “limite”, designazione che li situa in uno “spazio-tra”, ossia, tra la psicosi e la nevrosi. Sono i pazienti borderline, o personalità borderline (borderline personality), così chiamati soprattutto dagli autori inglesi e americani o i “cas-limites” degli autori francesi. André Green (1990), nel proporre il concetto di limite, osserva che “… il limite dell’insania non è una linea, bensì un vasto territorio senza alcuna netta divisione che permetta separare la sanità dall’insania”. Green ha riportato al riguardo come “paradossalmente i casi-limite costituiscono strutture abbastanza stabili nonostante o forse proprio in ragione della loro instabilità” (11).
In estrema sintesi, oggi il termine psicosi è stato nella storia utilizzato in una varietà di significati che lo hanno reso semiologicamente ambiguo e trova una sua specificità psicopatologica clinico – diagnostica dinamica solo all’interno del determinato contesto in cui viene utilizzato.
1. Edward Shorter. A historical dictionary of Psychiatry. Oxford University Press 2005.
2. Martin Bürgy. The Concept of Psychosis: Historical and Phenomenological Aspects. Schizophr Bull 2008; 34: 1200-1210.
3. Alberto Siracusano. Manuale di Psichiatria. Il Pensiero Scientifico editore 2014, in press.
4. Freud S. (1968). Opere 1892 – 1899. Progetto di una psicologia e altri scritti. Torino: Bollati Boringhieri.
5. Daniel Paul Schreber, Memorie di un malato di nervi, tradotto da F. Scardanelli e S. De Waal, Adelphi, 2007.
6. Sigmund Freud, Osservazioni psicoanalitiche sul resoconto autobiografico di un caso di paranoia (dementia paranoides) in Compendio di psicoanalisi e altri scritti, Newton Compton Editori, 2010.
7. Melanie Klein. La psicoanalisi dei bambini, a cura di H. A. Thorner e Alix Strachey, Milano: Fabbri, 2007
8. Wilfred R. Bion. Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico. Tr. it. Armando, Roma 1970.
9. Jacques Lacan. Libro XXIII, “Il sinthomo”, 1975-76; traduzione e cura di Antonio Di Ciaccia, Astrolabio, Roma, 2006.
10. Maurizio Balsamo (a cura di). Momenti psicotici nella cura. Franco Angeli 2014.
11. André Green. La folie privée: Psychanalyse des cas-limites. Paris, Gallimard, 1990.
Maggio 2014
Psicosomatica: uno spazio associativo
A cura di Claudia Peregrini
La storia
Nel 1925, lo psicoanalista viennese W. Stekel parla per la prima volta di ‘Somatizzazione’, per indicare il fatto che una nevrosi radicata può esprimersi attraverso un disturbo del corpo.
Un secolo prima, precisamente nel 1818, un medico a orientamento psicologico, J.C. Heinroth, aveva coniato il termine ‘Psicosomatico’.
Nel 1930, finalmente la psicosomatica diventa a tutti gli effetti una branca della medicina moderna.
Il corpo
Cosa intendiamo per corpo?
Con la parola corpo, ‘Soma’, mi riferisco sia al corpo biologico, reale – nient’altro che materia/energia/movimento-, sia all’esperienza che facciamo di lui, cioè al corpo vissuto.
Freud, quando diceva che l’Io è prima di tutto un Io corporeo, pensava al corpo vissuto, diventato già idea, rappresentazione fantasmatica, attraverso le fantasie inconsce e le difese in atto nelle nevrosi classiche, mentre, quando parlava di altre nevrosi che chiamava ‘attuali’ – la neurastenia, la nevrosi d’angoscia, l’ipocondria -, prive di contenuto psichico, dipendenti solo da fattori corporei (puro eccesso di eccitazione sessuale non psichicizzata), si riferiva proprio al corpo biologico, reale.
‘Somatizzare’ oggi vuol dire usare in modo più o meno intenso e ripetuto la dimensione corporea per esprimere il disagio.
Mentre si è affievolita l’idea della ‘somatizzazione’ come difesa per mantenere a livello inconscio conflitti relativi a desideri, pulsioni e affetti disforici associati.
Nel Manuale Diagnostico Psicodinamico (P.D.M., 2006, 43-44) leggiamo:
“E’ difficile parlare di persone somatizzanti -cioè di chi tende a esprimere le esperienze dolorose per mezzo di stati somatici -senza in qualche modo suggerire l’idea retrostante di una scissione mente-corpo, ma vorremmo che i nostri lettori comprendessero che questa difficoltà riflette più i limiti di un linguaggio che l’accettazione di un pregiudizio filosofico, tipico del diciannovesimo secolo, secondo cui la mente dovrebbe controllare il corpo”.
In effetti, se ci pensiamo bene, l’esperienza dolorosa è sempre sia un dolore fisico, sia un dolore mentale, simultaneamente. Per lo meno, risulta scolastico, artificioso, distinguere nettamente le due tipologie di dolore.
La definizione ‘Psicosomatico’ mantiene comunque molti significati diversi, secondo i differenti autori, e rimane un termine indeterminato.
La psicosomatica è soprattutto un modello teorico complesso che elimina almeno in parte la suddivisione della patologia in medica e psicologica (Trombini&Baldoni, 1999).
Personalmente ritengo che la psicosomatica sia una sorta di matrice culturale comune che integra tutti gli aspetti specialistici di cui si compone e sia principalmente un metodo di studio della patologia umana, che tiene conto delle variabili lette a livelli differenti, psicologico, sociale, biologico…
Un esempio di patologia con chiara evidenza psicosomatica.
La Neurastenia, che aveva colpito Freud trentenne per le grandi preoccupazioni, le fatiche e lo stato di eccitazione (sessuale) lontano dalla fidanzata Marta, si chiama oggi ‘Sindrome da Fatica cronica’. Non ha più come causa lo strano fattore chimico ipotizzato da Freud, ma riconosce un’eziopatogenesi multipla complessa, come la maggior parte della patologia umana.
Ha sintomi in comune con la depressione maggiore e alterazioni del sistema immunitario. Quindi è chiaramente una malattia sia psichica sia organica, dotata di sintomi senza alcuna connotazione simbolica precostituita, espressione di una sofferenza legata in parte a una non regolazione emotivo-affettiva.
Ogni patologia, pur non avendo la stessa chiara evidenza della Fatica Cronica, è psicosomatica e può essere letta da un punto di vista psicosomatico, mentre non esiste alcuna malattia che sia specificatamente psicosomatica, appunto perché nessuna malattia è solo psichica o solo somatica! (Solano, 2012).
Certamente esistono patologie che sembrano risentire più di altre di uno stato di non regolazione affettivo-emotiva, quali le vecchie Holy Seven della tradizione americana: l’ulcera peptica, l’artrite reumatoide, la tireotossicosi, l’ipertensione essenziale, le neuro dermatiti, la colite ulcerosa, l’asma bronchiale, alle quali nel tempo si sono aggiunte alcune coronaropatie, l’anoressia nervosa, la sindrome da fatica cronica…
Il ben noto cliché: Ho sempre mal di stomaco, evidentemente dipende da qualcosa di psicologico, perché gli esami medici non evidenziano nulla, diventa un assurdo. Posso dire tutt’al più che il mio mal di stomaco, non essendo visibile, misurabile, sul piano organico (con gli strumenti a disposizione), è ancora solo una disfunzione e non una lesione.
Noi abbiamo una mente o un corpo secondo i livelli a cui ci poniamo, e secondo gli strumenti e le lingue che utilizziamo per descriverli.
Questa nostra unità mente corpo (senza trattino) evolve grazie anche alla possibilità di provare e riconoscere emozioni e affetti, e alla progressiva capacità di oscillare tra diversi pensieri, diversi stati emotivi e loro correlati fisici (per esempio, il funzionamento del sistema neuro-immuno-endocrino), in un arricchimento e in una complessificazione progressivi.
E’ grazie al fatto di provare sentimenti che sappiamo chi siamo, questo è il nucleo centrale di ciò che chiamiamo intelligenza emotiva, che è prima di tutto la capacità di accedere alla propria vita affettiva, in secondo luogo, è l’intelligenza interpersonale, cioè la capacità di leggere almeno un po’ gli stati d’animo, le intenzioni e i desideri degli altri.
Il nucleo emotivo-affettivo – ciò che sentiamo – è strettamente legato al metabolismo corporeo e all’esperienza, anche quando non ne siamo consapevoli. Si può dire che il metabolismo corporeo, con la sua fisiologica continua variabilità, a un certo livello può essere letto proprio come nucleo emotivo-affettivo.
Le emozioni cattive, o non riconosciute (insieme a molti altri fattori eziopatogenetici), ci fanno ammalare. Troppa impotenza, troppa paura…
Il vertice psicosomatico si occupa di questo.
In particolare, ‘Alessitimia’ (di vario grado, transitoria, stabile, primitiva o secondaria) è il nome che diamo alla difficoltà di identificare e descrivere ciò che sentiamo; operatorio è il nome del pensiero che spesso accompagna lo stato alessitimico grave, un pensiero iperrazionale, concreto, privo di coloritura affettiva e della tradizionale dimensione simbolica.
Mondo alessitimico, operatorio e non regolazione affettiva sono tutt’uno: comportano, come risposta agli stimoli, un aumento anche marcato dei livelli tonici di attivazione del sistema nervoso autonomo, con le conseguenti disfunzioni e lesioni, perché c’e’ uno scollamento tra quello che si sente e si riconosce e le risposte del sistema nervoso autonomo.
Per esempio, quando non siamo in grado di renderci conto che stiamo provando una grande rabbia, la pressione arteriosa può andare a mille. Proprio perché, non sentendo e non riconoscendo l’affetto rabbia a un certo livello, siamo costretti a utilizzare solo un suo concomitante organico, appunto la pressione arteriosa.
Studiosi di psicosomatica a confronto
Due importanti scuole di psicosomatica studiano rispettivamente l’alessitimia e il pensiero operatorio.
Il gruppo di Toronto, attivo dagli anni ’70, fondato dallo psicoanalista Graeme Taylor, lo psicologo Mike Bagby e lo psicologo clinico Jim Parker, tre autori con diversi orientamenti teorico-metodologici che lavorano insieme e, collaborando con ricercatori di tutto il mondo, non hanno mai chiuso il cerchio attorno a sé, si occupa di alessitimia.
La scuola di Parigi, con Pierre Marty, Michel Fain. Michel de M’Uzan, Christian David, dagli anni ’60 parla di un pensiero molto simile, che chiama operatorio.
I due gruppi di studiosi hanno modelli molto diversi. Per esempio, i malati psicosomatici, secondo la scuola di Parigi, soffrono di una grave inibizione fantasmatica, accompagnata da uno stato di depressione essenziale e da una disorganizzazione progressiva, per cui imboccano una sorta di percorso a ritroso verso livelli di funzionamento psichico primitivo, fino ad arrivare a compromettere il funzionamento biologico stesso, fino alla malattia…
BIBLIOGRAFIA
PDM (2006) Manuale Diagnostico Psicodinamico (a cura di V. Lingiardi & F. Del Corno). Milano: R. Cortina, 2008.
Trombini G. & Baldoni G. (1999) Psicosomatica. Bologna, Il Mulino.
Solano L. (2001, 2012) Tra mente e corpo. Milano, R. Cortina
Taylor G.J. et al. (1997) I disturbi della regolazione affettiva. Roma, Giovanni Fioriti, 2000.
Merciai S. www.psychomedia.it/ pm-bookshop/merciai/volume.pdf
APPROFONDIMENTI
Psicosomatica 2
A cura di Claudia Peregrini
Il problema mente corpo (La loro simultaneità)
Come si genera l’emozione
Più di centoventi anni fa, W. James, medico, psicologo e filosofo statunitense di origini irlandesi,scriveva in Principi di psicologia (1890) che, se non esistessero gli stati del corpo successivi alla percezione, percepire rimarrebbe un fatterello di stampo puramente ‘cognitivo’, freddo, pallido, incolore. Se un oggetto venisse solo e semplicemente percepito, -se non si trasformasse in qualcosa di sentito emozionalmente-, per noi non sarebbe quasi nulla.
James era il grande scienziato che, ormai anziano, ascoltando le conferenze di Freud all’università di Clark, in America, ebbe a dirgli: “Il futuro della psicologia e’ nelle sue mani!”.
Oggi, un neuroscienziato altrettanto importante, A. Damasio, pensa che le intuizioni di James sulla mente umana siano talmente sorprendenti da essere paragonabili a quelle di Shakespeare e di Freud.
James spiegava il modo in cui il nostro corpo risponde a un oggetto o a un evento emotivamente carico, per esempio, la paura. Dapprima nel corpo succede un cambiamento inconsapevole: si modifica il sistema nervoso autonomo con la sua regolazione, aumentano la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa, la sudorazione ecc.; successivamente la corteccia cerebrale riconosce (diventiamo consapevoli) i nuovi stati corporei. Non e’ solo il cervello a comunicare con il corpo, cervello e corpo comunicano nei due sensi.
Mentre allora si credeva che fosse il feedback della risposta del corpo allo stimolo a generare la sensazione e il feedback al cervello a dare conto di come ci sentiamo in una certa situazione (lo stimolo da’ la risposta corporea, la quale genera il feedback, che e’ responsabile dell’emozione), oggi gli scienziati ipotizzano che l’emozione venga innescata simultaneamente sia dalla valutazione cognitiva dello stimolo sia dalla specifica risposta corporea, autonoma e viscerale. Significa che la valutazione cognitiva non e’ basata sulla risposta corporea specifica, perché sono i due fatti insieme, o quasi insieme, valutazione (mentale) e risposta (corporea), a generare l’emozione.
La simultaneità mente corpo letta con gli strumenti della neurobiologia Uno dei più importanti neuroscienziati americani che si occupano di psicoanalisi, A. N. Schore,
spiega (2003) che siamo in grado di leggere in tempo reale, in ‘linea’, una rappresentazione, (immagine in risonanza magnetica di certi distretti cerebrali), di una relazione oggettuale.
Più precisamente, con la tomografia a emissione di positroni (PET) possiamo vedere che, quando soggetti appartenenti a una popolazione non clinica provano sentimenti negativi e fanno fantasie legati a una perdita d’oggetto -per esempio, la perdita di una persona amata-, c’e’ un incremento di flusso di sangue soprattutto nelle aree cerebrali orbitali prefrontali. Le fantasie e gli affetti negativi avvengono insieme all’incremento del flusso di sangue in quelle aree cerebrali.
Il fenomeno mentale e il fatto corporeo sono cioè simultanei e sono imprescindibilmente uniti, perciò vanno letti assieme, perché, soli, al di fuori della relazione che li lega, perdono di senso e di forza. Ovviamente, la risonanza magnetica funzionale e’ soltanto una specie di fotografia del metabolismo in corso in quella particolare zona del cervello, una lettura fatta dalla medicina con i suoi strumenti. Siamo noi psicologi, psicoanalisti, psicosomatisti, con il paziente, a poter leggere quella specifica relazione nella sua originalità, con la sua storia e con le caratteristiche di intensità affettiva. A cosa serve conoscere una PET, oltre a insegnarci dati specialistici affascinanti che non appartengono al nostro abituale campo di indagine?
La specifica tipologia di relazione oggettuale, che prima potevamo solo immaginare, quando la ‘vediamo’ così, con la PET, traslocata nel campo corporeo grazie alla risonanza strumentale, non rimane solo nella sfera delle astrazioni mentali, entra nella sfera della risonanza vera, scende a terra, si dissolve fino a farsi materia. E’ come se la sentissimo passare attraverso i differenti livelli, sotto l’azione di forze, in un movimento importante che genera nei nostri controtransfert sensazioni nuove. Prima di tutto li interroga, creando nuovi e forti vincoli alla nostra attività interpretativa.
Poi, produce in noi operazioni immediate di offuscamento, estraniamento, fenomeni di sfocatura, con effetti di allontanamento e improvvisa ricollocazione in un campo più potente: tutto si riorganizza in funzione del confronto (paradossalmente possibile) delle due diverse logiche con le loro differenti lingue, psicoanalitica e medica. Cosa diventa per esempio quella particolare relazione d’oggetto, intrisa di una perdita dolorosa, quando, trasferendosi nel corpo, cambia di stato, si fa flusso di sangue, con una forza e un ritmo, in un’area del cervello?
Quali sensazioni generano i due stati, il corporeo e il mentale -che sappiamo simultanei-, quando li teniamo a mente assieme?
Mente e corpo sono la stessa sostanza letta a livelli diversi; psicoanalisi e neuroscienze sono solo due sistemi esplicativi, autonomi e paralleli, che ovviamente non possono validarsi vicendevolmente. I domini delle due discipline possono essere considerati come logicamente -non fisicamente- distinti e quindi ne’ dualistici, ne’ veramente interagenti.
Tra di essi troviamo sempre più corrispondenze, correlazioni: non e’ il cervello, il corpo, a determinare -come base- la mente, né viceversa, siamo noi a registrare concomitanze tra mente e corpo, secondo una legge statistico-probabilistica, la causalità tradizionale e’ tramontata.
Il problema
Ci diciamo monisti, ma in realtà raccontiamo sempre che la mente e’ basata sul corpo, o che esiste una relazione tra mente e corpo, come se i due si parlassero, si influenzassero vicendevolmente… E ci poniamo un falso problema: questo fatto e’ psichico o fisico? Oppure, nasce prima nella psiche o nel corpo?
Perché cadiamo nel tranello?
Perché è proprio il processo del pensiero occidentale a svolgersi così, non esiste altro modo: per pensare e parlare, distinguiamo la mente dal corpo (e usiamo le rispettive discipline che li studiano, per esempio, la psicoanalisi e la medicina), poi, per continuare a pensare, se non ci irrigidiamo in sterili distinzioni, torniamo per forza ‘indietro’, all’unità indivisibile (mente corpo, senza trattino).
Non si arriva a una conclusione, non c’e’ un capolinea, il problema mente corpo, psicoanalisi neuroscienze, non è risolvibile, però e’ assolutamente necessario al pensiero, che, per essere vivo, deve potere oscillare, ‘avanti’ e ‘indietro’, tra distinzione e unita’, in uno stato perpetuo di transizione. Parlo di un pensiero autentico, avviato (per esempio, dal processo psicoanalitico) all’infinito -un infinito inteso come limite matematico: la’ dove non si arriva mai-; avviato all’Inconscio, l’ignoto del corpo, che non conosceremo mai fino in fondo, il luogo dell’intraducibile,destinato a rimanere per sempre enigmatico.
A cosa serve nella clinica oscillare tra i vari livelli e le differenti lingue
Serve a entrare in una prospettiva (di coesistenza) che allarga il nostro modo di vedere e ci porta lontano da ogni totalitarismo ermeneutico, da ogni riduzionismo che può operare il realismo tout court, da ogni forma di narratologia a oltranza, con cui alla fine l’analista si sente autorizzato a raccontare ‘qualunque cosa’ in analisi -e’ sufficiente sentirla controtransferalmente- ignorando i ‘dati di realtà’.
Conoscere i dati di realtà (per esempio, il corpo letto dalla medicina), sapere oscillare tra le due forme di conoscenza, psicoanalitica e medica, apre prospettive di pensiero e di contatto con i pazienti assolutamente nuovi.
Con il premio nobel E. Kandel, sappiamo che le esperienze diventano strutture biologiche: l’attivazione continua di cellule a livello di certe giunzioni neuronali (‘barriere di contatto’ in Freud) innesca meccanismi genetici cellulari che promuovono la crescita di altre sinapsi.
L’esperienza dell’imparare e del ricordare, esplicitamente e implicitamente, e il suo grado di intensità, hanno effetto trofico di per se stessi. La parola ha la possibilità di operare come stimolo particolare che modifica in modo duraturo l’anatomia e la funzionalità delle aree nervose interessate…La moderna neurobiologia ha la stessa idea di memoria di Freud.
Il futuro
Sembra un sogno quasi utopico, sognato grazie a strumenti avveniristici, straordinarie risonanze magnetiche (Mri), ‘ultra microtomi’ in grado di tagliare il cervello in sezioni di 50 nanometri, che poi vengono lette con microscopi elettronici seriali… (S. Seung, 2013).
Potremo forse decifrare e descrivere tutte le connessioni neurali del cervello umano, il ‘Connettoma’. Potremo forse arrivare a conoscere la mappatura dinamica di ogni stato e processo mentale, non solo schemi motori e percezioni, ma ricordi, fluttuazioni emotivoaffettive, pensieri complessi, potremo forse individuare le ‘connettopatie’ (deficit o
anomalie di trasmissione sinaptica), momenti eziopatogenetici di un largo spettro patologico, dalle sindromi autistiche a quelle degenerative.
Potremo forse entrare nel groviglio dei singoli neuroni, con le loro sinapsi e gli impulsi elettrici, i recettori e i neurotrasmettitori, la’ dove costruzione e eliminazione, cioè attivazione e inibizione degli stimoli, coesistono incessantemente…Vedremo neuroni sempre in movimento, mentre ripesano le connessioni, rinforzandole o indebolendole; si
riconnettono, creando o eliminando sinapsi; si ricablano, facendo crescere o ritraendo le modificazioni; si rigenerano, con nuovi neuroni che prendono il posto dei vecchi.
Più di cento anni fa Freud immaginava che le connessioni funzionali delle cellule nervose -altrimenti dette sinapsi- fossero plastiche e il risultato della loro plasticità, le micro modificazioni fisiche, fosse la memoria. Capiva che lo stivaggio dei dati nel cervello comportava una crescente permeabilità delle barriere di contatto tra i neuroni del
sistema memoria. La psicoanalisi con lui e dopo di lui si occupa del lavoro della memoria, mentre la medicina si occupa di memoria da un punto di vista neurobiologico.
Le due memorie non possono prescindere l’una dall’altra.
Nel Connettoma, viene ritenuto fondamentale il rapporto tra localizzazione e plasticità, tra aree specializzate in funzioni precise, per esempio del linguaggio, della visione, ecc. e le possibilità che il cervello, grazie alla sua plasticità, ne surroghi eventuali lesioni con un ricablaggio neurale.
Da più di cento anni siamo al lavoro insieme, psicologi, psicoanalisti, psicosomatisti, medici e in particolare neuroscienziati, per comprendere lo sviluppo del corpo mente umano studiandolo contemporaneamente a vari livelli, distinti e strettamente interconnessi, dal livello dell’organizzazione biologica, al livello del funzionamento socio culturale e psicologico. Per decenni ci siamo occupati insieme dell’interazione tra ambiente e maturazione delle strutture organiche e delle loro funzioni. In particolare abbiamo sviluppato un modello multidimensionale della relazione ambiente/struttura/funzione per avvicinarci alla parziale comprensione dello sviluppo emotivo umano, studiando per esempio come si crea in modo interattivo e quali strutture/funzioni influenza il legame di attaccamento tra madre e bambino, la loro comunicazione affettiva.
Studiare i vari livelli, con le diverse lingue, le loro specificità, l’uguale importanza e dignità, diventando sempre più capaci di mescolarli, a tratti, quando serve, per poi tornare a distinguerli, riconoscendoli, e’ il futuro.
Bibliografia
Damasio A. (1994) L’errore di Cartesio, emozione, ragione e cervello umano. Adelphi, Milano:1995
Fonagy P; Target M. (1997) Attaccamento e funzione riflessiva. Cortina, Milano: 2001
Kandel E. K. (2012) L’età dell’inconscio. Cortina, Milano: 2012
James W. (1890) Principi di psicologia. Soc. ed. Libraria, Milano:1901
Matte Blanco I. (1975) L’Inconscio come insiemi infiniti. Einaudi, Torino:1981, 2000
Seung S.H. (2013) Il Connettoma. Codice Edizioni, Torino: 2013
Pubertà

Puberty-Edvard-Munch-
A cura di Mirella Galeota
Pubertario
L’adolescenza è da considerarsi non solo un tempo della vita, ma soprattutto un agente organizzatore decisivo, quasi un enzima del funzionamento mentale. L’adolescente si trova a dover riorganizzare, sperimentando e cercando di integrare, lo sviluppo psicologico precedente nel nuovo contesto di maturità sessuale. Affrontare l’adultità è proprio ciò che l’adolescente teme, diventa fondante affrontare l’adultità del corpo e la relazione con esso.
Eglé Laufer (2002) distingue tra corpo come oggetto interno, che rappresenta il corpo libidico, e l’immagine corporea basata sull’esperienza sensoriale.
Nuove sensazioni mai sperimentate prima emergono in adolescenza e riguardano il nuovo evento delle trasformazioni puberali: l’impregnazione ormonale, la nuova muscolarità, la nuova statura fisica, la maturazione sessuale e i nuovi genitali, le nuove esperienze legate al menarca, al pubarca e all’iniziazione sessuale. Quest’ultima permette, in particolar modo nella ragazza, sensazioni nuove connesse con lo sperimentare gli organi interni (Laufer, 2002; Nicolò, 2011). Sappiamo che non è solo l’aspetto ormonale: esso è direttamente collegato alla straordinaria fioritura di connessioni neurali nell’area prefrontale (Giedd, 2010) che è responsabile del turmoil dell’adolescente fino ai 25 epoca in cui sarà completato il suo sviluppo.
Philippe Gutton (Le pubertaire, PUF Paris 1991) attribuisce notevole importanza al periodo puberale e afferma che “la parola pubertà sta al corpo come la parola pubertario sta alla psiche”. Cioè con la pubertà inizia il lavoro psichico per integrare lo sviluppo corporeo. Gutton scrive che mentre il bambino è passivo, tenero e sedotto, nella scena pubertaria diventa attivo, potenzialmente seduttore, fonte di passione. La concretezza del pubertario è il momento della separazione e della distinzione. Il pubertario rappresenta la messa a dura prova del funzionamento dell’Io che in questo momento deve tener conto contemporaneamente di tutte le necessità della realtà interna e di tutte le necessità concrete della realtà esterna, ovvero quello che Freud chiama l’assunzione del principio di realtà articolato con il principio di piacere. Questo tipo di esperienza, anche se occorsa durante l’infanzia diverse volte, non ha però mai raggiunto le quantità, le differenze, le concretezze corporee della dimensione pubertaria. Gutton scrive(1) : “Il pubertario non nasce dall’infantile, ma nel corso dell’infanzia dalla quale prende in prestito i modelli delle sue rappresentazioni e delle sue azioni”.
La creazione di una parola non solo connota un percorso ma rappresenta il tentativo di raffigurare una modalità di funzionamento peculiare di questo momento della vita. Emerge il conflitto tra infanzia e pubertario che si “simbolizza nel conflitto tra teoria sessuale infantile e teoria pubertaria”. Dal conflitto “si costruisce il compromesso adolescens, la cui negazione interrompe l’evoluzione (breakdown)”. Spesso l’adolescente, che ha riconosciuto l’evento pubertario e che si trova ad affrontare un enorme lavoro per elaborarlo, può utilizzare varie persone o vari eventi per potersi appoggiare nel tentativo di delegare qualcuno alla risoluzione di aspetti propri rievocando modalità infantili. L’obiettivo principale dell’adulto e, nel nostro caso, dell’analista resta sempre, però, quello di far progredire l’adolescente nella sua assunzione di responsabilità. Possiamo così pensare all’adolescente come immerso in una dimensione di sé che intravede e insegue ma che gli sfugge, come ben sottolinea Gianluigi Monniello nella prefazione al libro di Gutton “Il genio adolescente”.
L’adolescente così, trovandosi davanti a vissuti di estraneità del corpo e nel corpo, rappresenta “l’artista di se stesso”, impegnato in un continuo atto creativo. L’adolescente che nega l’evento pubertario con la complicità delle figure di riferimento, è immerso in una situazione infantile ineluttabile, in contrasto con una realtà esterna che per questo viene vissuta persecutoriamente.
Nel pubertario c’è un margine di dilazionabilità che quindi può far uso dell’immaginario, del simbolico e della trasformazione sublimativa, questo margine dipende dalla quantità di concretezza che l’Io è riuscito a dare alla realtà interna e a quella esterna.
Anche se l’infantile spesso non viene ricordato dall’adolescente è però certamente una modalità che orienta il pubertario, anche se questo trasforma e rimaneggia l’infantile. L’infantile è il solco su cui il pubertario si organizza. Nel pubertario quindi l’infantile viene rivissuto in modo diverso anche in funzione della potenza delle spinte pulsionali di tale momento.
L’evento della nascita rappresenta l’avvio delle prime or¬ganizzazioni mentali. Quello della pubertà è al tempo stesso esito ed inizio di una profonda trasformazione. E’ l’approdo di un lungo lavoro riepilogativo ed integrativo della storia internalizzata di ogni individuo, ma è anche l’i¬nizio di un complesso processo di riorganizzazione del soggetto che va verso la soggettivazione..
La caratteristica dell’adolescenza è quella di una mente che apprende il suo potere di funzionamento e si riconosce nel tempo della sua storia presente e passata e contemporaneamente si proietta nel futuro. E’ il tipico funzionamento di una mente che lavora su due fronti utilizzando un vertice strategico per controllare ed amministrare due potenti forze dello psichismo: quella che tende a confondere e quella che tende a se¬parare.
L’adolescente, profondamente dilaniato fra un Sé ineluttabilmente legato all’origine ed un Sé che tende alla separazione come prospettiva per affermare ed individuare se stesso, lavora incessantemente per organizzare quei due fronti ugualmente pressanti.
Credo che l’adolescenza sia il punto di gravità intor¬no a cui ogni soggetto umano costruisce il suo universo.
Pertanto, e sono molti a dirlo, la vera e propria patologia dell’adolescente riguarda principalmente la capacità di fare ingresso nell’adolescenza e vivere la dimensione pubertaria. Si tratta della tragicità del limite, un limite a volte insuperabile: quello della differenza di genere, il limite della perdita, il limite della vita e della morte.
R. Chan: L’adolescente nella psicoanalisi Borla – Roma 2000
S.Freud: Precisazioni sui due principi dell’accadere psichico 1911
Gutton :Psicoterapia e adolescenza, Borla Roma 2002,
Philippe Gutton : Le pubertaire , PUF Paris 1991
Jay N. GIiedd, MD: Adolescent Brain Maturation (Child Psychiatry Branch, National Institute of Mental Health, USA) Published online November 2010.
Laufer M e E.Adolescenza e break down evolutivo Boringhieri – Torino 1986
A.Novelletto: L’adolescente Astrolabio – Roma 2009
Luglio 2014
Approfondimenti
Sotto la pelle. Recensione di Maria Naccari Carlizzi
Note:
(1)P. Gutton:Psicoterapia e Adolescenza.Borla 2002 Roma
Pulsione

Anish Kapoor, 2000
Lavoro postumo di Laura Contran. Un ringraziamento a Anna Migliozzi e Dario Contardi per il lavoro di ricerca materiali e revisione.
Pulsione
A cura di Laura Contran
Il concetto di Pulsione in Freud compare per la prima volta nello scritto Tre saggi sulla sessualità infantile (1905), per definire l’eccesso di stimoli intollerabili che devono trovare una via di “risoluzione” attraverso la motilità e l’azione. In Pulsioni e loro destini (1915), Freud chiarisce che la pulsione è un concetto limite tra lo psichico e il somatico. La pulsione è rappresentata nella mente da un’idea (essenzialmente, un desiderio), e da una quota di affetto, una registrazione di piacere o dispiacere che riflette le oscillazioni sottostanti nella tensione energetica.
La pulsione sarebbe dunque il rappresentante psichico degli stimoli che traggono origine all’interno e sono una misura delle operazioni che vengono richieste alla sfera psichica in forza della sua connessione con quella corporea. Il corpo, per Freud va ricordato, è sempre un corpo psichico-sessuale.
Successivamente, nel Compendio di psicanalisi (1938) Freud affermerà che la dottrina delle pulsioni è per così dire la nostra mitologia. Le pulsioni sono entità mitiche, grandiose nella loro indeterminatezza. Nel lavoro psicoanalitico, non possiamo prescinderne un solo istante e al contempo non siamo mai sicuri di coglierle chiaramente.
Freud tenterà lungo tutta la sua vita di definire esaustivamente la pulsione in chiave metapsicologica, lasciando però zone d’ombra e di ambiguità.
Oggi, la pulsione, vista come un’obsoleta adesione ad una dottrina ritenuta ormai superata, è stata messa in ombra assieme alla metapsicologia ma rimane un elemento imprescindibile insieme all’Edipo, alla prima topica Conscio Preconscio Inconscio, alla seconda l’Io, l’Es, e il Super-io.
Nella storia della psicoanalisi, infatti, abbiamo assistito ripetutamente alla tendenza a depulsionalizzare (a desessualizzare) il funzionamento psichico, attraverso teorie che hanno fatto a meno dell’apparato concettuale metapsicologico. Questa dinamica ha avuto un impatto tale da provocare un cambiamento drastico al paradigma concettuale psicoanalitico.
Ma procediamo con ordine partendo dalla distinzione tra Instinto e Pulsione.
Instinkt e Trieb
Freud (1915) usava Trieb che deriva dal verbo trieben (spingere) per sottolineare il carattere di “spinta” della pulsione laddove il termine Instinkt rimanda ad una condotta fissata e regolata dalle leggi della natura.
Una certa confusione terminologica è senz’altro dovuta alla traduzione del testo Freudiano dal tedesco all’inglese, curata da J. Strachey (1956-1974), dove è presente la traduzione instict piuttosto che drive. In questo modo la teoria delle pulsioni è diventata la teoria degli istinti: istinti di autoconservazione, sessuali, di vita, di morte. Ma l’istinto è connotato da regole rigide determinate biologicamente.
Il destino della pulsione è soggetto invece a trasformazioni che hanno a che fare con la vita psichica, con le nostre esperienze di soggetti, con la realtà che viviamo e con cui ci scontriamo o magari subiamo.
Pulsioni di autoconservazione e sessuali
Freud (1915) propone un dualismo pulsionale distinguendo tra pulsioni di autoconservazione (dell’Io) e pulsioni sessuali ma occorre specificare che se è la psicosessualità a connotare il pulsionale, esso non ha niente a che vedere con l’istinto di conservazione che riguarda un modello di comportamento trasmesso geneticamente, connesso con la sopravvivenza, l’adattamento dell’individuo e la conservazione della specie. Con istinto di conservazione intendiamo un insieme di risposte-reazioni a livello neurofisiologico che mettono in atto comportamenti finalizzati a salvaguardare la sopravvivenza (la fame, la sete, comportamenti di attacco-fugo di fronte al pericolo). Oggetto della psicoanalisi è, invece, l’esperienza del piacere più che il soddisfacimento del bisogno ed è questa differenza tra istintualità e pulsionalità.
Freud (1916-17) non smetterà mai di precisare che il concetto di sessualità introdotto dalla psicoanalisi non coincide con quello di genitalità. Infatti la sessualità non è considerato da Freud (1905) un fatto appartenente alla natura, per il semplice fatto che l’uomo è dotato di parola. Non c’è atto umano, anche quello più istintivo, che possa fare a meno di passare da quella struttura simbolica che è il linguaggio.
Come si incontrano le due pulsioni quella conservativa e quella sessuale?
La fame, come istinto autoconservativo, un volta soddisfatto il bisogno biologico, diventa ben presto fame di oggetto entra cioè nel pulsionale attraverso l’esperienza di soddisfacimento e di piacere.
L’oggetto viene dunque cercato non più sulla scia del bisogno (fisiologico) ma sulle ali di un desiderio (psicosessuale) che si appoggia ed è in continuità con la soddisfazione del bisogno per cui l’autoconservativo, pur essendo a partenza istintuale, è preso ben presto nel funzionamento pulsionale che a sua volta lo plasma (Mangini, 2015). In Pulsioni e loro destini (1915), Freud chiarisce che l’oggetto è un elemento più variabile della pulsione ed un mezzo attraverso cui la pulsione raggiunge solo in parte la sua meta. Questo non significa sminuire il significato dell’oggetto, ma renderlo forse meno “realistico”.
Nel Compendio di psicoanalisi (1938), aggiunge, a proposito dell’oggetto, che il primo oggetto erotico del bambino è il seno della madre che lo nutre e l’amore nasce in appoggio al bisogno soddisfatto di nutrimento. All’inizio il bambino non distingue tra il seno materno e il proprio corpo; ma l’oggetto-madre andrà via via a comprendere tutta la sua persona in quanto lo nutre e lo accudisce, suscitando in lui sensazioni corporee, ora piacevoli, ora spiacevoli. L’oggetto è un oggetto primario e, solo quando avverrà la separazione, si avrà il riconoscimento dell’altro in quanto separato da sé. Se la pulsione è una spinta essenziale per il funzionamento psichico, dunque, l’essere umano è alla ricerca dell’oggetto che colmi la propria mancanza, un modo di riparare a una ferita narcisistica originaria.
Sulle pulsioni parziali
Laplanche e Pontalis (2005) affermano che con pulsioni parziali vengono designati gli elementi ultimi a cui giunge la psicoanalisi nell’analisi della sessualità.
Ciascuno di questi elementi è specificato da una fonte (per esempi: pulsione orale, pulsione anale) e una meta (per esempio pulsione di guardare, pulsione di appropriazione). Le pulsioni parziali funzionano dapprima indipendentemente e tendono a unirsi nelle diverse organizzazioni libidiche. Il termine parziale non significa soltanto che le pulsioni parziali sono specie appartenenti alla classe generale della pulsione sessuale e quindi aver assunto un senso genetico e strutturale.
I due autori ( 2005) aggiungono che all’oggetto parziale corrisponde la pulsione parziale senza che necessariamente sia assunta come oggetto d’amore una persona nel suo insieme. Si tratta principalmente di parti del corpo reali o fantasmatiche e dei loro equivalenti simbolici, Anche una persona può identitificarsi o essere identificata con un oggetto parziale.
Il termine oggetto parziale è stato introdotto ma direi meglio, è stato sviluppato dagli psicoanalisti kleiniani in quanto era già presente in Freud (1915) quando studiava l’oggetto delle pulsioni parziali e metteva in evidenza le equivalenze e le relazioni che si stabiliscono tra i vari oggetti parziali.
Critiche alla teoria delle pulsioni e più in generale della metapsicologia freudiana.
Tra gli autori post-lacaniani A. Green, J. Laplanche, P. L. Assoun, vengono indicati da Conrotto (2014) come coloro che più di altri si sono interessati alla questione metapsicologica e, più in generale, allo statuto epistemologico della psicoanalisi. Il loro contributo ha portato ad un allargamento dei confini del “sistema inconscio” nonché a una rielaborazione di alcuni concetti metapsicologici di derivazione freudiana. Si tratta dunque di valutare a oggi la tenuta della metapsicologia freudiana rispetto ai cambiamenti paradigmatici del nostro tempo. Si tratta di stabilirne o meglio di riconfermarne il posto che le spetta nel complesso della teoria generale anche nei confronti di altre scienze che ne hanno sempre contestato la sua “sostenibilità” e che invece, da qualche tempo, ne riconoscono il valore come, ad esempio, le scienze neurobiologiche.
Bibliografia
Conrotto F (2014) Ripensare l’inconscio, Franco Angeli, Milano, 2014
Freud S (1905) Three Essays on the theory of Sexuality, Strachey J (1953) The Standard Edition of the Complete Psychological Works of S Freud, Volume VII (1901-1905) The Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis, London.
Freud S (1915) Instincts and Their Vicissitudes, Strachey J.(1957). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914-1916) The Hogarth Press and the Institute of Psycho-analysis, London.
Freud S (1916-17) Introductory Lectures on Psycho-Analysis, Strachey, J. (1963). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVI, The Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis, London.
Freud S (1938) An Outline Of Psycho-Analysis, Strachey J, The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXIII (1937-1939), The Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis, London.
Laplanche e Pontalis (2005) Enciclopedia della Psiconalisi, Laterza, Bari 2005
Mangini A(2015), Metamorfosi della pulsione, AA.VV a cura di Munari F e Mangini E, Franco Angeli, Milano 2015
Pulsione di morte

Anselm Kiefer, 1989
A cura di F. De Masi
Pulsione di morte
un concetto controverso
L’esistenza dell’istinto di vita e di morte, entrambi presenti nell’individuo, è stata discussa ampiamente nella letteratura psicoanalitica con opinioni divergenti.
Freud nel 1920 in Al di là del principio del piacere, partendo dalla tendenza umana a ripetere le esperienze spiacevoli, ipotizza l’esistenza della pulsione di morte che agisce insieme alla pulsione di vita ma è più potente di questa. La pulsione di morte, secondo la visione di Freud, non sarebbe psichicamente rappresentabile e si legherebbe alla pulsione di vita che la modera e la contiene. Il suo scopo distruttivo si manifesta quando le due pulsioni si slegano, come ad esempio nelle perversioni. Freud presenta la pulsione distruttiva in due modi apparentemente incompatibili: da una parte come un’evenienza distruttiva o auto-distruttiva per l’Io, dall’altra come un quieto ritorno al Nirvana. Non è facile capire se questi due punti di vista implichino fenomeni differenti o se indichino diversi aspetti dello stesso fenomeno.
Nella letteratura analitica esistono due principali posizioni rispetto alla pulsione di morte.
La prima, che la considera un istinto primitivo e autonomo, è stata inaugurata da Freud e sviluppata poi ampiamente da Melania Klein e dai suoi seguaci. Nella visione della Klein esiste un conflitto permanente tra le due pulsioni che dà origine nel mondo interno alla contrapposizione tra oggetto buono e oggetto cattivo.
Un secondo gruppo di analisti pensa invece che l’aggressività non derivi da una pulsione distruttiva primaria quanto da esperienze carenziali o traumatiche: questa è la posizione di Anna Freud, Fairbairn, Winnicott e Kohut.
Aggressività e distruttività
Mentre l’aggressività può essere considerata come un’emozione, e in certe situazioni come una difesa utile alla sopravvivenza, la distruttività si volge contro le radici stesse della vita. La differenza tra l’aggressività reattiva e distruttiva non risiede tanto nell’intensità dell’odio, che può essere estremo in entrambe le situazioni, quanto nel carattere e nella qualità dell’oggetto attaccato. L’odio è difensivo quando è diretto verso un oggetto cattivo, è distruttivo se si volge verso un oggetto buono.
Il piacere perverso non è caratterizzato dall’aggressività o dall’intensità dell’odio ma dall’assenza di amore ossia dall’indifferenza. La distruttività compiaciuta che si accompagna all’indifferenza e alla mancanza di passione costituisce il nucleo della perversione. Quando la distruttività si coniuga con il piacere esiste il pericolo di una progressione senza limiti.
Il trauma
La nozione di un trauma primitivo e prolungato può aiutarci a capire come un bambino, prematuramente esposto a sfavorevoli condizioni, può sviluppare una particolare tendenza a distruggere l’istinto di vita. Riflettendo sulle storie di molti pazienti in terapia siamo diventati sempre più consapevoli dell’importanza per la crescita mentale delle risposte empatiche degli adulti che si prendono cura del bambino. Quando queste mancano si creano condizioni che interferiscono con il potenziale sviluppo del bambino e possono produrre importanti conseguenze psicopatologiche. Anche se non ha subito chiare violenze, il bambino può aver sofferto di un trauma che può essere chiamato emotivo e che deriva dalle risposte mancate o distorte di chi si prende cura di lui.
E’ possibile pensare che la sofferenza prolungata di un piccolo bambino che non riceve un risposta empatica dalla madre possa generare un nucleo di auto-distruttività.
In questi casi l’attacco al sé vitale e libidico può essere una difesa paradossale tesa a mettere fine a una sofferenza intollerabile. La rabbia e l’odio diretti all’inizio contro la madre vengono spostati contro il sé libidico ritenuto responsabile della sofferenza. E’ possibile che questa dinamica che si sviluppa nelle prime fasi della vita sia destinata ad esplodere più avanti quando si creano situazioni traumatiche analoghe. La rabbia inconsapevole può annullare la pulsione di vita e spingere alcuni individui a idealizzare la morte in uno stato d’animo euforico.
Da questo punto di vista la fascinazione verso la morte rappresenta una risposta inconscia, paradossale e drammatica, al trauma e ad una sofferenza precoce e indicibile. Si formano in questi casi aree mentali cariche di impulsi auto-distruttivi che rimangono silenti nella personalità, ma pronte ad esplodere nei momenti di crisi. Non sempre l’attrazione verso la morte si manifesta in termini drammatici; in pazienti meno gravi, che incontriamo più frequentemente in terapia, l’attrazione verso la morte può essere rappresentata nei sogni con immagini di bei paesaggi nei quali un cimitero sembra particolarmente suggestivo per i suoi brillanti colori.
Il pericolo di realizzare la propria morte psichica e fisica rappresenta un’evenienza possibile nelle condizioni di seria psicopatologia. Questo pericolo è immanente nello stato melanconico quando l’odio per la vita e per lo stesso individuo è intenso al punto tale che Freud ha parlato del Super-io melanconico come pura cultura della pulsione di morte. La distruttività sostiene le patologie gravi come le perversioni, l’anoressia, alcune sindromi borderline e le dipendenze tossicofiliche.
Conclusioni
Il mio punto di vista è che il concetto di pulsione di morte, come pulsione originaria, non trova una conferma convincente nell’esperienza clinica. E’ invece possibile considerare la spinta verso la morte come una potenzialità trasformativa della mente umana quando la vita diventa soggettivamente e oggettivamente intollerabile.
La mia idea è che la distruttività umana non deriva da un patrimonio innato (la pulsione distruttiva) ma necessita per la sua azione di uno sviluppo lungo e complesso, spesso favorito da una complementare violenza da parte dell’ambiente. Da questo punto di vista sembra importante supporre l’esistenza di un’organizzazione patologica che si forma gradualmente e cerca di conquistare la parte sana della personalità come avviene nelle perversioni.
Il potere acquisito dall’organizzazione patologica distruttiva dipende anche dal ruolo del Super-io che coincide con una struttura perversa che ha un carattere seduttivo o intimidatorio.
Dal mio punto di vista il problema del piacere auto-distruttivo è molto complesso. Il piacere non è solamente ricercato come difesa dalle difficoltà della realtà esterna o come scarico della pulsione libidica. In certi casi l’attacco diretto contro la vita produce una soddisfazione intensa pari a quella che si ottiene mediante l’affermazione di sé e la scarica delle pulsioni.
La distruttività, distinta dall’aggressività, è legata al piacere che si ricava dal male. Io penso che, per ottenere questo scopo e per trasformare l’aggressività in distruttività, sia necessario un lungo processo in cui le disposizioni originarie si incontrano con stimoli ambientali negativi in modo da formare quel tipo di costellazione perversa che presenta, a chi lo agisce, l’atto distruttivo come capace di conferire potere, superiorità e onnipotenza.
Bibliografia
Freud S. (1920) Al di la del principio di piacere, OSF IX, Boringhieri.
Reverie

GEORGIA O’KEEFFE
A cura di Michele Bezoari
La parola “rêverie” , importata dal francese, è usata in italiano – soprattutto nel linguaggio della critica letteraria e musicale – con il significato di fantasticheria: sia come condizione di chi si abbandona al fantasticare sia come prodotto che è espressione di questo stato (Vocabolario Treccani online).
Nella psicoanalisi francese “rêverie” traduce (in alternativa a “rêve diurne”) i termini tedeschi “Tagtraum” e “Träumerei”, con cui Freud denomina il sogno a occhi aperti (o sogno diurno) e la fantasticheria. In inglese le parole corrispondenti sono “daydream”e “reverie” (senza accento circonflesso).
Ma è a partire da Bion (1962a, 1962b) che il concetto di reverie assume un nuovo e specifico significato psicoanalitico.
(Per rimarcare questa svolta, nelle seguenti note si userà la forma inglese della parola. Bisogna dire, tuttavia, che spesso anche nelle traduzioni italiane dei testi di Bion si trova la forma francese, in quanto già integrata nella nostra lingua).
Bion indica con questo termine la capacità della madre di ricevere le impressioni emotive e sensoriali del neonato, convogliate in lei per mezzo dell’identificazione proiettiva, e di elaborarle in una forma che la psiche del neonato possa quindi reintroiettare e assimilare.
La teoria bioniana del pensiero ipotizza che l’esperienza non può diventare pensabile, né in modo conscio né in modo inconscio, se non è trasformata in rappresentazioni elementari (gli elementi alfa) per opera di una funzione psichica chiamata dapprima lavoro del sogno alfa e successivamente, com’è più noto, funzione alfa.
Con la reverie la madre mette la propria funzione alfa al servizio di quella, ancora immatura, del bambino. Le inevitabili frustrazioni nel rapporto col seno scatenano nel neonato sensazioni angosciose di morte incombente, che soltanto dopo essere state contenute e metabolizzate nella mente della madre possono venire assimilate come una tollerabile paura di morire.
Insieme alle proprie esperienze emotive rese pensabili, il bambino introietta così un oggetto accogliente e comprensivo col quale identificarsi, sviluppando via via la sua capacità di pensare.
Non trovando un’ adeguata accoglienza che dia senso alle sue proiezioni, per gravi carenze della reverie materna, il bambino rischia invece di reintroiettare un terrore senza nome, non integrabile nella sua personalità in via di sviluppo.
Il modello astratto e unipersonale della funzione alfa acquista, declinandosi nella reverie, uno spessore affettivo e relazionale.
Per Bion, infatti, la reverie consiste in uno stato mentale aperto alla ricezione di tutto ciò che proviene, mediante l’identificazione proiettiva, da un oggetto amato.
Con la reverie la madre provvede al bisogno di amore e di comprensione del bambino, così come con il latte provvede al suo nutrimento. Se non fosse associata all’amore per il bambino o per suo padre, sottolinea Bion, la reverie materna non sarebbe davvero tale e non potrebbe espletare il suo effetto per la crescita psichica.
Il riferimento al legame con il padre come terzo sta anche a significare che l’intimità del contatto emotivo nella reverie non equivale a una esperienza fusionale che isola la madre dai suoi oggetti interni e dal mondo esterno.
Ciò che importa è la qualità di questi legami e la loro maggiore o minore adeguatezza a garantire nella mente della madre uno spazio insaturo, aperto ad accogliere la specificità del neonato e ad offrirgli un riconoscimento simbolico originale, non troppo vincolato alla mentalità del gruppo di appartenenza (Gaburri e Ambrosiano, 2003).
Il concetto di reverie così inteso viene poi impiegato, già dallo stesso Bion, anche per definire l’assetto mentale dell’analista in seduta.
Disponendosi all’ascolto con la mente il più possibile sgombra da memoria e desiderio (così come Bion riformula il principio freudiano dell’attenzione fluttuante) l’analista si rende ricettivo verso le emozioni trasmesse dall’analizzando mediante l’identificazione proiettiva, in attesa che il lavoro della propria funzione alfa produca in lui rappresentazioni spontanee da cui potranno scaturire forme adeguate di comprensione e interpretazione.
Viene così valorizzata quale preziosa risorsa per la cura analitica l’attività di pensiero onirico della veglia, che è in continuo svolgimento come metabolismo basale dell’esperienza emotiva e che l’analista si dispone a utilizzare nel setting a beneficio del paziente.
Nella mente dell’analista in stato di reverie affioreranno, ad esempio, immagini visive ma anche rappresentazioni acustiche o di altri registri sensoriali, più o meno organizzate: da semplici flash istantanei a sequenze narrative di varia durata (Ferro, 2010).
L’ adeguatezza di tali contenuti psichici emergenti a trasformare in pensieri le emozioni vissute dall’analizzando non è, comunque, garantita in partenza e va verificata attraverso un’elaborazione che impegna varie componenti dello spettro mentale dell’analista, dalla polarità ricettiva-sognante a quella investigativa-razionale (Riolo, 1983).
Non tutti i fenomeni descrivibili come reveries sono prodotti della funzione di reverie intesa nel senso bioniano del termine.
A differenza di quanto accade per i sogni notturni, scanditi dal confine sonno/veglia, non esiste alcun criterio immediato per distinguere le manifestazioni della reverie da altri contenuti mentali dell’analista, non necessariamente derivati dal contatto emotivo con l’analizzando. Il valore di tali rappresentazioni si chiarirà soltanto attraverso gli ulteriori scambi comunicativi nella coppia analitica (Ogden, 1997).
L’effettivo funzionamento clinico della reverie si basa dunque su una cooperazione intersoggettiva, conscia e inconscia, tra analista e analizzando.
BIBLIOGRAFIA
Bion W.R. (1962a). Una teoria del pensiero. In: Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico. Roma, Armando, 1970.
Bion W.R, (1962b). Apprendere dall’esperienza. Roma, Armando, 1972.
Ferro A. (2010). Tormenti di anime. Milano, Cortina.
Gaburri E., Ambrosiano L. (2003). Ululare con i lupi. Conformismo e rêverie. Torino, Bollati Boringhieri.
Ogden T. (1997). Rêverie e interpretazione. Roma, Astrolabio, 1999.
Riolo F. (1983). Sogno e teoria della conoscenza in psicoanalisi. Riv.Psicoanal., 29, 279-295.
Vocabolario Treccani online, http://www.treccani.it/vocabolario/
Rimozione

Richard Weller, 2016
RIMOZIONE
A cura di R. MUSELLA
Per rimozione intendiamo un processo dello psichismo umano, attivo nelle nevrosi così come nel funzionamento normale, che agisce nella direzione inversa alla presa di coscienza. Tra i meccanismi di difesa è il primo ad essere stato riconosciuto e sistematizzato da Freud (Freud S., 1915; Freud A., 1936). Come ogni altro meccanismo di difesa è fisiologico entro certi limiti. L’eventuale effetto patologico è dato quindi da una differenza quantitativa.
Per via della rimozione, l’apparato psichico si protegge da un contenuto che non tollera e, ponendolo nella condizione inconscia, si sforza di mantenerlo tale. Se si rimuove ci dovrà quindi essere un contenitore, evidentemente inconscio, in grado di accogliere la rimozione stessa. Da un punto di vista metapsicologico, tutto ciò ha un rilievo dinamico, topico e economico.
Freud (1915) pose a fondamento della rimozione secondaria, o rimozione propriamente detta, la cosiddetta rimozione originaria, pietra angolare della formazione dell’inconscio e presupposto imprescindibile della rimozione secondaria. Il rimosso propriamente detto perviene, infatti, allo stato inconscio sotto l’egida di due forze che determinano l’effetto di rimozione. La prima forza è il controinvestimento operato dalla coscienza rispetto ad un dato contenuto di cui non si vuole sapere niente; la seconda forza è data dall’attrazione “gravitazionale” che la rimozione originaria esercita sul contenuto da rimuovere. In questo modo, per effetto di queste due forze congiunte, il contenuto rimosso resta saldamente ancorato allo stato inconscio. Il rimosso propriamente detto verrà conservato in uno stato di rimozione (inconscio) e a sua volta costituirà il nucleo di attrazione per successive rappresentazioni da rimuovere. Per essere chiari, se per qualche motivo che non stiamo qui a spiegare, una rappresentazione, mettiamo una scena a contenuto sessuale, viene rimossa in un dato tempo, ne deriverà una tendenza successiva a rimuovere successive scene a contenuto sessuale che subiranno da una parte il controinvestimento dell’Io e dall’altra l’attrazione da parte dei contenuti già rimossi. Se è vero che il rimosso propriamente detto, o rimosso secondario, esercita un’attrazione per affinità nei confronti di successivi contenuti da rimuovere la domanda che si pone è: quale forza di attrazione viene esercitata dalla rimozione originaria sulle prime rappresentazioni da rimuovere? Alcuni autori (Conrotto, 2014; Musella, 2016), pur prendendo le distanze dall’ipotesi freudiana (Freud, 1934-38) della trasmissione ereditaria dei caratteri acquisiti, ipotizzano che il rimosso originario contenga già delle potenzialità protorappresentazionali che coinciderebbero con i cosiddetti fantasmi originari (Laplanche e Pontalis, 1964) che, a loro volta, agirebbero come primi poli di attrazione per le rimozioni secondarie. Tali categorie protorappresentazionali elementari, la castrazione, la seduzione, la scena primaria, sarebbero universali e determinerebbero, tra genetica ed epigenetica, la complessità dell’organizzazione simbolica dello psichismo umano esitando infine, tra i tre e i cinque anni di età, nella formazione del complesso edipico, a sua volta pietra angolare della struttura simbolica dello psichismo rimosso.
Dalla teoria della rimozione derivano sia la teoria delle produzioni sintomatiche dei complessi nevrotici che la cosiddetta psicopatologia della vita quotidiana, sogno compreso. L’imperfezione della dinamica della rimozione produce infatti, con portati qualitativi e quantitativi diversi, Il ritorno del rimosso, lo spostamento, la condensazione, la conversione sul corpo, la crisi d’angoscia. Tutte manifestazioni dinamiche alla base delle produzioni sintomatiche, degli atti mancati, dei lapsus, dei sogni ecc.
Fin quando la rimozione, che è entro certi limiti assolutamente normale, non produrrà dispiacere, il suo effetto non sarà avvertito dall’apparato psichico come patogeno. Invece, un eccesso quantitativo (economico) di rimozione genera dispiacere perché il materiale rimosso premerà sull’apparato psichico che, a sua volta, spenderà molta energia per mantenere lo stato di rimozione. L’energia psichica utilizzata per mantenere lo stato di rimozione non sarà fruibile all’Io, il quale risulterà impoverito nel suo potenziale funzionamento, con un effetto sintomatico che andrà dalla produzione attiva di sintomi, al ritiro psicoaffettivo con esito depressivo.
Per semplicità useremo il complesso edipico per facilitare il compito espositivo. Se un bambino deve rimuovere la rappresentazione incestuosa della madre, o del padre, come oggetto del desiderio sessuale perché minacciato dal fantasma di castrazione, il destino della rappresentazione di desiderio e l’affetto corrispondente potranno prendere diverse strade.
Il desiderio/affetto per la madre può, ad esempio, in condizioni “normali” prendere la via di un sogno. Il sogno, nel rispetto della rimozione della rappresentazione interdetta (nel nostro esempio l’oggetto incestuoso del desiderio), usa soluzioni di compromesso per deviare attraverso lo spostamento e la condensazione, la rappresentazione rimossa su rappresentanti sostitutivi che l’apparto psichico può tollerare. In altre circostanze quotidiane la libido, slegata dalla rappresentazione rimossa, si può legare a sostituti che in un modo, più o meno chiaro, la rappresentano, ad esempio la maestra, la nonna, la zia, ecc. Il transfert in psicoanalisi si spiega proprio come effetto dello spostamento del rappresentante rimosso sulla figura dell’analista che si presta a tale scopo. In questo caso l’investimento libidico o aggressivo prende di mira lo psicoanalista che, consapevole delle dinamiche sottostanti, saprà maneggiare il ritorno del rimosso mettendolo al servizio della cura.
In altri casi l’affetto libero può investire l’Io del soggetto. Si tratta di quella forma di narcisismo secondario benigno che è alla base della tenuta strutturale dell’Io. In casi fortunati l’ammontare di affetto libero può prendere la via della sublimazione. Il capitale affettivo può investire attività psichiche che caratterizzano le più alte produzioni artistiche, culturali e scientifiche che l’uomo conosce. Anche l’investimento del linguaggio, delle parole, può rappresentante una via di scarica normale dell’eccitazione. Il transfert sulla parola (Green, 1984, 2002) viene perseguito in analisi come uno degli obiettivi del trattamento.
In circostanze meno fortunate la rimozione della rappresentazione di desiderio pone, economicamente, l’affetto corrispondente in una condizione penosa (data proprio dall’ammontare libero di pulsione slegata) che costringe lo psichismo a violente scariche che si risolvono sintomaticamente nella produzione di angoscia. È questo il caso della nevrosi d’angoscia, quella che attualmente si usa definire nevrosi con attacchi di panico. La depressione nevrotica può essere a sua volta dovuta alla repressione dell’ammontare pulsionale avvertito come una minaccia dalla psiche. Nelle altre nevrosi, la pulsione libera, slegata dalla rappresentazione di desiderio rimossa, per non essere esperita come angoscia, deve essere vincolata ad una serie di coercizioni che ne impediscono il libero fluire. Il divieto al godimento sessuale, interiorizzato, costringerà il nevrotico ad evitare e controinvestire l’affetto libero, ponendo una serie di interdetti e impedimenti che rendono la vita dell’ammalato molto triste e limitata. Una paziente affetta da una nevrosi ossessiva grave controllava l’impulso sessuale costringendo la sua vita quotidiana ad una serie interminabile di impedimenti delle rappresentazioni sostitutive del desiderio (tipo un professore del liceo di cui sembrava essersi invaghita). Per essere certa che il controllo fosse totale, la notte chiudeva la porta a chiave e spalmava la maniglia di rossetto per evitare che presa dal desiderio, in uno stato sonnambolico potesse, nel cuore della notte, uscire dalla stanza in cerca di amore. La prova sarebbe stata data dalle macchie di rossetto che avrebbe ritrovato il mattino seguente sula porta, sulle mani, sulle lenzuola, sulle pareti della camera da letto.
Altri pazienti, fobici, assumono rappresentati macroscopici, per lo più di facile reperimento, a sostituti del desiderio rimosso e così facendo, collegando inconsciamente a tali rappresentanti la produzione di angoscia, si impediscono lo svolgersi di una vita “normale”. Se i rappresentanti sostitutivi del desiderio interdetto sono oggetti di vita quotidiana, tipo uccelli, gallerie, aria aperta, diventa molto difficile vivere una vita decente. I pazienti agorafobici, ad esempio, vivono una vita fatta di limitazioni intollerabili.
Altri pazienti, ancora, convertono sul corpo il desiderio e il conflitto che lo accompagna, intrattenendo con alcune zone del corpo un rapporto sintomatico che ne limita il normale funzionamento fisiologico. Una paziente non poteva usare le braccia, che risultavano “paralizzate” perché la fantasia che rimuoveva era quella di masturbarsi. Un altro aveva impotenza sessuale e cefalea persistente come effetto della rimozione del desiderio sessuale rimosso nei conforti del padre. La mancata scarica del desiderio sulla rappresentazione corrispondente o su un eventuale rappresentazione sostituiva determinava una pressione alla testa che, in analisi, si risolse finalmente nella capacità di investire l’analista nella relazione di transfert.
La rimozione caratterizza anche la normale evoluzione ontogenetica dell’essere umano. La cosiddetta sessualità in due tempi del bambino prevede che, nella fase di latenza, le rappresentazioni di desiderio della sessualità infantile vengano rimosse. Con il presentarsi della pubertà, in adolescenza, l’affetto libero dai rappresentanti rimosi potrà nuovamente e diversaemente investire oggetti sostituivi del desiderio originario rimosso.
L’ultimo punto riguarda il vantaggio procurato dal percorso inverso, quello che dalla rimozione porta alla presa di coscienza, alla riappropriazione da parte dell’Io della rappresentazione rimossa. Tale processo alla base delle prime formulazioni della tecnica psicoanalitica, consente di legare l’affetto alla rappresentazione corrispondente e in questo modo di abreagire (Freud e Breuer, 1895) il complesso patogeno che nel frattempo aveva prodotto, per effetto della rimozione, un sintomo. Il processo di abreazione non è superato dalle successive teorizzazioni psicoanalitiche ma resta intimamente collegato a concetti quali transfert, ripetizione, elaborazione. Nella stanza di analisi si continua a lavorare, per varie vie, sul rimosso e sul processo di sollevamento e superamento della rimozione, quel lavorio che Anna O. (ibid.) aveva definito chimney sweeping (pulizia del camino). Il presupposto, alla base di questa esigenza della tecnica psicoanalitica è quello sopra descritto, rendere consci contenuti che gravano sull’inconscio e liberare parte dell’energia psichica impegnata a mantenere lo stato di rimozione.
Bibliografia
Breuer J., Freud S. (1895). Studi sull’isteria. OSF. 1
Freud A. (1936). L’Io e i meccanismi di difesa. Firenze, Martinelli, 1967.
Freud S. (1915). La rimozione. OSF. 8
Freud S. (1934-38). L’uomo Mosè e la religione monoteistica. OSF. 11
Green A. (1984). Il linguaggio in psicoanalisi. Roma, Borla, 1991.
Green A. (2002). Idee per una psicoanalisi contemporanea. Milano, Cortina, 2004.
Laplanche J., Pontalis J.B. (1964). Fantasma originario. Fantasmi delle origini. Origini del fantasma. Bologna, Il Mulino, 1988.
Laplanche J., Pontalis J.B. (1967). Enciclopedia della psicoanalisi. Bari, Laterza, 1968.
Conrotto F. (2014). Ripensare l’inconscio. Milano, FrancoAngeli.
Musella R. (2016). Tre piani di interpretazione del sogno in Freud. Rivista di Psicoanalisi, LXII, 1
Riparazione

kintsugi
A cura di Daniela Battaglia
Definizione e sviluppo del concetto
Il termine riparazione, introdotto da Melania Klein nel 1929, indica i tentativi che l’individuo fa di rimediare a un danno arrecato, in fantasia o in realtà, a un oggetto d’amore.
Il concetto di riparazione è, nella teorizzazione kleiniana, un processo che riguarda il mondo interno del soggetto ed è in genere rivolta ad oggetti del mondo esterno, che rappresentano (simboleggiano) l’oggetto danneggiato. Si realizza tramite una azione, reale o in fantasia, che tende a produrre un cambiamento sia nel soggetto che nell’oggetto. Si tratta quindi di una modalità di funzionamento psichico di tipo evolutivo, che permane tutta la vita, che comporta un lavoro di ricostruzione del mondo interno e del mondo esterno e si accompagna ad un processo di elaborazione della propria ambivalenza e dei propri conflitti. E’ indissolubilmente legato a quello di posizione depressiva, nella cui concettualizzazione occupa un ruolo centrale.
Nella teoria kleiniana vengono distinti due tipi di angoscia: quella persecutoria propria della posizione schizo-paranoide, connessa al pericolo di annientamento dell’Io, che ha quindi a che fare con la sopravvivenza, e quella depressiva legata all’ambivalenza ed al timore di aver distrutto il proprio oggetto d’amore.
Va sottolineato che le due posizioni, schizoparanoide e depressiva, indicano configurazioni del rapporto con l’oggetto, delle angosce e delle difese che persistono per tutta la vita, mantenendosi in una continua oscillazione tra loro. Il termine «posizione», utilizzato dalla Klein, indica per l’appunto che la conquista dei sentimenti e della consapevolezza depressiva non è stabile ma soggetta a frequenti ritorni alla posizione schizoparanoide, sotto la spinta di angosce non altrimenti tollerabili. Sono proprio le fantasie e le attività riparative che risolvono le angosce della posizione depressiva ( Segal 1964), in quanto la riparazione fantasmatica dell’oggetto materno esterno e interno consente all’Io del bambino un’ identificazione stabile con l’oggetto buono riparato.
L’acquisizione di una reale capacità riparativa può comportare una fase di passaggio, fisiologica e ricorrente se transitoria o al contrario patologica se fissata, in cui prevalgono attività falsamente riparative di tipo difensivo, ossessivo o maniacale .
Questo avviene quando una non ancora consolidata integrazione dell’Io e/o una accresciuta invidia per l’oggetto determinano intolleranza del dolore depressivo che non può essere affrontato.
Secondo la Klein, il processo d’integrazione dell’Io, che si sviluppa intorno al 6° mese di vita, comporta una diminuzione dei processi di scissione (che avevano determinato la formazione di oggetti parziali), il riconoscimento e la possibilità di identificazione con un oggetto intero (la madre, per esempio) e quindi l’unificazione delle fantasie e dei sentimenti ad esso relativi, con la conseguenza che il bambino entra in contatto con la propria ambivalenza e può provare l’angoscia depressiva, che viene quindi sperimentata sia nei confronti dell’oggetto che nei confronti dell’Io stesso, che si sente minacciato nell’identificazione con l’oggetto.
Stili di riparazione
La riparazione di tipo ossessivo consiste nella ripetizione coatta di azioni che mirano, tramite l’annullamento, a placare l’angoscia in modo magico, senza nessun reale elemento di creatività. In un normale processo evolutivo ai rituali ossessivi, che si sviluppano fondamentalmente contro le manifestazioni aggressive, subentra una reale spinta riparativa che mobilita elementi creativi.
La riparazione maniacale ha lo scopo illusorio di ripristinare un oggetto integro , “come era prima”, che non porti quindi in sé i segni dell’attacco e della riparazione. In questo modo si cerca di evitare di sperimentare la colpa e la perdita, la dipendenza, l’ambivalenza; tutti elementi che caratterizzano l’angoscia depressiva.
Il rapporto maniacale con gli oggetti è caratterizzato da dominio, trionfo , disprezzo, sentimenti in cui sono operanti difese come la negazione, l’idealizzazione, l’identificazione proiettiva, la scissione.
Il dominio è un modo illusorio di negare la dipendenza e contemporaneamente assicurarsela, tramite un controllo onnipotente dell’oggetto; quindi ha anche a che fare con la manipolazione.
Il trionfo è un diniego dei sentimenti depressivi ed è anch’esso in relazione all’onnipotenza. Se l’attacco all’oggetto primario era connotato da una forte invidia, il senso di trionfo onnipotente sperimentato nello sconfiggere l’oggetto allontana, momentaneamente, la nostalgia per la sua mancanza, mentre ne viene negata l’importanza.
Anche il disprezzo nega il valore dell’oggetto che così, impoverito e svalutato, non è degno di suscitare sentimenti di colpa.
Le difese di tipo maniacale non hanno necessariamente una connotazione patologica; possono infatti rappresentare una tappa di quel percorso accidentato che è la crescita, proprio in virtù di una continua oscillazione tra la posizione SP e la posizione D che caratterizza l’ acquisizione di un costruttivo rapporto con la realtà, come ha ben evidenziato Bion. Diventano un elemento patologico solo se, essendo troppo forti, mettono in moto circoli viziosi che vanno a costituire un ostacolo al percorso evolutivo.
Il superamento delle difese maniacali comporta un lungo lavoro di riconoscimento della realtà psichica con conseguente rinuncia all’onnipotenza e alla magia e diminuzione delle scissioni. Man mano che il bambino sperimenta che il suo amore è più forte del suo odio acquisisce maggiore fiducia nelle proprie capacità riparative. Le ripetute esperienze di lutto e riparazione, di perdita e di recupero arricchiscono l’Io del bambino degli oggetti che ha ricreato dentro di sé e che diventano parte di sé, contribuendo alla sua crescita. Quello che viene assimilato è quindi un oggetto nuovo trasformato dall’Io.
Il riconoscimento della realtà interna ed esterna è parte fondamentale del processo di riparazione, che comporta anche il poter riconoscere gli oggetti come separati e liberi di amarsi tra di loro, con una propria vita, in parte indipendente dal soggetto, ma non per questo contro di esso. Anche questo non è un evento che si presenta una volta per tutte, ma un processo continuamente oscillante.
Evoluzione/ Sviluppi successivi del concetto
Winnicott ha studiato e arricchito la comprensione del processo riparativo sottolineando l’importanza dell’ambiente in cui vive il bambino nel favorire o al contrario ostacolare il processo. Egli, infatti, ha intuito che il riconoscimento e l’accettazione della presenza di idee distruttive e aggressive dentro di sé sarebbe intollerabile, e quindi inaffrontabile, senza la possibilità di sperimentare contemporaneamente un’esperienza riparativa, per la quale è quindi necessaria la presenza costante dell’oggetto d’amore, che la possa condividere, riconoscere e accettare. Perché possa svilupparsi la capacità riparativa è fondamentale la relazione con la madre come persona reale; è questa la principale differenza tra la posizione Winnicottiana e quella Kleiniana.
Il differente ruolo attribuito all’ambiente, l’importanza della madre come persona reale e la diversa teorizzazione della depressione di Winnicott rispetto alla Klein portano quest’autore a sottolineare aspetti del processo riparativo in modo diverso .
Piuttosto che intendere la depressione come centrata intorno alla fantasia inconscia che la propria rabbia abbia danneggiato l’oggetto amato ( Klein), Winnicott la intende come l’assunzione (inconscia) da parte del bambino della depressione della madre, o di quella degli altri oggetti amati, con lo scopo inconscio di curarla.
In accordo con questa visione egli evidenzia come spesso ci troviamo di fronte a bambini (e pazienti) che operano una falsa riparazione (da non confondere con la riparazione maniacale) in relazione alla depressione della madre (o del terapeuta) . Con il termine falsa riparazione si intendono quelle situazioni in cui il processo riparativo si determina in risposta alla colpa e alla depressione della madre. Quando non si verificano le situazioni che permettono al bambino di acquisire la necessaria sicurezza psichica per differenziarsi dal suo oggetto primario, egli rimane immerso in un mondo governato dai processi affettivi dell’altro, identificandosi con le difese della madre contro la propria depressione e la propria colpa inconscia. In questi casi il comportamento del bambino assume le caratteristiche di una falsa riparazione, non collegata al sentimento di colpa personale e pertanto non funzionale alla sua crescita mentale. E’ come se il bambino offrisse se stesso a riparazione dell’oggetto, rinunciando all’espressione e al riconoscimento dei suoi bisogni per assumere comportamenti compiacenti, che lo proteggano dalla ritorsione o dall’abbandono materni, sentiti come intollerabili. ( Winnicott 1958). E’ solo all’interno di un contesto che permetta al bambino di vedere riconosciuti e di riconoscere i propri sentimenti di amore e di aggressività che può realizzarsi un’autentica preoccupazione (“stadio della preoccupazione”) per l’oggetto amato e danneggiato.
La relazione con una ‘madre oggetto’, in grado di rimanere “vera e viva”, capace di soddisfare i bisogni del bambino e resistere ai suoi attacchi istintuali e l’esistenza di una ‘madre ambiente’, in grado di accoglierlo con un amore incondizionato, permettono al bambino di sopportare l’angoscia derivante dall’aver arrecato un danno alla persona amata e di trasformarla in capacità di preoccuparsi. Questa può svilupparsi man mano che nella mente del bambino la ‘madre oggetto’ e la ‘madre ambiente’ vanno riunendosi; in altri termini è necessaria la presenza di una figura attendibile (la madre, il terapeuta), in grado di essere attaccata senza essere distrutta, capace di sopravvivere e contemporaneamente in grado di ricevere un gesto riparativo e di rispecchiarlo. In questo modo la colpa diventa tollerabile e si possono sperimentare la preoccupazione e la responsabilità ad essa collegate. In questo senso la capacità di preoccuparsi può legarsi a, e accrescere, le capacità autoriflessive. Il bambino inizia a preoccuparsi anche delle conseguenze delle sue esperienze e del proprio Sé, in modo tollerabile, perché trasformabile.
Il fallimento dell’atto riparativo porta a una perdita della capacità di preoccuparsi e alla sostituzione di questa con forme primitive di senso di colpa e di angoscia. Al contrario la possibilità di oscillazione tra la posizione schizoparanoide e la posizione depressiva ( progressione e regressione) e il conseguente formarsi di oggetti interni buoni fa sì che questi funzionino come elaboratori di ulteriori capacità riparative (Bion, 1992), permettendo il contenimento della persecutorietà e avviando un processo trasformativo e potenzialmente creativo.
Bibliografia
Bion W. R. (1992) Cogitations Armando 1996
Hinshelwood R.D. (1989 )Dizionario di psicoanalisi kleiniana Raffaello Cortina Editore 1990
Klein M. (1921-1958) Scritti 1921-1958, Boringhieri 1978
Klein M. e Riviere J ( 1953) Amore odio e riparazione , Astrolabio 1969
Laplance J. E Pontalis J-B ( 1967) Enciclopedia della Psicoanalisi, Editori Laterza 1984
Segal H. (1964) Introduzione all’opera di Malanie Klein, Martinelli 1975
Winnicott D.W. (1948) Dalla pediatria alla psicoanalisi, Martinelli 1975
Winnicott D.W. (1965) Sviluppo affettivo e ambiente Armando Armando Editore 1970
Ritiro (Il)

NALINI MALANI 2008
Il ritiro psichico
Una lettura dall’analisi infantile
Maria Giuseppina Pappa
Il concetto di Ritiro psichico presenta una natura alquanto complessa, essendo tra i meccanismi, che si strutturano molto precocemente, nel primo anno di vita, che possono variamente esprimersi, in un’ampia gamma di manifestazioni, dal fisiologico e transitorio ritiro difensivo in fantasticherie, a vere e proprie organizzazioni psicopatologiche. In seguito a un eccesso di stimoli o a forti tensioni, un bambino può semplicemente addormentarsi, in una sorta di risposta auto protettiva. Tuttavia esperienze di intrusione, violazione emotiva, o deprivazione affettiva, o deficit di comprensione da parte delle figure di accudimento, possono rinforzare la tendenza al ritiro, che diventa una modalità di funzionamento più strutturata nel corso della crescita, tale da portare a uno stato di distacco mentale che sottrae il soggetto al contatto con gli altri e con la realtà circostante (https://www.spiweb.it/la-ricerca/ricerca/spipedia/#:~:text=Riparazione-,Ritiro%20Psichico,-La%20Spi ).
Le concezioni teoriche riferibili al ritiro sono varie, e partono da vertici differenti.
Freud (1907) afferma che gioco, fantasticheria, fantasia e sogno sono gratificazioni sostitutive che si fanno avanti quando le esigenze della realtà impediscono il soddisfacimento del desiderio e aggiunge che sono una forma di appagamento allucinatorio di desiderio (Freud, 1911).
Melanie Klein (1932) aggiungerà che l’appagamento allucinatorio accompagna incessantemente l’attività del bambino. I contributi degli analisti postkleiniani approfondiscono lo studio delle difese e degli stati mentali che rientrano nell’ambito delle organizzazioni psicopatologiche in risposta all’angoscia.
Bion (1967) sottolinea che l’assenza di un ambiente capace di “contenere”, e ‘trasformare”, depriva il bambino di un nutrimento fondamentale per lo sviluppo della mente. Nelle situazioni più favorevoli la frustrazione è tollerata e si può assistere al formarsi di un “apparato per pensare”, mentre in altri casi gli ostacoli e le difficoltà precoci di questo processo, creano i presupposti per lo strutturarsi di organizzazioni difensive. Il fallimento della dialettica contenitore/contenuto, l’assenza di rêverie, di preoccupazione materna, portano a deficit, arresti dello sviluppo del Sé potenziale, ma anche a organizzazioni psicopatologiche, che alterano in modo più incisivo e profondo la percezione del senso di Sé, e della realtà psichica. Il ritiro nella fantasia è caratteristicamente il ritiro difensivo, in un mondo immaginativo, illusionale, autocreato, per far fronte a un vuoto insostenibile, legato a un danno catastrofico alla naturale dimensione relazionale affettivo-emotiva del bambino, che viene lasciato ‘solo’. Tutto ciò ha a che fare con qualcosa di diverso da una ‘semplice’ sofferenza traumatica, traducendosi in una drammatica assenza di strutturazione della mente, in cui il bambino crea un mondo di piacere sensoriale e di onnipotenza, in cui rimane catturato, da cui diventa dipendente, che viene preferito al piacere del legame, del pensiero, e dell’autentica creatività.
Meltzer (1973) ha messo in evidenza la tirannia esercitata dalla parte crudele sul Sé sano del paziente, e il carattere di dipendenza e di piacere che la costruzione psicopatologica può assumere.
L’autore (1992), ritiene necessaria un’integrazione specifica con la teoria del pensiero di Bion, considerando indispensabile la teoria bioniana degli affetti, L (Amore), H (Odio) e K (Conoscenza), come i legami emotivi delle relazioni umane. Questo consente un ampliamento del significato del concetto di difesa, in quanto viene contemplata non solo la difesa contro la sofferenza mentale, ma anche quella contro l’emozione. Pertanto accanto alla difesa contro il dolore, viene sottoposta ad attenzione anche la difesa contro il piacere, data dalla mancanza di felicità che deriva dall’esperienza del crescere, la speranza che nasce dal contatto diretto con la bellezza del mondo.
Steiner (1993) ampliando ulteriormente la concettualizzazione di ritiro, arriverà ad affermare che i “rifugi” sono luoghi della mente dove il paziente si colloca, e si nasconde, per proteggersi dalle angosce schizoparanoidi e depressive. Il rifugio è da lui concepito come una difesa onnipotente, un’organizzazione patologica della personalità, intesa sia come raggruppamenti di difese, sia come sistemi di relazioni oggettuali strutturate, che viene usato dal paziente per evitare il contatto con gli altri e con la realtà. Per Steiner le organizzazioni patologiche della personalità funzionano come una medicazione per l’Io danneggiato dall’impatto con la realtà e incapace di riparazione. Il rifugio è messo in relazione con i meccanismi psichici coinvolti nella psicosi, ed è secondario alla catastrofe dell’Io per un attacco al pensiero. Come per Bion (1967) Steiner sottolinea quanto il paziente psicotico, nel tentativo di sbarazzarsi di una realtà odiata e temuta, attacchi l’Io percettivo, la parte dell’Io preposta alla percezione della realtà. Si tratta di un attacco che provoca una frammentazione dell’Io e degli oggetti, e conseguentemente un senso di angoscia e di confusione così forte, che l’unico modo per contrastarlo è l’organizzazione psicotica, sostenuta da forze deliranti e onnipotenti. Il rifugio psicotico è allora per il paziente un tentativo estremo di difesa contro una simile catastrofe mentale: il mondo psicotico viene idealizzato e vissuto come un luogo piacevole, perché costituisce comunque un rifugio dal terrore psicotico di disintegrazione e annientamento.
De Masi (2000, 2003, 2006, 2018) sostiene che il ritiro psichico sia primitivo e si stabilisca precocemente nell’infanzia, favorito dall’assenza psicologica delle figure di accudimento. Il bambino perde il contatto emotivo con la madre e con il mondo relazionale, e viene così a mancare un’esperienza capace di strutturare la mente, di nutrire le funzioni emotive comunicative, appartenenti all’inconscio emotivo-ricettivo. Per De Masi il ritiro è pertanto una condizione di vulnerabilità alla psicosi, una protezione dall’angoscia, per la mancanza di significato e il vuoto relazionale, ma anche un luogo di piacere e di onnipotenza, in cui la mente, anziché usare il pensiero, è usata come un organo sensoriale. Più in particolare il ritiro lede in maniera progressiva il contatto con la realtà emotiva e relazionale, non solo impedendo la percezione dell’assenza dei genitori e del senso di abbandono, ma creando uno stato di piacere. L’angoscia catastrofica compare secondariamente, quando il piacere dell’onnipotenza ha disgregato le funzioni del pensiero. Dunque se per Steiner il rifugio consegue alla catastrofe psicotica, per De Masi, il ritiro ha inizio nell’infanzia ed è invece il possibile preludio a una futura esplosione psicotica. La psicosi si insidia e si alimenta nel distacco emotivo, e nella dissociazione dalla realtà psichica in cui il soggetto si trova a vivere a lungo. Il ritiro diventa un luogo di piacere, in cui il soggetto arriva a sentirsi capace di creare dal niente i propri oggetti e di trasformare la realtà psichica, in tutti i sensi, anche nel suo contrario. C’è una prima fase in cui avviene una distorsione trasgressiva del pensiero, che non discrimina più tra sogno, delirio, e realtà, che affascina il soggetto, in una dimensione di “perversità”, una sorta di droga mentale, che prepara la strada alla successiva esplosione psicotica, con un caratteristico andamento a due fasi. De Masi (1999) sottolinea peraltro le forti analogie esistenti tra il paziente psicotico, che crea una realtà onnipotente, in cui può fare tutto quello che vuole, e quello perverso, che crea un mondo in cui può sovvertire l’organizzazione delle relazioni umane. Il ritiro è un luogo della mente che per poter continuare ad esistere, viene mantenuto segreto, ai genitori e, in analisi, all’analista. Le differenti concezioni teoriche di Steiner e di De Masi riguardo al ritiro, rivestono delle importanti implicazioni cliniche, e terapeutiche. Se Steiner descrive i rifugi della mente come operazioni difensive nella vita psichica adulta, De Masi li prospetta come condizione originaria, patogena e precoce nel bambino. Questo rende essenziale il contributo della psicoanalisi infantile, nei suoi vari ambiti di estensione del metodo psicoanalitico, sia come cura, che come prevenzione, come evidenziato anche da Colombi (2010; 2017). È possibile così avviare un lavoro analitico in età evolutiva, che aprendo alla relazione psichica, potrà preservare il soggetto dal rischio di una possibile deriva psicotica. De Masi peraltro mette in luce la necessità di un maggiore approfondimento del concetto di ritiro psichico infantile, in particolare per coloro che si occupano di problemi emotivi dell’infanzia, anche per differenziarlo e caratterizzarlo meglio rispetto all’ampia area dei Disturbi dello Spettro Autistico, che include una vasta serie di situazioni aventi come elemento comportamentale comune il ritiro sociale. Si tratta di condizioni psichiche che hanno origini ed evoluzioni diverse. Si può correre il rischio di includere nello Spettro Autistico bambini con difficoltà di socializzazione, ma che non mostrano gli aspetti più caratteristici dell’autismo, come ad esempio le bizzarrie del comportamento, destinate a non scomparire nel corso della vita.
De Masi sottolinea come sia essenziale, nel corso dell’analisi, che il paziente arrivi a rendersi progressivamente consapevole, nel tempo, anche se solo periodicamente, e in alcuni momenti, del suo funzionamento psicotico e della sua costruzione delirante. A tal fine è indispensabile che l’analista possa raggiungere il paziente nel ritiro psicotico, sostenendo le parti sane, in modo che l’organizzazione psicotica non inglobi il sé e non distrugga il senso di realtà.
Riferimenti bibliografici
Bion, W.R. (1967), Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico. Armando Editore, Roma. 1970.
Colombi L. (2010), The dual aspects of fantasy: Flight from reality or imaginative realm? Considerations and hypothesis from clinical psychoanalysis. Int. J. Psycho-Anal., 91, 1073-1091.
Colombi, L. (2017), Sofferenze agoniche e dipendenza sensoriale. Riv. Psicoanal., 63, 527-551.
De Masi, F. (1999), La perversione sadomasochistica. L’oggetto e le teorie. Bollati Boringhieri, Torino.
De Masi, F. (2000), “The unconscious and psychosis. Some considerations on the psychoanalytic theory of psychosis”. In Int. I. Psychoan., 81, pp. 1-20.
De Masi F. (2003), On the nature of intuitive and delusional thought: its implications in clinical work with psychotic patients. Int. J. Psycho-Anal. 84, pp 1149-1169.
De Masi, F. (2006), Vulnerabilità alla psicosi. Raffaello Cortina Editore, Milano.
De Masi, F. (2018), Svelare l’enigma della psicosi. Mimesis Edizioni, Milano.
Freud, S. (1907), Creative writers and day-dreaming. SE, vol. 9.
Freud, S. (1911), Formulations on the two Principles of Mental Functioning. SE., vol. 12.
Klein, M. (1932), La psicoanalisi dei bambini. Martinelli Editore, Firenze. 1988.
Meltzer, D. (1973), Stati sessuali della mente. Armando Editore, Roma. 1983.
Meltzer, D. (1992), Claustrum. Raffaello Cortina, Milano. 1993.
Steiner J. (1993), I rifugi della mente. Bollati Boringhieri, Torino. 1996.
Ritiro Psichico

Alberto Savinio_Le songe d'Achille_1929
A cura di Laura Colombi
Per ritiro psichico s’intende in termini generali uno stato di distacco mentale che sottrae il soggetto al contatto con gli altri e con la realtà circostante.
Il ritiro psichico può essere annoverato tra i meccanismi di difesa e, nello specifico, tra i meccanismi di difesa primari che si strutturano molto precocemente, nel primo periodo di vita.
Ad esempio se il bambino è sovrastimolato o soggetto a forti tensioni talora può anche semplicemente addormentarsi; possiamo così considerare come, all’origine, il ritiro psichico in un diverso stato di coscienza sia una risposta auto protettiva automatica osservabile normalmente nell’infante. Tuttavia esperienze d’intrusione o violazione emotiva da parte delle figure di accudimento possono rinforzare la tendenza al ritiro, che può venire a costituirsi nel corso della crescita come modalità di funzionamento più strutturata, che finisce via via con l’escludere il soggetto dal contatto con il mondo relazionale.
Madri (o altre figure significative) eccessivamente intrusive, angosciate, ma anche psicologicamente assenti – e in quanto tali non in grado di relazionarsi al bambino in modo sintonico ai suoi bisogni emotivi – possono facilitare nel bambino un uso eccessivo del ritiro, che segnala allora il fallimento dell’esperienza di una buona dipendenza.
Il ritiro psichico può essere dunque inquadrato da due punti di vista: quello adattivo con cui vengono fronteggiate situazioni di disagio e/o emotivamente traumatiche e quello patogeno che si struttura fin dall’infanzia come modalità più costante di funzionamento mentale, che allontana progressivamente il bambino dalla necessaria permeabilità con la realtà che lo circonda. In questi casi il ritiro perde la sua valenza iniziale difensiva (adattiva), e si costituisce come dimensione mentale antievolutiva che può assumere le sembianze di una sorta di ‘fuga’ dalla realtà in una realtà ‘altra’, autoalimentata dal piacere dell’onnipotenza. Spesso il ritiro psichico si configura infatti come un mondo di fantasie totalmente immaginarie e ‘su misura’ che captano il bambino ma che conducono ad un impoverimento (e/o grave deterioramento) del funzionamento psicologico, perché lo allontanano dal contatto emotivo e relazionale su cui si fonda la crescita mentale.
La natura complessa del ritiro fa sì che in esso vi siano aspetti molto diversi, che vanno dal fisiologico e transitorio rifugio difensivo in fantasticherie romantiche o di successo dove tutto è idealizzato, fino alle forme più perniciose, che divengono vere e proprie organizzazioni psicopatologiche (ritiri di carattere sessualizzato, ritiri in personaggi di fantasia, ritiri distruttivi).

La differenza nella qualità della natura dei ritiri e l’incidenza (riequilibrante o patogena) che essi possono avere nella dinamica psichica individuale, rendono quindi particolarmente importante, sul piano clinico, un suo attento monitoraggio in grado di distinguerne la componente benigna – e momentaneamente funzionale alla crescita o al superamento di situazioni emotivamente complesse – da quella maligna che lo distacca dalle relazioni offrendo i falsi vantaggi di una vita dissociata dalla realtà.
A seconda dei principali modelli teorici che costituiscono l’impianto psicoanalitico, esistono differenti inquadramenti di questo meccanismo.
Nel modello freudiano il ritiro totale dell’investimento libidico della realtà esterna, con la successiva frattura tra Io e realtà, costituisce il punto focale di differenza tra nevrosi e psicosi.
Nel successivo modello kleiniano, spostandosi l’attenzione sulla precocità e intensità delle angosce che accompagnano lo sviluppo infantile, si approfondisce anche lo studio delle difese “primitive” e del loro possibile assemblaggio in organizzazioni patologiche.
In questo contesto un contributo specifico alla concettualizzazione sul ritiro psichico viene da J. Steiner. Affrontando il tema del ritiro in termini soprattutto clinici, egli definisce “rifugi” quei “luoghi della mente” dove il paziente si colloca per proteggersi dalla violenza delle angosce schizo-paranoidi e/o dal dolore mentale delle angosce depressive. Il rifugio dunque rappresenta una zona dove ci si ritira dalla realtà e dal contatto con gli altri e dove, dunque, non può avvenire alcuno sviluppo.
All’interno di un differente modello, quello centrato sul Sé, D. Winnicott ha posto una specifica attenzione sugli esiti che le carenze ambientali possono avere sullo sviluppo emotivo del bambino. In questa cornice Winnicott considera la fantasia immaginativa – resa possibile dalla buona esperienza del rapporto precoce con la madre- come essenziale allo sviluppo, contrapponendo a questa attività creativa il ritiro nell’immaginazione – il “fantasticare”- che segnala per questo autore la presenza di un’attività mentale di carattere dissociato derivata dal fallimento delle esperienze relazionali primarie. Il ritiro starebbe dunque a significare un’ipertrofia della tendenza all’isolamento soggettivo che conduce ad un impoverimento dello sviluppo emozionale costituente il senso di Sé.
BIBLIOGRAFIA
Freud S. La perdita di realtà nella nevrosi e nella psicosi, O.S.F. 10, Boringhieri , Torino, 1978,pp.39-43.
Klein M. Note su alcuni meccanismi schizoidi, Scritti, Bollati Boringhieri, Torino, 1978, pp.409-434
Steiner J. I rifugi della mente, Bollati Boringhieri, Torino, 1996.
Winnicott D. W. (1935) La difesa maniacale. Tr.it in “ Dalla pediatria alla psicoanalisi” Martinelli, Firenze,1975
Winnicott D.W. (1956) La preoccupazione materna primaria. Tr.it in “Dalla pediatria alla psicoanalisi” Martinelli , Firenze,1975.
Winnicott D.W. (1971) Sogno, fantasia e vita reale. Tr.it. In “ Gioco e realtà” Armando, Roma, 1974.
Settembre 2014
Sacerdoti Giorgio
Maestri della psicoanalisi
A cura di Antonio Alberto Semi e Giuseppe Moressa
Sacerdoti Giorgio (Padova, 1925 – Venezia, 2000)
Giorgio Sacerdoti è stato psicoanalista con funzioni di training della Società Psicoanalitica Italiana e direttore dei Servizi Psichiatrici della Provincia di Venezia, ove ha fondato l’Ospedale di giorno di ‘Palazzo Boldù’ per i giovani psicotici.
La vita
Giorgio Sacerdoti nacque a Padova il 3 gennaio 1925 da una famiglia di tradizione ebraica e si trasferì a Venezia negli anni ’50. Ebbe un’infanzia agiata, da adolescente fu grande appassionato di equitazione, che praticava nel parco di famiglia a Padova, e di voga all’inglese, che svolgeva presso la Società Canottiera patavina co-fondata dal nonno. Negli anni bui del regime fascista gli fu negato l’accesso alle istituzioni pubbliche, scolastiche e sportive. Riuscito a sfuggire alla persecuzione fascista e a quella tedesca, dopo la liberazione riprese gli studi universitari, laureandosi nel 1949 in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova con il massimo dei voti. Nel 1952 si specializzò in Neurologia presso lo stesso ateneo, dove nel 1953 conseguì anche una seconda specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni.
Dal 1950 Giorgio Sacerdoti fu in servizio presso l’Ospedale Psichiatrico Provinciale di Venezia, dapprima quale medico di sezione incaricato, quindi, dal 1952 -a seguito di pubblico concorso- quale medico di sezione effettivo e, dal 1960, in qualità Primario. Dal 1964 fu incaricato della vice-direzione e dal 1969 divenne Direttore dei Servizi Psichiatrici del Centro Storico di Venezia e sostituto del Direttore dei Servizi Psichiatrici della Terraferma veneziana. Alla fine degli anni sessanta fondò l’Ospedale di Giorno di ‘Palazzo Boldù’ per giovani psicotici. A partire dalla fine degli anni cinquanta dedicò parte dei suoi interessi alla trasmissione del sapere in ambito psichiatrico, psicoterapeutico e medico legale. Tra i molti corsi tenuti presso l’Università di Padova, si ricordano le lezioni di Psichiatria (libera docenza ottenuta nel ’59), Psichiatria Infantile (a. a. ’60-’61), Psichiatria Forense (a. a. ’62-’63), Antropologia Criminale (libera docenza ottenuta nel ’64) e Delinquenza Minorile (a. a. ’63-’69).
Nei primi anni ’60 iniziò la sua analisi personale con Cesare Musatti, diventando ordinario e poi didatta della Società Psicoanalitica Italiana. Fu profondo conoscitore di Freud e di molti altri Autori che soleva leggere in tedesco ed in inglese prima ancora che in italiano. Consapevole che l’opera di traduzione contiene sempre anche un certo grado di tradimento, nei suoi scritti citava spesso i testi in lingua originale. Per diversi anni fu l’unico analista didatta del Veneto e attorno alla sua persona iniziarono le prime attività del Centro Veneto di Psicoanalisi. Il 13 dicembre 1980 Giorgio Sacerdoti, assieme ad Anteo Saraval, Antonio Alberto Semi, Savo Spacal e Carla Rufina Zennaro, fondò il Centro Veneto di Psicoanalisi.
Di quei primi incontri, svolti nel salotto della casa di Sacerdoti e poi degli altri colleghi del neonato centro, si ricordano la grande ospitalità e la cura affinché tra i partecipanti si potesse instaurare un clima autenticamente accogliente, una sorta di alone affettivo che rendeva quegli incontri non solo occasioni di proficuo scambio di idee ma anche momenti estremamente piacevoli.
Il contributo alla psicoanalisi
Giorgio Sacerdoti è stato uno psicoanalista della “generazione di mezzo” degli analisti italiani. Fu nel contempo rappresentativo quanto appartato. Il suo pensiero psicoanalitico, profondamente radicato nella teoria classica freudiana, sapeva cogliere quanto di utile fosse contenuto nelle differenti teorizzazioni. Dalla lettura dei numerosi scritti, l’impressione generale che se ne ricava è quella del piacere per una ricerca precisa e originale. Il rigore terminologico che sempre lo contraddistingue appare uno dei pilastri sui quali poggiano i rapidi quanto illuminanti cambiamenti di prospettiva. È interessante seguire i fili che Sacerdoti tesse, perché questi conducono il lettore all’osservazione della complessità e mutevolezza dei fenomeni psichici, istituzionali e sociali, partendo da una base fornita da chiare definizioni teoriche, attraverso momenti di necessaria rottura.
Sacerdoti fu un esperto scopritore e costruttore di ponti. Un ponte potrebbe essere definito come una struttura pensata(1) e/o realizzata per superare un ostacolo che impedisce la continuità di una via di comunicazione. Si potrebbe aggiungere che un ponte esiste quando sono presenti alcuni elementi fondamentali come una via di comunicazione, cioè un desiderio di proseguire una certa strada perché effettivamente necessaria o utile, e un ostacolo che si frappone ad essa segnalando nel contempo la presenza di aree separate che possono essere collegate. Quindi una via, un desiderio, un ostacolo e delle differenze che per quanto uno lo voglia saranno sempre presenti, almeno finché il ponte sarà lì a testimoniarlo. Ed il pensiero di Sacerdoti è sempre volto a collegare e distinguere, proprio come fa un costruttore di ponti. Questa polarità è rintracciabile in tutta la sua opera, come una necessaria oscillazione tra poli – ad esempio realtà psichica/realtà materiale, conscio/inconscio, pulsione/relazione, pensiero clinico/pensiero teorico – a garanzia della complessità della realtà umana.
Il modo di procedere di Sacerdoti mette continuamente in evidenza come la scienza, e quindi anche la psicoanalisi, sia una impresa umana e come tale non potrà mai spiegare la totalità dell’esperienza’. Tuttavia, questo dato di fatto coesiste con l’esigenza di considerare la totalità, a patto che si tenga a mente che è un’impresa impossibile e che esistono dei limiti del pensiero, che molto preoccupavano il professore. Dogmatismo, scorciatoie mentali, irrigidimenti teorici ma anche specifici meccanismi difensivi quali la negazione e il diniego, finalizzati a impedire di considerare il tutto o a salvaguardare il senso di unità dell’Io. Per Sacerdoti la realtà umana è sempre più complicata di quel che riusciamo a pensare.
La sua originalità di pensiero gli permise di collegare, senza mai confondere, psicoanalisi classica e psichiatria. Nel lavoro di tutti i giorni, riuscì ad introdurre elementi umani e scientifici in modo tale da non negare né le dinamiche istituzionali, né quelle intrapsichiche. Un articolo del ’71, dal titolo “Fantasmi, miti e difese nell’assistenza psichiatrica”, illustra molto bene il collegamento tra la sponda psicoanalitica e quella psichiatrica. In questo lavoro, l’autore dimostra come lo strutturarsi dell’assistenza psichiatrica sia determinato dai tipi e dalle vicissitudini dei meccanismi di difesa nei confronti della malattia psichiatrica: “(…) un’importanza preminente possano avere le difese nel senso psicoanalitico del termine (…) in particolare, prendendo in considerazione il meccanismo difensivo di negazione, si può intravedere la possibilità di un’applicazione concreta del metodo psicoanalitico all’istituzione psichiatrica; evitando da un lato la tendenza a generalizzare quanto emerge dall’esperienza clinica individuale ai fenomeni collettivi (‘etnocentrismo professionale degli psicoanalisti’) e dall’altro la tendenza a negare la specificità del fatto psicopatologico (‘negazione istituzionalizzata’ degli ‘antipsichiatri’)” (Sacerdoti, 2008, 54).

L’ospedale Psichiatrico provinciale San Clemente di Venezia
“Primo giorno. Ha dormito poco. Stamane, condotta nell’ufficio medico, risponde con un filo di voce e piange sommessamente. Pare sia possibile condurla alla realtà parlandole con tono energico! Allora l’espressione si ravviva e risponde. Quando però è il momento di riaccompagnarla a letto si oppone con tutte le forze, sempre piangendo.
Secondo giorno. Allettata. Ha conservato per tutto il giorno lo stesso atteggiamento di passività dolorosa. Rifiuta ostinatamente di alimentarsi. Completamente assorbita nel suo dolore, non parla, non ha cura di sé, ogni tanto singhiozza. 1° Accesso convulsivo completo.
Terzo giorno. Si guarda attorno con occhi smarriti, l’espressione tesa. Se le si rivolge una domanda sbuffa di continuo. È stato praticato enteroclisma evacuativo.
Quarto giorno. Ancora chiusa in se stessa. 2° Accesso convulsivo completo. Alla sera prende un caffè.
Quinto giorno. Ogni tanto piange e appare addolorata. Viene interrogata a lungo e fornisce risposte insignificanti quali: ‘come vuole che stia?’ oppure ‘cosa vuole che le dica?’
Sesto giorno. 3° Accesso convulsivo completo. Alla sera appare arrabbiata.
Settimo giorno. Si rifiuta di mangiare. Viene nutrita per sonda.
Ottavo giorno. 4° Accesso convulsivo completo. Alla sera si decide a mangiare.
Nono giorno. Passeggia per la sala. Quando vede i medici si mette a sospirare o a sbuffare ma non parla. Si mostra imbronciata”.
Questo è lo stralcio del diario clinico di una paziente – meglio “inferma” o “alienata”, perché così venivano identificati i pazienti del manicomio – ricoverata in stato confusionale all’Istituto di San Servolo(2) . Le cose procedono così finché la paziente non apparirà “normalizzata”, ovvero risponderà a tono, si alimenterà in modo corretto, smetterà di piangere. Ci vorranno dodici accessi convulsivi completi ed un incisivo trattamento farmacologico (Librium, Letargin, Serenase e molto altro ancora) per ottenere questo risultato. Questa toccante vicenda colpisce anche per l’impressione di assoluta “prassi” che se ne ricava. Questa persona, arrivata in stato confusionale all’Istituto, è stata “normalizzata” in circa due mesi di ricovero coatto. Dopo averle riconsegnato il proprio diritto di voto, tolto appena varcata la soglia del manicomio, la paziente venne riconsegnata alla città. In tutta la cartella clinica pochissimo spazio viene dedicato all’evento traumatico che ha portato al ricovero, l’inatteso tradimento e abbandono da parte dell’amato. La paziente si sforzava di far capire quello che provava: “come vuole che stia?” Parole insignificanti, commentarono i medici. Noi ora sappiamo che non esistono parole insignificanti e che si tratta sempre di un problema di traduzione. Tuttavia, al tempo della nomina a direttore di Sacerdoti la prassi era un’altra e con questi “usi e costumi” egli si dovette scontrare. L’arrivo della psicoanalisi fu un’autentica rivoluzione scientifica, metodologica e culturale. Il giorno dopo l’ottenimento dell’incarico di Direttore dell’Ospedale San Clemente, sintomaticamente l’elettroshock cessò completamente e i livelli di contenzione e di trattamento farmacologico diminuirono drasticamente. I cambiamenti occorsero a tutti i livelli. Il ricordo degli infermieri che lavoravano in quegli anni all’Istituto narra di una sorta di “effetto cascata” che coinvolse tutti gli operatori. L’approccio mutò da uno stile autoritario ad uno responsabilizzante. Sacerdoti era capace di un contatto profondo con le persone. Una certa signorilità, il grande rispetto e la delicatezza con i quali trattava i pazienti, la rapidità delle intuizioni riguardo a ciò che stava accadendo nel mondo interno, funsero da elementi catalizzatori anche per il personale. La psicoanalisi era arrivata nell’istituzione. Da lì a poco iniziarono le prime uscite dall’isola, a Venezia come fuori città: gli infermi e gli alienati divennero persone alle quali cercare di offrire una nuova prospettiva.
“Un quadro dipinto da una persona ricoverata all’Istituto di San Clemente ritrae l’ingresso dell’Ospedale con i pazienti affacciati al canale intenti ad osservare una regata”.
A ben guardare, faceva notare Sacerdoti, qualcosa risaltava agli occhi. Un gioco di prospettive. Alla tridimensionalità dei regatanti impegnati nella gara faceva da contrappunto la quasi totale assenza di prospettiva dell’isola, della chiesa e dei pazienti. Quasi per essere certo di farsi capire, il paziente aveva dipinto quel particolare pubblico sdraiato a terra .
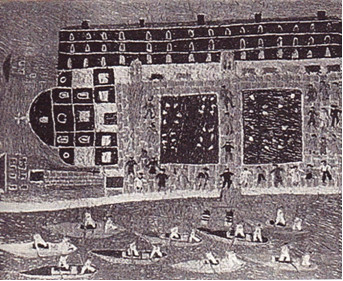
Dipinto di un paziente ricoverato all’Istituto San Clemente
Ecco come dovevano sentirsi i pazienti dell’Ospedale: i regatanti erano persone della città dotate di prospettiva mentre loro erano le persone di San Clemente, sdraiati a terra e senza prospettive. C’era quindi un prima, rappresentato dalla linea che separa la laguna dall’isola di San Clemente, e un dopo, vissuto come arresto del tempo, assoluto ed immodificabile. Ecco come Sacerdoti descrive l’autore del dipinto: “Da molto tempo (e fino alla morte), se gli si chiedeva quanti anni avesse, egli rispondeva dando l’età che aveva al momento del ricovero. Da quel momento il tempo non era più passato, non c’era più stata per lui una prospettiva, diversamente da prima” (Sacerdoti, 1976, 333).
Serviva un ponte, quindi, e Sacerdoti era un esperto in questo campo. L’idea che lo muoveva era quella di offrire le scoperte della psicoanalisi ad ogni persona che ne avesse avuto bisogno. A Sacerdoti e alle persone che con lui ebbero il privilegio e l’opportunità di lavorare spettò il compito di trovare le modalità via via più efficaci per riuscirci.
Di nuovo un quadro di un paziente ci appare illuminante

Opera in tessuto di un paziente ricoverato all’Istituto San Clemente
L’opera, realizzata dal paziente annodando singoli fili di tessuto colorato rinvenuti qua e là nei locali del guardaroba, mostra la facciata dell’Istituto con i giardini ben curati che incorniciano l’ingresso principale. E’ proprio la grande accuratezza con la quale è stata rappresentata la facciata che ci permette di evidenziare un’importante sottolineatura dell’autore. Le finestre dell’Istituto non sono tutte uguali. Le differenze non sono quelle di forma o dimensione, ma la presenza o l’assenza di sbarre. Al secondo piano, a sinistra rispetto all’ingresso principale, l’autore chiaramente inserisce alcune sbarre alle finestre. Dietro quelle vetrate sbarrate, esattamente al contrario rispetto alla realtà esterna, trovavano posto gli alloggi del personale medico, la farmacia e gli ambulatori. In questo modo il paziente rappresentava l’esistenza di mondi scissi, di vere e proprie aree psichiche riconosciute come off limits: ci siamo noi, i pazienti e ci sono loro, i curanti. Evidentemente la faccenda può essere vista anche in un altro modo. Se le sbarre sono alle finestre del personale, chi è di fatto “dietro le sbarre?”.
“Bisogna vedere dottore … perché si può essere vivi o morti. Solo che si può essere vivi ma essere morti lo stesso: bisogna vedere chi hai intorno. Il manicomio dopo è diventato più bello”.
Queste sono le parole di una paziente che aveva vissuto il cambiamento dell’Ospedale Psichiatrico Provinciale con l’arrivo di Sacerdoti. E accadde proprio ciò che raccontava. Passando per un attimo ad un livello metapsicologico, che tanto aveva a cuore Sacerdoti, sembra che le parole usate dalla paziente rievochino una pulsione di vita che finalmente trovava modalità di espressione e di legame. “Si può essere vivi ma essere morti lo stesso” a proposito dei destini dell’impasto pulsionale. Le persone ricoverate vennero finalmente riconosciute in tutta la loro complessità e per realizzare questo Sacerdoti si servì della psicoanalisi. Per l’insight della relazione con il paziente psicotico egli utilizzò, tra gli altri, i concetti di derivato pulsionale, regressione, principio di piacere, processo primario e di acting out. Proprio il tema dell’azione e della controazione – e cosa non è il diario clinico sopra riportato se non un’accurata cronistoria di acting e contro-acting – trovò un’importante applicazione. La consapevolezza che i problemi della relazione con il paziente psicotico si sviluppavano all’insegna dell’azione, e più propriamente attraverso l’identificazione e la controidentificazione proiettiva dell’azione provocata su loro stessi, permise la graduale formazione del pensiero degli attori in gioco. Attraverso il riconoscimento dei fenomeni di transfert e di controtransfert si attuava uno sforzo continuo per favorire un atteggiamento di effettivo ascolto. Il paziente poteva quindi essere riconosciuto, in un modo per così dire unitario, grazie all’introduzione del lavoro di équipe. Così ogni operatore, depositario di parti scisse del paziente, diveniva un elemento imprescindibile all’insight. Di pari passo, l’onnipotenza della precedente relazione curante-paziente, autentica formazione reattiva di una inconscia impotenza, lasciava il posto alla consapevolezza della complessità dell’individuo e al riconoscimento che se non si poteva fare tutto, qualcosa di importante poteva essere fatto. E di questo i pazienti man mano divennero consapevoli, il manicomio era diventato un posto effettivamente più bello. Ora Venezia era pronta ad accogliere le persone che solo poco tempo prima aveva dovuto isolare a San Clemente.
L’Ospedale di Giorno di Palazzo Boldù: nascita di un modello di assistenza psichiatrica a tempo parziale
Un chiaro esempio di istituzione psichiatrica pensata, realizzata e ripensata grazie al contributo della psicoanalisi fu l’Ospedale di Giorno di ‘Palazzo Boldù’ per giovani psicotici. Tale esperienza, fortemente voluta da Sacerdoti, fu in qualche modo legata e caratterizzata dalla sede veneziana. Come Venezia si caratterizza per essere una città anfibia circondata dall’acqua come elemento al contempo difensivo e connettivo, così l’esperienza dell’Ospedale di Giorno, seguendo l’andamento della città, fu anch’essa circoscritta, ma per ciò stesso ricca di dinamismo, tempestività e verificabilità, quindi anche potenzialmente idonea alla gemmazione . Quanto detto va visto anche dalla parte del mondo interno, con un isolamento che però doveva essere pronto a cogliere i momenti di rottura, come nelle attività creative e produttive. Pensato, ideato e fatto maturare con il minimo apporto dei diversi livelli amministrativi, il ‘Boldù’ divenne il primo centro psicoterapico pubblico in Italia. Non fu tuttavia un percorso privo di difficoltà. Basti pensare che l’allora amministrazione propose di realizzare l’Ospedale di Giorno, secondo il ben noto processo conservativo della coazione a ripetere, su di un’altra isola – l’isola di Poveglia – o come alternativa in zone periferiche della città. Alla fine Sacerdoti, coadiuvato dal dottor Giancarlo Cecchinato che poi diresse in modo magistrale il Centro, riuscì a realizzare la nuova struttura in un palazzo magnifico ubicato nel cuore della città. Nel sestiere di Cannaregio, a due passi da Rialto, nacque l’Ospedale di Giorno di Palazzo Boldù.

Ingresso principale di Palazzo Boldù
Sacerdoti aveva ben presente che la sofferenza mentale era un problema di cronicità e non di acuzie. Il Centro Psicoterapico infatti non fu solo il tentativo di impedire la cronicizzazione dei nuovi pazienti ma fu anche l’espressione della volontà, attraverso un percorso di decronicizzazione, di curare le persone già ricoverate in manicomio. È possibile rappresentare il modello di assistenza del Boldù come una sorta di edificio su palafitte sorretto da un certo numero di sostegni di eguale importanza. Innanzitutto il palo della motivazione. Il personale che fu ricollocato all’Ospedale di Giorno proveniva dal manicomio ed era stato appositamente selezionato sulla base di caratteristiche personali e motivazionali. Dai medici agli infermieri, fino al personale amministrativo, tutti erano consapevoli che stavano per contribuire ad un progetto importante, unico ed altamente simbolico. Un altro sostegno importante fu quello della formazione del personale attraverso quella che oggi verrebbe chiamata “formazione continua”. Ogni giorno, a cavallo del turno della mattina con quello del pomeriggio, da una a due ore erano dedicate all’apprendistato, all’aggiornamento ed alla discussione clinica di gruppo. Inizialmente tale processo fu facilitato dalla conduzione di uno psicoanalista in qualità di supervisore esterno all’istituzione. E poi i molti pali costituiti dalle applicazioni della psicoanalisi alla pratica clinica di tutti i giorni. Dalla psicoanalisi di gruppo che Sacerdoti praticava proprio al Boldù, alle moltissime ore dedicate alla psicoterapia orientata psicoanaliticamente, fino al quotidiano contatto con il paziente letto attraverso i movimenti transferali e controtransferali, le difese, la tendenza ad agire e a controagire. Il rapporto con il paziente assumeva di fatto uno spessore umano e scientifico profondo.
Se l’arrivo di Sacerdoti a San Clemente poteva essere connotato come la venuta della psicoanalisi al manicomio, l’apertura del Centro Psicoterapico rappresentò lo sbarco istituzionale della psicoanalisi a Venezia. E con essa arrivarono anche i pazienti col loro carico di interrogativi.
È suggestivo ripensare ad uno dei pittori di San Clemente. Forse avrebbe dipinto un secondo quadro, magari riassegnando ad ognuno quello che dovrebbe essere uno dei diritti fondamentali dell’uomo, il diritto di avere una prospettiva.
Sacerdoti, esperto scopritore e costruttore, con Palazzo Boldù realizzò certamente uno dei suoi ponti più belli.
Nonostante l’impegno richiesto dalla direzione dei servizi psichiatrici, Sacerdoti garantì a se stesso lo spazio dell’analisi dedicandosi giornalmente alla clinica psicoanalitica classica. Questa scelta fu, in realtà, uno degli elementi principali che gli permisero di portare avanti il suo modo di pensare, progettare e lavorare nelle istituzioni. La stanza di analisi poteva essere pensata come una bottega o un laboratorio artigianale che gli garantiva la comprensione dei fenomeni psichici e l’osservazione puntuale di tutti quei processi intrapsichici (topici, dinamici ed economici) come anche culturali, che successivamente potevano trovare applicazione anche a livello istituzionale. Fu proprio in quella stanza che Sacerdoti mise in luce l’ironia come antidoto al fenomeno della polarizzazione nell’analista di parti megalomaniche o di grande incapacità. Un analista che può far uso dell’ironia, come lo stesso Sacerdoti faceva spesso e con gusto, relativizza il suo apporto all’analisi permettendo nel contempo di osservare controtransferalmente ciò che sta accadendo. Ed ancora dalla clinica psicoanalitica e dall’intreccio di questa con la riflessione teorica , va ricondotto lo studio sull’assimilazione degli ebrei come pericolo dell’assimilazione del soggetto alla cultura. In tutti i suoi scritti, come anche nel suo lavoro istituzionale, è possibile riconoscere l’applicazione della conoscenza maturata dal lavoro psicoanalitico con i pazienti. Il punto centrale è l’individuo, in lotta per sfuggire da un lato alla spinta pulsionale (intesa come linea del destino) e dall’altro lato a quella culturale (oggi forse ancor più minacciosa).
Note
(1)Un ponte può anche essere “dato”, cioè non essere realizzato intenzionalmente, come nel caso di un albero che cadendo tra una sponda e l’altra di un corso d’acqua ne permetta il collegamento. Questi ponti naturali pre-esistenti hanno tuttavia bisogno che qualcuno li scopra e li pensi, ovvero che ne riconosca la possibile funzione. In quel caso l’albero che unisce le due sponde cambia statuto e diventa un ponte. Come dire che a volte le cose devono essere riconosciute più che costruite.
(2)Il progetto della costruzione di un manicomio femminile da erigersi nell’isola di San Clemente di Venezia era stato predisposto attorno agli anni 1855-1857, durante la seconda dominazione austriaca. I lavori iniziati nel 1858 si protrassero a lungo fino ai primi mesi del 1873, e soltanto il 1 luglio dello stesso anno fu inaugurato. Concepito sulla base del modello del manicomio di Vienna, l’ospedale San Clemente divenne isola destinata a coloro che si voleva isolare.
(3)Sacerdoti G. (1982). Riflessi di Venezia sul lavoro analitico. Rivista di Psicoanalisi, 28, 1, 88-96.
(4)In seguito l’Ospedale di Giorno fu ribattezzato per motivi amministrativo-legali proprio “Centro Psicoterapico”.
Bibliografia
Sacerdoti G. (1950). La menomazione alla gioia di vivere come lesione personale in penale e come elemento di risarcimento in civile. Atti dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Padova. Treviso, Tipografia Ed. Trevigiana.
Sacerdoti G. (1954). Considerazioni neurofisiologiche e psichiatriche per la valutazione medico-legale dei traumi emotivi. Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Università di Padova, 1-24.
Sacerdoti G. (1955). Riflessi medico-legali e giuridici dei rapporti fra lavoro e igiene psichica. Journal Brasilero De Psiquiatria, 3, 288-295.
Sacerdoti G. (1959). Diagnostica polidimensionale ed entità nosologiche in psichiatria infantile. Il lavoro neuropsichiatrico, vol. XXV, 3, 1-3.
Fagioli M., Sacerdoti G. (1959). Sul test per l’abilità mentale residua di Williams. Risultati in un gruppo di senili prima e dopo il trattamento con ‘Consaldon’. Folia Psychiatrica, II, 2, 175-186.
Sacerdoti G. (1959). A proposito di nosografia e di diagnostica in psichiatria infantile. Considerazioni metodologiche. Archivio di Psicologia Neurologia e Psichiatria, XX, 1-16.
Sacerdoti G. (1959). Aspetti e prospettive della “psicosomatica” in una recente pubblicazione olandese, Rassegna di Studi Psichiatrici, XLVIII, 2, 280-294.
Rigo L., Sacerdoti G. (1960). Contributo allo studio delle correlazioni biopsicologiche nella zoofilia erotica. Quaderni di Criminologia Clinica, IV, 479-494.
Sacerdoti G. (1960). Sul giudizio di imputabilità in rapporto ad alcuni moderni orientamenti della psichiatria. Riv. Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale delle Alienazioni Mentali, LXXXIV, 2, 1-23.
Rigo L., Sacerdoti G. (1960). Studio della personalità di un minorenne omicida con deduzioni sull’imputabilità. Medicina Legale e delle Assicurazioni, VIII, 1, 5-39.
Rigo L., Sacerdoti G. (1961). Problemi di interpsicologia nella perizia psichiatrica con particolare riguardo agli aspetti irrazionali. Riv. Sperimentale di Freniatria, LXXXV, 4, 1145-1163.
Rigo L., Sacerdoti G. (1961). Valorizzazione del “campo psicologico” nei giudizi di imputabilità in reati compiuti da minorenni. Archivio di Psicologia Neurologia e Psichiatria, XXII, 6, 643-665.
Sacerdoti G. (1962). Recensione: Ego & Milieu – L’Io e l’ambiente. Cumming E., Atherton Press, New York, Giornale Psichiatria, Neuropat., I, 1-7.
Sacerdoti G. (1962). Etude pluridimensionelle d’un adolescent sacrilège. Actions apparemment obsessionnelles. Structure paranoique. L’Encéphale, Paris, 2, 3-7.
Rigo L., Sacerdoti G. (1963). Il concetto di polidimensionalità in psichiatria clinica e forense. Riv. Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale delle Alienazioni Mentali, LXXXVII, 22, 3-47.
Sacerdoti G. (1964). Spunti critici in tema di prognosi sociale dei minori. Esperienze di Rieducazione, V.
Rigo L., Sacerdoti G. (1965). Rapporti e limiti tra psicodinamica individuale e psicodinamica di gruppo. Annali di Neurologia e Psichiatria e Annali Ospedale Psichiatrico di Perugia, LIX, 1, 87-100.
Sacerdoti G. (1965). “Crisi di originalità giovanile” e “psicopatizzazione” con particolare riguardo alle c.d. personalità sociopatiche. Riv. Sperimentale di Freniatria, LXXXIX, 2, 336-342.
Sacerdoti G. (1965). Su di un caso di psicosi isterica in soggetto aderente a “Subud”. Archivio di Psicologia Neurologia e Psichiatria, 26, 412.
Sacerdoti G. (1966). Sull’applicazione delle misure di sicurezza ai minori. Esperienze di Rieducazione, XIII, 46-62.
Sacerdoti G. (1966). Denial of illness: its relation to mental institutions. Proceedings of the Fourth World Congress of Psychiatry, Madrid (Reprinted from Excerpta Medica International Congress Series, n. 117).
Sacerdoti G. (1966). Osservazioni sulle fobie di un paziente ossessivo (la fobia della moglie gravida). Rivista di Psicoanalisi, 12, 3, 299-323.
Sacerdoti G. (1967). Sintesi di letteratura psicoanalitica. Rivista di Psicoanalisi, 13, 2, 197-204.
Fattovich G., Sacerdoti G. (1969). Der Pathologishe Raush. Simposium dei Medici Tedeschi, Venezia.
Sacerdoti G. (1969). Discussione su Psichiatria e Servizio Sanitario Nazionale. Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza, 25.
Sacerdoti G. (1969). Recensione: Analisi del carattere ed emancipazione Marx, Freud, Reich. Lopez D., Psichiatria Generale e dell’età evolutiva, VII, 2, 211-215.
Sacerdoti G. (1969). Equivalenze e vicissitudini degli aspetti “psicopatologici” e “delinquenziali” dell’immagine del sé. Congresso Internazionale di Psicoanalisi, Roma.
Sacerdoti G. (1971). Fantasmi, miti e difese nell’assistenza psichiatrica. Rivista di Psicoanalisi, 17, 1, 83-110.
Sacerdoti G. (1973). Smerz und Depression. XIII Symposium und Fortbildungstagung fur Facharzte und Praktische Artze, Pula (Jugoslawien), 20-24 giugno.
Sacerdoti G. (1974). Il concetto psicoanalitico di istinto di fronte alla etologia. In: Etologia e Psichiatria, Balestrieri A., De Martis D., Siciliani O., Bari, Laterza.
Sacerdoti G. (1976). Metafore spaziali e temporali: raffigurazioni del mondo interno. Rivista di Psicoanalisi, 22, 3, 333-345.
Sacerdoti G. (1977). Transfert, preconscio e “clichés” culturali. Rivista di Psicoanalisi, 23, 2, 214-229.
Sacerdoti G. (1977). Relazione introduttiva al convegno: “Assistenza psichiatrica a tempo parziale” (Venezia).
Sacerdoti G. (1977). Spunti clinico-metapsicologici in tema di (dis)continuità con particolare riguardo al sogno. Rivista di Psicoanalisi, 23, 372.
Sacerdoti G. (1979). Le “Contre-Acting” et ses Rapports avec l’”insights” dans les Problèmes Psychotiques. Reveue Francaise de Psychanalyse, 43, 2, 335-342.
Sacerdoti G. (1980). Giochi e ragioni (Letture). Gli Argonauti, II, 6, 247-256.
Sacerdoti G. (1980). La relazione analitica come eironeia: vicissitudini degli aspetti ludici e di quelli lavorativi. Comunicazione al Congresso S.P.I., Taormina.
Sacerdoti G. (1981). Continuità e discontinuità nel processo analitico. Relazione al Convegno a Seminari Multipli, Bologna.
Sacerdoti G. (1981). Prefazione a Maternità e sesso. Langer M., Torino, Loescher.
Sacerdoti G. (1982). Riflessi di Venezia sul lavoro analitico. Rivista di Psicoanalisi, 28, 1, 88-96.
Sacerdoti G. (1983). Prefazione a Cultura e Sé. Semi A.A., Padova, Cedam.
Sacerdoti G. (1983). Continuità e discontinuità tra aspetti terapeutici e conoscitivi in diverse situazioni analitiche, Gli Argonauti, V, 15, 25-29.
Sacerdoti G. (1984). Sull’insight teorico. Relazione al Centro Veneto di Psicoanalisi.
Sacerdoti G. (1984). Sullo stile in psicoanalisi. Gli Argonauti, VI, 20, 19-33.
Sacerdoti G., Spaçal S. (1985). Insight. Rivista di Psicoanalisi, 31, 1, 59-74.
Sacerdoti G. (1985). Il dilemma ironicida (Nota: A proposito del libro di Guido Almansi “Amica ironia”). Rivista di Psicoanalisi, 31, 3 393-396.
Sacerdoti G. (1985). Psichiatria e Psicoanalisi: un rapporto ambivalente. In: Atti Convegno Trieste 5-8 dicembre 1985, Ed. Studio Tesi.
Sacerdoti G. (1986). Luci e ombre dell’insight teorico. Gli Argonauti, VIII, 28, 17-32.
Sacerdoti G. (1986). Riflessioni sulle bipolarità inerenti al processo psicoanalitico con particolare riguardo alla continuità-discontinuità. Rivista di Psicoanalisi, 32, 2, 195-208.
Sacerdoti G. (1987). Ebraismo e psicoanalisi davanti all’assimilazione. In: L’altra scena della psicoanalisi. Tensioni ebraiche nell’opera di Freud, Meghnagi D. (a cura di), Roma, Carucci.
Sacerdoti G. (1987). Insight e parole double-face nell’area psichiatrico-psicoanalitica. Gli Argonauti, XI, 34, 173-186.
Sacerdoti G. (1987). In tema di raffigurabilità del dolore e della sofferenza. Considerazioni sul contributo di Gori. Rivista di Psicoanalisi, 33, 3, 371-377.
Sacerdoti G. (1987). L’ironia attraverso la psicoanalisi. Milano, Raffaello Cortina Editore.
Sacerdoti G. (1988). Problemi di applicazione o sviluppo della psicoanalisi. In: Trattato di psicoanalisi, vol. I, Semi A.A. (a cura di), Milano, Raffaello Cortina Editore.
Sacerdoti G. (1988). Che genere di analista per che genere di paziente. In: Del genere sessuale, Russo L., Vigneri M. (a cura di), Roma, Borla.
Sacerdoti G. (1989). Isteria. In: Trattato di psicoanalisi, vol. II, Semi A.A. (a cura di), Milano, Raffaello Cortina Editore.
Sacerdoti G., Semi A.A. (1989). Denial and Weltanschauung. In: Denial, Edelstein E., Nathanson D.L., Stone A.M., Plenum Publishing Corporation.
Sacerdoti G. (1989). “Rivoluzione psichiatrica” e psicoanalisi negli ultimi tre decenni. Gli Argonauti, XI, 42, 169-177.
Sacerdoti G., Semi, A.A. (1989). Trauma as a shibboleth in psychoanalysis? International Journal of Psychoanalysis, 70, 95.
Sacerdoti G. (1989). Recensione: Costruzioni freudiane. Gori E.C., 1987, Roma, Armando, Rivista di Psicoanalisi, 35, 2, 445-449.
Sacerdoti G. (1990). Recensione a Antoedipe et ses destins. Recamier P.C., 1989, Parigi, Aspygee Editions, Rivista di Psicoanalisi, 36, 3, 743-761.
Sacerdoti G. (1992). Recensione a Semi A.A.: Dal colloquio alla teoria. 1992, Milano, Cortina, Rivista di Psicoanalisi, 38, 2, 551-559.
Sacerdoti G. (1992). Recensione a Il padre e la legge. Freud e l’ebraismo. Meghnagi D., 1992, Venezia, Marsilio, Rivista di Psicoanalisi, 38, 3, 865-875.
Sacerdoti G. (1993). Recensione a Paranoia e tradimento: per una teoria dei bisogni. Zapparoli G.C., 1992, Torino, Bollati Boringhieri, Rivista di Psicoanalisi, 39, 1, 167-174.
Sacerdoti G. (1993). Recensione a Perdere di vista. Pontalis J.-B., 1993, Roma, Borla, Rivista di Psicoanalisi, 39, 3, 523-529.
Sacerdoti G. (1993). Visioni psicoanalitiche delle realtà e stili di scrittura. Rivista di Psicoanalisi, 39, 3, 633-637.
Sacerdoti G. (1993). I paradossi della solitudine. Relazione all’Ospedale Civile di Venezia.
Sacerdoti G. (1994). Recensione a Défence de toucher ou la jouissance du dit. Flouroy O., 1994, Paris, Calmann-Lévy, Rivista di Psicoanalisi, 40, 4, 745-752.
Sacerdoti G. (1995). Introduzione a Tolleranza e intolleranza. Sacerdoti G., Racalbuto A. (a cura di), Torino, Bollati Boringhieri.
Sacerdoti G. (1997). Quali legami tra indifferenza, differenza e differimento? Colloquio psicoanalitico di Venezia. In: Sacerdoti G., Racalbuto A. (a cura di), 1977, Dunod Masson, Milano.
Sacerdoti G. (1999). Diritto a delirare, diritto a curare. Letto al Centro Veneto di Psicoanalisi.
Sacerdoti G. (1999). Verità storica e psicoanalisi. In: Racalbuto A. (a cura di), 2004, Verità storica e psicoanalisi, Roma, Borla.
Bibliografia su Giorgio Sacerdoti
Sacerdoti G. (2008). Scritti psicoanalitici. Borla, Roma.
Collegamenti in Spiweb:
– Centro Veneto di psicoanalisi: www.centrovenetodipsicoanalisi.it
 Read in english
Read in english
Giorgio Sacerdoti was a training analyst of the Psychoanalytical Society. He was also the director of the Psychiatric Services in Venice where he founded the daily Hospital ‘Palazzo Boldù’ for young psychotics. His approach was deep-seated in classical Freudian theory, yet with a look at what he found useful in other theories. As builder of bridges, he was able to connect without ever confuse different elements. This polarity can be traced throughout his work, as a necessary oscillation between poles – for instance psychic reality/material reality, conscious/unconscious, drive/relationship, clinical thought/theoretical thought – to guarantee the complexity of human reality.
Settembre 2014
Scena Primaria

DOROTEA TANNING, 1983
SCENA PRIMARIA
a cura di Roberto Musella
In psicoanalisi, con scena primaria, indichiamo la rappresentazione primitiva del coito della coppia dei genitori osservata, fantasticata, o ricostruita après-coup, dal bambino.
La scena risulta ad un tempo estremamente seduttiva ed escludente e viene generalmente vissuta come violenta. La scena primaria, per la sua particolare organizzazione fantasmatica, racchiude in sé anche altre rappresentazioni, che nel loro insieme definiamo ‘fantasmi originari’. Tra queste oltre alla scena primaria ritroviamo il fantasma di castrazione e quello di seduzione, ampiamente condensati e rappresentati anch’essi nella scena primaria.
Dopo avere a più riprese accennato all’importanza di questa e di altre rappresentazioni fantasmatiche ‘originarie’ (Urphantasien), Freud fa una descrizione puntuale e dettagliata della scena primaria (Urszene) nel caso clinico de L’uomo dei lupi (1914). Questo scritto è rilevante non solo per la descrizione del fantasma di scena primaria da cui deriverebbe il celebre sogno dei lupi ma anche per una riflessione profonda circa l’origine del fantasma.
Il sogno de L’uomo dei lupi dopo un’analisi dettagliata e puntuale, porta infatti Freud a ricostruire la scena primaria, facendogli inizialmente affermare che ci si troverebbe di fronte ad un avvenimento reale – che risale a un’epoca assai remota (ibid., 512). Freud, ad una prima analisi, ritiene infatti che la finestra che si spalanca improvvisamente nel sogno dei lupi rappresenti la traccia mnestica collegata ad un risveglio pomeridiano inatteso: in un tempo, ricostruito puntualmente e un po’ forzosamente (Musella, 2016), gli occhi del paziente, ancora molto piccolo, si sarebbero aperti improvvisamente ed avrebbero visto il padre possedere la madre in un convulso coito a tergo. Il coito ‘more ferarum’ ripropone uno scenario violento con annesse fantasie sadomasochistiche di esclusione, di sopraffazione e di castrazione cui il bambino partecipa, identificandosi alternativamente con il padre castrante e con la madre castrata.
Nel ricostruire il fantasma di scena primaria, nel caso de L’uomo dei lupi, Freud va incontro ad un lavoro periglioso, procede a tentoni, rettifica e giunge a conclusioni gravide di implicazioni. L’autore si convince di essere arrivato alla soluzione del problema anche se teme di essere giunto a un punto in cui dovrà abbandonare l’appoggio fornito dal materiale dell’analisi e teme di non avere, per questo, il credito del lettore. (ibid., 514). Freud, perplesso, denuncia una mancanza di nesso, di un ponte associativo che conduca dal contenuto della scena primaria a quello della storia dei lupi. Il collegamento sembrerebbe derivare dalla posizione, e solo da quella. (ibid., 519). Sappiamo infatti che i lupi del sogno vennero associati dal paziente ad un’immagine che la sorella maggiore, durante l’infanzia, era solita mostrargli per spaventarlo. Si trattava dell’immagine, contenuta in un libro di fiabe, raffigurante un lupo eretto, con il piede proteso e orribili artigli sporgenti che Freud, a sua volta, aveva associato al padre del ragazzo per via della posizione eretta che lo stesso genitore avrebbe assunto durante il coito di cui il paziente sarebbe stato spettatore.
Una diversa interpretazione dell’origine della scena primaria non tardò ad arrivare con un’aggiunta al testo fatta da Freud nel 1918, nella quale afferma come non ci sia più bisogno di ricorrere alla supposizione – ostica per molti di noi – che i genitori avessero compiuto un atto sessuale in presenza del proprio bambino (ibid., 533). Per questa via, si arriva direttamente alla caduta della verità storica a favore del primato del fantasia. Sempre nel 1918, Freud aggiunge che, presumibilmente, il rapporto sessuale osservato dal bambino non fu tra i genitori ma tra animali e fu, conseguentemente, spostato sui genitori, come se il bambino avesse presunto che anche i genitori lo facessero in quel modo (1915-17: 526, 532). Il piccolo potrebbe non avere visto affatto i genitori copulare e, di conseguenza, tutta la ricostruzione storica e cronologica, con relativo risveglio rappresentato nel sogno dall’apertura della finestra, crolla come un castello di carte in favore del primato del fantasma.
Rileggiamo, quindi, il sogno dei lupi come la conseguenza di uno spostamento, già prodottosi in età infantile, tra il fantasma della scena primaria, il demone della castrazione e gli animali osservati durante l’accoppiamento. Da qui a considerare anche la percezione dell’accoppiamento animale come un elemento accessorio e incidentale alla rappresentazione della scena, il passo è breve.
Nella lezione 23, dell’Introduzione alla Psicoanalisi(1915-17:526), Freud dichiara che le fantasie originarie hanno un carattere ereditario e vengono trasmesse filogeneticamente. La psiche degli esseri umani sarebbe organizzata sulla base di principi organizzatori che, prescindendo dall’esperienza individuale, affonderebbero le loro radici in contenuti collettivi e trans individuali. Come afferma Green (1990, 50), se ci sono pochi dubbi sull’universalità dei fantasmi originari ne rimangono molti per quanto riguarda la loro origine. Secondo Freud (1914, 590) si tratterebbe di, schemi filogenetici innati, che, al pari di “categorie” filosofiche, presiedono alla classificazione delle impressioni che derivano dall’esperienza. Un sapere istintivo, patrimonio genetico, che costituirebbe il nucleo dell’inconscio, una sorta di attività mentale primitiva (ibid., 591). Non essendo scientificamente sostenibile l’ipotesi di una memoria in cui sono iscritti i sedimenti dell’evoluzione storica della civiltà umana (ibid., 590)[1], che si tramanderebbe lamarkianamente (ereditarietà dei caratteri acquisiti cui Freud restava sorprendentemente affezionato), resta certamente da spiegare l’origine di tali contenuti. Le ipotesi aperte potrebbero essere sostanzialmente due. La prima di derivazione culturalista e la seconda di origine genetica ma indubbiamente non lamarkiana. I fantasmi originari potrebbero essere, come afferma Laplanche (1986), trasmessi per via di una comunicazione inconscia che si tramanderebbe nei primi anni di vita, favorita dalla prematurità dell’infante e dal suo rapporto di dipendenza dalla madre. La seconda ipotesi prevedrebbe invece una forma di ereditarietà psicobiologia, trasmessa geneticamente per via evolutiva, espressione di una sintassi psichica ereditata dall’uomo che predisporrebbe all’iscrizione dei cosiddetti fantasmi originari, i quali potrebbero rappresentare, da questo punto di vista, degli organizzatori elementari che avrebbero la funzione di fondare l’inconscio umano.
Bibliografia
Dias B. G. & Ressler K. J. (2014). Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in subsequent generations. Nature Neuroscience, 17, 89–96.
Freud S. (1914). Dalla storia di una nevrosi infantile (caso clinico dell’uomo dei lupi) O.S.F.,7.
Freud S. (1915-17). Introduzione alla Psicoanalisi O.S.F., 8.
Green A. (1990). Il complesso di castrazione. Borla, Roma, 1991.
Laplanche J. (1986). De la théorie de la seduction restreinte à la théorie de la seduction généralisée. Etudes freudiennes, 27, 7-25.
Musella R. (2016). Tre piani di interpretazione del sogno in Freud. Riv. Psicoanal., 62, 73-97.
Nota
[1] Recenti scoperte della biologia (Dias e Ressler, 2014) affermano che alcune esperienze acquisite (nello specifico si tratta di esperienze olfattive in ratti da laboratorio) possono essere tramandate da una generazione all’altra ma non oltre la terza generazione.
Scissione dell’Io

Picasso, 1937
Scissione dell’Io
A cura di Maria Moscara
Freud all’inizio della sua opera usa il termine scissione (“spaltung”) per designare i processi di separazione nel funzionamento psichico conseguenti ad un conflitto. Successivamente preciserà l’inquadramento metapsicologico e utilizzerà il termine scissione per indicare fenomeni psichici differenti. Di seguito delineerò le principali tappe del pensiero Freudiano e di alcuni Autori che hanno sviluppato il concetto.
Freud e la Scissione dell’Io
Freud si occupa della scissione sin dai primi lavori (1892-95) e fino al 1938. La scissione, inizialmente, in continuità con Breuer e Janet, compare nell’accezione di dissociazione della coscienza come meccanismo psichico di difesa da un traumatismo; in questa accezione lo usa anche nel 1912 per differenziare i pensieri e i processi psichici in “consci” ed “inconsci”. Nel 1915 parla di “scissione dell’Io” per descrivere come nella melanconia una parte dell’Io si contrapponga all’altra e individua nella scissione il meccanismo che consente la formazione “dell’istanza critica”.
La scissione è implicata nel passaggio dal principio di piacere al principio di realtà (1920) e nei processi di sviluppo dell’apparato psichico permettendone la differenziazione in sistemi (1922); la stessa formazione del Super Io avviene per “separazione” dall’Io. Riconosce che vi è sempre una diminuzione della compattezza ed unità dell’Io nelle psicosi (1923). Nel 1927 la scissione dell’Io è l’esito di una reazione ad un trauma ed, in particolare, il risultato del meccanismo difensivo del diniego. Qui per Freud la scissione è, a tutti gli effetti, un meccanismo difensivo che compromette la funzione sintetica dell’Io in modo insanabile e duraturo, producendo “una lacerazione dell’Io che non si cicatrizza e si approfondisce col tempo. Le reazioni antitetiche al conflitto permangono entrambe come nucleo della scissione dell’Io” (1938a:558).
Nei lavori della maturità (1938b), la scissione dell’Io si connota come concetto metapsicologico. Freud introduce l’aspetto economico quando parla di “forza” e l’aspetto dinamico quando evidenzia che esistono due impostazioni contrastanti ed indipendenti nella vita psichica, di cui una appartiene all’Io, l’altra rimossa appartiene all’Es. La scissione è topicamente inconscia in quanto processo psichico ubiquitario (come avviene nel sogno e nella formazione del Super Io) e meccanismo difensivo.
La scissione come meccanismo difensivo incrocia altri concetti. La rimozione nella teorizzazione della prima topica (1894) spinge il contenuto rimosso nell’Inconscio; nella seconda topica (1922) l’Io rimuove sotto la pressione del principio di realtà e del Super-Io. Dal punto di vista economico la rimozione è più costosa della scissione che risulta più accessibile per un Io più debole (Kernberg 1966; Speziale Bagliacca 2004).La negazione (1925) è un meccanismo difensivo deputato ad eliminare dalla coscienza un settore della realtà esterna o interna in contraddizione con l’Io senza comprometterne la funzione sintetica.
La scissione incrocia anche le tematiche dei rapporti dell’Io con la realtà e con la processazione dei dati percettivi poiché opera su percezioni distinte della realtà esterna, di cui rinnega dei dati e nega l’esistenza del rapporto tra due distinte percezioni (1927). La scissione come meccanismo difensivo permette che contenuti nettamente contraddittori tra loro siano nel sistema Conscio avvertibili dal paziente anche se, in ciascun momento, l’uno ignora l’altro.
La scissione dell’Io è uno dei costrutti teorico-clinici più generativi della psicoanalisi fino ai giorni nostri. M. Klein ne enfatizza l’aspetto dinamico: ”a seguito delle interpretazioni dei motivi specifici di una scissione si producono progressi nella sintesi e nell’integrazione” (1946:430). Tale cambiamento di ottica pone nuovi interrogativi sulle possibili evoluzioni della scissione e sulla struttura dell’Io che la scissione ha indotto.
La Scissione dell’Io negli Autori successivi
Klein (1946) utilizza il termine scissione per designare uno dei meccanismi difensivi dell’Io attivi nelle prime fasi di vita contro l’angoscia primaria che ha la finalità di disgiungere e separare l’odio dall’amore. La scissione riguarda l’oggetto primario ancor prima dell’Io ed è strettamente connessa alla pulsione distruttiva che viene proiettata sul seno materno; contrassegna la posizione schizo-paranoide insieme ad altri meccanismi difensivi (idealizzazione, diniego e proiezione) attivi nell’Io primitivo. Nonostante l’azione di tali meccanismi l’angoscia di distruzione rimane attiva e l’Io tende a frammentarsi. L’Io è indebolito da un uso massiccio di scissione che comporta l’espulsione di sue componenti nel mondo esterno.
M. Klein (1957) enfatizza la funzione della scissione come processo psichico di base fisiologico essenziale per il contenimento dell’angoscia e per avviare i processi integrativi dell’Io precoce. L’Io precoce separa l’oggetto buono da quello cattivo accrescendo la sicurezza dell’Io. Al contempo sottolinea l’aspetto quantitativo della scissione quando la collega all’idealizzazione: una scissione molto profonda indica la divisione tra oggetto idealizzato ed oggetto persecutorio.
R. D. Fairbairn partendo dal sogno e dalla teorizzazione sulla formazione del Super-Io evidenzia la natura fisiologica della scissione; descrive la scissione in azione ab origine che determina la formazione delle istanze psichiche a partire “da un’originaria e unitaria struttura egoica dinamica” che si scinde formando “l’Io centrale e due Io sussidiari” (1946 p181). Dal punto di vista psicogenetico collega la scissione ad una fissazione nella fase orale precoce (1946); la scissione compromette lo sviluppo progressivo delle funzioni adattative dell’Io. Approfondisce (1940) le manifestazioni cliniche della scissione nelle patologie gravi e nei riadattamenti nelle diverse fasi del ciclo della vita, anticipando le teorizzazioni più recenti sul funzionamento psichico differenziato a seconda delle circostanze di vita e dei livelli di attivazione emotiva con cui la persona si confronta.
Per W. Bion la scissione è uno dei meccanismi difensivi primitivi come identificazione proiettiva e proiezione. Nella psicosi vi è “una scissione minuta” (1967:74) che produce una estrema frammentazione della personalità. Bion critica l’uso intercambiabile di scissione e dissociazione; propone di usare scissione per ”quanto si verifica nei pazienti più gravi” e dissociazione quando si riferisce agli “aspetti benigni del fenomeno che riflettono l’attività separativa eseguita dalla parte non psicotica della personalità” (1967:109-110). La dissociazione attacca le funzioni integrative dell’Io.
Gli Autori della Psicologia dell’Io, attenti alle funzioni integrative dell’Io, correlano la scissione alla dissociazione e alla depersonalizzazione. Per Federn la depersonalizzazione è “esperienza soggettiva di disgregazione del proprio Io” (1952:252) e riconosce nella perdita di continuità dell’Io un sintomo cardine della depersonalizzazione. Nunberg (1974) riconosce la presenza di una lacerazione dell’Io nella depersonalizzazione. Per E. Jacobson (1957) il diniego è alla base della scissione, sottolinea che essa svolge una funzione anche nella vita normale, individua nella depersonalizzazione una scissione dell’Io e delle rappresentazioni del Sé (1959).
Nella Psicologia del Sé lo studio della scissione dell’Io diviene più complessa poiché molti Autori usano i termini Io e Sé in modo intercambiabile.
Kernberg (1952) nota come negli scritti psicoanalitici compaia sia il termine “scissione della personalità” (Ferenczi 1932; M. Klein 1946) sia “scissione della psiche” (Kohut 1971) senza una chiara distinzione.
Alcuni Autori parlano di scissione della psiche trasversale e verticale (Hinshelwood 1989; Kohut 1977; Meltzer 1971).
Per Kernberg (1952) la scissione è il prodotto naturale di quella che all’origine della vita psichica era un’assenza fisiologica della capacità integrativa dell’apparato psichico che, poi, diventa operazione difensiva essenziale per l’Io primitivo. Esaminando l’aspetto economico della scissione ritiene che una scissione eccessiva, patologica ostacoli l’integrazione degli affetti, del Sé e lo sviluppo del mondo rappresentativo nel suo complesso. Sottolinea, inoltre, che la scissione dell’Io è la strategia difensiva tipica delle strutture borderline e ha l’effetto di “tenere separati gli stati affettivi primitivi contraddittori inseparabilmente collegati a relazioni oggettuali interiorizzate patologiche” (1966:21).
Il costrutto teorico-clinico della scissione è fecondo di approfondimenti anche in anni recenti (Bayle e Altri 1996, AA 2007) gli psicoanalisti ne hanno approfondito, la relazione con gli altri meccanismi difensivi, la metapsicologia, gli effetti sulle funzioni sintetiche dell’Io.
R. B. Blass (2015) ricostruisce come gli psicoanalisti abbiano via via ampliato il concetto di scissione dell’Io di Freud e come il concetto di scissione per dissociazione si sia evoluto nel pensiero di Ferenczi (1932) e di Kohut (1971), mentre le teorizzazioni sulla scissione dell’oggetto si siano evoluti nei modelli di Klein (1946) e Kernberg (1966).
BIBLIOGRAFIA
AA (2007) 12° Colloquio franco-italiano di psicoanalisi: “Rimozione e scissioni nell’attività clinica oggi”, Venezia, 24-25-11-2007
- Bayle e Altri (1996) Les clivages, Revue Française de Psychanalyse, LV
Bion W. (1967) Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico, Armando, Roma, 2009
Blass R. B. (2015) Conceptualizing splitting: On the different meanings of splitting and their implications for the understanding of the person and the analytic process, Int J psychoanal 2015, 96: 123-139
Fairbairn W.R.D (1940) Fattori schizoidi nella personalità in: Studi psicoanalitici sulla personalità, Boringhieri, To, 1992
Fairbairn W.R.D (1946) Relazioni oggettuali e struttura dinamica in: Studi psicoanalitici sulla personalità, Boringhieri, To, 1992
Federn P. (1952) Psicosi e Psicologia dell’Io, Boringhieri, To, 1976
Ferenczi S. (1932): Confusione di lingue tra gli adulti e il bambino in: Opere, Cortina, Mi, 2002
Freud S. (1892-95) Studi sull’Isteria, O.S.F.,I, Boringhieri, To
Freud S. (1894) Le neuropsicosi da difesa, O.S.F.,II, Boringhieri, To
Freud S. (1912) Nota sull’inconscio in psicoanalisi, O.S.F.,VI, Boringhieri, To
Freud S. (1915) Lutto e Melanconia, O.S.F., VIII, Boringhieri, To
Freud S. (1920) Al di là del principio di piacere, O.S.F.,IX, Boringhieri, To
Freud S. (1921) Psicologia delle Masse ed Analisi dell’Io, O.S.F.,IX, Boringhieri, To
Freud S. (1922) L’Io e l’Es, O.S.F.,IX, Boringhieri, To
Freud S. (1923) Nevrosi e Psicosi, O.S.F.,IX, Boringhieri, To
Freud S. (1925) La negazione, O.S.F., X, Boringhieri, To
Freud S. (1927) Feticismo, O.S.F., X,Boringhieri, To
Freud S. (1938a) La Scissione dell’Io nel processo di difesa, O.S.F.,XI, Boringhieri, To
Freud S. (1938b) Compendio di psicoanalisi, O.S.F.,XI, Boringhieri, To
Glover E. (1943) La Nascita dell’Io, Astrolabio, Roma, 1971
Hinshelwood R. D. (1989) Dizionario di Psicoanalisi Kleiniana, Cortina, Mi,1990
Jacobson E. (1964) Il Sé e il mondo oggettuale, Martinelli, Fi, 1974
Jacobson E. (1957) Diniego e rimozione in: La depressione, Martinelli, Fi, 1977
Jacobson E. (1959) La depersonalizzazione in: La depressione, Martinelli, Fi, 1977
Kernberg O. (1952) La teoria e la sfida di Fairbairn in: W. R. D. Fairbairn: Studi psiconalitici sulla personalità, Bollati Boringhieri, To, 1970
Kernberg O. (1966) Derivati strutturali delle relazioni oggettuali in: Teoria della relazione oggettuale e clinica psicoanalitica, Bollati Boringhieri, To,1980
Kernberg O. (1975) Traslazione e controtraslazione nel trattamento di pazienti bordeline in: Teoria della relazione oggettuale e clinica psicoanalitica, Bollati Boringhieri, To, 1980
Klein M. (1946) Note su alcuni meccanismi schizoidi, Boringhieri, To, 2006
Klein M. (1957) Invidia e gratitudine, Martinelli, Fi, 2000
Kohut H. (1971) Narcisismo e analisi del Sé, Boringhieri, To, 1976
Kohut H. (1977) La Guarigione del Sé, Boringhieri, To, 1980
Meltzer D. (1971) Il processo psicoanalitico, Armando, Roma, 1981
Nunberg H. (1932) Teoria delle nevrosi, Astrolabio, Roma, 1974
Perrotti N. (1960) Contributo allo studio della depersonalizzazione, in: L’Io legato e la libertà, Astrolabio, Roma, 1989
Speziale Bagliacca R. (2004) Ubi Maior, Astrolabio, Roma
Searles H.F.

H.F. SEARLES
Parole chiave:H.F. Searles, Chesnut lodge, Psicoanalisi, Psicosi, Depressione
H.F. SEARLES
(1918-2015)
A cura di L. Masina
Note biografiche
Harold Frederic Searles, psichiatra e psicoanalista statunitense, nacque ad Hancock (New York) nel 1918 e morì a Los Angeles nel 2015 all’età di 97 anni. Trascorse l’infanzia nello stato di New York, nella regione dei monti Catskill, che così ricorda nella prefazione del suo volume “L’ambiente non umano nello sviluppo normale e nella schizofrenia,”
“…Sicuramente, per me, la regione di Catskill, nel nord dello stato di New York, possiede un incanto perenne, una bellezza ed una conferma della bontà della vita che saranno con me fintanto che vivrò.” (1960, XXXI).
Aveva una sorella maggiore di 4 anni; tra le loro due nascite vi era stato un altro fratello, un bambino nato morto, della cui esistenza entrambi seppero solo molti anni dopo, in occasione della scomparsa di uno dei genitori. L’Autore descrive in un volume pubblicato nel 1980 – che consiste in una lunga intervista “auto-analitica” (Souffir, 2005) condotta da Robert Langs – la sua infanzia come traumatica e i genitori come entrambi capaci di incutere paura. (Langs & Searles, 1980).
Ogden (2009) nel riferire di una supervisione svolta con Searles, riporta come questi avesse fatto più volte riferimento “allo sconsolato riconoscimento dell’impossibilità di stabilire un affidabile collegamento […] con la propria madre schizofrenica”. Altrove (1980) Searles descrive le caratteristiche schizoidi e depressive della madre. Del padre, definito, “sciovinista, maschilista e razzista”, riferisce le propensioni suicidiarie, che si concretizzavano nell’angoscia che lo psicoanalista da bambino provava per la vicinanza della casa dell’infanzia alla ferrovia e nel timore che il genitore non rientrasse, quando si recava su un ponte a buttare la spazzatura nel fiume. “Avevo avuto così tanti anni di minacce implicite di suicidio da lui (searles,1980)” e riferisce dei sentimenti di angoscia e dei sensi di colpa provati nei confronti dei genitori. Al contempo, nell’intervista con Langs, accanto alle dure critiche nei confronti del padre, non manca di fornire un ritratto emotivamente denso delle qualità paterne, quali il senso dell’umorismo e la grande abilità di narratore di storie, ricordando come da bambino trascorresse lunghe ore nel suo negozio di abbigliamento, ascoltandone, affascinato, i racconti.
Iniziò gli studi di medicina alla Cornell University e, a proposito di quel periodo, scrive che durante il secondo e il terzo anno di corso “evitò di poco un breakdown schizofrenico” (ibidem,12). A questo proposito, successivamente si espresse così: “Nel periodo degli studi universitari provai un’angoscia così intensa che restai affascinato, e per sempre, da quella cosa arcana e intangibile che è la personalità dell’uomo e mi prese il desiderio di capire le misteriose forze che o la fanno funzionare in modo adeguato o ne determinano la dissoluzione oppure fanno sì che essa si ristrutturi e continui a maturare. Allorchè, nove anni dopo, ebbi finalmente la possibilità di ottenere un ausilio psicoterapeutico sotto forma di analisi didattica, ero consapevole che tale analisi […] mi era necessaria; e non solo per scopi puramente didattici. Posso dire che il vantaggio che ne trassi corrispose ai miei bisogni.” (1965, 19)
Si trasferì nel 1940 ad Harvard e, pur avendo progettato di diventare un internista, durante una turnazione in psichiatria, rimase affascinato da questa disciplina. Scrisse in seguito, “…Sentivo che avrei potuto diventare un internista competente, ma niente di più, mentre la psichiatria mi appassionava.” (1980, 22) (trad.mia) Prestò servizio come medico nell’esercito durante la seconda guerra mondiale e in quegli anni cominciò a leggere Freud e altri testi di psicoanalisi finché, terminato il periodo bellico, decise di diventare psicoanalista.
Prima della guerra aveva sposato Sylvia, laureata in discipline infermieristiche e conosciuta in un reparto di ortopedia del Massachussetts General Hospital. Al termine della guerra, la coppia decise di stabilirsi a Washington D.C. perché Searles era a conoscenza del fatto che vi erano molti analisti in zona e aveva intenzione di intraprendere un trattamento analitico. Il suo analista fu Ernest Hadley, un “analista classico”, come egli lo definì, che aveva avuto un rapporto molto significativo con H. S. Sullivan, nonostante non fosse, secondo quanto l’Autore afferma, un seguace di Sullivan. Della propria analisi con Hadley, alla frequenza di 5 sedute settimanali, fra le altre cose, egli scrisse, “…La mia grandiosità era un aspetto su cui [il mio analista] lavorò molto. Arrivò a chiamarmi, ironicamente, Dio Searles.” (1980, 31).
Al termine dell’analisi regalò ad Hadley, appassionato di cavalli, la statuetta di un toro, regalo che ha così commentato nell’intervista di Robert Langs (1980), “…Penso che il toro esprimesse la mia ostinazione, il mio andare controcorrente, la corrente convenzionale (53) (trad. mia).”
Iniziò in questo periodo a lavorare nella celebre clinica Chestnut Lodge di Rockville, nel Maryland, allora diretta dallo psichiatra Dexter Bullard, dove si integravano le concezioni della psichiatria dinamica con l’approccio interpersonale di H.S. Sullivan. Esercitò a Chestnut Lodge dal 1949 al 1964, divenendo uno dei più originali e creativi teorici e clinici nel trattamento della schizofrenia e dei disturbi borderline.
Completò il proprio training psicoanalitico presso il Washington Psychoanalytic Institute e divenne analista di training nel 1958. In seguito fu consulente psichiatra dal 1962 al 1970 e supervisore dal 1962 al 1978 presso il Bethesda Institute nel Maryland. Dal 1964 insegnò psichiatria alla Georgetown University School of Medicine di Washington ed esercitò al contempo come psicoanalista e psichiatra libero professionista a Washington D.C. Tenne conferenze, seminari e dimostrazioni a scopo didattico di colloqui clinici.
Infine, dopo una lunga carriera, si ritirò dalla professione a metà degli anni ‘90 e si trasferì in California nel 1997.
Alla sua morte ha lasciato 3 figli, 5 nipoti e 8 bisnipoti.
Il lavoro e il pensiero di Searles nel panorama psicoanalitico.
Harold Searles racconta che le sue prime letture psicoanalitiche furono le opere di Freud. In seguito la sua posizione teorica è stata collocata, sulla scia di Sullivan, nell’ambito della cosiddetta psicoanalisi interpersonale. L’Autore stesso ha scritto che ammirava Sullivan e lo riteneva brillante, malgrado la sua “grandiosità”, che era, a suo parere, “enorme” e riconosce il contributo di Sullivan nella genesi del proprio pensiero; tuttavia Langs (1980) ha osservato che, a differenza di Sullivan, Searles ha saputo combinare molto sapientemente l’ambito dell’intrapsichico con quello dell’interpersonale. Sembra dunque di poter rintracciare nel suo pensiero una cifra del tutto originale. Egli ha molto valorizzato l’apporto che gli è derivato dal milieu di Chestnut Lodge, un’istituzione che fu per lui molto importante e nei cui confronti scrisse di aver nutrito un potente transfert paterno: “Quel posto rappresentava mio padre per me” (1980, 35) (trad. mia).
A proposito di Chestnut Lodge, l’Autore ha efficacemente descritto che cosa rendeva “quel posto” così unico: “…Non è solo che i pazienti lì sono molto malati, ma difficilmente ti coinvolgi con loro allo stesso modo in qualsiasi altra parte del mondo, su una sorta di base personale e con un’intensità ed una vicinanza che sono realmente roba potente” (1980) (trad. mia). Scrisse che anche l’ambiente non umano faceva parte del suo attaccamento a quel luogo “molto bello,” al quale anche i pazienti erano profondamente legati.
Fra gli analisti di maggior rilievo per la sua formazione, egli ha ricordato, oltre ad Ernest Hadley, Edith Weigert, che fu il suo primo supervisore.
Un’altra figura importante fu per lui, Frieda Fromm Reichmann, anche lei appartenente allo staff di Chestnut Lodge e a sua volta influenzata da Sullivan. Searles (1981) scrive che il suo rapporto con la Fromm Reichmann era caratterizzato da una notevole ambivalenza: egli la ammirava e imparò molto da lei, pur non essendo fra i suoi amici intimi o fra i suoi studenti prediletti. Frieda lo aiutò, tuttavia, ad ottenere un grant che rese possibile la pubblicazione del suo primo libro e quando ella organizzò un gruppo di ricerca all’interno del Lodge all’inizio degli anni ‘50, lui fu uno dei quattro colleghi che scelse per costituirlo. L’Autore (1981) racconta un episodio significativo a proposito del suo rapporto con Frieda, che viene riassunto anche nella biografia di Frieda Fromm Reichmann, scritta da Gail Hornstein:
“Molti anni più tardi quando i Bullard convertirono il cottage di Frieda in uffici, Harold Searles ebbe la sua camera da letto. Egli spesso lavorava lì da solo fino a tardi la notte e nei weekend. Per molti mesi si sentì visitato dal suo fantasma, <una presenza ostile e minacciosa da qualche parte nella casa>. Infine il fantasma divenne amorevole e protettivo e Searles si rilassò e lasciò che si prendesse cura di lui. Egli più tardi disse che la sua ostilità inconscia verso Frieda [ e-aggiunge Searles nel testo originale- “la componente ostile dei sentimenti di lei nei miei confronti” (1981, 176)] e la sua identificazione con la solitudine [della Fromm Reichmann] lo avevano portato a percepire il fantasma” ( Hornstein, 2005, 339) (trad. mia).
In questa stessa biografia della Fromm Reichmann, Searles viene duramente criticato da vari punti di vista, peraltro a fronte di una celebrazione delle doti cliniche e teoriche della Fromm Reichmann. Fra le varie critiche che la Hornstein gli rivolge, vi è quella che riguarda Mrs. Douglas, pseudonimo della gravissima paziente schizofrenica, il cui trattamento si protrasse per ben 38 anni, a detta della Hornstein senza evidenti miglioramenti; peraltro, ella stessa definisce la paziente “una delle più disturbate mai ricoverate a Chestnut Lodge” (2000, 376).
Souffir (2005) afferma, a giusta ragione, che il lavoro di questo Autore non va valutato in termini di risoluzione dei sintomi o di ritorno del paziente ad una “vita normale”, quanto piuttosto va considerata l’importanza per questi gravissimi pazienti di aver fatto un’esperienza di tale profondità con un analista così coraggioso da aver lavorato con loro letteralmente “tra la vita e la morte.”
D’altra parte, giova ricordare quanto afferma Ogden (2009) a proposito “dell’intensa rabbia che Searles notoriamente suscitava nell’uditorio a cui presentava il suo lavoro. Searles rifiuta di smussare gli angoli di una esperienza. Leggere il suo lavoro non è una esperienza di arrivo ad una comprensione; è un’esperienza di essere rudemente portati ad aprire gli occhi su verità sconcertanti a proposito della propria esperienza con i propri pazienti.” (215)
Fra coloro con cui l’Autore ebbe un rapporto molto significativo sotto il profilo non solo professionale, ma anche umano, va ricordato Ping Nie Pao, un altro analista di Chestnut Lodge, suo intimo amico per molti anni, che viene rievocato nella toccante ed intensa esperienza di supervisione con Searles riportata da Ogden nel suo scritto “Sulla supervisione psicoanalitica”. (2009)
Ferenczi è stato un precursore delle teorie delle relazioni oggettuali e certamente anche del pensiero dello psicoanalista americano: la questione della simmetria e dell’asimmetria nella relazione analitica costituisce un trait d’union fra i due Autori. Entrambi hanno, in modi differenti, approcciato il problema e sono stati considerati degli anticipatori delle implicite attenuazioni dell’asimmetria analitica contenute nelle teorizzazioni delle prospettive interpersonali, relazionali, intersoggettive e della psicologia del sè .( Turnbull, 2018)
Scrive Aron (1996, 98,99), “…Nella psicoanalisi c’è una tradizione-anche se è sempre rimasta alla periferia dell’evoluzione ufficiale della psicoanalisi-che ne ha sottolineato l’aspetto mutuo. Questa tradizione è cominciata con gli scritti di Groddeck (1923) e Ferenczi (1932) ed è andata avanti specialmente grazie al lavoro di Harold Searles (1975, 1979).”
A questo proposito, di quest’ultimo va ricordato lo scritto “Il paziente come terapeuta del proprio analista” del 1975, in cui descrive “una simbiosi [terapeutica] che promuove mutualmente la crescita”. Partendo dalla considerazione che sovente i pazienti si ammalano a causa dei tentativi psicoterapeutici frustrati nei confronti dei loro genitori, egli sostiene che analoghi tentativi nel transfert vengano attivati nei confronti dei terapeuti e che il successo degli sforzi riparativi dei pazienti possa alleviare la loro colpa e farli sentire “più pienamente umani” (Aron, 1996).
Irwin Hoffman (1983) ha collocato Searles, insieme a Gill, Levenson, Racker e Watchel tra gli autori che hanno teorizzato una concezione del transfert che implica un’attenzione particolare al ruolo dell’analista, ritenendo che il transfert non sia il risultato di una distorsione del paziente indipendente dalla personalità dell’analista e dal suo comportamento reale. Secondo questo approccio teorico, l’analista partecipa all’analisi influendo sulla co-creazione del transfert. (Aron, 1996)
Searles viene anche annoverato da Aron (1996) fra gli Autori che per primi hanno contribuito all’utilizzo della self-disclosure, che negli anni successivi è stato sempre più discusso e sviluppato. Tuttavia, lo psicoanalista americano ha compiuto un’importante distinzione, che lo differenzia da altri analisti, soprattutto di orientamento interpersonale, tra il disvelamento al paziente di ciò che avviene al terapeuta in seduta e il disvelamento degli accadimenti che riguardano la vita dell’analista al di fuori dell’analisi. Egli ha scritto: “Ho sempre espresso liberamente i sentimenti e le fantasie che provo nel corso della seduta, ma ai pazienti racconto molto poco della mia vita fuori dallo studio (1975, 335)”
Kernberg (2005) afferma che Searles nel formulare una teoria del trattamento dei pazienti psicotici e borderline ha integrato i concetti kleiniani mutuati dal pensiero di Rosenfeld e Bion con l’influenza di Sullivan. Giovacchini (1993) ritiene che Melanie Klein abbia incoraggiato molti autori, anche di differenti orientamenti teorici, fra i quali annovera Searles, ad occuparsi di pazienti adulti o bambini che in precedenza sarebbero stati considerati non analizzabili.
Tuttavia, Searles ha un atteggiamento critico nei confronti delle interpretazioni di transfert basate sulla identificazione proiettiva utilizzate dagli analisti kleiniani, con pazienti gravemente regrediti, ritenendo che si rivolgano alle parti non psicotiche delle personalità e che sia difficile comprendere se siano d’aiuto al paziente per l’accuratezza del loro contenuto o non siano piuttosto i sentimenti di sicurezza e comprensione che veicolano, ad essere importanti per il paziente. Egli sostiene di aver lavorato con pazienti profondamente non differenziati per anni, prima che essi potessero distinguere fra un “interno” e un “esterno”. (Kernberg, 1993). Ogden rintraccia ed illustra “una complementarità fra il lavoro di Searles e quello di Bion”, in particolare per ciò che concerne il concetto bioniano di contenitore-contenuto, il bisogno umano della verità e la concezione di Bion della relazione fra esperienza conscia e inconscia (Ogden, 2009).
Infine, va ricordato che durante la sua vita, Searles ritenne che il suo pensiero non fosse stato tenuto nel debito conto da figure di spicco della psicoanalisi americana, quali Edith Jacobson e Margaret Mahler. Le relazioni che egli tenne presso l’Associazione Psicoanalitica Americana venivano apprezzate dal pubblico, ma considerate con sufficienza dai suoi discussant, che giudicavano illusorio il trattamento psicoanalitico degli psicotici (Souffir, 2005). Invece le sue idee ebbero una risonanza significativa presso analisti inglesi, quali Donald Winnicott e Margaret Little, che condividevano la possibilità di un approccio psicoanalitico ai pazienti psicotici e borderline. (ibidem). Egli riscosse, inoltre, grande successo presso un vasto pubblico di analisti che apprezzavano il suo stile originale e le sue straordinarie intuizioni.
Il pensiero di Searles: originalità e innovazione
Una caratteristica peculiare di questo Autore è quella di attingere alla propria esperienza personale per formulare le riflessioni teoriche e cliniche in modo da incrementare la propria efficacia comunicativa e conferire ai suoi scritti una cifra assolutamente unica e peculiare.
Ogden (2009) ha scritto di lui:
“Harold Searles è, secondo me, senza pari per la sua abilità di tradurre in parole le osservazioni che riguardano le sue risposte emotive a ciò che si sta verificando nella situazione analitica, e per l’uso che fa di queste osservazioni nel suo sforzo di comprendere e interpretare il transfert-controtransfert (p.205).”
E sempre Ogden ha evidenziato la “squisita sensibilità” di questo psicoanalista “alle comunicazioni inconsce del paziente. Tale recettività alle comunicazioni inconsce del paziente richiede da parte dell’analista una forma di messa a nudo della sua propria esperienza inconscia. Il modo di Searles di usare sé stesso analiticamente implica molto spesso un venir meno alla distinzione tra la propria esperienza cosciente e inconscia, così come della distinzione tra la sua esperienza inconscia e quella del paziente.” (ibidem, 205).
L’esperienza sorprendente nella lettura degli scritti dello psicoanalista americano è quella del passaggio dalla sua vita interiore e dalla sua risposta straordinariamente intuitiva e percettiva di ciò che accade nella relazione analitica, al contesto psicologico del paziente e al modo in cui egli percepisce sé stesso. Dai suoi scritti e dai suoi resoconti clinici in particolare emerge come “l’esperienza cosciente e inconscia sono qualità di una coscienza unitaria, e che noi abbiamo accesso alla dimensione inconscia dell’esperienza guardando dentro l’esperienza cosciente, non guardando “dietro” o “al di sotto” di essa (ibidem, 230).
Nella già citata supervisione con Searles riportata da Ogden (2009), risaltano, a mio avviso, due elementi assai significativi e peculiari di questo psicoanalista così fuori dall’ordinario, vale a dire la sua capacità di creare “un’intimità senza riserve” con chi gli stava di fronte, sgombrando rapidamente il campo in modo rapido e intenso da ogni “artificio sociale” (ibidem, 2009) e il silenzioso invito all’altro (il supervisionato) “a sperimentare e a parlare da un livello inconscio” di se stesso “e a entrare, e simultaneamente osservare, uno scenario di sogno senza sapere dove il sognare avrebbe portato.” (ibidem, 2009, 70), tanto che Ogden chiama questa esperienza di supervisione “sogno guidato”.
Della prima delle due caratteristiche che ho sottolineato, ossia la capacità di stabilire “un’intimità senza riserve”, è possibile trovare splendidi esempi nei suoi resoconti clinici, fra cui colpiscono in modo particolare quelli dei pazienti più gravi, come questo che segue:
“Spesso, durante le sedute, [la paziente] viveva palesemente il paesaggio esterno come un vortice di automobili in collisione, di treni sferraglianti e di aerei precipitanti al suolo. Fu un momento memorabile quando, molti mesi dopo, mentre eravamo seduti fianco a fianco su due sedie vicine, guardando verso le finestre situate sul lato opposto della stanza, io iniziai a dire qualcosa e lei mi fermò con un ordine calmo, ma fermo: “Stia zitto e guardiamo il panorama”; al che ci abbandonammo al placido, rilassato sentimento di comunione che stavamo vivendo .Sentii a questo punto per la prima volta in tutto il mio lavoro con lei, che finalmente stavamo entrambi vedendo lo stesso dolce panorama dalla finestra”. (Searles, 1960, 292)
Di recente è stato scritto anche che Searles ha così attentamente investigato le “emozioni intollerabili” dentro di lui, nella convinzione che ciò fosse indispensabile per contattare nei pazienti gli stessi stati della mente (Shah, 2023). Ha esplorato sentimenti, quali la gelosia e l’invidia nei confronti dei pazienti, che, pur essendo ubiquitari, sono stati raramente trattati, in quanto fonte per gli analisti di vergogna e motivo di ferita narcisistica. In particolare, ha approfondito le possibilità terapeutiche derivanti dall’affrontare il sentimento della gelosia, sperimentato sia dal paziente che dall’analista. La possibilità di esperire ed affrontare la propria gelosia nei confronti del paziente, permette, secondo l’Autore, di comprendere in modo profondo la gelosia del paziente.
E’ stato anche sottolineato come egli ritenga importante e potenzialmente mutativa la consapevolezza del paziente di avere un impatto emotivo sull’analista. (Buechler, 2017)
A conclusione di questo sintetico e necessariamente parziale ritratto di Harold Searles, sembra opportuno riportare le sue parole:
“Spesso le persone ritengono che possieda un’intuizione terapeutica straordinaria, oppure che io sia forse un po’ folle nelle mie risposte apparentemente fuori dagli schemi al paziente, o entrambe le cose. Ma il fatto è che l’esperienza soggettiva che ho con il paziente nella situazione immediata, è monitorata costantemente da una parte del mio Io osservante, in un confronto valutativo con le esperienze cliniche decennali che ho avuto in precedenza, con le centinaia di pazienti che ho intervistato…” (1980, 104)
Bibliografia
Aron L. (1996) Menti che si incontrano. Raffaello Cortina, Milano, 2004.
Aron L., Lieberman A. In memory of Harold Searles.1918-2015. Psychoanal.Dial., (27)(2):182-191.
Arrigoni Scortecci M. La tecnica del trattamento degli stati psicotici. In Semi A.A. (a cura di) Trattato di psicoanalisi. Vol. primo. Teoria e tecnica. Raffaello Cortina, Milano, 1988.
Buechler S. (2017) Psychoanalytic Reflections: Training and Practice. IPBooks, New York.
Giovacchini P. (ed.) (1993) Tactical Approaches: an overview. in Tactics and Techniques in Pshychoanlytic Therapy (vol.1) Aronson, New Jersey.
Hornstein G.A. To Redeem One Person Is to Redeem the World. The Life of Frieda Fromm-Reichmann. Other Press, Milton Keynes-UK, 2005.
Kernberg O. (1993) Critique of the Kleinian School in Giovacchini P. (ed) Tactics and Techniques in Pshychoanlytic Therapy (vol.1) Aronson, New Jersey.
Kernberg O. (2005) Teoria delle relazioni oggettuali e tecnica psicoanalitica in Person E.S., Cooper, A.M., Gabbard G. O. (a cura di ) (2005) Psicoanalisi. Teoria-clinica-ricerca. Raffaello Cortina, Milano, 2006.
Masina L. Dossier “Cure per il creato” a cura di Vessella S., Spiweb.
http://www.spiweb.it/dossier-spiweb/909-cura-per-il-creato
Langs R., Searles H.D. (1980) Intrapsychic and Interpersonal Dimensions of Treatment. A clinical dialogue. Jason Aronson, New York, London.
Lingiardi V. L’eminente clinico americano, pioniere nel trattamento analitico della schizofrenia, scomparso a 97 anni. Il Sole 24 ore, 29 novembre 2015.
Ogden T.H. (2007) Leggendo Harold Searles in Riscoprire la psicoanalisi. CIS, Milano, 2009.
Ogden T.H. (2009) Sulla supervisione psicoanalitica in Riscoprire la psicoanalisi. CIS, Milano, 2009.
Searles H.F. (1960) L’ambiente non umano nello sviluppo normale e nella schizofrenia. Einaudi, Torino, 2004.
Searles H.F. (1965) Scritti sulla schizofrenia. Bollati Boringhieri, Torino, 1974.
Searles H.F. (1979). Il controtransfert. Bollati Boringhieri, Torino, 1994.
Searles H.F. (1986) Il paziente borderline.Bollati Boringhieri, Torino, 1988.
Searles H. F. (1981) Psychoanalytic Therapy with Cancer Patients. Some speculations in Goldberg J.G.(ed) Psychotherapeutic Treatment of Cancer Patients. (1981) Routledge, New York, 2017.
Shah D. (2023) The Analyst’s Torment. Unbearable Mental States in Countertransference. Phoenix Publishing House, Bicester, UK.
Souffir V. (2005) Harold Searles. Presses Universitaires de France, Paris.
Treccani, Enciclopedia on line, voce : Searles H.F.
Turnbull S. (2018) The analyst’s passion and the Other asymmetry in Willock B., Coleman Curtis R., Bohm L.C. (a cura di) (2018) Psychoanalytic Perspectives on Passion. Meanings and Manifestations in the Clinical Setting and Beyond. Routledge, UK.
Self-disclosure
A cura di Ettore Jogan
Il termine self-disclosure (traducibile con autorivelazione) è entrato a far parte del linguaggio psicoanalitico negli ultimi anni e indica uno svelamento cosciente e voluto, da parte dell’analista, di qualche aspetto di sé al paziente. Questa condotta dell’analista entra in contrasto con il setting analitico tradizionale dove si richiede al terapeuta neutralità, astinenza e anonimato. Proprio a causa di questo contrasto il dibattito attorno a questo fenomeno e alla sua collocazione nella tecnica psicoanalitica è ancora aperto.
Il concetto è apparso nell’ambito della psicoanalisi nord- americana nel decennio 1990-2000, periodo in cui numerosi autori si sono dedicati all’argomento.
Dobbiamo inquadrare infatti questo concetto nel contesto dello sviluppo della psicoanalisi nord-americana che, partendo dagli assunti della Psicologia dell’Io (con un’impostazione ancora positivista e l’analista neutrale e “obbiettivo”) è approdata a paradigmi più orientati alla relazione dove l’analista ha un ruolo interattivo e svolge un compito essenziale nell’accompagnare lo sviluppo psichico del paziente.
L’analista non è più considerato “schermo opaco” e neutrale ma costruisce, insieme al paziente, il processo terapeutico. Negli Stati Uniti questo sviluppo è stato influenzato dal contributo della Psicologia del Sé di Kohut e da analisti appartenenti alle correnti di pensiero note sotto la definizione di interpersonalisti e intersoggettivisti.
In Europa invece, in estrema sintesi, il pensiero psicoanalitico di Freud si è progressivamente arricchito di altri paradigmi tra cui quello della “teoria delle relazioni oggettuali” di scuola britannica che ha comunque influenzato a sua volta alcuni analisti nord-americani.
Gli analisti intersoggettivisti americani sono dell’opinione che l’anonimato dell’analista inteso in senso tradizionale è un mito difficilmente sostenibile e che l’analista entra sempre nel rapporto terapeutico con la sua soggettività (Renik 1993,1995). Nella condizione più neutrale egli si autodisvela comunque (self-revelation) attraverso i suoi atteggiamenti, comportamenti, vestiario, arredo dello studio, scelte e modalità interpretative.
Questo tipo di disvelamento rientra in manifestazioni non consapevoli e non determinate, attraverso le quali il paziente riesce in ogni caso a conoscere alcuni aspetti della persona reale dell’analista.
Per brevità di spazio non riesco citare le posizioni di tutti gli autori americani che si sono soffermati sul tema.
A grandi linee mi sembra di capire che ci sono degli analisti che si schierano nettamente contro la self-disclosure (Hanly, 1998) difendendo il setting tradizionale e ci sono degli analisti che sostengono la self-disclosure come un nuovo strumento tecnico da poter usare accanto ad altri approcci, come p.es. il già citato Renik.
Poi c’è un gruppo di “moderati” che ammettono la possibilità di poter ricorrere alla self-disclosure, ma con notevole cautela e dosaggio ben calibrato (Jacobs, 1999).
I primi si preoccupano, attraverso l’anonimato del terapeuta, di tutelare il processo terapeutico e favorire le dinamiche proiettive transferali del paziente (che, con un terapeuta troppo conosciuto sul piano reale, emergerebbero con difficoltà) . In questo modo dichiarano di proteggere anche le specificità della terapia psicoanalitica.
Secondo questi analisti la self-disclosure potrebbe rappresentare una difficoltà controtransferale dell’analista e talora essere espressione di una sua necessità narcisistica di rivelarsi.
I sostenitori della self-disclosure criticano invece l’eccessiva neutralità e anonimato del terapeuta perché sostengono che questa posizione (che può essere vissuta dal paziente come rigida, fredda e distante) inibisce il processo terapeutico e blocca le libere associazioni del paziente.
Per quanto riguarda l’ autorivelazione dell’analista, possiamo prendere in considerazione varie modalità e vari contenuti. Questa può riferirsi a domande dirette provenienti dal paziente, a comunicazioni spontanee dell’analista che fanno parte del vissuto controtransferale, ad ammissioni dei propri errori oppure ad esperienze personali che sono in qualche modo collegate al materiale clinico del paziente.
Sarebbe auspicabile che l’analista, quando decide di autorivelarsi, lo faccia sempre in funzione del paziente e della promozione del processo terapeutico e che riesca, attraverso l’autoanalisi, a bloccare l’ eventuale espressione di bisogni personali.
Con alcuni pazienti e in alcuni momenti dell’analisi queste auto rivelazioni dell’analista funzionerebbero come elemento che stimola il processo terapeutico dove, fra l’altro, l’analista può funzionare come modello d’identificazione e promuovere una maggiore apertura e migliore comunicazione da parte del paziente.
In Italia si sono occupati di questo tema alcuni autori ( es. Meterangelis e Spiombi 2003, Turilazzi Manfredi e Ponsi 1999, Ponsi 1999).
In particolare Turilazzi Manfredi e Ponsi si chiedono se la partecipazione soggettiva dell’analista al processo terapeutico sia qualcosa di diverso rispetto al controtransfert. Per certi aspetti potrebbero essere due concetti sovrapponibili mentre per altri versi non lo sono. Forse il controtransfert con la sua connotazione “contro” potrebbe avere sempre il significato di una reazione al transfert, mentre la partecipazione soggettiva comprenderebbe un coinvolgimento personale dell’analista in senso più complessivo.
A mio avviso la self-disclosure è da prendere in considerazione, sempre in modo moderato e con cautela, con i pazienti gravi, poco strutturati, con notevoli problemi di deficit e non solo di conflitti, che hanno bisogno di vivere con il terapeuta un’esperienza relazionale costruttiva e positiva accanto a tutta l’esperienza transferale negativa che spesso può emergere solo dopo che si è stabilita un’ alleanza terapeutica abbastanza sicura. Con questi pazienti è doveroso, anche se molto difficile, oscillare fra la funzione di oggetto transferale e nuovo oggetto relazionale che cerca di colmare i deficit evolutivi più precoci.
La funzione più classica di analista anonimo, neutrale che favorisce le proiezioni transferali del paziente e le evidenzia attraverso le interpretazioni, risulta talora con i pazienti più compromessi insufficiente. In questi casi, nel tentativo di costruire con il paziente una relazionalità sufficientemente valida, la self-disclosure acquista un senso.
Bibliografia
Hanly C.: Reflections on the analyst’s self-disclosure.Psychoanalytic Inquiry, 18, 1988.
Jacobs T.J.:On the question of self-disclosure by the analyst: Error or advance on technique?Psychoanal Q. 68, 1999.
Meterangelis G., Spiombi G.: La soggettività dell’analista e il grado della sua partecipazione alla costruzione della relazione analitica: il problema della self-disclosure.Riv. Di Psicoanalisi, 3, 2003.
Ponsi M.: La partecipazione dell’analista: un tema emergente nella psicoanalisi nord-americana.Riv. Di Psicoanalisi, 1, 1999.
Renik O.: Analytic interaction: conceptualizing technique in the light of the analyst’sirreduciblesubjectivity.Psychoanal.Q. ,62,1993.
Renik O.: The ideal of the anonymus analyst and the problem of the self-disclosure.Psychoanal.Q., 64, 1995.
Turilazzi Manfredi S., Ponsi M.: Transfert-controtransfert e intersoggettività. Contrapposizione o convergenza?Riv. Di Psicoanalisi, 4, 1999.
Luglio 2014
Self-disclosure

GIOVANNI ANSELMO
Parole chiave: Self disclosure, Psicoanalisi, Owen Renik
SELF-DISCLOSURE 2
di Cristiano Rocchi
La self-disclosure in psicoanalisi può essere intesa come una esposizione al paziente di certi pensieri, idee, fantasie, emozioni, osservazioni dell’analista che possono riguardare l’hic et nunc della seduta in riferimento sia al paziente («…mi pare di percepire un Suo stato d’animo turbato , forse da…»), sia all’analista stesso («…sento crescere in me una forte emozione di malinconia accompagnata da un certo sentimento come di languidezza ; che sia perché …»), sia alla situazione («… è come se si fossero accese improvvisamente delle luci, mentre un attimo fa si era al buio e sono un po’ accecato, forse anche Lei è accecato come lo sono io …»), sia infine al loro rapporto («…sento come se mi avesse abbandonato, trovandosi di fronte a qualcosa che l’ha impaurita…»). Può anche non riguardare l’hic et nunc, ma sempre si riferisce al riconoscimento, con conseguente verbalizzazione, di eventi concernenti la relazione tra analista e paziente. Tali verbalizzazioni avrebbero il fine di consentire al paziente di entrare in contatto con dei “dati” presenti nella seduta che non sono o non erano stati, per vari ordini di ragioni, ri-conoscibili o ri-conosciuti: dati concernenti l’analista e la relazione. Ed attraverso ciò superare la resistenza, che come diceva Wolstein (1989), è spesso un correlato funzionale del controtransfert.
La gamma delle self-disclosure è molto ampia; esse possono essere diverse per grado, intensità, profondità; non è questo l’ambito adatto e neppure mi è concesso lo spazio per poter disquisire di ciò; dico soltanto che è importante che le consideriamo strumenti tecnici, e non artifici; strumenti tecnici che occorre saper maneggiare con grande destrezza difatti i contenuti a cui si riferiscono derivano non di rado da strati profondi della relazione emotiva inconscia tra paziente e analista e possono da quest’ultimo essere utilizzate per una comprensione migliore -e condivisa- dell’esperienza analitica. È ovvio a questo riguardo sottolineare che solo l’analista accorto e maturo può farne un uso appropriato. E inoltre va tenuto presente che la cornice teorica entro la quale questi si muove è una cornice psicoanalitica relazionale, che prevede per esempio quanto scrive P. Heiman: “Un analista che si permette apertamente di pensare “ad alta voce” -mostrando lo sforzo di comprensione e la sua ricerca passo a passo del significato- indica al paziente ch’egli non si ritiene onnisciente e lo invita a dividere con lui i suoi pensieri recando i suoi propri contributi al lavoro di scoperta della verità” (P. Heimann, 1975,c p. 474); discende da ciò anche che un elemento fondamentale nell’uso della self-disclosure è il suo “dosaggio”. Per precisare ulteriormente il concetto ed il suo uso, interessante quanto scrive Edgar A. Levenson, distinguendo la self-disclosure dalla self-revelation. La self-revelation dovrebbe riferirsi a quegli aspetti del terapeuta che inavvertitamente o deliberatamente è possibile che il paziente colga. La self-disclosure dovrebbe riguardare tutto ciò che deliberatamente decide di mostrare (o dire) al paziente (Levenson, 1996).
A differenza di quanto sostengono i critici a priori della self-disclosure, Owen Renik sostiene che secondo le sue osservazioni la self-disclosure non porta ad un’attenzione eccessiva sull’analista a discapito della centralità del paziente. Accade invece proprio il contrario: quanto più l’analista riconosce ed è disponibile a discutere la propria presenza personale nella situazione terapeutica, tanto minore è lo spazio che occupa e quindi ne lascia di più al paziente. L’analista reticente risulta ingombrante, occupando il centro della scena come oggetto misterioso. Il paziente è profondamente consapevole di essere in rapporto con un altro essere umano e il bisogno di conoscerne le intenzioni, le convinzioni, i valori, vale a dire il bisogno del paziente di sapere qualcosa della persona con cui ha a che fare, non scompare, anche se l’analista lo considera irrilevante ai fini della esplorazione della cosiddetta “realtà psichica” (Renik, 1998). Insomma, con una frase: quanto è maggiore il grado di soggettività riconosciuto all’analista, tanto maggiore sarà quello di oggettività garantito al paziente. Sulla stessa linea Jay R. Greenberg (1986), che considera la self-disclosure un importante strumento tecnico per agevolare il consolidamento della necessaria neutralità, che è vista come la posizione in grado di promuovere un tensione ottimale tra l’essere visto come un nuovo e come un vecchio oggetto.
In un lavoro del 2015 in cui svolgevo una disamina della self-disclosure controtransferale, ne individuavo il precursore nell’analisi reciproca di cui S. Ferenczi aveva scritto nel suo Diario clinico. Sostenevo che nonostante il l’insuccesso di quei tentativi, occorresse dare atto a Ferenczi di aver riconosciuto insito nella analisi reciproca un grosso potenziale, che consiste nella disponibilità dell’analista a creare un legame di fiducia quasi totale che può essere raggiunta solo attraverso la sua rinunzia parziale e temporanea alla asimmetria (nel senso classico che gli diamo in psicoanalisi), in quanto quel significato è inestricabilmente connesso con il principio di autorità. Rinunciare a quest’ultimo non vuol affatto dire abbandonare la necessaria posizione asimmetrica che implica la responsabilità dell’analista per la cura del paziente, la tenuta tanto del setting esterno quanto di quello interno, e neppure sostanzialmente derogare dalle auree regole della astinenza e neutralità, vuol dire però assumere una posizione nuova e diversa che comporta imparare a tollerare la necessità di momenti di simmetria, se non addirittura favorire il loro verificarsi. Questi momenti, che potremmo considerare “presentati” iperbolicamente e concretamente dai tentativi effettuati di analisi reciproca di Ferenczi con alcune sue pazienti, sono quelli in cui l’analista, attraverso la self-disclosure, offre al paziente una dimensione di sé da conoscere, in modo autentico ma non spontaneistico, in modo sincero ma misurato, governato e guidato in definitiva dalla sua funzione analitica ; è anche per questo motivo che sopra richiamavo l’importanza della provata esperienza dell’analista nell’usare questo strumento e la consapevolezza di stare adottando una cornice teorico-tecnica di matrice relazionale :“Non siamo vittime passive dell’esperienza, ma piuttosto creatori attivi e perpetuatori fedeli degli schemi di interazione conflittuale in un mondo che, se non è sicuro, è perlomeno conosciuto” (Mitchell, 1988, pag. 158). Anzi, parrebbe che sia proprio in quei momenti che l’analista, sufficientemente consapevole e tranquillo sulla non confondibilità dei confini tra sé e paziente, possa offrire all’analizzante una funzione psicoanalitica effettiva ed efficace perché integra nel suo svolgersi autenticità, comprensione e rispetto profondi dell’altro e della relazione stessa e può favorire l’accesso a dimensioni inconsce, a nuclei psichici forse inaccessibili altrimenti.
BIBLIOGRAFIA RAGIONATA
Ferenczi, S. (1928), L’elasticità della tecnica psicoanalitica, in Opere, vol. 4, Cortina, Milano 2002
- (1932a), Confusione di lingue tra gli adulti ed il bambino, in Opere, vol. 4. Cortina, Milano 2002
- (1932b), Diario Clinico, Cortina, Milano, 1988
Levenson, E (1996), Aspects of self-revelation and self-disclosure, Contemporary Psychoanalysis, 32: 237-248
Mitchell, S. A. (1988), Relational concepts in psychoanalysis: An integration,Harvard University Press, tr. it. (1993) Gli orientamenti relazionali in psicoanalisi. Per un modello integrato. Bollati Boringhieri, Torino
Renik, O. (1998), The analyst’s subjectivity and the analyst objectivity, Int. Jour. Of Psych., 79:487-497
Rocchi, C. (2003) The counter-transference of the patient, The International Journal of Psychoanalysis, vol 84: 1221-1239
- (2009) Beyond the couch, Rivista di Psicoanalisi, Anno, LV: 765-77
- (2010) Privacy e disclosure dello psicoanalista alle prese con … inconsci difficili” presentato al XV Congresso Nazionale SPI, Taormina, maggio 2010
- (2015) “L’analisi reciproca di Sándor Ferenczi come precursore della self-disclosure controtransferale” in Rileggere Ferenczi oggi. Contributi italiani, a cura di F. Borgogno, 2015 Borla Editore
Wolstein, B. (1959), Countertransference, Grune & Stratton, New York
- (1989), Ferenczi, Freud and the origins of American interpersonal relations, Contemp.Psychoanal., 25: 672-685
Senise Tommaso

Tommaso Senise
Maestri della psicoanalisi
Foto d’archivio
Tommaso Senise
A cura di Simonetta Bonfiglio
Tommaso Senise (Napoli 12 dicembre 1917- Milano 28 febbraio 1996)
Tommaso Senise, pioniere nella cura degli adolescenti, innovatore e formatore, ha lasciato un’impronta profonda dentro e fuori l’istituzione psicoanalitica, dove ha operato in un arco di tempo che va dal 1948 alla sua morte, avvenuta il 28 febbraio del 1996.
Cenni Biografici
Nasce a Napoli il 12 dicembre del 1917. Primogenito di quattro fratelli, si laurea in Medicina nel 1942 ed inizia nel 1943 le sue prime esperienze come assistente presso la Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell’Università di Napoli. All’interno della solida famiglia borghese trova nel padre e nello zio paterno, entrambi antifascisti, figure che animeranno le sue scelte di studio insieme ad una forte tensione etica. I valori della libertà e della giustizia saranno testimoniati con coerenza e continuità nel suo operare e guideranno la ricerca clinica e scientifica della sua figura di psicoanalista.
Della sua infanzia serena e della sua adolescenza turbata da inibizioni intellettuali lascia lui stesso ricordi significativi. In alcuni scritti, offre stralci di autoanalisi e con acuta lucidità dà testimonianza di una modalità di ricerca libera e innovatrice, mettendo se stesso in gioco per la comprensione di meccanismi specifici del funzionamento mentale in adolescenza e per l’approfondimento delle motivazioni profonde personali alla psicoanalisi e alla cura degli altri. Un esempio coraggioso e non così ovvio e frequente nella comunità degli psicoanalisti, soprattutto negli anni ’50.
Durante l’esperienza universitaria e poi nella Napoli del dopoguerra, fa parte di un gruppo di giovani intellettuali antifascisti, al cui interno troviamo personalità di spicco sia del mondo politico che artistico e culturale, come Ermanno Rea, Giorgio Napolitano, Raffaele La Capria e altri. Il suo rigore metodologico è testimoniato dalle prime pubblicazioni in ambito neurologico, ma presto il suo interesse si rivolge alla psichiatria ed alla psicoterapia, cui si accosta esprimendo sensibilità, tensione alla ricerca e spirito critico nei confronti dei metodi di cura dell’epoca.
Vince un concorso a Milano nel 1948 presso l’Ospedale Manicomiale Paolo Pini di Milano, dove si trasferisce. I suoi interessi, già orientati verso la psicoanalisi, gli fanno iniziare nel 1949 l’analisi con Cesare Musatti, che in quegli anni poneva le basi organizzative e di rinascita della Società Psicoanalitica Italiana. Senise entra a far parte di quel “ primo cenacolo” che darà vita al Centro Milanese di Psicoanalisi (1963) e che si riuniva a casa Musatti. Nel 1963 è Membro Associato e nel 1965 diventa Socio Ordinario della SPI, nel 1975 è Didatta e ricopre dal 1986 al 1990 la carica di Segretario Nazionale di Training.
Come per la maggior parte degli psicoanalisti di quell’epoca, il forte impegno nel sociale trovò espressione nel lavoro istituzionale e successivamente nell’opera di formazione di operatori delle istituzioni psichiatriche, di salute mentale e di neuropsichiatria infantile, lasciando testimonianza di uno stile di ascolto psicoanalitico improntato al rispetto della persona ed alla libertà del soggetto. Questo panorama aiuta a comprendere meglio come nacque e si sviluppò il suo interesse per gli adolescenti. Nel 52, nell’istituto manicomiale di Mombello, conosce Giancarlo Zapparoli, impegnato nei primi tentativi di studio e ascolto degli psicotici. Entrambi interessati a trovare risposte alla sofferenza, mossi da uno slancio di curiosità ricerca e passione, stringeranno un legame professionale e di amicizia che durerà nel tempo; collaboreranno, negli anni ’80 nel Centro di Psicologia Clinica della Provincia di Milano, diretto da Zapparoli e dove Senise diviene consulente e responsabile per l’adolescenza.
La psicoterapia breve di individuazione nella consultazione con l’adolescente o analisi del sé
Nel ‘52 Senise compie una svolta: lascia il Paolo Pini, avvia l’attività privata e assume la direzione di un Centro Medico Psico Pedagogico dell’Ente Nazionale per la Protezione Morale del Fanciullo di Milano (ENPMF), affiancando l’amica e collega Mariolina Berrini, pioniera nella psicoanalisi infantile, fondatrice a Milano del primo CMPP (1948). E’ da questo momento che inizia ad occuparsi di adolescenti, una fascia d’età completamente scoperta in quegli anni, attrezzato inizialmente, come egli stesso racconta, solo della sua formazione psicodinamica.
Prende così il via un percorso autodidattico, che lo porterà ad elaborare il suo modello di intervento, un contributo innovativo per la cura e la comprensione della specificità del mondo interno dell’adolescente, attraverso una lunga esperienza che occupa circa 40 anni e trova comunicazione ad un pubblico più allargato nel volume, del 1990, scritto in collaborazione con M. T. Aliprandi e E. Pelanda, dal titolo “Psicoterapia breve di individuazione – La metodologia di Tommaso Senise nella consultazione dell’adolescente.”
Il volume si apre con la “Lettera a un adolescente” testimonianza diretta delle qualità di Senise nell’accostarsi e aprire un canale comunicativo profondo con l’Altro.
Alle origini
La collaborazione dell’Ente (ENPMF) con il Tribunale dei Minori comportava l’impegno di redigere relazioni psicodiagnostiche per minori che avevano commesso reati. Nel ’57 entrerà a dirigere il neonato Gabinetto medico-psicopedagogico del Centro di Rieducazione per minorenni della Lombardia. A partire da questo compito e dalla personale elaborazione dei problemi di ordine deontologico ad esso connessi, prende le mosse la sua metodologia. In una intervista del 1991 su Repubblica a Laura Lili, Senise stesso racconta i punti fondanti del suo operare. Profondamente convinto che il giudice per capire e decidere dovesse “sentire”, opera un salto creativo e introduce un uso diverso dello strumento diagnostico, in un periodo in cui era diffuso l’uso di diagnosi psichiatriche oggettivanti. Abbandona le relazioni tecniche e scrive, invece, storie cliniche per far conoscere al giudice sia i rischi che le potenzialità dell’adolescente. Per fare questo, ascolta e parla con l’adolescente sui risultati dei test, coinvolgendolo con lealtà e schiettezza nell’esplorazione di sé. L’attività diagnostica diviene, così, strumento di trasformazioni e risposta terapeutica, riattivando investimenti vitali nell’adolescente.
Abbiamo qui i cardini della metodologia innovativa, che Senise affinerà nel tempo e che presenterà ufficialmente soltanto nel 1980 al Convegno di San Marino della Neuropsichiatria Infantile. In essa, sistematizza la tecnica psicoterapeutica per gli adolescenti, approfondendo, come egli stesso sottolinea, i meccanismi psicodinamici attraverso cui si può agire per determinare o agevolare movimenti maturativi strutturali.
Profondamente radicato nella teoria psicoanalitica, il modello presenta caratteristiche e modalità relazionali diverse dal setting classico, non ritenuto adatto per l’adolescente. ll dispositivo terapeutico messo a punto, organizzato secondo un modello di consultazione prolungata o psicoterapia breve, mira a mobilitare nell’adolescente un investimento nel proprio funzionamento mentale, attraverso una “corretta identificazione” del terapeuta, con la costruzione di una relazione empatica. I concetti teorici, attraverso cui esplora i movimenti endopsichici del processo adolescenziale, sono: il processo di individuazione/separazione, il rapporto tra l’Io ed il Sé, i meccanismi di identificazione, la portata dell’ambiente familiare.
Insieme ad un estremo rigore teorico, troviamo una intensa partecipazione ed una speciale qualità clinica, dove intuizione, empatia e conoscenza raggiungono una sintesi semplice, originale e profonda.
Nell’ultima edizione ampliata del volume (2014) sulla sua specifica metodologia di lavoro (op.cit.), alcuni contributi meritano una particolare attenzione per la loro originalità e per l’anticipazione di temi ancora oggi molto attuali.
In particolare
1) “Breve digressione su origine ed evoluzione dei sentimenti di mortificazione”(II capitolo op.cit,2014). Questo lavoro è considerato tra i suoi contributi più originali e profondi. Si tratta di una esplorazione delle origini del sentimento di mortificazione e delle ricadute sul bambino, vivificanti o distruttive, in relazione al tipo di investimento che il genitore fa sul figlio. L’argomentazione approfondisce dinamiche interne inconsce, stati depressivi e difficoltà ad elaborare il lutto, che travasati dai genitori sui figli alimentano ferite e sentimenti umilianti di inadeguatezza.
2) Stati “come se” in adolescenza ( III cap. op.cit,2014).
Un lavoro di grande attualità, dove pone a confronto i concetti di falso sé di Winnicott e di “come se “ di H.Deutsch per la comprensione di stati limite nell’adolescente. Viene sottolineato come l’uso temporaneo di un funzionamento “falso sé” possa avere, in adolescenza, un aspetto finanche evolutivo, mentre gli stati “come se” siano sempre potenzialmente pericolosi e nocivi.
3) “Elaborazione delle motivazioni profonde e consapevolezza delle possibili interferenze di esse e della “Weltanshauung” nella relazione, come requisiti indispensabili di ogni forma psicoterapeutica.”(v. cap. op.cit.,2014)
Il lavoro è un “manifesto” sui requisiti ritenuti necessari per una buona formazione in psicoterapia ed un invito alle scuole di formazione ad una riflessione sul tema.
Offre ancora una volta se stesso come strumento per illustrare il significato delle motivazioni profonde alla professione, il grado di sublimazione o neutralizzazione della carica pulsionale e le ricadute nel controtransfert. Accanto a queste, il tema della visione del mondo, come evoluzione di ideali dell’Io e del super-Io, che riguardano l’investimento per il sapere e la verità. Questo scritto può essere considerato il testamento del maestro.
La persona dell’analista
Aveva una speciale qualità di ascolto: era curioso ed attento, silenzioso, ma anche molto sincero ed esplicito quando parlava, immediato nelle sue comunicazioni, mai intrusivo e nello stesso tempo fortemente presente.
Rigore etico, rispetto, investimento dell’ideale di libertà, curiosità intellettuale, caratterizzavano il suo impegno ed il suo incontro con l’altro, e forse proprio queste qualità lo rendevano un interlocutore speciale per gli adolescenti che trovavano in lui un analista, e vedevano un adulto, capace di ascoltarli con autentica lealtà ed interesse. Non aveva mai un atteggiamento banalmente amichevole, ma al contrario la serietà con cui ascoltava, la sincerità a volte scomoda con cui parlava, creavano una dimensione di fiducia e ponevano l’adolescente in una posizione in cui l’attenzione dell’altro lo confrontava con la responsabilità verso se stesso.
Sapeva guardare i nuclei più profondi della sofferenza mentale e identificare le patologie senza patologizzare, mantenendo un atteggiamento interno di equilibrio tra accettazione dei limiti e ricerca delle possibilità di cambiamento.
Era, come lui stesso diceva, un po’ pigro, poco ambizioso, ma appassionato del suo lavoro. La sua ambizione si esprimeva soprattutto nel piacere del raggiungimento di obiettivi attraverso la relazione con gli altri, per questo il suo successo e il suo ricordo sono soprattutto legati all’esperienza stessa delle persone che hanno avuto modo di lavorare con lui o di conoscerlo.Ha lasciato una importante eredità nella formazione e in molte scuole di psicoterapia psicodinamica, nate nel territorio milanese che a lui si sono ispirate e che lo hanno avuto come maestro.
All’apice della sua carriera di analista, manteneva un atteggiamento interiore di autentico under statement, espressione del suo essere laico anche nei confronti della psicoanalisi, a cui con libertà interiore si dedicava. Uno degli ultimi ricordi è la partecipazione all’apertura del Centro Milanese di Psicoanalisi (1994) nella nuova sede di Corridoni 38, dove nel saluto esprime insieme alla sua gratitudine ed al legame per la psicoanalisi, un augurio ai giovani, affinché prevalga in loro l’amore per la clinica rispetto al potere e competizione, a volte inevitabili, ma nemici nello sviluppo del pensiero e del gruppo.
Bibliografia
M.L.Algini, Sulla storia della psicoanalisi infantile in Italia, Edizioni Borla, Roma 2007
M.T.Aliprandi, E.Pelanda,T.Senise, Psicoterapia Breve di Individuazione,(nuova edizione ampliata), Mimesis 2014
Momigliano, L.N. (1991). Maria Teresa Aliprandi, Eugenia Pelanda, Tommaso Senise. Psicoterapia breve di individuazione: la metodologia di Tommaso Senise nella consultazione dell’adolescente. Feltrinelli, Milano, 1990. Rivista di Psicoanalisi, 37, 747-753.
A. Sala, La psicoterapia di individuazione dell’adolescente nell’opera di Tommaso Senise, Tesi di laurea, Università degli studi di Torino, anno accademico 1998-1999
Senise, T.L. (2005). Gli esami non finiscono mai. Il ruolo terapeutico, 2, 13-25.
Zapparoli, G.C. (1996). Tommaso Senise. Rivista di Psicoanalisi, 42, 533-536.
Senso di solitudine

foto di Rooze Mirjan
A cura di Gabriella Giustino
Nell’esperienza umana il senso di solitudine può essere inteso sostanzialmente in due modi:
-come sentimento doloroso che si associa a stati interni d’isolamento ed abbandono.
-come spazio d’introspezione ed espressione della propria soggettività e creatività personale.
Nel pensiero psicoanalitico incontriamo due principali concettualizzazioni sul senso di solitudine e sulla sua origine psichica: quella di Melanie Klein e quella di Donald Winnicott.
La tesi di fondo di Melanie Klein consiste nel considerare il senso di solitudine come il sentimento di perdita di uno stato interiore di perfetta intesa con la madre. L’intimo contatto tra l’inconscio della madre e quello del bambino rende possibile una comprensione profonda che non richiede l’uso di parole: il sentimento di solitudine è un sentimento che nasce dalla nostalgia per la perdita irreparabile di questa comunicazione e comprensione profonda ed é, per l’Autrice, una condizione ineliminabile di tutta la vita. La Klein afferma che per comprendere l’origine di questo sentimento é necessario rivolgersi alla prima infanzia: l’Io, presente fin dall’inizio dello sviluppo, si difende dall’angoscia di annientamento (proveniente dall’istinto di morte), operando meccanismi di scissione e proiezione (degli impulsi sull’oggetto e dell’oggetto stesso). Accanto alla tendenza alla scissione che neutralizza l’insicurezza, cresce però anche la tendenza dell’Io all’integrazione. Se l’oggetto buono é stabilmente radicato nel mondo interno, diventa il centro dello sviluppo dell’Io. Il bisogno di essere compresi dall’oggetto interno e l’aspirazione a comprendere se stessi (così come l’integrazione) non si raggiungono mai in modo completo. Se ciò é vero,afferma la Klein, allora il senso di solitudine nasce da una impossibilità di accettazione e comprensione completa delle proprie emozioni, angosce e fantasie. L’Autrice esamina poi come si declina questo specifico sentimento all’interno delle due “posizioni”, distinguendo il senso di solitudine che deriva dall’insicurezza paranoide da quello sostenuto da angosce depressive. In condizioni di sviluppo psicopatologico e, in particolare, nella schizofrenia, il paziente si sente solo in quanto circondato da un mondo ostile e soffre di sensi di confusione con le altre persone (per l’eccessiva identificazione proiettiva). Nella melanconia soffre, invece, di angosce paranoidi a causa dell’ambivalenza verso l’oggetto. Quando predominano le angosce depressive (e comunque in parte anche nello sviluppo normale) la paura della morte gioca un ruolo centrale nel senso di solitudine. Infatti, quando la madre non é presente, il bambino può sentirla come perduta per sempre, il che equivale alla paura della sua morte.
La morte della madre esterna significa anche la perdita dell’oggetto interno buono. In conclusione, secondo l’Autrice, l’internalizzazione dell’oggetto buono mitiga il senso di solitudine e determina la presenza di un SuperIo indulgente (non eccessivamente severo)che genera tolleranza verso di sé e verso l’oggetto amato. Quanto più é severo il SuperIo, tanto più grande sarà la solitudine, perché le sue dure esigenze fanno aumentare le angosce depressive e paranoidi.
Per Winnicott il senso di solitudine indica un difetto nell’ esperienza di essere stato solo in presenza di un altro significativo. L’autore si concentra dunque sugli aspetti positivi della “capacità” di essere solo: egli concepisce questa capacità come una meta importante dello sviluppo emozionale dell’individuo che si basa su un paradosso e cioé sull’esperienza di essere solo (da infante e da bambino piccolo) in presenza della madre.
La “relazionalità dell’Io”, e cioé la capacità del soggetto di essere in rapporto con un altro, é il presupposto per raggiungere questa meta e affonda le sue radici nel primo rapporto madre-bambino. E’ dalla qualità di questo rapporto che dipende la capacità del soggetto di godere della solitudine, una solitudine libera dalla qualità del ritiro.Punto di partenza vitale per lo sviluppo emozionale sano dell’individuo é dunque per Winnicott il periodo precoce in cui la madre rispecchia il bambino e riesce ad identificarsi con lui e con i suoi bisogni. La madre preoccupata per il proprio bambino costituisce l’ambiente che lo protegge e gli consente di raggiungere la fase dell’ “Io sono”, fornendogli la base per il senso di continuità dell’essere. La fase ulteriore dell’ “Io sono solo” presuppone invece anche la “consapevolezza” da parte del bambino della continuità dell’esistenza di una madre affidabile. L’individuo che sperimenta un senso di profonda solitudine ha, dunque, per Winnicott, sperimentato anche l’interferenza nello sviluppo dovuta alla mancanza di questo tipo di esperienza nel rapporto precoce con la madre.
BIBLIOGRAFIA
Klein M. (1959), Sul senso di solitudine, tr. it. in “Il nostro mondo adulto” Martinelli, Firenze 1974.
Winnicott D.W.(1958), The Capacity to be Alone, Int. J. Psycho-Anal., 39. Tr. it. in “Sviluppo affettivo e ambiente” Armando Editore, Roma, 1970
Gennaio 2015
Servadio Emilio

Emilio Servadio
Maestri della Psicoanalisi
A cura di Rachele Mariani
Servadio Emilio (1904-1995)
Presentazione
Emilio Servadio (1904-1995) fu un pioniere della psicoanalisi in Italia. Scrisse la voce Psicoanalisi sull’Enciclopedia Italiana Treccani e insieme a Edoardo Weiss, Musatti e Perrotti fondò La Società Psicoanalitica Italiana. Inoltre, fu nell’editoriale della Rivista Italiana di Psicoanalisi. Servadio formulò una originale concezione sullo sviluppo precoce della mente, focalizzando la sua attenzione sui conflitti pre-edipici e su come questi possano direttamente influenzare la manifestazione dello stesso complesso edipico.
 Emilio Servadio (1904-1995) was a psychoanalyst pioneer in Italy. He drown up a Psychoanalisis lexical item on Italian Encyclopedia Treccani, and together with Edoardo Weiss, Musatti and Perrotti founded the Italian Psychoanalytic Society. Also, he was member of the editorial board of the Rivista Italiana di Psicoanalisi. Servadio formulated an original conception of the early formation of mind, focusing his interest in pre-Oedipal conflicts that influenced how the Oedipus complex would manifest itself.
Emilio Servadio (1904-1995) was a psychoanalyst pioneer in Italy. He drown up a Psychoanalisis lexical item on Italian Encyclopedia Treccani, and together with Edoardo Weiss, Musatti and Perrotti founded the Italian Psychoanalytic Society. Also, he was member of the editorial board of the Rivista Italiana di Psicoanalisi. Servadio formulated an original conception of the early formation of mind, focusing his interest in pre-Oedipal conflicts that influenced how the Oedipus complex would manifest itself.
La vita
Emilio Servadio nacque a Sestri Ponente, Genova, nel 1904 e morì a Roma nel 1995 all’età di 91 anni. E’ stato uno dei fondatori della psicoanalisi italiana oltre che un giornalista pubblicista, un poeta e un appassionato di fenomeni parapsicologici come la telepatia.
Di famiglia ebraica, Emilio Servadio sin da piccolo mostrò una passione per la musica e uno spiccato interesse per il teatro e l’arte in genere. La passione per la musica lo accompagnerà per tutta la vita. Studente brillante, conseguì studi classici, parlando anche correttamente tre lingue Inglese, francese e tedesco; appena maggiorenne pubblicò il suo primo articolo sul quotidiano genovese Il lavoro, con il quale stabilì una collaborazione giornalistica. Si iscrisse a Giurisprudenza dove si laureò a pieni voti discutendo una tesi sull’ipnosi in medicina legale.
Negli anni ’20 si appassionò alla poesia d’avanguardia, strinse un’amicizia con Montale e debuttò con il suo primo libro di poesie Licheni. Si trasferì stabilmente a Roma, lavorando come redattore dell’Enciclopedia Italiana Treccani e del Dizionario Enciclopedico Italiano; negli stessi anni consolidò la passione per la psicoanalisi entrando in contatto con Edoardo Weiss, per stilare la voce Psicoanalisi.
In seguito a questo incontro Servadio diventò un allievo di Weiss, il quale lo coinvolse nel 1932, insieme a Cesare Musatti e Nicola Perrotti, nella fondazione della Società Italiana di Psicoanalisi (SPI), progetto, questo, pienamente sostenuto da Freud.
Subito dopo la nascita della SPI partecipò all’avvio della Rivista Italiana di Psicoanalisi, come rivista ufficiale per la diffusione e divulgazione della psicoanalisi. Dopo qualche anno Servadio venne ammesso all`Associazione Psicoanalitica Internazionale (IPA).
Parallelamente alla psicoanalisi, i suoi interessi di studio e ricerca riguardavano i fenomeni paranormali e le comunicazioni telepatiche, tanto che nel ‘34 partecipò al congresso dell’Associazione Psicoanalitica Internazionale di Lucerna presentando una relazione in tedesco su psicoanalisi e telepatia.
Purtroppo, con l’introduzione delle leggi razziali in Italia, fu costretto nel ’38 ad abbandonare il paese; in modo del tutto originale, decise di trasferirsi a Bombay in India, spinto dalla sua passione per lo yoga, le religioni antiche e l’esoterismo.
La carriera nel movimento psicoanalitico internazionale era in piena ascesa in quel periodo, ma il dramma della guerra non lo risparmiò, anche se con conseguenze minori rispetto ai suoi familiari (la sorella e il cognato furono deportati ad Auschwitz). Pur essendo un rifugiato, Servadio venne internato in un campo di concentramento inglese per più di tre anni, assieme ad altri italiani residenti in India. Egli fu sempre molto riservato su questi aspetti e nel 1987, tracciando una “semi-autobiografia” della permanenza in India per la Rivista di Psicoanalisi, commentò: “Sorvolo sui tre anni e oltre dell’internamento che dovetti subire. Quando mi fu possibile ritornare a Bombay, ripresi per un certo tempo la mia attività, ma infine, quando le condizioni lo consentirono, tornai in Italia. Era un freddo gennaio del 1946”.
Tornato in Italia, gli anni ’50 furono per Servadio il momento di una fiorente produzione teorica psicoanalitica, vedendolo presentare i suoi principali contributi tra cui: La ricerca psichica (1930; 1946); Rôle des conflits pré-oedipiens (1953) e Il sogno (1953).
Nel 1962 alcune divergenze fra gli analisti didatti della SPI, circa la questione del training formativo, fecero sì che si costituissero due gruppi a Roma ed un terzo a Milano occupandosi in modo autonomo della preparazione degli allievi della Società Psicoanalitica Italiana, di cui fu Presidente dal 1963 al 1969.
Oltre ad occuparsi di psicoanalisi, si dedicò a studi di parapsicologia scrivendo alcuni saggi su questo tema e insieme ad altri studiosi fondò la Società Italiana di Parapsicologia.
Il suo profondo impegno nella divulgazione della Psicoanalisi lo portò a collaborare con vari quotidiani tra cui Il Tempo di Roma, nonché come consulente della RAI sia per la realizzazione di trasmissioni a carattere scientifico sul tema psicoanalisi, sia per la realizzazione della miniserie RAI ESP del 1973, per la regia di Daniele D’Anza.
Nel 1984 pubblicò il secondo libro di versi, Poesie d’amore e di pena, vincendo il Premio Donatello.
Nel 1992 Servadio e altri membri Società di Psicoanalisi Italiana, rivolsero al Comitato Esecutivo dell’IPA la domanda di poter costituire una diversa Società componente, denominata Associazione Italiana di Psicoanalisi (A.I.Psi.), scindendosi in questo modo dalla S.P.I.
Nel 1993, il Presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi gli consegnò il premio speciale della cultura, per la medicina e psicologia, assegnato dalla Presidenza del Consiglio.
Alla sua morte venne sepolto nel cimitero acattolico di Roma, noto come Cimitero degli Inglesi, nel rione di Testaccio.
Il contributo alla psicoanalisi
Alla celebrazione dei 70 anni di Servadio, Gaddini (1974, p. 5) scrisse: “è giunto alla soglia dei suoi anni settanta senza che noi, pur essendogli accanto, ce ne avvedessimo. Ciò non dipende soltanto dall’eccezionale disinvoltura con la quale la sua persona fisica sostiene l’incalzare del tempo, ma anche dalla sua non meno eccezionale capacità di essere vivo e operante a pieno ritmo in un modo costante e con grande naturalezza. Per sorprendersi dell’attività di Servadio occorre che capiti di pensarci sopra. Allora soltanto se ne rimane stupefatti.”
La grande intelligenza e l’ampiezza di conoscenza sono il primo contributo che Servadio in quanto pioniere della psicoanalisi ha portato a servizio di questa disciplina. Novelletto (1995, p.171), commemorandone la scomparsa, disse: “A colpirmi per prima fu l’eccezionale qualità del suo metodo di studio, di lavoro e di ricerca. Non era tanto la dimensione enciclopedica delle sue conoscenze a meravigliarmi, quanto piuttosto il constatare che, pur senza aver mai appartenuto ad alcun ambiente universitario, dopo la laurea in legge, egli mostrava un approccio alle problematiche della ricerca scientifica che, per conoscenza della bibliografia, puntualità dei riferimenti, lucidità d’impostazione delle ipotesi, non aveva niente da invidiare alle migliori tradizioni accademiche, senza peraltro patire dei vezzi, dei fronzoli e della retorica che tanto spesso affliggono queste ultime”.
Servadio debuttò nel ’34 ad un convegno internazione di psicoanalisi con un lavoro molto originale “psicoanalisi e telepatia”, che sancì un legame stretto tra il lavoro psicoanalitico e alcuni fenomeni di comunicazioni inconsce da lui studiati. Gaddini (1974), commentando il lavoro di Servadio, affermò come quest’ultimo potesse essere considerato un antesignano, in psicoanalisi, delle ricerche sul contro-transfert, avendo aperto, con lo studio della telepatia, la porta a specifici fenomeni contro-transferali, anticipando di almeno 20 anni gli studi in questo campo. Egli sottolineava costantemente quanto fosse importante che la ricerca in psicoanalisi dovesse sempre partire dalla clinica, privilegiando lo studio della situazione psicoanalitica.
La sua profonda curiosità lo portò ad avere sempre un pensiero autonomo e indipendente, orientando i suoi interessi sullo sviluppo psichico in relazione ai conflitti pre-edipici, anche in un momento storico in cui questo interesse era meno apprezzato. Nella sua teoria, egli propose una nuova concettualizzazione del complesso edipico, affermando che non fosse il punto centrale dello sviluppo psicopatologico, bensì che i conflitti pre-edipici avessero una diretta influenza su come il complesso edipico si possa strutturare e manifestare, sviluppando delle compromissioni psicopatologiche. Infatti nel suo scritto “Il ruolo dei conflitti pre-edipici”, presentato in francese al XVI Congresso degli psicoanalisti di lingue romanze (Roma, 1953), Servadio enfatizzò il ruolo primario svolto dalle proiezioni e dalle fantasie nei conflitti pre-edipici e la loro diretta influenza nella costellazione edipica. Secondo Servadio la necessità di riesaminare e ridefinire in termini di una situazione binaria (pre-edipica), anziché ternaria (edipica), alcuni dei più importanti problemi psicologici e psicogenetici, risultava essenziale per comprendere la strutturazione dell’apparato psichico, sia nel senso di una sua sufficiente e “normale” funzionalità, sia in quello di un suo anormale sviluppo e funzionamento. La condizione di dipendenza infantile da un solo oggetto, scriveva Servadio, nella fase pre-edipica, fa sì che per sussistere l’apparato psichico infantile debba erigere in sé alcuni meccanismi ed istanze di autoregolazione, fatti di oggetti parziali introiettati aventi funzione di Super-Io precoce, le cui note caratteristiche sono, anche nel migliore dei casi, la rigidità, la mostruosa discrepanza rispetto alle loro ulteriori e più adulte sovrastrutture, la loro enorme capacità di essere “produttori d’angoscia”. Dal punto di vista istintuale, tali precocissimi conflitti sono contraddistinti dall’autoaggressività più o meno masochistica e dal sentimento di colpa più o meno libidizzato. Questo spostamento teorico proposto da Servadio sulla conflittualità pre-edipica e il ruolo della madre nella strutturazione della personalità, contribuì senz’altro alla formazione della successiva teorizzazione gaddiniana.
Un ulteriore contributo innovativo proposto da Servadio, è l’attenzione posta allo studio nella situazione analitica di fenomeni e.s.p. -percezioni extra-sensoriali. Egli definiva tali fenomeni percettivi come derivanti da una particolare situazione reciproca, in un rapporto tra due persone, generalmente consanguinei. Tali percezioni sono connotate da un carattere regressivo, che Freud aveva già concettualizzato come sorta di comunicazione primitiva. L’aspetto regressivo del fenomeno e l’aspetto di familiarità dà ragione del suo riprodursi nella situazione analitica, dove per effetto del transfert del paziente e del contro-transfert dell’analista le situazioni infantili reciproche vengono riattivate. Il movente inconscio caratteristico dell’effetto e.s.p., secondo Servadio, è legato all’angoscia di separazione, vissuta come possibile perdita dell’oggetto e del sé. La sperimentazione quindi nel setting analitico darebbe modo di esplorare fondanti conflittualità pre-edipiche che hanno formato e strutturato l’Io del soggetto.
Un ulteriore aspetto analizzato da Servadio che ha arricchito il dibattito psicoanalitico in Italia e all’estero, è rappresentato dalla sua visione del femminile e dalla rivisitazione delle concezioni edipiche alla luce di brillanti intuizioni teoriche arricchite dalle sue conoscenze della cultura orientale.
Rileggendo oggi i contributi del maestro Servadio, emerge con chiarezza la sua ampiezza e complessità di pensiero, che è ancora oggi al centro dei principali dibattiti psicoanalitici contemporanei. I temi teorici sollevati da Servadio sono tuttora attuali e fecondi, tanto in relazione alle più attuali ricerche sulle comunicazioni pre ed extra verbali, che alle nuove conoscenze sorte in campi affini come le neuroscienze.
Cronologia degli scritti
Articoli:
Servadio, E. (1932). Christa Winsloe Gestern und Heute. Tr. fr. Demoiselles en uniforme Fasquelle ed., Paris, 1932, Frs. 12.. Riv. Ital. Psicoanal., 1, 415-415.
Servadio, E. (1932). Edgard Michaelis Freud, son visage et son masque, traduit de l’allemand avec une introduction sur les éléments romantiques de la psychologie freudienne par le Dr. Jankélévitch. Paris, Les Editions, Rieder, 1932 Frs. 30.. Riv. Ital. Psicoanal., 1:262-264.
Servadio, E. (1932). Forme larvate di omosessualità. Rivista Ital. Psicoanal., 1:248-252.
Servadio, E. (1932). G. Franceschini «Vita sessuale» Hoepli, ed. Milano, 1933, L. 10.. Riv. Ital. Psicoanal., 1:267-268.
Servadio, E. (1932). Histoires d’enfants contées et illustrées par eux-mêmes. Denoël & Steele, Paris, 1932. Frs. 15.. Riv. Ital. Psicoanal., 1:413-414.
Servadio, E. (1932). Mary Chadwick Adolescent Girlhood George Allen & Unwin ed., Londra, 1932, 10s. 6d.. Riv. Ital. Psicoanal., 1:411-411.
Servadio, E. (1932). Quattro casi di “lapsus”. Riv. Ital. Psicoanal., 1:56-57.
Servadio, E. (1932). R. e Y. Allendy Capitalisme et sexualité Les éditions Denoël et Steele. Paris, 1932.. Riv. Ital. Psicoanal., 1:194-195.
Servadio, E. (1932). Stefan Zweig L’anima che guarisce (Mesmer, Mary Baker-Eddy, Freud). Trad. it. di Lavinia Mazzucchetti, Sperling e Kupfer, Milano, 1931.. Riv. Ital. Psicoanal., 1:74-78.
Servadio, E. (1933). F. Alexander The Relation of structural and instinctual Conflicts New York, 1933, s. i. p. (estratto da The Psychoanalytic Quarterly). Riv. Ital. Psicoanal., 2:399-399.
Servadio, E. (1933). Hans Jacobi Handschrift und Sexualität A. Marcus & E. Weber’s Verlag. Berlin und Köln, 1982, s. i. p. (ma RM. 3,80), Riv. Ital. Psicoanal., 2:63-64.
Servadio, E. (1933). Il motto di spirito. Riv. Ital. Psicoanal., 2:256-273.
Servadio, E. (1933). Il nome dimenticato. Riv. Ital. Psicoanal., 2:216-217.
Servadio, E. (1933). Pietro Zanfrognini Cristianesimo e psicanalisi. Guanda, Modena, 1933, L. 5.. Riv. Ital. Psicoanal., 2:222-223.
Perrotti, N., Servadio, E. (1933). Predica bene e … . Riv. Ital. Psicoanal., 2:274-281.
Servadio, E., Weiss, E. (1933). Varia. Riv. Ital. Psicoanal., 2:385-393.
Zoller, I., Servadio, E. (1933). Varia. Riv. Ital. Psicoanal., 2:138-141.
Servadio, E. (1933). Vittorio Benussi. Suggestione e Psicanalisi a cura di Silvia Musatti De Marchi. Casa Ed. Giuseppe Principato, Messina e Milano, 1932, L. 15.. Riv. Ital. Psicoanal., 2:64-68.
Servadio, E. (1934). La paura del malocchio. Riv. Ital. Psicoanal., 3:67-83.
Servadio, E. (1947). Psicoanalisi Della Vita Istintiva (Psychoanalysis of Instinctual Life): By Joachim Flescher, M.D. Rome, Italy: Scienza Moderna, 1945. 266 pp.. Psychoanal Q., 16:556-558.
Servadio, E. (1951). An Unknown Statuette of Moses. Int. J. Psycho-Anal., 32:95-96.
Servadio, E. (1953). The Lure of the Forbidden. Int. J. Psycho-Anal., 34:325-327.
Servadio, E. (1955). A Presumptively Telepathic-Precognitive Dream During Analysis. Int. J. Psycho-Anal., 36:27-30.
Servadio, E. (1955). Le prime situazioni conflittuali rispetto alla formazione dell’Io: i meccanismi di base. Riv. Psicoanal., 1A:18-22.
Servadio, E. (1955). Realtà psichica e realtà obiettiva. Riv. Psicoanal., 1B:15-19.
Servadio, E. (1956). Transference and Thought-Transference. Int. J. Psycho-Anal., 37:392-395.
Servadio, E. (1957). Reply to Dr. David Brunswick’s Comment. Int. J. Psycho-Anal., 38:57.
Servadio, E. (1958). Ernest Jones (1879–1958). Riv. Psicoanal., 4:79-81.
Servadio, E. (1958). Magic and the Castration-Complex. Int. J. Psycho-Anal., 39:147-150.
Servadio, E. (1959). Le oscure vie della guarigione. Riv. Psicoanal., 5:149-164.
Servadio, E. (1962). Communication. Psychoanal. Rev., 49D:121.
Servadio, E. (1963). Recenti orientamenti della psicoterapia. Riv. Psicoanal., 9:81-96.
Servadio, E. (1964). Felix Deutsch 1885–1964. Riv. Psicoanal., 10:4-4.
Servadio, E. (1964). Franz Alexander 1891–1964. Riv. Psicoanal., 10:3-3.
Servadio, E. (1965). La psicoanalisi in Italia. Riv. Psicoanal., 11:3-8.
Servadio, E. (1968). Psychotherapy: Myth and Method—An Integrative Approach. Jan Ehrenwald. New York and London: Grune and Stratton, 1966. 224 pp.. Psychoanal. Rev., 55:323-324.
Marty, P., Servadio, E. (1970). Discussion of ‘The Intrapsychic Process and its Analysis: A Recent Line of Thought and its Current Implications’. Int. J. Psycho-Anal., 51:195-209.
Servadio, E. (1970). Edoardo Weiss (1889-1970). Riv. Psicoanal., 16:5-10.
Servadio, E. (1972). L’aggressività nelle nevrosi. Riv. Psicoanal., 18:119-138.
Servadio, E. (1972). “Processo alla psicoanalisi”. Riv. Psicoanal., 18:230-231.
Servadio, E. (1973). Roberto Cavanna (A cura di) Aspetti scientifici della parapsicologia. Universale Scientifica Boringhieri, Torino, 1973, pp. 273, L. 1500.. Riv. Psicoanal., 19:91-93.
Servadio, E. (1974). Funzione dei conflitti pre-edipici. Riv. Psicoanal., 20:15-59.
Servadio, E. (1974). La psicoanalisi e il fascismo. Un documento inedito significativo. Riv. Psicoanal., 20:60-67.
Servadio, E. (1976). Il movimento psicoanalitico in Italia. Riv. Psicoanal., 22:162-168.
Servadio, E. (1978). “Psiche” e psicoanalisi. Riv. Psicoanal., 24:327-335.
Servadio, E. (1979). Licantropia e “realtà”. Riv. Psicoanal., 25:331-339.
Servadio, E. (1979). S. H. Frazier & A. C. Carr, Introduzione alla psicopatologia. Armando Armando Editore, Roma, 1978, L. 5.000.. Riv. Psicoanal., 25:149-150.
Servadio, E. (1980). Sui fenomeni ESP nella pratica analitica Nota introduttiva. Riv. Psicoanal., 26:206-209.
Servadio, E. (1982). Ricordando Anna Freud: (Vienna 1895 Londra 1982). Riv. Psicoanal., 28:611-617.
Servadio, E. (1984). La bacchetta del rabdomante. Tentativo d’interpretazione psicoanalitica. Riv. Psicoanal., 30:509-521.
Servadio, E. (1984). “Thalassa” rivisitato. Riv. Psicoanal., 30:522-537.
Servadio, E. (1986). Eugenio Gaddini (1916–1985). Riv. Psicoanal., 32:169-172.
Servadio, E., Palli, F.G. (1987). Arnaldo Novelletto Psichiatria psicoanalitica dell’adolescenza Borla, Roma, 1986, 226 pagine, L. 20.000.. Riv. Psicoanal., 33:287-289.
Servadio, E. (1987). C. Albarella e M. Donadio (a cura di) Il Controtransfert. Liguori, Napoli, 1986, pagg. 247, L. 22.000.. Riv. Psicoanal., 33:157-158.
Servadio, E. (1987). La psicoanalisi in India: (una semi-autobiografia). Riv. Psicoanal., 33:429-432.
Servadio, E. (1987). Piero Bellanova (1917–1987). Riv. Psicoanal., 33:315-317.
Servadio, E. (1988). Filosofia Dell’ Ascolto.: By Gemma Corradi Fiumara. Milano: Jaca Book. 1985. Pp. 275.. Int. R. Psycho-Anal., 15:262-263.
Servadio, E. (1988). Psychoanalyse Und Telepathie. Int. R. Psycho-Anal., 15:132-132.
Servadio, E. (1990). Graziella Magherini. La sindrome di Stendhal. Ponte alle Grazie, Firenze, 1989, 182 pages, lire 20.000.. Riv. Psicoanal., 36:206-212.
Servadio, E. (1990). Maurizio Filippeschi and Giuseppe Celano. Scuole di psicoterapia in Italia. Edizioni Centro Diffusione Psicologia, Genova, 1988. Riv. Psicoanal., 36:490-494.
Servadio, E. (1991). Su L’infinito di Leopardi: un’ipotesi. Riv. Psicoanal., 37:915-919.
Servadio, E. (1993). Replica di Emilio Servadio. Riv. Psicoanal., 39A:195-196.
Libri:
Servadio, E. (1929). Licheni. Torino, Fratelli Ribet.
Servadio, E. (1930). La ricerca psichica. Roma, Cremonese.
Servadio, E. (1955). Il sogno. Milano, Garzanti.
Servadio, E. (1961). La psicologia dell’attualità. Milano, Longanesi.
Servadio, E. (1970). L’educazione sessuale. Napoli, Guida.
Servadio, E. (1972). Psiche e sessualità. Roma, Astrolabio.
Servadio, E. (1972). Sesso e Psiche. Milano, Armenia.
Servadio, E. (1977). Passi sulla via iniziatica. Roma, Ed. Mediterranee.
Servadio, E. (1988). Poesie del sogno e dell’estasi. Firenze, Nardini.
Servadio, E. (1989). Poesie del cuore e del cielo. Firenze, Nardini.
Servadio, E. (1991). Poesie dell’aria e del fuoco. Firenze, Nardini.
Servadio, E. (1993). Poesie della spada e della rosa. Firenze, Nardini.
Servadio, E. (1994). Poesie del vento e della luce. Firenze, Il Fauno.
Bibliografia e Sitografia su Emilio Servadio:
Carotenuto A. (a cura di) (1992). “Servadio Emilio”, in Dizionario degli psicologi contemporanei. Bompiani.
David, M. (1966). La psicoanalisi nella cultura italiana. Torino: Bollati Boringhieri.
Errera, G. (1990). Emilio Servadio. Dall’ipnosi alla psicoanalisi. Firenze: Nardini.
Gaddini, E. (1974). I settanta di Emilio Servadio. Un tributo. Riv. Psicoanal., fascicolo unico, 5-13.
Garzia P. (1980), Intervista con Emilio Servadio, Luce e Ombra, 1.
Garzia P. (1995), Qualche riflessione sui novant’anni di Servadio, Luce e Ombra, 4.
Gramigna G. (1995), Servadio: lo psicoanalista che s’ immerse nel Gange, Corriere della Sera, 19-01-1995.
Lilli L. (1995), La scomparsa di Emilio Servadio, la Repubblica, 19-01-1995.
Magherini, G. (1994). Servadio: un profilo intellettuale. Inventario, 3, 131-140.
Novelletto, A. (1995). Emilio Servadio. Riv. Psicoanal., 1, 171-179.
Riferimenti in rete
http://www.archiviapsychologica.org/index.php?id=909
http://www.treccani.it/enciclopedia/emilio-servadio/
http://www.eternoulisse.it/vite_straordinarie/emilio_servadio.html
Shrenger Weiss Vanda

Vanda Shrenger Weiss (1920 c.a.)
Maestri della psicoanalisi
A cura di Rita Corsa
Vanda Shrenger Weiss (1920 c.a.)
Vanda Shrenger Weiss, medico e pediatra, è stata la prima psicoanalista in Italia e l’unica donna a far parte dell’originario gruppo fondatore della S.P.I. E’ stata, inoltre, la prima psicoanalista a discutere un proprio contributo in S.P.I. e a pubblicare un articolo sulla Rivista Italiana di Psicoanalisi.
La vita
La vita di Vanda Shrenger, nata in Croazia da una numerosa famiglia di ascendenza ebraica, si tesse inestricabilmente con i periodi più tremendi della Grande Storia europea: il primo conflitto mondiale, le rivoluzioni e le dittature degli anni Venti e Trenta, la persecuzione antisemita nell’Europa Orientale, che decimò la sua famiglia d’origine (1), le leggi razziali introdotte dall’Italia fascista, che indussero i Weiss a rifugiarsi in America.
Vanda nasce nel 1892, a Pakrac (Croazia); è la quintogenita di nove germani; il padre è un proprietario terriero che, in seguito ad un dissesto finanziario, si troverà ad industriarsi in svariati mestieri per mantenere la famiglia.
Di carattere determinato, generoso e d’intelligenza brillante, Vanda sogna di diventare medico sin da piccolina. Sarà, infatti, la seconda donna – e la prima ebrea – a laurearsi in medicina a Vienna.
Durante gli studi universitari, completati in tempo di guerra (1917), incontra Edoardo Weiss e i due ragazzi s’innamorano. Insieme cominciano ad interessarsi a questa misteriosa ed osteggiatissima nuova disciplina annunziata dal Professor Freud ed ambedue frequentano le lezioni da lui tenute alla facoltà di medicina della capitale asburgica. Allo scoppio della Grande Guerra, Edoardo Weiss, fresco di iscrizione alla Società psicoanalitica viennese (1913) e di laurea in medicina (1914), viene richiamato nell’esercito austro-ungarico ed inviato in qualità di medico militare sul fronte austriaco orientale, sorte comune ai cittadini dell’Impero di nazionalità italiana. Nonostante il conflitto in atto, nel 1917 i due giovani fidanzati contraggono matrimonio e l’anno dopo nascerà Emilio, il loro primogenito.
Alla fine delle ostilità belliche la coppia torna a Trieste, la città d’origine di Edoardo, dove quest’ultimo trova subito un impiego come psichiatra nel locale frenocomio. Nel frattempo egli comincia a professare la psicoanalisi nel suo studio privato, sotto la diretta supervisione di Sigmund Freud e di Paul Federn.
Vanda, intanto, inizia a praticare la professione di pediatra. L’approccio ai piccoli pazienti è improntato ad un’inedita attenzione psicologica. Non si può affermare che la giovane pediatra adoperi direttamente lo strumento psicoanalitico nell’avvicinare la sofferenza infantile, ma gli assunti freudiani sono ben presenti nel suo bagaglio tecnico/teorico. Lo stesso Marhaba puntualizza che Vanda è stata la prima psicoanalista italiana, specialista in pediatria, psicologia infantile ed educativa (1981, p. 44).
La maggior parte dei neuropsichiatri triestini, laureatisi quasi tutti a Berlino, a Vienna o a Graz, conosce i saggi freudiani, ma considera assai malamente la psicoanalisi. I Weiss, invero, vivono un penoso isolamento professionale e a Trieste non riescono a raccogliere intorno a loro un gruppo di allievi.
Nel 1928 ad Edoardo Weiss, distintosi nella sua attività psichiatrica istituzionale, viene proposto di ricoprire il ruolo di primario, ma alla condizione di italianizzare il cognome, come imposto dalle normative fasciste inerenti al pubblico impiego. Lo psicoanalista triestino controbatte con grande coraggio e dignità ai diktat fascisti e all’opposizione delle istituzioni scientifiche e mediche: nel gennaio 1929 si licenzia dall’ospedale, rifiutandosi di cambiare il cognome. E’ un momento molto tormentato per la famiglia Weiss, da poco allargatasi con la nascita del secondogenito, Guido (dicembre 1928). La situazione professionale e il travaglio psicologico rimangono a lungo critici e una buona soluzione ai molti problemi sembra essere quella di lasciare Trieste per andare all’estero, dove Edoardo vede svilupparsi con maggior vigore la psicoanalisi e spera di poter assicurare un futuro economicamente più tranquillo alla sua famiglia (Corsa, 2013).
Ma su questa opzione la moglie spende parole decisive per il futuro della psicoanalisi italiana.
Vanda non vuole assolutamente abbandonare l’Italia, per non allontanarsi troppo dalla Croazia – dove risiede la sua famiglia d’origine, con cui è in stretto contatto e a cui offrirà spesso aiuto – e per non essere obbligata a cambiare, ancora una volta, lingua e cultura.
Nei primi anni Trenta, inoltre, il clima politico a Trieste diventa sempre più pesante, a causa del manifestarsi di forme esasperate di nazionalismo, che si traducono in campagne xenofobe nei confronti soprattutto delle componenti slave. La somma di questi elementi sociali e personali fa sì che Vanda sostenga con energia l’ipotesi di spostarsi in un’altra città italiana, ma non di espatriare. Come è noto, la scelta cade su Roma, dove i Weiss si trasferiscono nel 1931.
A ben pensare, se Vanda non si fosse opposta all’iniziale progetto di Edoardo di lasciare l’Italia già alla fine degli anni Venti, il movimento psicoanalitico italiano avrebbe avuto senz’altro un altro destino. La durezza dell’epoca era solo un prologo a un’età ben più buia e, senza i coniugi Weiss, la disciplina freudiana nel nostro paese sarebbe rimasta sospesa per un tempo assai più lungo ed imprevedibile, prima di prendere una forma organizzata (Corsa, 2014).
L’attività scientifica
Nella capitale i coniugi Weiss raccolgono ben presto intorno a loro uno sparuto manipolo di seguaci e, già nel 1932, ricreano la Società Psicoanalitica Italiana e danno vita alla Rivista Italiana di Psicoanalisi. Sia la Società che la Rivista hanno sede nell’abitazione privata dei Weiss, in Via dei Gracchi 328-A .
Vanda Weiss risulta essere tra i membri fondatori della rinata Società Italiana di Psicoanalisi. Collabora alacremente alle iniziative scientifiche e all’organizzazione della Società e della Rivista. Nel 1932 è tra i 5 soci che rappresentano la S.P.I. al XII Congresso Internazionale di Psicoanalisi, svoltosi a Wiesbaden dal 4 al 7 settembre (Bellanova, 1982, p. 50). Un mese e mezzo dopo (26 ottobre) tiene in Società il seminario scientifico dal titolo La realtà nella fantasia. Nell’anno successivo la Weiss partecipa alle serate scientifiche della S.P.I., alcune volte intervenendo attivamente – il 1° febbraio sul tema Il Super-Io, presentato da Edoardo Weiss; il 1° marzo su L’analisi di un caso di ereutofobia, esposto sempre dal consorte (ibid., p. 51).
Vanda ha contatti diretti con Federn e con Jones; conosce di persona Freud e saltuariamente partecipa insieme ad Edoardo ai seminari scientifici presso la Società Psicoanalitica Viennese (3).
Negli anni romani la Shrenger, oltre ad esercitare come medico pediatra e radiologo e a tradurre testi scientifici tedeschi per il grande cattedratico Sante de Sanctis, avvia la sua attività di psicoanalista, condividendo lo studio con il consorte. Dal febbraio 1937 al marzo 1939 ella si sottopone ad un’analisi con lo junghiano Ernest Bernhard, che in quegli anni analizza anche lo stesso Edoardo Weiss (lettera di Weiss a Federn; Roma, 25 settembre 1937).
Il fascicolo n. 5/1932 della Rivista Italiana di Psicoanalisi ospita il primo articolo di un’analista donna. Si tratta di La realtà nella fantasia, a firma di Vanda Weiss (2). Come ricorda anche David (1966, p. 202n.), la collaborazione scientifica della psicoanalista croata è incominciata fin dal numero d’esordio della Rivista, per il quale ha realizzato la traduzione dal tedesco dell’articolo di Heinrich Meng, Il bambino e la psicoanalisi (1932).
Il nome di Vanda Weiss compare anche sul secondo fascicolo della Rivista, dove recensisce il libro di Hanns Sachs, Bubi Caliguta (1932), un «interessante studio psicoanalitico su Caligola» centrato sulle dinamiche infantili che presiedono alla formazione del Super-io.
Tuttavia, il più significativo lavoro scientifico in italiano di Vanda Shrenger è l’articolo del 1932, La realtà nella fantasia: un breve scritto di rara chiarezza espositiva, dove l’autrice illustra diverse condizioni fisiologiche e patologiche in cui interviene il prodotto della fantasia a influenzare la vita psichica dell’individuo. Sfiora, così, una tematica che avrà grande risonanza nella psicoanalisi di fine Novecento. Le coordinate concettuali entro le quali si destreggia sono quelle classiche freudiane – alcune derivate ancora dalla prima topica ed altre ispirate alla seconda – con dei bruschi, ma innovativi viraggi alla psicologia dell’Io di Federn.
L’America
Alla fine degli anni Trenta i tempi si fanno funesti e gravidi di dolore. Nel 1934 la Rivista Italiana di Psicoanalisi deve chiudere i battenti (nel 1933 il regime fascista non rinnova il permesso di pubblicazione) e nel 1938 la stessa S.P.I. è obbligata a sciogliersi. Con la promulgazione delle leggi razziali del 1938, il piccolo gruppo di psicoanalisti italiani, quasi tutti ebrei, si disperde: nel 1939 i Weiss emigrano a Topeka (Kansas), una cittadina nel cuore degli Stati Uniti.
Vanda riprende subito la sua attività psicoterapica privata, ma, a differenza di Edoardo, non si iscrive alla Società Psicoanalitica di Chicago, né all’International Psychoanalytical Association (I.P.A.) (4).
Pratica la psicoanalisi nello stesso studio del marito, dapprima a Topeka e, successivamente, a Chicago, dove i Weiss si trasferiscono nel 1942.
Il 16 giugno 1940 Vanda Weiss («Dr. Vanda (Mrs. Edoardo) Weiss (by invitation)») viene invitata a presentare una relazione dal titolo Analysis of a Case of Erythrophobia presso la Topeka Psychoanalytic Society, all’interno del programma annuale dei “Scientific Meetings”. Si tratta di un resoconto clinico, già discusso nel piccolo gruppo analitico romano e che, più di vent’anni dopo, avrebbe riproposto al C.G. Jung Institute di San Francisco. Questo intervento alla Topeka Psychonalytic Society è l’ultima traccia lasciata dalla Shrenger nel mondo psicoanalitico freudiano.
Nel 1949 la Shrenger compera una casa a Berkeley per l’estate, non sopportando più il clima caldo-umido di Chicago; nel 1953 vi trasloca definitivamente, insieme alla figlia Marianna.
Nel 1949 Vanda (Wanda) Weiss risulta essere tra i membri fondatori del primo gruppo statunitense di matrice junghiana, l’Association of Analytical Clinical Psychologists di San Francisco. Da allora e fino alla sua morte – avvenuta nel marzo del 1968, per un carcinoma mammario – Vanda Shrenger Weiss si dedica alla psicoanalisi junghiana: un’intensa attività clinica, un continuo lavoro formativo di giovani analisti e un’originale produzione scientifica connoteranno i suoi ultimi anni Americani. Un’ebrea croata destinata a pellegrinare in terre straniere per seminare futuro.
NOTE
(1) La notte dell’antivigilia di Natale del 1941, i militanti dell’Ustasha– il movimento nazionalista croato di estrema destra, fondato da Ante Pavelić negli anni Venti, che si opponeva al Regno di Jugoslavia dominato dall’etnia Serba – irruppero in Pakrac e deportarono gli ebrei nei campi di concentramento di Djakovo e di Jasenovac, dove morirono trucidati o di stenti. I membri della famiglia Shrenger che ancora risiedevano in Pakrac non scamparono all’eccidio. Il fratello maggiore di Vanda, Jacques (Jacob) e sua moglie furono tra le vittime, così come i due primogeniti adolescenti. La loro terzogenita, Marianna, era nata da meno di due settimane (10 dicembre 1941); si salvò perché venne affidata ad una zia acquisita non ebrea, che la portò a Zagabria, dove venne cresciuta da un altra zia paterna. A nove anni, nel 1951, fu fatta migrare negli Stati Uniti, dove venne adottata da Vanda ed Edoardo, divenendone la terza figlia («fully adopted daughter»).
L’autrice di questa Voce di SPIpedia è da circa due anni in contatto epistolare con Marianna Shrenger Weiss, che le ha generosamente messo a disposizione buona parte del materiale storico e clinico adoperato nella ricostruzione della figura di Vanda Shrenger Weiss.
(2) L’articolo, con il titolo Uber die Realität in der Phantasietätigkeit, verrà pubblicato nel 1933 su Psycho-analytische Bewegung. Melitta Schmideberg lo segnalerà nel 1934 nella sezione “Childhood”, da lei curata per l’International Journal of Psycho-Analysis.
(3) Si veda l’epistolario Weiss/Federn, presso l’Archivio Weiss dell’A.S.P.I.
(4) Negli Stati Uniti Vanda non sostenne gli esami per la qualifica a medico («qualifing Board exames»), per cui non poté mai esercitare come dottore, né iscriversi ad una Società psicoanalitica americana afferente all’I.P.A.. A Chicago ella ottenne però il permesso ufficiale di esercitare la professione di psicoterapeuta con i pazienti che le venivano inviati da altri medici o analisti (comunicazione personale di Marianna Shrenger Weiss, aprile 2014).
Bibliografia
Le notizie storiche riguardanti la figura di Vanda Shenger Weiss sono attinte dal carteggio intrattenuto da Rita Corsa con Marianna Shrenger Weiss (2013-14).
BELLANOVA (1982). Le due Gradive. Roma, C.E.P.I.
CORSA R. (2013). Edoardo Weiss a Trieste con Freud. Alle origini della psicoanalisi italiana. Le vicende di Nathan, Bartol e Veneziani. Roma, Alpes.
CORSA R. (2014). I NO che segnarono le origini della psicoanalisi italiana. Psiche, 2, 515-528.
DAVID M. (1966). La psicoanalisi nella cultura italiana. Torino, Boringhieri.
MARHABA S. (1981). Lineamenti della psicologia italiana. 1870-1945. Firenze, Giunti.
MENG H. (1932). Il bambino e la Psicoanalisi. Riv. Ital. Psicoanal., 1,154-166.
SACHS H. (1932). Bubi Caliguta. Wien, Internationaler Psychoanalytischer Verlag.
SCHMIDEBERG M. (1934). Childhood: Vanda Weiss. “Uber die Realität in der Phantasietätigkeit”, Psycho-analytische Bewegung, 1933, Jg, V, S. 263-270. Int. J. Psycho-Anal., 15, 324.
WEISS V. (1932). Recensione. Hanns Sachs. Bubi Caliguta. 2. ed. Riv. Ital. Psicoanal., 2-3, 191-192.
WEISS V. (1932). La realtà nella fantasia. Riv. Ital. Psicoanal., 5, 297-304.
WEISS V. (1933). Uber die Realität in der Phantasietätigkeit, Psycho-analytische Bewegung, Jg, V, S. 263-270.
Sitografia
www.aspi.unimib.it (ASPI – Archivio Storico della Psicologia Italiana). Archivio Weiss.
25 settembre 2014 CMP Incontro con Rita Corsa: “Vanda Weiss: la prima psicoanalista italiana”
Novembre 2014
Sintomo organico (ricerca del significato)

M.DUCHAMP,1946 (ESPOSTA DOPO LA MORTE)
A cura di Ana Emilia Juraga
La ricerca del significato del sintomo organico comporta la necessità di interpretare l’importante comunicazione inconscia contenuta nella manifestazione fisica.
Ci è spesso capitato di venire a conoscenza di persone brillanti, professionisti di successo con una buona vita sociale i quali, poco tempo dopo il raggiungimento della pensione, si ammalano. Malattie non gravi che, tuttavia, interferiscono nella normale routine e che comportano un’attenzione e un riguardo inediti rispetto alla propria salute. Altre volte abbiamo visto l’amico, rimasto vedovo, il quale, a seguito del lutto, manifesta un quadro clinico di grave sofferenza tale da richiedere addirittura un ricovero. Su questo argomento, a ognuno di noi, verranno sicuramente in mente esempi sia personali sia familiari.
Una malattia può presentarsi non solo contemporaneamente a situazioni dolorose, ma anche quando si realizzano desideri molto ambiti. Tale evento interferisce nello stile di vita, e possiamo pensare che esso ripropone, per meglio dire “riattualizza”, aspetti rimossi della nostra vita psichica che erano in attesa di poter essere vissuti. Ci troviamo allora a cercare di dare un senso a queste vicende che riguardano la salute del nostro corpo.
L’esordio di una malattia genera un turbamento profondo e la rottura degli equilibri raggiunti in quanto, ciò che avviene nel corpo, condiziona la vita di relazione e gli stati d’animo, segnando un capitolo importante nella storia di una persona. Può accadere, a volte, che il malato si senta colpevolizzato dalla propria famiglia come se questo grave evento dipendesse dalla sua volontà. Possiamo invece ipotizzare che proprio quel sintomo organico sia stato l’unico mezzo che inconsciamente il soggetto è riuscito ad utilizzare per esprimere qualcosa che non avrebbe voluto sapere, non accettare, e di cui ha cercato di negare l’esistenza attraverso la rimozione.
La ricerca del senso della malattia, del significato che può racchiudere quel tipo di patologia in quel determinato soggetto e nella sua particolare storia, trova fondamento nella convinzione che dietro alle manifestazioni del corpo, mascherate dal sintomo fisico, si nascondono vicissitudini legate ad un profondo compromesso affettivo.
Il metodo della patobiografia, creato da Luis Chiozza, è stato pensato per poter essere applicato nelle situazioni di insorgenza della malattia, per poter individuare, con gli strumenti della psicoanalisi, quali contenuti inconsci rimossi possono colludere con il processo morboso.
La ricerca di una spiegazione dei rapporti tra mente-corpo, è stata presente nello sviluppo del pensiero filosofico e scientifico dagli albori dell’umanità fino ai giorni nostri. Possiamo ricordare nel sistema filosofico di Platone, la distinzione tra un mondo sensibile e un mondo delle idee, ognuno con caratteristiche definite e molto differenti l’uno dall’altro. Senza dimenticare Descartes e il suo “cogito ergo sum” che ha superato la dicotomia mente corpo addentrandosi in territori impervi, dato il clima culturale in cui il filosofo viveva.
Ci sono esempi nella medicina dell’antica Grecia. Tra i tanti, ricordiamo l’episodio in cui il medico Erasistrato, al fine diagnosticare la malattia di cui era affetto un giovane principe, decide di trasferirsi a casa di questi per capire che cosa stesse accadendo. Nessun altro collega era riuscito a guarirlo. L’osservazione del comportamento del giovane malato e l’essere venuto a conoscenza dei cambiamenti avvenuti in famiglia, portano Erasistrato alla conclusione che quella febbre indomabile era dovuta all’innamoramento del giovane principe per la nuova giovane sposa di suo padre.
Parlare, scrivere di psicosomatica non sempre riscuote interesse e approvazione ma, al contrario, suscita atteggiamenti svalorizzanti. Ci sono persone che concordano e sostengono le tesi della psicosomatica, altre invece che tendono a ridicolizzare o a disprezzare tali argomentazioni.
Sicuramente separare queste due realtà – mente/corpo – può essere utile per lo sviluppo di certe linee di ricerca, nella fisica, nell’anatomia, anche nella psicologia, senza perdere la consapevolezza che è una separazione artificiale attuata a fini conoscitivi e parziali.
Oggi si parla spesso dell’assenza dell’occhio clinico, della capacità diagnostica del medico che sembra andata smarrita o forse potremo dire “offuscata” dalle procedure protocollari; una buona diagnosi, in realtà, non avviene soltanto attraverso la semiologia, ma anche attraverso l’osservazione della persona nella sua interezza.
Il problema della relazione della mente con il corpo è stato presente nella psicoanalisi fin dall’inizio. Freud, nei suoi scritti, ci ricorda di quanto i pazienti somatici sembrano incapaci di parlare d’altro rispetto al proprio stare male ed alla descrizione dei sintomi corporei. Ci vuole molto tempo, durante un trattamento psicoterapico, per consentire loro di fare collegamenti con le proprie vicende e storie personali. Forse è stata questa caratteristica a dar luogo a diverse correnti di pensiero dentro la stessa psicoanalisi: dalle teorie che considerano i pazienti somatici come persone con difficoltà a mentalizzare, a quelle che ritengono che la malattia sia la risultante di eventi stressanti ma senza un significato, a quelle concezioni che danno alla malattia somatica con un “senso psichico,” un significato inconscio preciso.
Freud ha decifrato il linguaggio occulto dei sintomi somatici dell’isteria, affermando che questi esprimevano simbolicamente affetti “ostacolati” nel loro cammino di accesso alla coscienza. Questi affetti portavano alle componente rimossa della storia personale del paziente ed erano legate alle vicissitudini della sua vita di relazione e sessuale. Nei pazienti l’idea che riguardava desideri intollerabili veniva rimossa ma non l’affetto: gli affetti e i desideri ritenuti intollerabili trovavano quindi una “ via di scarica” nel corpo. Freud individua nell’inconscio il mediatore tra il somatico e il mentale, e le sue ricerche lo porteranno alla scoperta dell’importanza dell’inconscio, alla formulazione della sua teoria sull’apparato psichico e del funzionamento mentale dell’essere umano.
L’interesse di Freud per il problema della relazione mente-corpo presente nei suoi lavori con le pazienti isteriche (dal 1888 – 1897) verrà sospeso per alcuni anni, per poi riapparire nel 1925 in “Inibizione sintomo e angoscia”, scritto in cui si propone il tema della compiacenza somatica. Tuttavia, è soprattutto nel suo ultimo lavoro del 1938 nel “Compendio di psicoanalisi”, dove con “estrema chiarezza e precisione espositiva “, Freud formula la seconda ipotesi fondamentale della psicoanalisi: “La psicoanalisi reputa che i presunti processi concomitanti di natura somatica costituiscano il vero e proprio psichico, e in ciò prescinde a tutta prima dalla qualità della coscienza”(1938, 585).
L’evoluzione del pensiero di Freud sul rapporto mente-corpo si riflette nelle diverse formulazioni che adotteranno i suoi successori. Alcuni psicoanalisti sostengono il ruolo della simbolizzazione nello sviluppo delle malattie del corpo, altri non concordano con queste tesi, altri invece considerano solo alcune malattie come propriamente psicosomatiche.
Autori che come la Mahler, Alessander, Winnicot, Gaddini, Marty sostengono una concezione secondo la quale la dimensione psichica è una realtà che si sviluppa in un secondo tempo, rispetto all’essere corporeo. Un gran numero di autori conviene nel sostenere che la formazione di un forte senso di sé dipende dal fatto che la madre funge da scudo protettivo per il bambino, decodificando le comunicazioni del neonato nel modo più sensibile possibile. La malattia “psicosomatica” viene collegata ad un fallimento della vita emotiva, piuttosto che alla sua rappresentazione.
Analisti come Marty e de M’Uzan sostengono che la simbolizzazione non ha nessun ruolo nell’attivarsi delle malattie psicosomatiche. Essi sostengono di avere individuato un tipo di personalità associato allo sviluppo di queste malattie. Sono personalità di scarsa vita fantastica, incapaci di fare libere associazioni e senza pensieri che non siano oggettivi e quindi privi di metafore. Gli autori hanno definito questo fenomeno ”pensiero operatorio” o funzionamento meccanico proponendo, per questo tipo di soggetti, il nome di personalità “alessitimica”. Partendo dal presupposto che queste persone hanno subito un sovraccarico psichico della vita mentale precoce, ritengono che le tensioni producono una sorte di corto circuito di qualsiasi elaborazione psichica e trovano una “soluzione somatica”.
Anche Joyce Dougal nel suo libro “Teatri del Corpo” fa riferimento agli autori che hanno studiato lo sviluppo precoce della mente e sottolinea che tutti riconoscono, implicitamente o esplicitamente, che il senso di sé e l’identità individuale dipendono dal modo in cui vengono vissute le separazione precoci e le differenziazioni.
Bion colloca il fenomeno psicosomatico al di fuori della funzione simbolica: quando parla dei destini degli elementi beta, dice che questi, quando non sono elaborati dalla funzione alfa, possono essere proiettati, allucinati o evacuati nell’apparato protomentale come disturbi psicosomatici.
Altri autori come Grodeck, Felix Deutsch, Weiszaecker e Chiozza ritengono che la malattia possieda una valenza simbolica.
Chiozza e i suoi collaboratori sostengono che ogni individuo possiede una storia conscia di se stesso che presenta lacune e distorsioni, soprattutto rispetto ad eventi particolarmente dolorosi. Esistono però altri elementi talmente dolorosi e intollerabili da rimanere inconsci. La malattia avrebbe la funzione di “coprire” di fronte alla coscienza questi aspetti drammatici, ma simbolicamente essa stessa finisce per riproporre tali eventi.
Chiozza scrive “Quando affermiamo, seguendo Weizsaecker (1946) che tutto ciò che è corporeo possiede un significato psicologico e tutto lo psichico un correlato corporeo, non presupponiamo che un fenomeno psichico si converta in corporeo o viceversa, ma che l’esistenza stessa del fenomeno somatico sia dotata di questo significato e l’esistenza stessa del fenomeno psichico possieda un aspetto corporeo.”
Questa concezione dello psichico e somatico non corrisponde a piani ontologicamente distinti della realtà, come siamo abituati a pensare, ma dipende unicamente dalla posizione dello spettatore, dalla modalità della sua osservazione e comprensione. Somatico è tutto ciò che può essere esplorato con i sensi mentre psichico rimanda alla storia del soggetto.
Questi autori ritengono che sia la malattia che la scelta dell’organo, abbiano un senso e rappresentino simbolicamente una fantasia inconscia; ribadiscono inoltre che non è la fantasia che determina o provoca il processo somatico, e sostengono che nemmeno il processo somatico è causa della fantasia; entrambi, processo somatico e fantasia, sono aspetti della stessa realtà. Essi sostengono che la capacità di simbolizzare sia inerente alla vita e questo si manifesta nelle fantasie inconsce.
In Italia il gruppo coordinato da Fabrizio Franchi ha lavorato per molti anni studiando e applicando le idee di Chiozza, fino ad elaborare una sua propria concezione sulla malattia somatica e il rapporto corpo-mente, discostandosi, in alcuni aspetti, dalle teorie di Chiozza.
Franchi scrive “Condividiamo l’affermazione di Chiozza che il linguaggio sia un corollario proprio della materia animata, che esso compaia con il vivente, prima e indipendentemente dalla maturazione della psiche individuale. Gli essere umani non sono come buchi neri nei quali gli stimoli esterni possano scomparire, ma sono fatti per re-agire cioè per dialogare con la realtà esterna. Il linguaggio è connaturale in noi perché connaturata è l’esigenza di entrare in relazione con il mondo esterno.” All’interno di questa concezione il linguaggio è definito come il modo in cui un soggetto porta a compimento manifestazioni di sé, significative nella relazione con l’altro ed è possibile dire che il linguaggio presiede alle relazioni improntate agli istinti.
La psicosomatica è intesa come approccio a una relazione terapeutica dove si cura l’uomo intero, nella sua complessità psicofisica. La malattia è determinata dall’interrelazione tra le forze della sua eziologia organica e le influenze mentali del soggetto. Sarà la risultante di queste forze a plasmare la sostanza somatica.
Questo gruppo non concorda completamente con l’impianto dottrinale di Chiozza, soprattutto dove va a schematizzare, in maniera eccessiva, il legame tra emozioni tipizzate dell’esistenza umana associandole a precise parti e funzioni dell’apparato corporeo, nel senso di collegare inestricabilmente un determinato affetto ad una certa malattia, evidenziando un’esigenza classificativa precedentemente criticata. Condividono altresì il pensiero di Joice McDougall quando scrive “(…) di fronte al medesimo conflitto un individuo risponderà con una nevrosi, un altro svilupperà una perversione sessuale, un delirio o una malattia psicosomatica.”
Interessante ricordare, in questo ambito di ricerca, il lavoro di Alessandra Piontelli sull’osservazione dello sviluppo intrauterino di gemelli, lavoro nel quale l’autrice ipotizza che una forma di differenziazione tra il sé e l’altro incominci già nell’utero. “(…) l’osservazione dei feti con l’ecografia ci può dire solo come i feti si comportano e non cosa possono o non possono sentire o pensare. Probabilmente questo non lo sapremo mai, ma se guardiamo il comportamento come espressione di un precursore di qualche tipo di sentimento o pensiero, possiamo anche tentare di proporre una speculazione di natura ipotetica.” Il feto apparentemente agisce già su una base di piacere-dispiacere. Non sappiamo quanto il feto o il neonato possa avere una consapevolezza di sé, però riteniamo che sia già presente una consapevolezza precoce dell’altro. Forse si potrebbe ipotizzare che gli eventi del mondo animato vengono in essere in un modo non caotico o causale, bensì motivato e sensato in un senso psico-linguistico.
Le vicissitudini della relazione mente-corpo è una questione tuttora aperta sia a ulteriori studi sia a maggiori esperienze che, indipendentemente dal nostro orientamento psicoanalitico, ci stimolano ad essere ricettivi alle comunicazioni, ai bisogni dei pazienti, a tollerare l’incertezza, a formulare ipotesi basate sull’osservazione. E’ proprio il fatto di essere esposti alla critica e al dubbio che ci consente di immaginare nuove possibilità.
Bibliografia
Cagli V. La crisi della diagnosi. Editore Armando. Roma, 2007
Chiozza Luis A. Corpo, Affetto e linguaggio. Editore Loescher. Torino, 1981
Chiozza Luis A. Las cosas de la vida.. Editore Libros del Zorzal. Buenos Aires, Arg. 2005
Franchi F. ed altri. Il corpo nella stanza d’analisi. Edizioni Borla, Roma, 2006
Franchi F. (a cura di). Cancro complessità e derive psicoanalitiche. “Il rischio di una superstizione scientifica” Editore Franco Angeli, Milano, 2007
Freud, Sigmund (1898). “La magia della parola” OSF, 2, Torino, Bollati Boringhieri.
Freud, S. (1925). “Inibizione, sintomo e angoscia” OSF, 10, Torino, Bollati Boringhieri.
Freud, S. (1938) “Compendio di psicoanalisi”, OSF, 11, Torino, Bollati Boringhieri.
Juraga Ana, Rosenholz Eva. “Il linguaggio del corpo nella malattia somatica: riflessione psicoanalitica” in Cancro complessità e derive psicoanalitiche. Ed. F. Angeli, Milano, 2007
Piontelli A. From fetus to child, Taylor and Francis group, UK, 2002
Dicembre 2016
Sogno

Dorothea Tanning, 1953
SOGNO
un’ introduzione freudiana a cura di Antonio Alberto Semi
Il sogno è il ricordo allo stato di veglia di un avvenimento psichico accaduto durante lo stato di sonno. Questa definizione è un po’ ingannevole. Essa non sottolinea l’attività del giudizio qualificativo che interviene immediatamente per “etichettare” un contenuto psichico cosciente come “sogno”. Il giudizio – funzione psichica di base per l’esame di realtà (Freud, 1925) – non è limitato alla distinzione “dentro/fuori” o “percezione/rappresentazione” ma implica una costante e non sempre semplice qualificazione: il tale contenuto psichico cosciente è una percezione, l’altro è un ricordo, il terzo una fantasia e così via. Poter riconoscere il sogno come tale è fondamentale, essendo la qualificazione di un contenuto psichico condizione necessaria (ma non sufficiente) per l’accesso al sistema conscio. La definizione rischia poi di porre in secondo piano il rapporto tra sonno e sogno. Freud (1917) concepisce il sonno come necessario tempo quotidiano di regressione ad una condizione narcisistica. Il sogno ricordato in sé stesso segnala il fallimento (almeno parziale) della funzione reintegrativa narcisistica del sonno. L’Io, che non è riuscito a smaltire gli effetti degli stimoli (interni ed esterni) pervenutigli durante lo stato di veglia, non ha potuto riconquistare con i propri mezzi il senso di pienezza, completezza e (re)integrazione caratteristico della sana soddisfazione narcisistica. Questa conclusione, tuttavia, è valida solo se partiamo dal punto di vista della coscienza, alla quale appare un insieme di immagini, idee, parole, affetti prevalentemente incongrui o bizzarri. Il sognatore, da sveglio, si chiede perché mai abbia sognato una cosa del genere. Se partiamo invece dal punto di vista dell’inconscio (ossia dalla stragrande parte dell’apparato psichico, quella che produce il pensiero) le cose cambiano. Per l’inconscio, il sogno è un successo, perché riesce a far giungere sul piano della coscienza contenuti altrimenti inaccettabili, usando materiali disparati. E mira alla coscienza perché il sistema C è quello che ha accesso alla motilità e dunque alla possibilità di scarica sulla realtà esterna. Per fare ciò, l’inconscio non esita: modifica, traveste, raffigura i propri pensieri condensando e spostando le proprie cariche e presentando il tutto al sistema Prec in un modo sufficientemente accettabile (dunque non censurabile) che consenta a quest’ultimo di collegare le rappresentazioni di cosa a rappresentazioni di parola, legando così anche l’energia a singoli contenuti, spesso apparentemente (ossia secondo la logica del sistema C) secondari. Ad esempio in un sogno provo una grande rabbia verso il mio amico Mario. Mi distrae dal compito che sto svolgendo e col quale lui non ha proprio nulla a che fare. Le associazioni tuttavia portano, anche tramite uno spostamento di accento (mario à marìo, marito in veneziano) ad un indirizzo veneziano (‘ma’ avversativo e ‘rio’ cioè canale) al quale abita una certa signora. Nel sogno ricordato, la “grande” rabbia è dunque un modo per scaricare/manifestare tramite un rovesciamento la grandezza dell’attrazione che provo inconsciamente per questa giovane signora che, mi viene da pensare, ha gli stessi occhi di mia madre. E che è sposata con un altro amico. Due piccioni con una fava: esprimere la rabbia per il “marìo” della signora e il “grande” desiderio verso quest’ultima. Che mi riporta a mia madre. Ho voluto molto bene a mio padre e questo sogno mi impone di (ri)chiedermi come mai.
Ai nostri scopi questo sogno è utile perché le associazioni su un dettaglio (il sogno era complicato e stranamente pensavo di ricordarlo tutto) hanno consentito di dipanare un filo di pensiero che esprimeva un forte desiderio il quale, tuttavia, a livello cosciente mi faceva sorridere (“Cosa ti metti in testa alla tua età?”) distraendomi da altri pensieri colà rappresentati. E molto meno allegri. Posso dunque essere un bambino (com’ero quando mia madre aveva l’età della giovane signora) che, benché con tutti i problemi di quell’età, non avrebbe però i problemi che ho ora. Bel colpo, penso per giunta, questo sogno va benissimo per i colleghi che mi hanno chiesto di scrivere la voce “sogno” per SPIpedia (ecco un grattacapo esterno, finora non risolto). Fili di pensiero diversi vengono intrecciati per realizzare il desiderio di risolvere alcuni problemi (come scrivere la ‘voce’?) negandoli e spostando l’attenzione su desideri antichi sì (per la coscienza) ma anche apparentemente attuabili oggi. Certo, Mario non c’entra ma è idoneo allo scopo per via del nome.
Quali desideri, dunque, presenti nell’inconscio e da appagare nella veglia? Almeno quattro: (1) scrivere la voce per spipedia, (2) annullare i grattacapi personali, (3) godere con mia madre, (4) vendicarmi di mio padre. Spero di riuscire a soddisfare almeno il primo. Ma questo desiderio all’apparenza ragionevole non realizza anche simbolicamente il desiderio (3)? Affettivamente sono molto legato alla SPI, anzi sono “dentro” alla SPI.
Intanto, ho illustrato alcuni meccanismi del sogno: esso è frutto di una elaborazione (secondaria) accurata che assembla derivati pulsionali differenti tra loro e molto attivi nell’inconscio. Ci sono diversi pensatori, laggiù. Possono essere raffigurati (condensati) assieme. Ma ognuno ha la propria energia, che può essere spostata o convogliata sullo stesso oggetto. Sono loro i capitalisti di cui parla Freud (OSF,III, 511). Ci mettono il capitale perché l’imprenditore possa cercare di realizzare il suo progetto (ad esempio: scrivere la voce che state leggendo) ma perseguendo un proprio e grosso guadagno. Già: chi ci guadagna di più? In fondo, finendo la ‘voce’ ottengo la scarica della tensione e , nell’ottica freudiana, l’oggetto della pulsione può essere variabile (Freud, 1915). La mamma può essere rappresentata dalla (sua) ‘voce’.
Chi volesse approfondire, può rileggersi i capitoli 5, 6 e 7 della Interpretazione dei sogni (Freud, 1900). E magari anche la prefazione all’edizione del 1908, nella quale Freud dichiara che quest’opera è un brano della sua autobiografia. Perciò non ho camuffato il sogno presentato come un sogno altrui.
Fin qui la prospettiva inaugurale freudiana sul sogno: ma la ricerca continua e, spesso, si avvale di analogie per allargare il tema. La seduta psicoanalitica ha analogie formali con il sonno e il sogno? Si vedano Green (2002) e Donnet (2005). Ma, ancora prima, fu Freud stesso a continuare la ricerca, osservando i sogni traumatici e cercando il loro significato in Al di là del principio di piacere (1920). Ancora una volta, lo studio del sogno – vera via regia all’inconscio, purché si segua il metodo psicoanalitico (Le Guen, 1989; Semi, 2011) – consentiva di mutare la concezione dell’essere umano. È un invito a proseguirlo.
Bibliografia ragionata
Donnet J.-L. (2005) La situation analysante. P.U.F., Paris.
Freud S. (1900) L’interpretazione dei sogni. OSF, III.
Freud S. (1915) Pulsioni e loro destini. OSF, VIII.
Freud S. (1917) Supplemento metapsicologico alla teoria del sogno. OSF, VIII.
Freud S. (1920) Al di là del principio di piacere. OSF, IX.
Freud S. (1925) La negazione. OSF, X.
Green A. (2002) Idee per una psicoanalisi contemporanea. Cortina Editore, Milano, 2004.
Le Guen Cl. (1989) Théorie de la méthode psychanalytique. P.U.F., Paris.
Musella R. Trapanese G. a cura di (2019) L’interpretazione dei Sogni. Dialoghi sulla tecnica psicoanalitica, Franco Angeli, Milano.
Semi A.A. (2011) Il metodo delle libere associazioni. Cortina Editore, Milano.
Sogno in W.R. Bion

Rene Magritte, 1966
A cura di Michele Bezoari
Per evidenziare il contributo innovativo di Bion alla teoria psicoanalitica del sogno è utile partire dal concetto di lavoro onirico, introdotto da Freud nel sesto capitolo della Interpretazione dei sogni (1899).
Il lavoro psichico da cui scaturisce il sogno consiste, per Freud, di due fasi successive: la produzione dei pensieri inconsci e la loro trasformazione nel contenuto manifesto del sogno. Solo questa seconda operazione, in quanto specifica dei sogni, è stata da lui considerata come il vero e proprio lavoro onirico e descritta mettendone in luce le modalità impiegate per eludere la censura (condensazione, spostamento, raffigurazione simbolica, elaborazione secondaria).
La ricerca di Bion si è, invece, focalizzata sulla prima fase, cioè sulla formazione dei pensieri inconsci mediante un processo dal quale derivano, come lo stesso Freud aveva ipotizzato, anche i pensieri coscienti. Per indicare la novità del suo apporto Bion ha usato inizialmente il termine lavoro-del-sogno-alfa, ridefinito in seguito funzione alfa (1962, 1992).
Questa funzione opera trasformando le impressioni emotivo-sensoriali (elementi beta) in immagini (gli elementi alfa) idonee alla costruzione dei pensieri sia consci che inconsci. Si tratta di un lavoro onirico basilare e necessario per la vita psichica: lavoro che, a differenza di quello che porta alla formazione del sogno, si svolge di continuo, non solo quando dormiamo ma anche quando siamo svegli. È un processo paragonabile, secondo Bion, alla digestione.
Nell’ottica bioniana il contenuto manifesto del sogno è un’aggregazione di elementi alfa articolati in forma narrativa durante il sonno e successivamente rielaborati durante la veglia. Il nucleo del sogno come evento vissuto dal soggetto dormiente è un’esperienza emotiva, che la funzione alfa elabora nel tentativo di renderla pensabile, analogamente a quanto accade per le esperienze emotive vissute nello stato di veglia.
Parlando di “sogno necessario” e affermando che ogni uomo deve poter “sognare” un’esperienza emotiva mentre gli capita, sia che gli capiti nel sonno sia che gli capiti da sveglio, Bion (1962) si riferisce dunque al primo livello di pensiero onirico. Per evitare di essere frainteso dal lettore, egli usa – almeno inizialmente – le virgolette quando con i termini “sogno” e “sognare” intende il prodotto e l’attività della funzione alfa, non il sogno e il sognare propriamente detti (che devono la loro specificità allo stato di coscienza peculiare del sonno), né le fantasticherie della veglia talvolta chiamate, nel linguaggio comune e anche da Freud, “sogni a occhi aperti”.
La nuova teoria è compatibile, come dichiara lo stesso Bion, con i concetti classici di rimozione, censura e resistenza impiegati da Freud a proposito del sogno. Ma questi meccanismi vengono ora considerati al servizio della funzione alfa, che crea e differenzia i pensieri inconsci e quelli consci per mezzo di una membrana virtuale in continuo sviluppo denominata barriera di contatto. Più che prodotti dall’inconscio, essi sarebbero dunque meccanismi produttori dell’inconscio.
Con Bion viene pienamente riconosciuta al sogno quella capacità di generare nuovi significati della vita emotiva che Freud aveva solo in parte e tardivamente ammesso, legato com’era al suo assunto teorico di considerare il sogno come una deformazione di significati già presenti nell’inconscio (Riolo 1983).
Ma non tutti i sogni sognati, ricordati ed eventualmente raccontati hanno lo stesso valore per la pensabilità dell’esperienza emotiva. Adottare la prospettiva bioniana non significa considerare il contenuto manifesto del sogno come se raccontasse “la verità, tutta la verità e nient’altro che la verità” (Meltzer 1984).
Per Bion il lavoro simbolopoietico della funzione alfa, nelle sue varie fasi, è soggetto a influenze contrastanti che tendono ad evitare invece che a favorire la consapevolezza di emozioni troppo dolorose. Il materiale onirico può essere inconsciamente usato come bugia – invece che per accostarsi alla verità – e la stessa funzione alfa può invertire il suo corso, come accade nei disturbi psicotici, trasformando anche i simboli già prodotti in elementi quasi concreti (simili agli elementi beta originari), non più utilizzabili per il pensiero ma destinati all’evacuazione nel corpo, nel comportamento o nel mondo esterno con modalità allucinatorie.
Alla luce degli sviluppi bioniani anche il posto del sogno in analisi viene in parte riconfigurato.
Mentre il sogno della notte è un tentativo di rendere pensabile l’esperienza emotiva del sognatore addormentato, nella seduta analitica il sogno raccontato dal paziente si inserisce nel contesto di un dialogo che ha come nucleo emotivo ciò che egli sta vivendo nella relazione con l’analista. È compito dell’analista cercare di sintonizzarsi con questa esperienza emotiva in atto per favorirne la simbolizzazione condivisa, mettendo la propria funzione alfa al servizio di quella del paziente grazie a una disposizione mentale definita da Bion reverie [], che integra il concetto freudiano di attenzione fluttuante.
L’analista, afferma Bion (1992), deve poter “sognare” l’analisi mentre questa avviene, ma naturalmente – precisa con un pizzico di umorismo – non deve addormentarsi. Obiettivo dell’analista è realizzare insieme al paziente una “trasformazione in sogno” (Ferro 2009) dei fatti della seduta. Tra questi fatti il racconto di un sogno ha un carattere speciale in quanto è espressione (più o meno riuscita) del lavoro onirico notturno del paziente e, soprattutto, in quanto può offrire al pensiero associativo della coppia analitica spunti inediti per esplorare nuove prospettive di senso (Bezoari e Ferro 1994).
Interpretare il sogno equivale per Freud a disfare i travisamenti del lavoro onirico notturno per risalire ai pensieri già presenti nell’inconscio del sognatore. Per Bion si tratta piuttosto di portare avanti il lavoro del sogno nella veglia, mettendo a frutto anche le potenzialità creative delle trasformazioni oniriche descritte da Freud (condensazione, spostamento, raffigurazione) per produrre nuovi pensieri, idonei a rappresentare l’esperienza emotiva in divenire. Come dice Ogden (2005) ispirandosi a Bion, scopo dell’analisi è migliorare nell’analizzando la capacità di “sognare i suoi sogni non sognati o interrotti”.
Bibliografia
Bezoari M., Ferro A. (1994). Il posto del sogno all’interno di una teoria del campo analitico. Riv.Psicoanal., 40, 251-272.
Bion W.R. (1962). Apprendere dall’esperienza. Roma, Armando, 1972.
Bion W.R. (1992). Cogitations. Pensieri. Roma, Armando, 1996.
Ferro A. (2009). Trasformazioni in sogno e personaggi del campo psicoanalitico. Riv.Psicoanal., 55, 395-420.
Freud S. (1899). L’interpretazione dei sogni. O.S.F., 3.
Meltzer D. (1984). La vita onirica. Roma, Borla, 1989.
Ogden T. (2005). L’arte della psicoanalisi. Milano, Cortina, 2008.
Reverie, Spipedia enciclopedia SPIWEB https://www.spiweb.it/la-ricerca/ricerca/spipedia/
Riolo F. (1983). Sogno e teoria della conoscenza in psicoanalisi. Riv.Psicoanal., 29, 279-295.
Sogno. Sviluppi in Masud Khan

Ettore Spalletti, 2016
Il sogno
Sviluppi in Masud Khan
A cura di Lucio Russo
Le ipotesi teoriche di Khan hanno portato alla luce l’altro sogno che gli enunciati positivi di Freud (1899;1925) avevano lasciato nell’ombra e nell’indeterminatezza. L’ombra del sogno di Freud, che la nuova teoria di Khan pone al centro dell’intero sistema-sogno, è l’esperienza del sognatore di sognare. E’ l’esperienza onirica «fuori testo», alla quale è preclusa la rappresentazione e il senso, che vive all’ombra del sogno narrato, ma che lo ispira. E’ la creatività umbratile del sogno.
Nel suo primo articolo sul sogno (1962), Khan mette in relazione la capacità di fare un «buon sogno» con stati di soddisfazione acquisiti e depositati nella memoria corporea e inconscia del sognatore. Il «buon sogno» è possibile solo se le immagini mnestiche di una soddisfazione anteriore dei bisogni sono pronte ad essere investite da energia libidica e riattivate nell’offuscamento allucinatorio del desiderio. Secondo lo psicoanalista pakistano, Freud spinto dall’autoanalisi dei propri sogni e dall’immedesimazione con le esperienze cliniche dei suoi pazienti, avrebbe ricreato «intuitivamente nello scenario analitico, un ambiente fisico e psichico» che corrisponde «in misura rilevante a quello intrapsichico che nel sognatore favorisce un “buon sogno”.
Già nel 1962 Khan introduce l’importanza degli spazi intrapsichico e fisico nella formazione del sogno e della situazione analitica.
In «Uso e abuso del sogno nell’esperienza psichica» (1972) egli propone l’idea della «capacità di sognare», che è facilitata dal sostegno delle cure dell’ambiente. Lo spazio del sogno è l’equivalente intrapsichico dello spazio transazionale, nel quale l’individuo può vivere alcuni tipi di esperienze.
Lo spazio del sogno contiene e elabora sensazioni e affetti, che altrimenti sarebbero messi in atto ed evacuati nello spazio sociale.
Khan differenzia il sogno inteso come processo mentale simbolico e le esperienze attualizzate nello spazio del sogno.
Egli scrive che nella realtà psichica interna di ogni paziente dovremmo distinguere il processo del sogno dallo spazio in cui il sogno si effettua. Sappiamo dalla monumentale opera di Freud che una delle funzioni monumentali del sogno è l’appagamento del desiderio; sappiamo inoltre che sognare è una capacità. E questa capacità dipende vuoi dal clima psichico interno in un determinato momento, vuoi dalla disponibilità di certe funzioni dell’Io che consentono di usare quel discorso simbolico che è l’essenza della formazione onirica.
Khan intende sottolineare che in molti pazienti per molto tempo il processo del sognare, che articola impulsi e conflitti inconsci, avviene senza che si sia costruito uno spazio onirico, dove il sogno può attualizzare l’esperienza del sogno. Egli consiglia, in questi casi, di «ridurre al minimo l’interpretazione del contenuto del sogno», in quanto un’eccessiva elaborazione del processo del sogno potrebbe nascondere l’incapacità del paziente di instaurare lo spazio onirico.
In questo secondo articolo sul sogno si comincia, dunque, a delineare lo statuto dell’esperienza del sognare, che è diversa dal testo del sogno.
Nel suo terzo articolo sul sogno, infine, «Al di là dell’esperienza onirica» (1976), Khan relativizza la centralità dell’interpretazione del testo-sogno e mette al centro dell’attenzione l’insieme del sogno come esperienza
Bisogna distinguere tra l’esperienza onirica e il significato del testo onirico che viene ricordato, il sognare è un’esperienza psichica del tutto diversa da quella fornita dal testo onirico rievocabile.
Khan giunge a definire la differenza tra l’interpretazione del significato del sogno e l’esperienza che il paziente fa del sogno come cosa in sé. Sottolineo i due termini «esperienza» e «cosa in sé», che Khan mette tra loro in relazione, per definire il fatto di sognare. Per lo psicoanalista pakistano l’esperienza del sognare si avvicina a quella «realtà fondamentale» e inconoscibile che Bion rappresenta con il simbolo «O». Nel pensiero di Khan l’esperienza del sognare, che il filosofo Maritain definisce «il mondo incomunicabile della “soggettività creativa”» dà forma ai primi confini dell’Io.
Il sognare «l’intero sogno» sarebbe, dunque, l’espressione di un fatto creativo, è una funzione della struttura inarticolata della mente inconscia e pre-logica, che non «diventa mai accessibile alla normale articolazione mentale», che «può adempiere a compiti di integrazione che superano di molto la capacità dell’attività mentale conscia di superficie».
Il sognatore utilizza l’esperienza onirica per avere un contatto diretto con la totalità del Sé e con il proprio senso di essere.
Khan identifica l’esperienza del sognare con la costruzione dello «spazio onirico», che definisce «la strutturazione nel soggetto di un ambiente interno, idoneo a usare “i meccanismi del sogno e il sogno stesso”, che è il risultato di provvigioni ambientali adeguate. Allorché mancano soccorsi ambientali adeguati, non si creano lo spazio onirico, la capacità di sognare e l’uso soggettivo e personale dei sogni.
In numerosi pazienti traumatizzati il processo del sognare e la formazione del testo onirico avvengono senza che si sia strutturato lo spazio onirico. Alcuni pazienti sfruttano lo spazio narrativo per drammatizzare e mettere teatralmente in atto i loro sogni privi dello spazio onirico.
Nel lavoro del 1976, Khan conclude la propria ricerca sul sogno identificando l’esperienza onirica con una forma paradossale di autoesperienza soggettiva, che amplia e completa l’esperienza del sé tramite il funzionamento del processo primario.
Khan amplia la teoria freudiana del sogno introducendo alcuni nuovi concetti. Il primo è quello di «spazio onirico», che ricalca lo «spazio potenziale», e che Khan definisce la strutturazione nel soggetto di un ambiente idoneo a usare i meccanismi del sogno e il sogno stesso. Egli fa l’esempio di pazienti che sognano e raccontano i loro sogni senza trarre da essi alcuna soddisfazione; sogni che non si realizzano nello spazio privato del Sé e che non conducono alla personalizzazione dell’esperienza del sogno.
Il secondo si riferisce al Sé, che non è l’Io, ma è l’esperienza soggettiva e personale del bambino, sostenuto dall’ambiente, di diventare capace di riconoscere se stesso nella dipendenza e di sostenere la separazione del non-me da me.
In «Scoperta e divenire del Sé» Khan definisce il Sé l’autoesperienza soggettiva che non comunica, creata dai suoi simboli, così come da essi è rappresentata ed espressa.
Rimane enigmatica «l’esperienza del sognare», che Khan ha introdotto nel sogno. L’esperienza non è un fatto oggettivo e non viene comunicata e trasmessa attraverso il modello dell’informazione oggettiva.
Ronald Laing, l’antipsichiatra inglese analizzato da Winnicott e supervisionato per breve tempo da Bion, ha visto nella musica un modello di comunicazione e di trasmissione dell’esperienza.
Dice Laing che la melodia non consisterebbe nelle note singole, separate, ma nella forma generata dalla sequenza dei rapporti delle altezze delle note. Questi rapporti non sono note e di per sé non produrrebbero suono. Se la musica arriva a noi, si verifica un’istantanea vibrazione empatica attraverso la quale entriamo in risonanza e in comunione con essa. Non è attraverso questa comunione risonante che i fatti oggettivi vengono comunicati.
L’esperienza è uno stato d’animo, un’atmosfera, sfumature di pathos, che né il pensiero logico, né il discorso possono trasmettere e nessun metodo scientifico può oggettivare. Eppure l’esperienza arricchisce la vita degli individui e la sua mancanza la impoverisce. In definitiva provo a definire l’enigmatica «esperienza del sognare», articolando i due termini «esperienza» e «sognare». La capacità di sognare è una funzione psichica, che presuppone la funzione materna primaria di cura e di holding dell’infante. Nel tempo del sognare il sognatore entra regressivamente nello stato di dipendenza assoluta dell’infante nelle braccia della madre.
L’attività del sognare può essere metaforicamente descritta, usando una felice espressione di Ferenczi: l’esperienza de «l’infante dormiente nell’inconscio dell’adulto».
Sostenuto dallo spazio onirico, metafora del corpo materno, il sognatore fa esperienza dell’inizio del Sé. Esperienza soggettiva, privata, che non può essere né ricordata, né rappresentata, né narrata.
BIBLIOGRAFIA
Freud S. (1899), «L’interpretazione dei sogni», in O.S.F., vol. III, Boringhieri, Torino, 1966
Freud S. (1925), «Osservazioni sulla teoria e pratica dell’interpretazione dei sogni», in O.S.F., vol. IX, Boringhieri, Torino, 1977
Freud S. (1925), «Alcune aggiunte d’insieme alla “Interpretazione dei sogni», in O.S.F., vol. X, Boringhieri, Torino, 1978
Khan M.M.R. (1974), «La psicologia del sogno e l’evoluzione della situazione analitica», in Lo spazio privato del sé, Boringhieri, Torino, 1979
Khan M.M.R. (1974), «Uso e abuso del sogno nell’esperienza psichica», in Lo spazio privato del Sé.
Khan M.M.R. (1974), «Scoperta e divenire del Sè», in Lo spazio privato del Sè, op.cit. p. 283.
Khan M.M.R. (1983),«Al di là dell’esperienza onirica», in I Sé nascosti, Bollati Boringhieri, Torino, 1990
Laing R. (1967), Nascita dell’esperienza, Mondadori, Milano, 1982.
Milner M, (1987), «1975:Discussione dell’articolo di Masud Khan “Alla ricerca dell’esperienza del sognare”», cit. p. 345;
Milner M. (1969), «Le mani del Dio vivente», Armando, Roma, 1974.
Winnicott D.W. (1989),«Le basi del Sé nel corpo», in Esplorazioni Psicoanalitiche, Cortina, Milano, 1995, pp. 294-295;
Winnicott D.W. (1989),«L’importanza del setting nelle situazioni regressive in psicoanalisi», in Esplorazioni Psicoanalitiche, op.cit., p. 121.
Sonno del bambino
A cura di Marco Mastella
Il sonno del bambino interessa i genitori, i ricercatori e i clinici. I genitori sono di solito interessati a che i figli dormano sonni tranquilli, che permettano loro di riposare, per affrontare serenamente la giornata.
Secondo diversi studiosi, il sonno nell’uomo può essere definito come: “stato dell’organismo caratterizzato da ridotta reattività agli stimoli ambientali, che comporta sospensione dell’attività relazionale e modificazione della coscienza; esso s’ instaura spontaneamente e periodicamente, si autolimita nel tempo, ed è reversibile “ ( Fagioli e Salzarulo, 1995, in : Salzarulo, 2002)
Peraltro, dormir bene tutta la notte non è di per sé sinonimo di “star bene”. Molti bambini in qualche modo si trattengono talora dall’esprimere il loro disagio quando le tensioni familiari sono troppo forti.
E’ bello vedere un bambino dormire tranquillo come è ben rappresentato in diversi dipinti. Un bambino di solito dorme molto e volentieri e, se sta bene e non è pressato da ritmi familiari troppo intensi, si sveglia altrettanto volentieri. L’acquisizione del ritmo sonno-veglia inizia già nel corso della vita intrauterina e prosegue soprattutto nel primo anno di vita giungendo di solito a sincronizzarsi sufficientemente con i ritmi di vita dei genitori, quando questi ritmi sono “sopportabili”.
L’organizzazione dei ritmi sonno-veglia e dell’alternarsi dei diversi tipi di sonno (sonno attivo e sonno calmo corrispondenti al cosiddetto sonno REM e NREM) dipende sia dalla maturazione biologica e cerebrale sia dalle abitudini di vita della famiglia che possono variare notevolmente sia su base culturale che sociale; essi possono variare inizialmente a seconda che il bambino sia nato a termine o pre-termine. Soltanto gravi malattie piuttosto rare possono impedirne l’acquisizione.
L’addormentamento è sempre un momento cruciale nella giornata di un bambino che accetta di affrontare, solo, l’avventura della notte. I genitori compiono di solito tutta una serie di rituali per ‘accompagnarlo fino all’ultimo’, ricordando qualcosa delle loro sere e notti di bambini, più o meno paurosi, più o meno ‘esclusi’ dal lettone e dall’intimità dei loro genitori, più o meno assaliti da incubi.
Questi rituali comprendono i preparativi per la notte, che cambiano con l’età del bambino, con l’organizzazione degli spazi all’interno della casa e della camera del bambino e con le abitudini e gli stili di vita familiare. Ricordiamo l’importanza del cullare, delle ninne nanne, delle canzoni, delle favole, ma anche del permettere al bambino di auto consolarsi ( con varie modalità, tra cui la possibilità di succhiare il succhiotto o il dito, o di ricorrere al cosiddetto ‘oggetto transizionale’, l’equivalente della copertina di Linus) e di giungere ad addormentarsi da solo.
In una direzione opposta va la tendenza di taluni bambini che si aggrappano a parti del corpo dei genitori ( in primis i capelli) con l’inconsapevole complicità dei genitori stessi: il che condiziona lo strutturarsi di abitudini difficilmente superabili, ma, soprattutto, di modalità di pensiero e di rappresentazione di sé del tutto particolari ( fantasie di fusionalità, negazione della separatezza fisio-psichica, persistere di uno stato del tutto particolare di dipendenza).
Un ruolo disturbante l’addormentamento è svolto spesso dalla televisione o da giochi eccitanti, talora introdotti dai genitori stessi come surrogato alle opportunità mancate durante la giornata.
In età più avanzata il bambino si organizza propri rituali, che di solito rimangono segreti, con un ritorno a stati mentali e fantasie più tipiche ad età precedenti.
In ogni caso, l’addormentamento è un’esperienza di passaggio, di transizione, di separazione, di perdita di controllo sulla realtà esterna, compreso l’ambiente e i genitori, e sulla fantasia, sull’immaginazione, che si dispiegano in modo più inquietante sia negli stati di transizione, di passaggio dalla veglia al sonno, sia negli stati di sonno profondo, attraverso i sogni.
Un’esperienza di passaggio verso il proprio mondo interno, i tentativi più intimi di rappresentarsi la realtà materiale e la realtà psichica, le emozioni, i sentimenti, i desideri, le paure, in uno stato di ripiegamento in se stessi e di solitudine mitigato dall’illusione di continuare ad essere tra le braccia della mamma o in presenza dei genitori che accompagnano l’addormentamento con dolce fermezza.
In schede successive potremo occuparci dei ritmi del sonno, dei sogni del bambino, delle difficoltà di addormentamento, dei risvegli notturni e dei disturbi del sonno, nell’ambito della crescita psichica .
Novembre 2013
Bibliografia semplice:
Bibliografia
de Leersnyder H. (1998) Il sonno del bambino. Come garantire ai vostri figli notti senza problemi e senza paure. Ediz. Pendragon, Bologna
Decobert S., Sacco F. (2001) (a cura di – ) Il sogno, il bambino e lo psicoanalista. F. Angeli, Milano.
Persico G. (2002) La Ninna Nanna. Dall’abbraccio materno alla psicofisiologia della relazione umana. Ediz. Univ. Romane, Roma.
Salzarulo P. ( 2002) Il primo sonno. Sviluppo dei ritmi sonno-veglia nel bambino. Bollati Boringhieri, Torino.
Salzarulo P. ( 2006) Come dormiamo. Giunti Barbera, Firenze
Speranza

La Speranza (Spes) di Giotto 1306
A cura di Rita Corsa e Lucia Monterosa
Il profondo disagio individuale, sociale ed etico che connota questo scorcio d’inizio millennio, travolto da trasformazioni brutali e tumultuose, tende a trascinare anche la psicoanalisi in territori che hanno costituito snodi cruciali nel pensiero occidentale, ma rimasti sinora appannaggio di altre discipline. Questo è senz’altro il caso della figura della Speranza, il cui significato ha assunto declinazioni diverse nei tempi e nelle culture, come testimoniato dalla sterminata letteratura teologica, filosofica, religiosa e psicologica ad essa dedicata. In psicoanalisi, però, non esiste una dottrina della speranza e solo in tempi recentissimi è diventata materia di studio, specialmente nelle situazioni di collisione con i limiti e le asperità del reale, dove si evidenzia l’essenziale funzione difensiva di tale sentimento, ma pure la sua potente forza propulsiva e di apertura al futuro.
Dal vaso di Pandora all’utopia attiva
Esiodo, nella sua teogonia risalente al VII secolo avanti Cristo, faceva derivare tutte le afflizioni del genere umano a Pandora, la prima donna dell’umanità, creata per ordine di Zeus che intendeva servirsene per punire la razza umana
in seguito al furto del fuoco operato da Prometeo. La fanciulla possedeva grande grazia e bellezza, ma era anche scaltra e menzognera. Venne condotta da Epimeteo, il fratello di Prometeo, che se ne innamorò e la sposò. Pandora
portò un vaso ermeticamente chiuso donatole da Zeus che il consorte, temendo un inganno degli dei, le proibì di aprire. Ella invece cedette alla sua curiosità e lo scoperchiò: ne fuoriuscì ogni sorta di malanni, che si sparsero per il mondo ponendo fine alla vita beata dei mortali. Pandora si affrettò a chiudere il vaso e dentro rimase la Speranza, l’unico bene restato agli uomini. Secondo una variante più tarda del mito, il vaso conteneva invece tutti i beni dell’umanità, che per colpa della curiosità di Pandora se ne tornarono agli dei e solo la speranza restò come conforto agli uomini. Un male come tutti gli altri: un affetto senza fondamento, una misera e illusoria consolazione.
Le possibili interpretazioni del mito ci lasciano nell’ambiguità riguardo alla materia dello sperare: è contemporaneamente un bene e un male necessari al vivere, un miraggio ingannevole ma pure un dono fondamentale, messo per questo nel vaso al di sotto di tutti i beni. Un lascito che accompagna l’incipit della vita umana, esposta al lutto e alle tribolazioni.
In ogni espressione religiosa la misericordia, la compassione, la pietas e la carità sono le caratteristiche dell’alleanza tra gli uomini attraverso cui la speranza può essere coltivata e trovare la sua espressione mediante la fede in Dio. Nella tradizione cristiana la speranza è una delle virtù teologali, dopo la fede e prima della carità: esse sono il fondamento che anima e su cui si radica l’agire morale (1). Su tali temi il dibattito teologico si è particolarmente arricchito di nuovi approfondimenti nel corso del secolo scorso.
Ernst Bloch e Maria Zambrano hanno esplorato la speranza attraverso una vasta produzione di scritti, collocando a pieno titolo questa materia nel panorama filosofico del Novecento. Entrambi considerano la speranza come una tonalità emotiva basilare dell’uomo e, a differenza di Heidegger, essi la ritengono più originaria dell’angoscia; quest’ultima affiorerebbe in un secondo tempo, quando la speranza si dissolve. Il loro pensiero ha un orientamento che non indulge ad un facile ottimismo: per i due pensatori il punto di emersione della speranza è proprio nell’esperienza umana di mancanza e di sconforto.
Ernst Bloch, nella sua opera enciclopedica Il principio speranza (1959), concepisce tale sentimento come un fattore gnoseologico che promuove conoscenza e progresso. La speranza permette al pensiero di dispiegarsi seguendo le complesse declinazioni delle cose, e alla ragione di liberarsi della concretezza dell’hic et nunc. La speranza dà corpo a quella che Bloch definisce l’«utopia concreta»; essa connota una dimensione del vivere protesa verso l’ignoto, «il non ancora divenuto»; è assediata dai rischi, è coscienza stessa del rischio, che promuove tuttavia l’esplorazione del mistero e la spinta alla conoscenza.
Maria Zambrano elabora il suo pensiero a partire dalla partecipazione diretta ai drammatici eventi del Novecento. Ella ritiene che proprio nelle situazioni di sofferenza possano essere rintracciate le radici della speranza, la quale procede con una serie di «passi» tra il deserto e la costruzione di un nuovo senso. «La speranza inafferrabile è un ponte tra passività, per estrema che sia, e l’azione» (1990). Il ponte con le sue arcate è il paradigma di una via che dispiega le ali al di sopra della corrente del fiume, così come i passi dello sperare indicano una strada che può essere percorsa sopra il proprio tumulto interiore e lo scorrere del tempo.
Il filosofo francese Gabriel Marcel ha dedicato un fondamentale saggio alla dialettica e al mistero della speranza: egli distingue la «speranza assoluta» dalle «speranze relative». Per Marcel, la speranza assoluta è «intima», «silenziosa», «riservata», che si risolve solo nella relazione fra due soggettività: il NOI è l’orizzonte della speranza assoluta, che non viene inquinata dalla scansione degli eventi quotidiani e dall’esperienza, caratteristiche delle speranze relative. La speranza assoluta è trascendente, tende alla riconciliazione, non si incaglia nel passato o nel tempo chiuso della disperazione, dischiude il tempo, vive nel futuro, avviando un processo integrativo tra passato e futuro, in una sorta di «memoria del futuro» (1944).
Un cenno fenomenologico
La corrente fenomenologica della psichiatria e della psicologia ha definito una vera e propria «categoria esistenziale della speranza». La speranza ha a che fare con il tempo e con l’attesa. La speranza, infatti, è anche attesa: spes, ma pure exspectatio (= attesa) (2). Non vi è speranza e non vi è attesa al di fuori del tempo, inteso come tempo interiore agostiniano e pascaliano. E l’attesa si riempie inevitabilmente d’angoscia (Angst): non c’è attesa senza angoscia. Ma la speranza va oltre l’attesa, «va più lontano» – afferma Minkowski: la speranza allontana dall’uomo il contatto immediato del divenire-ambiente, sopprime la morsa dell’attesa e consente di guardare liberamente lontano nello spazio vissuto che si dispiega davanti. La speranza costituisce così «un punto di intersezione fondamentale e naturale», una unione intima e indissolubile, tra il divenire e la visione umana del divenire (1936). Per Minkowski, invero, la speranza e il desiderio sono due pilastri della fenomenica dell’avvenire vissuto, grazie alla loro funzione generatrice di futuro (1933).
Come suggerisce lo stesso Minkowski, forse soltanto l’apostolo Paolo, nella sua lettera ai Romani (dove vengono dettati i precetti della vita cristiana), ci può sorreggere nello sforzo di intendere: «Fummo infatti salvati nella speranza; ma una speranza che si vede non è più speranza: chi infatti spera ciò che vede? Ma se noi speriamo ciò che non vediamo, stiamo in attesa mediante la costanza» (8, 24-25; trad. U. Vanni), che è la forza dell’attesa. La speranza, allora, come figura del vivere che sostiene l’uomo nel travaglio del transito terrestre.
La speranza nel pensiero psicoanalitico
Nelle sue opere Sigmund Freud usa raramente il termine speranza, mentre lo adopera generosamente nel privato, come documentato nei suoi tanti carteggi. La grande speranza che infiamma l’animo di Freud è quella di veder crescere la sua creatura, la psicoanalisi.
Freud non spera in Dio, né nell’uomo. Con fiero coraggio pubblica l’Avvenire di un’illusione (1927) e scrive all’amico, il pastore Pfister: «Il saggio ha per tema (…) il mio atteggiamento di decisa ripulsa verso la religione, in ogni forma e sfumatura» (lettera di Freud a Pfister, 16 ottobre 1927; in Freud, 1962). La religione è «la nevrosi ossessiva universale dell’umanità; come quella del bambino, essa ha tratto origine dal complesso edipico, dalla relazione paterna»: avrebbe una funzione sociale, controllando le istanze pulsionali, e d’illusoria consolazione (Freud, 1927). L’unica, vera speranza dell’uomo sta nella ragione e, di conseguenza, nella scienza. Solo la scienza sarà in grado di «riconciliare gli uomini con la civiltà». La «voce dell’intelletto è fioca, ma non ha pace finché non ottiene udienza» e, alla fine, riesce a farsi ascoltare: «Questo è uno dei pochi punti che consentono un certo ottimismo per l’avvenire dell’umanità (…) Ad esso possono essere ricondotte anche altre speranze». Per Freud, solo il lavoro scientifico consentirà di «apprendere qualcosa che servirà ad accrescere il nostro potere e a governare la nostra esistenza» (ibid.). Ogni altra forma di speranza ha soltanto il valore di aiutare a tollerare la fatica dell’esistere: «come per l’umanità nel suo insieme, anche per l’individuo singolo la vita è dura da sopportare» (ibid.) (3). Egli rimarca: «So quanto è difficile evitare le illusioni, forse anche le speranze a cui mi affido sono di natura illusoria». L’illusione non è dunque un errore, ma è una credenza nella cui motivazione prevale l’appagamento di desiderio, prescinde dal rapporto con la realtà e rinuncia ad una convalida. Freud rimase ateo dall’adolescenza fino all’ultimo istante della sua esistenza, seguendo un percorso di vita personale e intellettuale attraverso cui si distanziò dalla cultura del ghetto e dalla fede paterna nelle Sacre Scritture, ma, nel contempo, egli espresse il bisogno di dare una spiegazione alla religione e di capirne il suo potere sull’umanità.
Nelle pieghe degli scritti di Melanie Klein troviamo alcuni significativi riferimenti alla speranza, che emergono a partire dagli anni Trenta con l’inserimento nelle sue teorizzazioni della posizione depressiva. Nel saggio Il lutto e la sua connessione con gli stati maniaco- depressivi (1940), la descrizione della spinta intrisa di speranza tesa a raggiungere l’oggetto buono è accompagnata da termini desueti nel glossario psicoanalitico, come bontà, gioia, amore, struggimento: «L’essere amato, la gioia e il benessere che [il bambino] prova nei suoi rapporti con le persone rafforzano in lui la fiducia nella bontà propria e degli altri, e aumentano la speranza che gli oggetti buoni e il proprio Io possano essere tutelati e salvati». In tal modo il bambino acquisisce sicurezza nella bontà del proprio mondo interno, consente «ai sentimenti e agli oggetti interni una maggiore vitalità» e «i processi creativi possono reinstaurarsi e torna la speranza». In Invidia e Gratitudine (1957), l’ultimo suo saggio, la Klein ripercorre la trama della sua teoria sullo sviluppo del rapporto primordiale del bambino con la madre, il primo oggetto relazionale. Nelle righe finali, ella ci lascia in eredità, oltre ai suoi pensieri provocanti e originali, alcune parole cariche di speranza sul senso del lavoro analitico e conclude il discorso annotando che, nel corso dell’analisi, il paziente può gradualmente «costituire un oggetto buono, l’invidia si attenua e la sua capacità di provare piacere e gratitudine aumenta poco alla volta. Questi cambiamenti si estendono a molti aspetti della personalità del paziente e vanno dalla vita emotiva nelle sue forme più arcaiche alle esperienze e ai rapporti adulti. Nell’analisi degli effetti dei disturbi precoci di sviluppo è racchiusa (…) la nostra maggiore speranza di portare aiuto ai nostri pazienti». La Klein sollecita dunque l’analista a proseguire nella sua opera di perlustrazione del funzionamento primitivo della vita psichica, via regia per arricchire di speranza il futuro della disciplina psicoanalitica.
Sulla tematica dell’illusione Donald Winnicott ha elaborato il suo contributo più originale alla comprensione della natura umana. Nei suoi studi sugli stati emozionali primari, egli si sofferma nella zona dell’illusione: lo spazio potenziale; un’area dove fantasia e realtà si incontrano; un territorio dove il mondo interno ed esterno continuano a sovrapporsi, e che il bambino scopre specialmente mediante il gioco, creando il «non me». L’illusione viene collocata all’esordio della vita del soggetto e delineata come una dimensione psichica indispensabile nella visionarietà di qualsiasi gesto creativo (1958). Winnicott dà forma alle sue idee innovative anche sul tema della speranza, che viene messa in correlazione con la deprivazione, intesa quale forza portante degli atti antisociali compiuti da bambini e adolescenti: «La tendenza antisociale implica la speranza. La mancanza di speranza è il tratto fondamentale del bambino deprivato. E’ nel periodo della speranza che il bambino manifesta la tendenza antisociale». Per Winnicott, la speranza «sottende la coazione al furto» in età evolutiva: «Per aiutare dei bambini con tendenze antisociali è vitale comprendere che l’atto antisociale esprime una speranza» (ibid.). Quindi gli agiti delinquenziali testimonierebbero, in una fase precoce del loro manifestarsi, che il bambino deprivato, dopo un miglioramento delle sue condizioni di vita, sta ricominciando a sperare. Se l’ambiente sarà in grado di riconoscere le carenze che hanno prodotto il danno, allora il bambino potrà acquisire la capacità di soffrire, di sentirsi in colpa e potrà ritrovare l’emotività e la spontaneità perdute.
Winnicott, attraverso questa visione dell’atto terapeutico e dei legami umani, ci induce a chiosare che il terapeuta deve essere capace d’intravedere l’oscuro fondo di speranza che connota anche le azioni aggressive e respingenti, al fine di permettere il recupero di ciò che è andato perduto, e di favorire il transito da una speranza agita e carica di angoscia alla costruzione di relazioni improntate alla fiducia e alla reciprocità.
La formula adottata da Wilfred Bion in Cogitation per decifrare il concetto di speranza è complessa, ma gravida di implicazioni speculative: «Le “paure” sono opache come le “speranze”. La speranza è diversa dal desiderio? Sì, come i nodi; è desiderio + tempo. Oppure, Desiderio + Frustrazione = Speranze ↔ Paura» (1992). E’ possibile per la mente umana una speranza che guarisca dalla menzogna e dalla bugia, caratteristiche di quell’ipocrisia convenzionale che spegne la vitalità del pensiero ed inibisce «la spinta ad esistere» (Bion 1987)? Per Bion è l’“atto” della fede.
La fede è intesa come «proposizione scientifica», non inquinata dalla memoria e dal desiderio. La fede permette all’analista di «attendere» l’arrivo del fatto prescelto. Ma anche di sopportare le trasformazioni infinite di O, che trascinano ai limiti estremi del conoscibile. Il concetto di O racchiude l’esperienza ontologica ignota, inconoscibile, ineffabile e inscrutabile dell’essere ultimo, quella che Bion designa come «verità assoluta», «realtà ultima», posta sempre «al di là» (delle parole, del sapere, della contemplazione, etc.). Un eterno inconoscibile e inaccessibile, che obbliga l’analista ad abitare una «posizione di trascendenza». La trascendenza bioniana non ha alcun rapporto con la concezione religiosa, bensì con l’immanenza. In altri termini, la nostra trascendenza in potenza è situata presso di noi in quanto O. Quando, come conseguenza del nostro vivere le esperienze emotive, «diventiamo» tali esperienze, la nostra immanenza (divinità) si incarna e si realizza, e noi trascendiamo noi stessi, cioè evolviamo. E l’oscillazione Speranza↔Paura si colloca proprio in questa dinamica trasformativo/evolutiva della mente umana.
La speranza nella psicoanalisi contemporanea
La questione delle speranze nel lavoro dell’analisi riguarda, invero, sia il paziente sia l’analista. Esse sono spesso diverse e divergenti: la speranza del paziente è intrinseca al suo transfert, mentre quella dell’analista, profondamente connessa al proprio controtransfert, è di trasformare i vissuti e i sentimenti che sono alla base del transfert del paziente (Friedman, 1988). Comunque la speranza (come la curiosità e la passione) deve essere considerata un elemento centrale della vita affettiva umana e quindi dell’incontro analitico (Mitchell, 1993). Un «affetto» complesso, fonte di ispirazione continua durante il gioco dell’analisi (Buechler, 1995).
Nell’attuale pensiero psicoanalitico – d’altronde ancora poco dotato di un’esaustiva metapsicologia sull’argomento – si registrano due approcci in contrasto: l’uno valuta la speranza come un’esperienza remunerativa e progressiva, su cui si basa la crescita e l’emancipazione del paziente; l’altro, di converso, teorizza il ruolo regressivo della speranza, che ostacolerebbe la maturazione psicoaffettiva dell’analizzando.
Sin dal 1968 Erikson – similmente a Winnicott – rileva la funzione progressiva e costruttiva della speranza nella stanza d’analisi. Il suo approccio, incentrato sulla psicologia dell’Io, situa la speranza nell’area essenziale della fiducia di base: si tratterebbe dunque di un elemento costitutivo dell’esperienza umana, a partire dalle iniziali fasi dello sviluppo infantile. La speranza sarebbe la «prima e la più fondamentale» delle «virtù vitali», marcando in maniera pervasiva il «destino» dell’individuo.
Tuttavia, non tutti gli analisti la pensano così. Nella classica cornice teorica pulsionale, la speranza, insieme all’illusione, è spesso stata intesa nella sua cifra involutiva: le speranze che spingono il paziente a entrare in analisi derivano dal desiderio di gratificare gli impulsi infantili sessuali e/o aggressivi. Queste speranze affondano le radici nel processo primario e si distinguono recisamente dal più maturo processo secondario, che richiede la rinuncia alla fantasia e all’illusione a favore dell’adesione al principio di realtà (Mitchell, 1993).
Charles abbraccia questo orientamento regressivo, quando considera la speranza una preconcezione, che può diventare una fantasia improduttiva, in termini winnicottiani, impedendo la crescita e lo sviluppo dell’analizzando. Egli osserva che la speranza può rivelarsi una sorta di trappola analitica, caratterizzata da un accecante e paludoso ottimismo, che creerebbe un soddisfacimento immaginario, ostacolando una vitale tensione al cambiamento sul piano reale (2003). Charles suffraga le sue ipotesi ricorrendo ai precedenti studi di Boris sull’adesione dei neonati a “preconcetti” già pronti alla nascita. Tali “preconcetti” figurano le rappresentazioni dei bisogni primari, diventando a loro volta l’oggetto del desiderio infantile. La stessa speranza implica un ripiegamento, un’aderenza a preconcetti, a immagini aprioristiche ed ideali. Per Boris, il processo analitico dovrebbe indurre l’abbandono della speranza, onde facilitare l’emersione dei desideri autentici e tacitare quelli preconcetti (1976).
Composita e problematica appare la posizione espressa da Amati e Argentieri, che esaminano il tema della speranza da diverse angolature e indicano i pericoli insiti nel trascurare i confini di questo sentimento, per altri versi imprescindibile nella costruzione dell’alleanza terapeutica. Notano i rischi di un eccesso di speranza da parte dell’analista, che può nascondere aspettative o desideri riguardanti la vita del paziente, oppure travasare nella relazione terapeutica preoccupazioni private. Mettono pure in guardia da sentimenti onnipotenti coperti dalla speranza, che possono celare un’aggressività controtransferale. Precisano le fisiologiche oscillazioni del gradiente della speranza in ogni terapia e concludono affermando che, comunque, la speranza alimenta il legame terapeutico e le forze vitali del paziente, essendo espressione di una fiducia di base nel reale potenziale curativo dello strumento analitico (1989).
Altri psicoanalisti segnalano che durante l’analisi di malati difficili (bordeline, narcisistici, psicotici) spesso emerge una speranza regressiva, chiamata con le parole spinoziane “passione triste”: la sad passion è prepotentemente correlata al terrore e indebolisce, debilita e paralizza l’animo del paziente, piegandolo in un’angosciosa attesa densa di minacce e di sensazione di catastrofe imminente. L’analista deve strenuamente tentare di abbandonare tale condizione dominata dalla speranza involutiva, fondata su credenze e su oggetti velenosi, bizzarri e seduttivi, per acquisire una speranza creativa, elemento basilare per rianimare la vita mentale del paziente e della coppia analitica: questo sarebbe l’obiettivo più importante di tutto il lavoro dell’analisi. La speranza diventa, allora, un principio saldo del funzionamento mentale. Quest’ultima speranza, che consente di dischiudere la mente al futuro in una spinta libera e creativa, è strettamente correlata alla fede, intesa come «atto di fede bioniano» e, quindi, in termini del tutto «esterni a quelli religiosi» (Figueiredo, 2004).
Anche Domash considera la speranza come segno dell’«implicita spiritualità» che lega l’analista e il paziente, fondata sulla qualità meditativa dell’analisi e sulla profonda fede che accomuna la diade analitica. Una fede nel processo terapeutico che produce rinnovamento, mediante identificazioni e interpretazioni. La speranza è un ingrediente necessario per riconoscere la dimensione spirituale dell’analisi e per «piantare i semi del cambiamento», in una prospettiva libera e creativa (2009).
Pellizzari, infine, osserva che la speranza si distingue dalla certezza; nasce dall’inquietudine e dal dubbio, abitando quel «non ancora» di Bloch, che rende possibile la tensione conoscitiva verso l’ignoto. La speranza è un potente fattore di trasformazione nel lavoro dell’analisi. Nel suo essere insatura, perturba le convinzioni fondamentaliste dell’inconscio, che soggiace alla coazione a ripetere. L’uso della metafora sarebbe l’espressione linguistica di tale funzione perturbante e trasformativa della speranza (Pellizzari, 2015).
La speranza, corrispondente fenomenologico del desiderio, può essere considerata il motore della vita psichica: ciò che permette di contrastare la coazione a ripetere, di esprimere una trazione al cambiamento e di facilitare l’attesa fiduciosa al futuro. Ha radici antiche nella relazione primaria con l’oggetto materno, dove accade quel processo alchemico di traduzione del caos infantile in uno spazio potenziale di illusione onnipotente e creativa. In tale habitat si può così sviluppare una fiducia di base, gravida di potenzialità, di crescita e di futuro. La figura della speranza occupa dunque un nucleo centrale nel discorso analitico, alimentando il legame terapeutico e le forze vitali della coppia al lavoro.
Ma vi è anche il lato oscuro della speranza. Sull’ombra della speranza induce a riflettere il gesto estremo dell’ultranovantenne Mario Monicelli, che nel novembre del 2010 si suicidò defenestrandosi dall’ospedale romano dov’era ricoverato per una malattia terminale (4). Egli lasciò un rivoluzionario testamento, pronunciato nell’ultima intervista televisiva di pochi mesi prima, durante la quale asseriva con veemenza che «La speranza è una trappola, è una brutta parola che non si deve usare. (…) Mai avere la speranza. (…) E’ una cosa infame» (RAIperunanotte, 26 marzo 2010). Quest’affermazione, ampiamente diffusa dai quotidiani nazionali, sembra racchiudere in maniera fulminante secoli di pensiero filosofico e letterario sul grandioso tema della faccia illusoria della speranza; un grande imbroglio, senza il quale, però, non è possibile vivere – parafrasando la celeberrima tesi di Giacomo Leopardi nello Zibaldone.
La speranza, nel suo raffinato inganno, consente all’uomo di «non vedere il cadavere». L’incessante rimando al futuro, essenza della speranza, acceca il presente, procrastinando il tempo, ma anche l’atto, della rivelazione ultima (Moltman, 1970). L’uomo posto di fronte ai limiti dell’esistere ha bisogno di appellarsi alla potenza consolatrice e riparatrice del sentimento della speranza; ma la stessa speranza origina dall’urgenza penosa del limite. L’oscillazione tra il “limite” e la “speranza” (Limite↔Speranza) pare allora ben rappresentare la fatale dialettica del vivere (Corsa e Monterosa, 2015).
In un’ottica più propriamente psicoanalitica potremmo rilevare che la speranza è l’estrema difesa dall’angoscia di morte. L’ultimo male nietzschiano. Illusorio e menzognero. Ma salvifico per la mente, in quanto consente all’individuo di partecipare alla vita. Una magnifica istituzione della mente, una sorta di massiccio diniego, che ci permette di vivere, dimenticando che da un momento all’altro la fine dell’esistenza si rivelerà nel presente. Spes, ultima dea (5).
Note
(1) Fede, speranza e carità sono considerate dalla dottrina cristiana “virtù teologali”, in quanto infuse da Dio nell’anima dei fedeli per rendere le facoltà dell’uomo idonee a partecipare alla natura divina.
(2) Secondo alcuni filologi la radice della parola greca “elpis”, personificazione della spirito della speranza, entra attraverso una mutazione fonetica nella parola “voluptas”; ciò testimonierebbe un legame della speranza col desiderio.
(3) Quando Freud scrisse queste parole era tormentato dal carcinoma mascellare, diagnosticato nell’aprile del 1923, che lo obbligò a ripetuti interventi chirurgici e ad applicazioni di protesi che gli resero dolorosissimi l’alimentazione e la stessa fonazione.
(4) Il 5 ottobre 2013 anche un altro celebre regista italiano, Carlo Lizzani, pose fine alla sua vita lanciandosi dal balcone della propria abitazione nel quartiere Prati di Roma. Aveva 91 anni. L’ultima sua opera cinematografica porta il titolo “Speranza” e fa parte di Scossa, un film ad episodi, girato da 4 registi italiani nel 2011. La pellicola d’autore racconta del terremoto di Messina del 1908.
(5) Un’approfondita bibliografia sulla figura della Speranza in psicoanalisi si ritrova nel volume di Corsa e Monterosa, Limite è Speranza. Lo psicoanalista ferito e i suoi orizzonti (2015).
Bibliografia
AMATI MEHLER J., ARGENTIERI, S. (1989). Hope and Hopelessness: A Technical Problem?. Int. J. Psycho-Anal., 70, 295-304.
BION W.R. (1987). Seminari clinici Brasilia e San Paolo. Milano, Cortina, 1989.
BION W.R. (1992). Cogitations. Pensieri. Roma, Armando, 1996.
BLOCH E. (1959). Il principio speranza. Milano, Garzanti, 2005.
BORIS H. N. (1976). On hope: its nature and psychotherapy. Int. Rev. Psycho-Anal., 3, 139-150.
BUECHLER S. (1995). Hope as inspiration in psychoanalysis. Psychoanal. Dial., 5, 63-74.
CHARLES M. (2003). On Faith, Hope, and Possibility. J. Am. Acad. Psychoanal. Dyn. Psychiatr., 31, 687-704.
CORSA R., MONTEROSA L. (2015). Limite è Speranza. Lo psicoanalista ferito e i suoi orizzonti. Roma, Alpes.
DOMASH L. (2009). The emergence of hope: implicit spirituality in treatment and the occurrence of psychoanalytic luck. Psychoanal. Rev., 96, 35-54.
ERIKSON E.H. (1968). Identity: youth and crisis. New York, Norton; Gioventù e crisi d’identità. Roma, Armando, 1992.
FIGUEIREDO L.C. (2004). Belief, hope and faith. Int. J. Psycho-Anal., 85, 1439-1453.
FREUD S. (1927). L’avvenire di un’illusione. O.S.F., 10.
FREUD S. (1962). Lettere tra Freud e il pastore Pfister – 1909-1939. Torino, Boringhieri, 1970.
FREUD S., PFISTER O. (1990). L’avvenire di un’illusione. L’illusione di un avvenire. Torino, Boringhieri.
FRIEDMAN G.. (1988). The anatomy of psychotherapy. Hillsdale, Analytic Press; Anatomia della psicoterapia. Torino, Boringhieri, 1993.
KLEIN M. (1940). Il lutto e la sua connessione con gli stati maniaco depressivi. In: Scritti (1948). Torino, Boringhieri, 1978.
KLEIN M. (1957). Invidia e gratitudine. Firenze, Martinelli, 1968.
MARCEL G. (1944). Homo viator. Paris, Aubier.
MINKOWSKI E. (1933). Le temps vécu: études phénoménologiques et phychopathologiques. Neuchâtel, Delachaux (II ed.), 1968; Il tempo vissuto: fenomenologia e psicopatologia. Torino, Einaudi, 1971.
MINKOWSKI E. (1936). Vers une cosmologie: fragments philosophique. Paris, Aubier-Montaigne; Cosmologia e follia: saggi e discorsi. Napoli, Guida, 2000.
MITCHELL S.A. (1993). Hope and dread in psychoanalysis. New York, Basic Book; Speranza e timore in psicoanalisi. Torino, Boringhieri, 1995.
MOLTMANN J. (1970). Teologia della speranza. Brescia, Queriniana.
Pellizzari G. (2015). Due aspetti dell’azione terapeutica: speranza e metafora. Riv. Psicoanal., 1, 157-170.
WINNICOTT D.W. (1958). Dalla pediatria alla psicoanalisi. Firenze, Martinelli, 1975.
ZAMBRANO M. (1990). I Beati. Milano, Feltrinelli, 1992.
Leggi anche
RAIperunanotte, Intervista a Mario Monicelli 26 marzo 2010
Vai a Freschi di stampa
Squiggle in Psicoanalisi

S. Polke, 1972
A cura di Paola Silvia Ferri
Squiggle è il termine con il quale Donald W. Winnicott, psicoanalista della British Society, introduce (1968) la possibilità di ‘giocare’ in analisi.
Lo Squiggle è, infatti, la creazione attraverso lo ‘scarabocchiare’ della relaziona tra paziente e analista dove la coppia associa liberamente e costruisce il senso di ciò che sta avvenendo per favorire l’accesso ai vissuti traumatici del paziente.
Ma cos’è lo Squiggle
Winnicott propone al bambino uno scarabocchio (Squiggle) da cui sviluppare un disegno. Il bambino e l’analista associano liberamente e analizzano, con leggerezza, i contenuti emersi. Mentre cerca un modo di esprimersi, che viene rivestito di significato grazie alla maggior esperienza dell’analista, la coppia analista-paziente si deve divertire e deve saper creare una fantasia condivisa, molto più potente di qualsiasi verbalizzazione. In sede terapeutica, anche gli adulti possono necessitare del gioco, di servirsi, cioè, di carta e penna e disegnare quando i contenuti inconsci non sono facilmente accessibili o faticano ad emergere.
Lo scarabocchio è a tutti gli effetti un gioco, a cui partecipa anche l’analista, perché è nella co-costruzione che si definisce la realtà psichica, propria e del paziente. Senza l’altro non siamo niente e senza la creazione di quello spazio intermedio tra me e te, di cui il gioco fa parte, che entrambi ci contiene e al tempo stesso ci supera, non avremmo un luogo per costruire il pensiero. Questa è una mentalità che Winnicott auspica anche al di fuori della stanza d’analisi, ovunque ci siano da attivare dei processi di conoscenza e di azione, in ambito pedagogico o strettamente medico – pediatrico.
Come nasce lo Squiggle
Winnicott afferma che il bambino nasce fuso con la madre e dipende da lei in modo assoluto. Il processo di differenziazione e separatezza inizia gradualmente, e successivamente, attraverso la formazione di un’area transizionale, che fa da ponte tra il me e il non me, tra il soggetto e l’oggetto, tra il dentro e il fuori da sé, in cui io e te cominciamo a essere separati ma ancora e per sempre, legati.
Questa è l’area della creatività e l’oggetto transizionale (tradizionalmente riferito all’animaletto di peluche con cui il bambino si aiuta nelle sue separazioni notturne dalla madre) costituisce la precondizione per lo sviluppo di un pensiero autonomo e autentico. L’individuo ha bisogno di crearsi delle illusioni- pensieri ( in questo caso l’attore è il bambino attraverso il gioco, ma sarà un’esigenza che durerà tutta la vita) per far fronte alla realtà frustrante, interna ed esterna, evitando così di collassare e soccombere a un vuoto inaffrontabile, e a un terrore senza nome.
Il gioco dello scarabocchio, proprio nella sua continua riproposizione della dialettica tra me e non me, tra ciò che conosco e ciò che continuamente invento o mi illudo di inventare, nella fantasia benefica di controllare ciò che supponiamo dietro la realtà angosciante del vivere, rimanda al gioco del rocchetto di Freud (1920), dove il piccolo Ernst controllava l’angoscia per la separazione dalla madre. Attraverso il gioco del rocchetto che viene avvicinato e allontanato da sé, e quando è ritrovato ci sono gemiti di sorpresa e gioia, si costruisce la capacità di strutturare un Io solido e creativo.
L’uso dello Squiggle in analisi
Per Winnicott, il meccanismo base nell’esperienza analitica è quello della creazione. L’oggetto analista deve essere ricreato dal paziente là dove in realtà è sempre stato, proprio come il bambino piccolissimo deve poter sperimentare l’illusione di aver creato il seno. Per facilitare questa creazione, l’analista dovrà essere accogliente, a disposizione del paziente, favorendo la linea di sviluppo dell’Essere, molto più che essere interpretante ed invadentemente maschile. Dovrà essere capace di elaborare il suo “odio” di controtrasfert, così come la madre sufficientemente buona era stata in grado di accettare ed elaborare il suo proprio odio nei confronti del bambino, il quale non era stato solo una grande gioia per lei, ma anche un intruso che le ha messo a soqquadro l’esistenza. L’analista dovrà accettare di essere anche distrutto. La frase, “Io ti ho distrutto e ti amo-e mentre ti amo continuamente ti distruggo,” chiarisce il paradosso dove l’oggetto può rimanere vivo e vitale proprio perché viene continuamente distrutto e ricreato.
Dunque l’analista, non è più solo uno schermo opaco, o il frutto della proiezione del paziente, ma è qualcuno che deve essere usato dal paziente, deve saper giocare, essere creativo e protettivo per favorire la regressione del paziente prima e l’uscita da questa, poi. Il paziente potrà usufruire di un intervento “attivo” da parte di un analista che dovrà saper proporre una via d’uscita all’impotenza e alle eventuali conseguenze del trauma.
Esempi clinici
Winnicott è stato un innovatore geniale e la pratica dello squiggle si inserisce in questo filone rivoluzionario, se pure molto rigoroso e serio. Amava parlare semplicemente ed era convinto che la psicoanalisi dovesse penetrare come valore culturale e come scienza operativa. Per questo, è stato un grande divulgatore.
In Gioco e realtà (1971), fa un preciso riferimento al gioco del laccio, usato da un paziente per affrontare l’angoscia di separazione dalla madre, spesso costretta a soggiorni ospedalieri, e in questo riferimento rimanda al padre della psicoanalisi. Il bambino annodava il laccio intorno a tutto, pericolosamente anche alla sorella, ma nel momento in cui la madre, sostenuta da Winnicott, ha potuto esplicitare al figlio l’interpretazione suddetta, le cose sono volte per il meglio. L’autore tende a sottolineare che l’individuo può, attraverso il dolore o il rischio della sofferenza, proposti in una dimensione non necessariamente drammatica ma versatile e ludica, approdare a uno sviluppo creativo e significante della propria Persona.
In Esplorazioni Psicoanalitiche (1995), Winnicott ci dà altri gustosi esempi.
Nella consultazioni con una bambina, le mostra un ghirigoro che la coppia contribuirà a svolgere, divertendosi molto, e dandogli un senso. Nel mentre, lui le fa domande relativamente a quelli che potrebbero essere vissuti psichici consistenti e traumatici ed esplora con delicatezza le problematiche e le fantasie della bambina. Ne ricava materiale per una diagnosi e ha la capacità di individuare dei temi lungo tutto l’asse del gioco, senza regole, che la coppia sta facendo insieme. Può esplorare, così, la ferocia, o la fantasia di aver ucciso il fratellino nella pancia della madre incinta, o il bisogno di aggredire finalmente degli oggetti considerati troppo fragili per poter reggere alla sua angoscia. Winnicott non interpreta e non esplicita questi pensieri in maniera saturante, ma comincia a proporre alla bambina una versione giocosa delle possibili letture del materiale clinico.
Da Winnicott in poi, credo sia consuetudine, in particolare con bambini e adolescenti, offrire al termine del gioco una possibile interpretazione dei contenuti inconsci, o delle dinamiche che sono in corso proprio nel qui e ora della seduta, utilizzando il transfert e il contro transfert o quell’abbozzo di relazione creatasi fino a quel momento. L’uso dell’umorismo e lo scambio reciproco e divertito tra paziente e analista è considerato segno di sicura evoluzione verso la sanità.
Winnicott arrivava ad intervenire sul piano educativo, parlando con presidi e insegnanti, dicendo al ragazzo di “buttare nel gabinetto carta e penna” quando la sua situazione era troppo regredita o quando la sofferenza era troppo alta per potergli consentire una vita normale.
Bibliografia:
Ferri P.S, Zanelli Q.A.- Il corpo dell’analista come spazio relazionale nella cura dei bambini gravi, Riv Psicoanalisi, 2013, LIX, 3
Freud Sigmund, OSF vol 9, Al di là del principio del piacere , 1920, Bollati Boringhieri ed. 1980;
Winnicott D.W- (1965) La famiglia e lo sviluppo dell’individuo, trad. Carlo Mazzantini, Roma: Armando, 1968;
Winnicott DW (1968) Il gioco dello scarabocchio, in Esplorazioni psicoanalitiche (1989), a cura di Clare Winnicott, Ray Shepherd e Madeleine Davis, ed. it. a cura di Carla Maria Xella, Milano: Cortina, 1995 ;
Winnicott, D.W- (1971) Gioco e realtà, trad. Giorgio Adamo e Renata Gaddini, prefazione di Renata Gaddini, Roma: Armando, 1970;
Winnicott D.W., (1963) Sviluppo affettivo e ambiente: studi sulla teoria dello sviluppo affettivo, trad. Alda Bencini Bariatti, Roma: Armando, 1970;
Winnicott D.W., (1958), Dalla pediatria alla psicoanalisi: scritti scelti, trad. Corinna Ranchetti, Firenze: Martinelli, 1975;
Winnicott D.W., (1989) Esplorazioni psicoanalitiche, a cura di Clare Winnicott, Ray Shepherd e Madeleine Davis, ed. it. a cura di Carla Maria Xella, Milano: Cortina, 1995 ;
Sublimazione

San Giovanni della Croce di Leonardo Da Vinci
A cura di Laura Ambrosiano
Freud ha formulato la nozione di sublimazione per cercare di spiegare attività apparentemente non sessuali, quali quella artistica e quella scientifica.
Nel 1892 Freud parla per la prima volta di sublimazione (nelle minute a W. Fliess) e ne sottolinea la natura ambigua: fantasie, difese e sublimazioni sono tutte considerate come operazioni per abbellire i fatti.
Il primo modo di intendere la sublimazione è, dunque, riconducibile ad una difesa, esercitata soprattutto rispetto alle pulsioni parziali difficili da integrare da parte d ell’Io.
Nel lavoro su “Leonardo” (1910), Freud privilegia, tra le tante che immagina, l’ipotesi che la sublimazione sia frutto dell’inibizione (1) della vita sessuale.
Egli nota che gli affetti, in Leonardo, da lui scelto come campione esemplare dell’attività di sublimazione, sono sottomessi alla pulsione di ricerca e che la sua vita sessuale risulta impoverita e opaca.
Freud opta per l’idea che la sublimazione sia una difesa, un meccanismo teso a difendere dall’angoscia. L’inibizione della pulsione comporta la rimozione della spinta sessuale e della sua meta originaria: la scarica, il soddisfacimento. Rispetto agli altri meccanismi difensivi si tratterebbe però di un difesa ben riuscita.
Da queste premesse teoriche la tradizione psicoanalitica tende a considerare la sublimazione come una forma di difesa,magari riuscita, ma comunque un meccanismo che tende ad inibire la corrente pulsionale, in particolare le pulsioni parziali difficili da integrare.
E’ rilevante ricordare che la nozione di sublimazione è connessa in modo necessario con quella di pulsione, intesa come una rappresentazione non ideativa del caotico turbinare dei sensazioni e stimoli somatici. Per parlare dell’una occorre considerare l’altra, infatti i teorici che non ritengono utile la nozione di pulsione fanno a meno anche di quella di sublimazione.
Nella metapsicologia freudiana la nozione di pulsione indica qualcosa di originario, un nucleo somato-psichico dotato di una spinta innata a diventare esperienza, a rappresentare, a dare senso, dunque, a sublimare.
Ma, come sappiamo, la pulsione è inconscia, in senso letterale, essa ci spinge ma non la conosciamo, essa urge dal mondo interno verso realizzazioni che non propone immediatamente. L’individuo può accogliere la oscura spinta interna e farla propria trasformandola in desideri, progetti, tensioni e passioni personali.
Se la pulsione è un moto scomposto in una attesa di un significato, se essa stessa è già una rappresentazione non ideativa di un inconscio oscuro che ci abita, allora possiamo immaginare che la pulsione sia essa stessa una apertura alla ricerca di un significato per la oscurità della vita.Nell’organismo somato-psichico la pulsione spinge senza che l’individuo possa farci nulla, in un modo che è indipendente dal suo volere e dalla sua decisione.La pulsione è una spinta attiva, ma finché non la accoglie l’individuo la sperimenta come una invasione interna che egli subisce passivamente. Per questo è anche possibile che si sviluppi una paura delle pulsioni:
La paura di accogliere le pulsioni, cioè le emozioni che sono per noi le loro emissarie sensibili, esprime fondamentalmente il rifiuto della dipendenza dall’inconscio che è costitutiva degli individui, esprime la fantasia che accogliere le pulsioni significhi dipendere dall’inconscio, dagli oggetti, dagli altri; mentre il silenzio del desiderio rende liberi.
Per questo l’individuo può rimuovere anziché sublimare, in unapolarizzazione vitale per il singolo e per la specie.
Il rovesciamento della pulsione, l’anestesia-rimozione del desiderio, sembra offrire l’illusione di una qualche forma di attività, per così dire, in negativo. Qui entra in campo l’inibizione: l’angoscia di vivere le pulsioni inibisce sia la sessualità che il pensiero, zittisce sia il trasporto appassionato verso gli oggetti che quello verso la conoscenza.
La pulsione è Eros, spinta sessuale e “La sublimazione è un processo che interessa la libido oggettuale e consiste nel volgersi della pulsione a una meta diversa e lontana dal soddisfacimento sessuale”. (1914, 464).
Se ricorriamo al vocabolario il termine sublimazione può indicare un andare verso il sublime, verso attività umane più alte. Ma Freud stesso contesta questa accezione, egli ci tiene a precisare che la sublimazione va distinta dalla idealizzazione, perché questa accade all’oggetto, mentre la sublimazione descrive qualcosa che ha a che fare con la pulsione. “L’Ideale dell’Io, per così dire, esige la sublimazione, ma essa resta un processo indipendente da questa sollecitazione. L’Ideale dell’Io accresce le esigenze dell’Io stesso, ma, in questo senso finisce con il favorire la rimozione. Diversamente la sublimazione offre una via di uscita in virtù della quale le esigenze dell’Io possono essere soddisfatte senza dar luogo a rimozione.”(1914, 465)
Quindi abbiamo una prima oscillazione, che resta nei lavori di Freud, tra il considerare la sublimazione – come abbellimento, e – l’idea che non ha senso distinguere tra attività alte, quelle artistiche e scientifiche, e attività basse, quali a sessualità. Le une, egli dice, possono stare al posto delle altre, sono avvolte insieme in un’unica esperienza originaria che intreccia il divino e il corpo. (1910)
É sorprendente e interessante come Freud si dolga che, nelle nostre vicissitudini culturali, abbiamo distaccato la sessualità dalla dimensione del divino, abbiamo operato una rottura violenta tra la sessualità e la dimensione misteriosa ed elusiva, e perciò sacra, della natura. Di fatto l’incivilimento ha svuotato la sessualità della sua componente divina, impoverendo, in questo modo, sia il divino che il sessuale. Abbiamo operato, egli scrive (1910) una rottura dell’unità originaria tra sessuale e divino, unità che è alla base delle cose. La sublimazione implica una riuscita ricomposizione di tale unità, una sorta di riconciliazione tra elementi che sono stati artificialmente distaccati.
La sublimazione ri-unisce ciò che era stato separato, ri-afferma l’unità (tra natura e cultura).
Ma allora, e di qui partono altre e diverse considerazioni di Freud, se la sublimazione non è un abbellimento dei fatti, una difesa, allora è piuttosto assimilabile ad una operazione chimica di trasformazione da uno stato ad un altro. In questa accezione i prodotti culturali, artistici, lo sviluppo del pensiero e della conoscenza avrebbero le loro radici nella stessa dimensione interna che anima la sessualità, Eros, e ne sarebbero, appunto una trasformazione.
Questa seconda accezione si accorda con la natura nomade e deviante delle pulsioni: nella descrizione di Freud esse si spostano, sono plastiche, vagabonde, non sono legate ad un solo oggetto, ad un’unica meta, o scopo, ma si muovono investendo ora un oggetto, ora un altro, ora uno scopo ora un altro. La sublimazione emerge da questa proprietà della pulsione di scambiare le mete e gli ambiti di investimento, di trasformarsi, appunto.
La pulsione sessuale è una corrente che mette grandi energie al servizio della conservazione della specie e della cultura.
Ricapitolando, nella teorizzazione formale che Freud ci ha consegnato nel 1910, centrata sulla inibizione, la sublimazione riguarda in particolare le pulsioni parziali, che, appunto, necessitano di essere inibite quando l’apparato psichico non riesce ad integrarle. In questo senso essa comporta una perdita di spinta sessuale.
Ma, subito dopo questo enunciato, Freud aggiunge i suoi classici “anche se” che, in genere, allargano e donano complessità agli argomenti che sta trattando.
In questo caso “l’anche se” riguarda il fatto che non si può considerare la sessualità come una attività bassa, rispetto ad altre sublimi, anzi la sessualità viene definita come la “divina scintilla” che muove ogni attività umana. E noi possiamo considerare la teoria freudiana come una teoria della sessualità proprio nel senso che egli considera che ogni attività umana prende le sue energie dalla spinta pulsionale, sessuale: anche il conoscere e il teorizzare è una attività pulsionale, corporea, che incontra, palpa, gusta, sfiora, penetra l’alterità del mondo, quello interno e quello esterno. L’apparato psichico nel suo insieme è eretto con mattoni pulsionali, è fatto di desiderio e passione.
In questo modo Freud riconduce le diverse espressioni dell’attività umana non a polarità antitetiche, anima-corpo, pensiero-azione, passivo-attivo, primario-secondario, bensì ad una esperienza originaria.
Con l’ipotesi di una spinta originaria che connette sessualità e conoscenza, Freud dà ascolto ad altri pensieri, pensieri disobbedienti che cercano spazio nella sua e nella nostra mente. Per esempio la sete di conoscere viene ricondotta direttamente a una fonte pulsione: la pulsione di ricerca sembra proporsi, nelle parole di Freud, come una spinta originaria che conserva un carattere di passione e trasporto della stessa natura della sessualità. In effetti Freud commenta che Leonardo non era privo di passioni, non gli mancava la “divina scintilla” che è la forza motrice di ogni fare umano; egli aveva solo convertito la passione in sete di sapere, dedicandosi alla ricerca con quella tenacia e profondità che derivano dalla passione. E, quando la ricerca della conoscenza arriva al suo culmine, aggiunge, allora l’affetto sgorga, al culmine della ricerca si sperimenta un piacere intenso e sensuale senza scarica e senza acme (1910).
In questi passaggi Freud non sembra tanto parlare di un’”inibizione” dell’affetto, né immaginare due correnti pulsionali di cui l’una sarebbe sessuale e l’altra no, piuttosto pensa a una corrente pulsionale, a una spinta naturale, psico-biologica, che si trasforma, che prende ora una forma e una direzione e ora un’altra. Questo significa che l’individuo si dedica alla ricerca del sapere con la stessa passione con cui si dedica all’amore, all’amicizia, alla professione.
“L’indagare diventa un’attività sessuale e il sentire che si è raggiunta una chiarificazione offre una soddisfazione sessuale.” (1910)
Eros è una spinta appassionata che poi si incanala in sessualità, in pensiero, in creazione artistica, in amicizia, in lavoro, in esperienza sociale, conservando le sua natura divina.
La “divina scintilla” della sessualità muove sia le relazioni affettive che l’indagine sul mondo, sia la ricerca di contatto intimo con gli altri, sia la spinta ad arricchire il proprio sé, a evolvere sul piano narcisistico.
Freud sembra proporre una sorta di riconciliazione che intreccia sessualità e pensiero, narcisismo e investimento del mondo, senza farne due polarità opposte.
La sublimazione, come il procreare, è frutto di questa spinta a diventare, che travalica, in parte, i traumi e le vicende storiche di ciascuno.
La sublimazione implica l’introiezione, concetto che prende centralità con l’introduzione al narcisismo del 1914, questo meccanismo trasforma una scelta oggettuale erotica in un cambiamento dell’Io stesso, cioè in un’acquisizione narcisistica. Per la crescita dell’apparato psichico e della capacità di sublimare occorre che l’oggetto sia abbandonato in quanto tale, e introiettato; occorre che le vicissitudini della passione si trasferiscono nel mondo interno. La sublimazione emerge dall’abbandono degli oggetti concreti e dalla loro introiezione, qui si realizza una maggiore complessità psichica, un allargamento della vita psichica.
A partire da questi nuovi concetti non ha più senso intendere la sublimazione come inibizione della sessualità, come de-sessualizzazione. Piuttosto occorre pensare alla sublimazione come un processo che dona spessore al soggetto (e all’oggetto), ristrutturandoli su piani più articolati e più complessi. (H. Loewald)
Se il percorso verso la sublimazione è quello dell’interiorizzazione, anche il concetto di scarica non ha più senso. La libido è de-sessualizzata semplicemente perché si dispiega ora all’interno della struttura psichica, al servizio di un arricchimento narcisistico dell’individuo e non in termini di una scarica. Le relazioni si trasformano in relazioni interne tra strutture e piani diversi dell’apparato psichico.
La sublimazione ha una valenza narcisistica e una valenza oggettuale perché stabilisce il primato della connessione con il mondo, con la realtà che noi umani abitiamo insieme.
“ Al culmine di una scoperta, quando il suo sguardo è in grado di abbracciare un vasto settore di quel tutto di cui è parte, l’individuo è afferrato dal pathos e celebra con parole esaltate la magnificenza di quel frammento di creazione che ha indagato.”(2)
Il culmine della sublimazione è la celebrazione, momento in cui l’individuo non solo avverte l’arricchita organizzazione del suo Io, ma anche la misteriosa magnificenza del mondo che non ha creato lui, di cui può indagare solo frammenti e comunicarli al gruppo.
Da quello che si è detto risulta anche come la sublimazione abbia sempre una implicita componente di auto-cura, di auto-guarigione, essa ci sostiene nell’impatto con la dimensione ignota del mondo interno ed esterno, senza esigere il ricorso alla rimozione.
Bibliografia
Freud S. (1910) Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci. OSF 6
Freud S. (1914) Introduzione al narcisiscmo. OSF 7
Freud S. (1915a) Pulsioni e loro destini. OSF 8
Freud S. (1915b) Lutto e melanconia. OSF 8
Freud S. (1925) Inibizione, sintomo e angoscia. OSF 10
W.Loewald H (1988) La sublimazione. Torino, Boringhieri
(1) Nel lavoro “Inibizione, sintomo e angoscia” (1925) Freud sostiene che l’Io inibisce per evitare conflitti con l’Es o con il Super Io. L’Io ricorre all’inibizione quando avverte la pericolosità di rappresentazioni pulsionali emergenti, la rappresentazione pericolosa non solo è rimossa e spostata in chiave sintomatica, ma ad essa viene impedito di volgersi in azione. Ma quali sono queste rappresentazioni pericolose? Quali sono i moti pulsionali che l’Io avverte come pericolosi e inibiscee? Si tratta delle pulsioni coinvolte dalla configurazione edipica: l’odio omicida e la tenerezza verso il padre, l’angoscia di castrazione conseguente. La richiesta pulsionale non sarebbe un pericolo in sé se non portasse al pericolo di ritorsione, di evirazione. La paura dell’evirazione si trasforma e, nel corso dello sviluppo, diventa una angoscia che viene da dentro: angoscia sociale e morale, una minaccia da parte del Super Io, e non più da fuori, dai genitori. Nel corso dello sviluppo Freud immagina che la paura di evirazione alluda via via alla paura di vivere e di morire, e coglie una serie di nessi: evirazione-separazione-parto-svezzamento- perdita delle feci, morte. In definitiva il pericolo che suscita l’angoscia è la perdita, la separazione (50-60), che implica lutto, dolore e angoscia.
(2) Freud 1910, pag. 221.
Suicidio

Ophelia JOHN EVERETT MILLAIS 1851-1982
A cura di Mario Rossi Monti e Alessandra D’Agostino
Nell’era contemporanea il suicidio si caratterizza come un fenomeno trasversale e globale, che interessa l’Occidente quanto l’Oriente, la clinica quanto la cultura e la società intera. Dati recenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (2009) evidenziano che ogni anno circa 1 milione di persone muore per suicidio e un numero venti volte superiore tenta di uccidersi; scendendo più nel dettaglio, il tasso di mortalità suicidaria nel mondo è intorno a 16 su 100.000 abitanti, con un suicidio ogni 40 secondi e un tentativo di suicidio ogni 3; tra il 1950 e il 2000 il numero di chi si è tolto la vita su scala mondiale è salito del 60% e oggi la mortalità per suicidio è l’1-2% della mortalità totale; inoltre, mentre prima il suicidio riguardava soprattutto gli over 45, oggi è tra le tre principali cause di morte nella fascia di età compresa tra i 15 e i 44 anni e tra le prime due per la fascia tra i 10 e i 24 anni.
Numeri che segnalano un allarme. Da essi emerge, tuttavia, solo la punta di un iceberg ben più duro da sciogliere. Il suicidio, infatti, resta ancora un fenomeno sottovalutato, sottaciuto, quando non del tutto negato. E questo a causa della complessità che diversi fattori contribuiscono a determinare.
In primo luogo la categoria “suicidio” è costruita ex post sulla base della “fine della storia”. Come è stato detto, l’ombra del grande albero nero del suicidio finisce per nascondere tutta la foresta della vita. Sulla base di questo ultimo, tragico evento viene riscritta ex-post tutta una storia. Ciò fa sì che la classe di persone accomunate da un comportamento suicidario sia un contenitore eterogeneo, là dove il suicidio diventa l’elemento unificante di storie molto diverse tra loro o anche tutte difficilmente riconducibili a una patologia mentale. Jean Améry, intellettuale belga morto suicida e autore di una monografia sul suicidio, chiama “momento del salto” il momento in cui il proposito suicidario si trasforma in comportamento senza ritorno, rendendo irrilevanti tutte le differenze e stabilendo una “folle uguaglianza” (1990, p. 11). Non conta più chi sei o da dove vieni, una volta compiuto “il salto” entri a far parte di una categoria unica, fatta solo di un mucchio di cadaveri, tutti uguali.
In secondo luogo è necessario tenere in considerazione il fatto che il “percorso suicidario”, anche quando fosse particolarmente breve, si articola in più livelli: il livello della fantasia suicidaria, il livello dell’ideazione suicidaria e del progetto suicidario, il livello del comportamento suicidario.
Il primo livello, quello della fantasia suicidaria, ha la massima estensione, nel senso che è ampiamente diffuso nella popolazione generale e non implica necessariamente il passaggio agli altri livelli; fantasticare sulla propria morte ha spesso, al contrario, una forte valenza anti-suicidaria, costituendo talora la manifestazione di una vera e propria spinta trasformativi (così non si può più andare avanti!). Inoltre, nel corso dell’evoluzione, la fantasia suicidaria rappresenta una sorta di organizzatore dello sviluppo psichico, che segna la conclusione della fase di separazione-individuazione e con essa la piena assunzione di responsabilità della propria esistenza.
Il secondo livello, invece, quello dell’ideazione suicidaria, ha un’estensione inferiore al primo ma superiore rispetto all’ultimo: altrimenti detto, solo una piccola parte di chi sviluppa un’ideazione suicidaria passa poi effettivamente all’atto. A differenza però della fantasia, l’ideazione si pone come rappresentazione persistente della propria morte, che può assumere anche la forma di un vero e proprio progetto relativo ( il “come” darsi la morte, quali atti preparatori compiere, quali strumenti utilizzare, etc.).
Infine, il terzo livello, il comportamento sucidario, sottoinsieme del precedente in termini di estensione, è quello che appunto Amery chiama il momento del “salto”: clinicamente parlando, si tratta di un tentativo concreto di suicidio o di un suicidio vero e proprio. Mentre i primi due livelli sono reversibili, l’ultimo non lo è: dalla morte non si torna più indietro. Nemmeno a raccontare come si giunti alla determinazione di compiere quel salto. Le “note suicidarie” (i biglietti o le lettere che solo una minoranza di coloro che si suicidano lasciano, permettono di cogliere spesso solo una pallida eco di quel percorso).
A contribuire ancora alla complessità del fenomeno suicidio è ancora un altro fattore: la maggior parte dei suicidi si realizza nel contesto di un disturbo mentale diagnosticato in base agli attuali criteri diagnostico-nosografici.
In particolare, la depressione maggiore è la principale categoria nosografica alla quale viene ricondotto oltre il 50% dei suicidi, seguita da schizofrenia, disturbi di personalità, dipendenze da sostanze (soprattutto da alcol), disturbi dell’alimentazione e disturbi mentali organici (Cavanagh et al., 2003). Ma la depressione maggiore è una categoria fondata su criteri iperinclusivi, tale da indurre facilmente una sovrastima: siamo, infatti, in un’epoca in cui la categoria depressione è diventata il grande contenitore di un disagio che è solo genericamente depressivo in termini psicopatologici. In questo senso, si può vedere il legame suicidio-disturbo mentale come il risultato di un bias metodologico, che tende a sovrastimare la rilevanza di elementi psicopatologici, tenendo in scarsa considerazione invece variabili di altra natura, come quelle economico-sociali o culturali-religiose.
I dati che la epidemiologia psichiatrica ci propone indicano che solo una ridotta quota di suicidi si realizza in assenza di disturbi mentali (solo il 10%, secondo uno studio di Hawton & Van Heeringen del 2009). Questo dato tuttavia è da considerare con cautela perché può essere inficiato da una tendenza alla distorsione, legata alla forte medicalizzazione delle condotte abnormi. Infatti è più facile sbarazzarsi del problema suicidio, inquadrandolo come qualcosa di assolutamente alieno dalla vita quotidiana. Karl Jaspers, un secolo fa, in pagine rimaste memoriabili, metteva in guardia proprio da questo rischio, quando scriveva: “la via più semplice e comoda sembra sia quella di attenersi per il suicidio all’ipotesi della malattia mentale [….]. Il problema viene così sbrigativamente risolto, essendo collocato al di fuori del mondo normale; ma non è così” (Jaspers, 1941).
Resta il fatto che una parte di suicidi, per quanto minima, si sottrae comunque all’ interpretazione medico-psichiatrica, tanto da autorizzare a distribuire i comportamenti suicidari lungo uno “spettro” (spettro suicidario), dove ad un estremo si situano condotte suicidarie strettamente legate a disturbi mentali e ad un altro si collocano atti suicidari frutto di scelta consapevole.
Se il percorso suicidario rimane spesso nell’ombra e comunque difficile da ricostruire, resta il fatto che il suicidio può essere studiato non solo dal punto di vista della soggettività di chi lo ha espresso, ma anche come dato oggettivo. Quella massa di corpi morti, i suicidi, si prestano a studi che consentono di ricavare una messe di importanti elementi conoscitivi di carattere generale. Ad esempio: dati sulla estensione del fenomeno su larga scala, la mortalità media di suicidio all’anno nel mondo (14,5 suicidi ogni 100.000 persone), le variabili relative al sesso (per quanto riguarda le differenze tra maschi e femmine, nei paesi occidentali è di 2-4 a 1), l’età (il tasso più elevato si riscontra nella popolazione anziana, ma negli ultimi tempi c’è stata un’inversione di rotta, con un aumento del 55% dei suicidi tra i 5 e i 44 anni), l’appartenenza etnica ( negli Stati Uniti il suicidio è meno frequente tra gli ispanici e gli afroamericani rispetto agli americani di origine europea), i metodi usati (nei paesi europei le donne tendono a gettarsi dalla finestra o si avvelenano, i maschi invece tendono a ricorrere ad armi da fuoco o impiccagione), la professione (le più colpite sono quelle che consentono un più facile accesso allo strumento utile a togliersi la vita, quindi medici, infermieri, veterinari e agricoltori), etc.
Gli elementi di natura soggettiva, che permettono di inserire il suicidio all’interno di un percorso di senso, sono di più difficile individuazione. Secondo Schneidman (1993) sarebbe necessario realizzare un vero e proprio “identikit del suicida”, che tenga conto di diversi aspetti: lo scopo da raggiungere, lo stimolo da cui fuggire, lo stressor (ovvero l’elemento contingente) che ha portato alla frustrazione di un bisogno vitale, la sensazione emotiva prevalente, lo stato cognitivo dominante, l’azione realizzata attraverso il suicidio, il valore interpersonale dell’atto e lo stile di adattamento del soggetto che il pattern suicidario in genere riflette.
Nonostante tutto ciò, però, le nostre capacità di previsione del comportamento suicidario come clinici sono davvero modeste. Possiamo prevedere il grado di rischio a cui è esposta una persona ma non, in modo attendibile, la possibilità che il soggetto, gravato da quel rischio, traduca effettivamente in atto i suoi propositi. In altri termini, a rendere da ultimo ancora più complesso il fenomeno suicidio è il grande gap che esiste tra la ricerca epidemiologica che identifica i fattori di rischio e l’esperienza dei clinici che lavorano nel campo della salute mentale. Per ridurre questo gap al minimo, è necessario cercare di comprendere (almeno in parte) il senso che si cela dietro la scelta di darsi la morte.
A partire dalla metà dell’800 si sono sviluppate almeno quattro grandi chiavi di lettura: una sociologica, una psichiatrica, una psicoanalitica e una psicologica.
Secondo la prima, sociologica, il suicidio è un fenomeno esclusivamente sociale, ovvero causato da condizioni ambientali, economiche e culturali ben precise, come afferma Durkheim (1897) nel suo fondamentale studio sul suicidio.
Secondo la psichiatria il suicidio è sempre effetto e conseguenza di uno stato mentale alterato. Esquirol (1838) affermava che l’uomo tenta di uccidersi solo quando è mentalmente alienato.
Nella prospettiva psicoanalitica, Freud (1915) propone di considerare il suicidio come un omicidio mancato, perché l’Io può uccidersi solo quando riesce a trattare se stesso come un oggetto e quindi a dirigere verso l’interno l’aggressività che non è in grado di dirigere contro l’oggetto libidico.
Infine, secondo la prospettiva psicologica, il suicidio non esiste in quanto atto, ma in quanto persona che compie quell’ atto; in questo senso si deve focalizzare l’attenzione non tanto sul suicidio come oggetto, ma sul suicida come soggetto, analizzandone la storia personale, le situazioni esistenziali e la disposizione, cioè l’aderenza affettiva alla situazione; secondo Deshaies (1951), ad esempio, il suicidio risolve un conflitto occasionale e apporta una soluzione alla vita stessa dell’individuo, generando una rottura interiore che libera dal mondo attraverso l’annullamento dell’oggetto e l’annientamento del soggetto.
La prospettiva di studio del suicidio basata sulle “note suicidarie” ha consentito, fin dai primi studi di Schneidman alla fine degli anni ’40, di gettare uno sguardo sugli stati affettivi che precedono la fine. Tali stati affettivi possono essere disposti lungo tre assi (Rossi Monti & D’Agostino, 2012): l’asse “vergogna-colpa”, secondo cui il suicidio è associato a un sentimento di colpa, a un senso di responsabilità totale nei confronti di quanto accade intorno, ma anche, molto più spesso, a un sentimento di vergogna, ossia a un senso d’inadeguatezza profonda nei confronti della vita intera; l’asse “vuoto-disforia”, per il quale ad avere alta potenzialità suicidiaria sono sentimenti di ansia, irritazione, umore scontroso, con propensione ad acting out e rigidità affettiva (che racchiudiamo sotto il termine “disforia”) soprattutto se associati a un sentimento di vuoto cronico che pervade sia il mondo interno che quello esterno; e l’asse “hopelessness/helplessness”, per cui ciò che caratterizza in modo prevalente la condizione presuicidaria è la mancanza di speranza, accompagnata dalla convinzione di non poter ricevere alcun aiuto dal mondo esterno.
In ogni caso, però, una parte di questo senso si perde con la morte stessa del suicida. Come sottolinea Hillman, infatti: “Non è la persona che è morta, contrariamente a quanto dice Sartre, ad avere un accesso privilegiato alla propria morte, perché il significato di quella morte le era sempre rimasto in parte inconscio […]. Per comprendere davvero i propri atti c’è bisogno di uno specchio e quindi una comprensione profonda del suicidio si rende possibile in una relazione dialettica a specchio, come quella analitica. Rimane il rischio che anche in una relazione analitica il senso di questo gesto che si affaccia all’orizzonte possa non essere colto. Per questo l’analista deve mantenere un piede dentro e un piede fuori” (2010, p. 85).
Bibliografia
Améry, J. (1976). Levar la mano su di sé. Torino: Bollati Boringhieri, 1990.
Barbagli, M. (2010). Congedarsi dal mondo. Il suicidio in Occidente e in Oriente. Bologna: Il Mulino.
Cavanagh, J. T. et al. (2003). Psychological autopsy studies of suicide: A systematic review. Psychological Medicine, 33, 395-405.
Deshaies, G. (1951). Psicologia del suicidio. Roma: Astrolabio.
Durkheim, E. (1897). Il suicidio. Studio di sociologia. Milano: Rizzoli, 1987.
Esquirol, E. (1838). Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal. Paris: Chez J.-B. Ballière.
Freud, S. (1915). Lutto e melanconia. In OSF, volume 8, Torino: Bollati Boringhieri, 1989.
Hawton, K., Van Heeringen, K. (2009). Suicide. The Lancet, 373, 1372-81.
Hillman, J. (1997). Il suicidio e l’anima. Milano: Adelphi, 2010.
Rossi Monti, M., & D’Agostino, A. (2012). Il suicidio. Roma: Carocci.
Shneidman, E. S. (1973). Deaths of man. New York: Jason Aronson.
Shneidman, E. S. (1981). The psychological autopsy. Suicide and Life-Threatening Behavior, 11, 325-40.
Shneidman, E. S. (1993). Suicide as psychache: A clinical approach to self-destructive behaviour. Northvale: Jason Aronson.
Shneidman, E. S. (2006). Autopsia di una mente suicida. Roma: Fioriti.
Superio

Scuola di Atene di Raffaello_ particolare di Platone
A cura di Laura Contran e Gabriella Giustino
Definizione
Il Superio rappresenta una sorta di censore interno che giudica gli atti e i desideri del soggetto ed è costituito da un insieme di divieti e comandi che condizionano in vario modo sin dall’infanzia i comportamenti umani.
Vi possiamo riconoscere una funzione positiva (come regolatore dei desideri e delle pulsioni umane), e un aspetto negativo che causa invece un senso continuo di oppressione e di frustrazione interiore.
In sintesi: “il Superio è un’istanza psichica la cui funzione è sorvegliare l’Io, impartirgli degli ordini , dirigerlo e minacciarlo di punizione…” (Le Guen, 2013).
Evoluzione psicoanalitica del concetto
Freud inizialmente (1894) definisce il Superio soffermandosi sulla severità delle autoaccuse ossessive. in questa fase del suo pensiero il Superio è il rimprovero e la punizione per le “esperienze” ed il piacere sessuale del bambino ed è denominato “coscienza”.
In seguito (1913) Il Superio freudiano rappresenta l’istanza della legge dell’inconscio e la sua severità è legata alle vicende edipiche: quanto più forte è stato il complesso edipico, tanto più severo si farà in seguito il Super Io nell’esercitare il suo dominio sull’Io sotto forma di coscienza morale o forse di inconscio senso di colpa.
Nel saggio del 1914 sul narcisismo, la coscienza morale è definita, per la prima volta, in termini di Ideale dell’io. Esso si connota per lo stato d’onnipotenza infantile perduta e rappresenta l’ideale narcisistico personale. L’Ideale dell’io spiega anche le alterazioni nella percezione del sé e dell’oggetto che si verificano durante l’innamoramento. L’Io si confronta continuamente con tale ideale interno e pertanto persiste la “coscienza” (che Freud non chiamava ancora Superio), che controlla e critica le discrepanze tra Io e Ideale dell’io.
La malattia melanconica, invece, è affrontata da Freud (con Abraham) nel saggio Lutto e melanconia (1915) nei termini d’identificazione con un oggetto ambivalente che il melanconico continuamente attacca dentro di sé, attaccando se stesso. Una parte dell’Io del melanconico giudica severamente e sadicamente l’oggetto in un circolo vizioso interno (connotato da una relazione oggettuale ambivalente e narcisistica).
In questo scritto il Superio, anche se non ancora nominato come tale, appare già molto simile, come vedremo, al Superio sadico infantile primitivo descritto in seguito da Melanie Klein .
Il Superio, infine, fa la sua comparsa come istanza psichica vera e propria nella teoria strutturale nel saggio L’Io e l’Es (1922); esso viene descritto come un’istanza intrapsichica (parzialmente inconscia) con specifiche funzioni e rapporti con le altre strutture. Tale istanza è destinata a modificarsi ed integrarsi durante l’attraversamento e la risoluzione del complesso edipico. Il declino del complesso edipico corrisponde cioè alla rinuncia da parte del bambino dei propri desideri edipici (amorosi ed ostili).
Il conflitto tra Superio ed io, individuato da Freud come generatore d’angoscia, diventerà un punto importante di partenza della ricerca della Klein. L’Autrice in numerosi scritti (1924-32) riprende il concetto di Superio come oggetto introiettato in modo ambivalente (già accennato in lutto e melanconia) ma sviluppa questo concetto per descrivere il feroce e sadico Superio primitivo infantile che attacca l’oggetto (il seno) come fonte odiata ed invidiata di nutrimento (De Masi 1989).
Nel lavoro “ I primi stadi del conflitto edipico e la formazione del Superio” (1932) adotta la teoria del Superio come espressione dell’istinto di morte. Già in lavori precedenti l’Autrice sosteneva che il conflitto edipico e il rimorso s’instauravano molto precocemente, quando la psiche infantile era dominata da impulsi sadici e primitivi.
L’angoscia del bambino piccolo è, per la Klein, un’angoscia d’annientamento proiettata all’esterno (una deflessione all’esterno dell’istinto di morte). L’analisi transferale delle figure del mondo interno che rappresentano il Superio riduce, per l’Autrice, l’angoscia e rinforza l’Io del bambino rendendo il Superio più benevolo.
Siamo qui nelle primissime fasi dello sviluppo infantile, in un mondo di oggetti parziali dove regna un uso eccessivo dell’identificazione proiettiva.
Tuttavia, col procedere dello sviluppo, procede l’integrazione e s’installa nella psiche del piccolo la possibilità del riconoscimento dell’oggetto buono, seno amato e fonte di nutrimento. Quando successivamente l’Autrice affronta il tema dell’idealizzazione, diventa gradualmente sempre più chiaro che si tratta di un processo riguardante l’oggetto interno; la fusione in fantasia con l’oggetto idealizzato è la prima difesa contro l’angoscia d’annientamento.
Tuttavia, quanto più l’oggetto è idealizzato tanto più diventa persecutorio e pertanto attaccato, invidiato ed odiato. L’integrazione tra aspetti persecutori e idealizzati permette la trasformazione in un Superio più maturo. La gratitudine prende gradualmente il posto dell’invidia, la riparazione per l’attacco all’oggetto consente il passaggio alla posizione depressiva e alla capacità di elaborare il lutto per il proprio sadismo. Il circolo vizioso della distruttività, dominato dall’ istinto di morte ed il tentativo di distruggere gli oggetti cattivi costituisce il nucleo della posizione schizoparanoide. L’introiezione di una madre-oggetto buono contribuisce a costituire l’aspetto benevolente e libidico del Superio ( garante dello sviluppo psichico) e spezza il circolo vizioso. In sintesi, nel pensiero kleiniano, il Superio sadico (col suo funzionamento tutto o nulla) blocca lo sviluppo e la riparazione. L’angoscia riguarda il terrore della persecuzione di tale Superio primitivo che, se trasformato, genera meno angoscia e permette al senso di colpa di cominciare ad esistere. Il bambino acquisisce allora una coscienza morale (Klein 1935-1940) ed un riguardo per l’oggetto. Il senso di colpa della fase depressiva rende possibile la potenzialità psichica normale del lutto; la perdita dell’oggetto d’amore si accompagna al rendersi consapevole dell’ambivalenza inconscia verso l’oggetto.
Nelle teorizzazioni post-kleiniane è in primo piano l’elemento traumatico riguardo alle relazioni precoci tra il bambino e la madre. Il fallimento delle prime relazioni oggettuali ed il rifiuto da parte della madre di accogliere e trasformare le prime identificazioni proiettive del bambino (Bion, 1959) genera un Superio che si sviluppa prima dell’Io, opponendosi alla crescita, alla vitalità e alla curiosità infantile. Wilfred Bion , pur seguendo ancora in parte la teorizzazione kleiniana , parla del Superio come di un oggetto-Sé cattivo introiettato (1959) a causa di una carenza di contenimento materno delle identificazioni proiettive del bambino. Esse, non accolte né trasformate dalla madre, incapace di gestire le angosce e le emozioni intense del piccolo, sono reintrodotte in lui senza alcun processo di contenimento e digestione mentale e vanno a costituire quest’ oggetto interno con funzioni di Superio. Il legame tra il bisogno del bambino e il seno, segnato dal fallimento del contenimento, può generare nell’infante la percezione che l’oggetto esterno sia ostile alla curiosità. In questo stato mentale qualunque emozione è odiata in quanto percepita come troppo potente per poter essere contenuta dalla mente immatura del bambino.
L’ oggetto con funzioni di Superio è quindi confondente e autodistruttivo, impedisce di apprendere dall’esperienza ed è alla base della parte psicotica della personalità.
Il predominio di questa parte attacca il legame emotivo favorendo lo stabilirsi di legami crudeli, sterili e perversi. Inoltre l’autore afferma che il deficit di contenimento da parte dell’oggetto primario favorisce la strutturazione del Superio ed inibisce quella dell’Io.
Tra gli sviluppi postkleiniani è necessario ricordare la formulazione del concetto di Superio inteso come struttura psicopatologica. Questa concettualizzazione è frutto soprattutto di alcuni Autori post-kleiniani come Rosenfeld (1971) o Meltzer (1973). Essa indica una funzione del Superio intesa come struttura che colonizza la mente incitandola al piacere grandioso, maniacale o perverso. A nostro parere questo tipo di Superio, spesso presente nelle psicosi e nelle perversioni, non è tecnicamente trasformabile solo mediante una buona relazione analitica (come il Superio primitivo che abbiamo descritto).
Sulla scia del pensiero kleiniano che vede l’Edipo un processo in atto sin dalla nascita, lo psicoanalista francese Jacques Lacan ha dedicato ampio spazio alla teorizzazione sulla formazione del Superio a partire dai fantasmi originari.
Per Lacan l’originalità dell’articolazione kleiniana consiste nell’aver dato centralità al “corpo mitico della madre” (das Ding). A differenza però della Klein secondo la quale nelle relazioni primarie il corpo materno viene percepito come “oggetto parziale”, per Lacan la madre è vissuta come alterità assoluta “agente di frustrazione e di soddisfacimento” da cui l’infans nella sua condizione di prematurità e di impotenza (Hilflosigkeit) si trova a dipendere.
Lacan avanza una precisa distinzione fra le tre istanze postulate da Freud: l’Io Ideale, l’Ideale dell’Io e il Superio. L’Io ideale appartiene al registro dell’immaginario e riguarda l’immagine idealizzata del soggetto (è “come si vorrebbe essere visti”), l’Ideale dell’Io (registro del simbolico) è frutto dell’identificazione edipica, ed è in relazione allo sguardo sociale, al raggiungimento degli ideali condivisi, all’appartenenza al gruppo e al sistema culturale e linguistico, mentre il Superio (registro del reale) si pone come risvolto dell’Ideale dell’Io nei suoi aspetti punitivi, sadici e vendicativi. Lo psicoanalista francese evidenzia, come già sottolineato da Freud, la connotazione “pulsionale” del Superio, rispetto a quella più filosofica di coscienza morale.
Nella vicenda edipica, la figura paterna è fondamentale in quanto viene a svolgere una duplice funzione: da un lato di interdizione all’incesto, mentre dall’altro, attraverso l’identificazione, di favorire la sublimazione.
La sublimazione, infatti, implica una rinuncia al soddisfacimento immediato che permette l’investimento in nuovi oggetti libidici: in altri termini è impossibile per l’uomo ritornare là dove è venuto, cioè dal corpo materno, da quella situazione originaria di soddisfacimento e godimento illimitati. Ma la funzione del padre è soprattutto quella “di unire e non opporre il desiderio alla Legge” intendendo con questo che la condizione umana deve fare i conti con la castrazione, cioè con il senso del limite, con quella linea di confine invalicabile che stabilisce ciò che è impossibile.
Bibliografia
Bion W.R. (1959), Attacchi al legame. In Analisi degli Schizofrenici e metodo Psicoanalitico, Armando, Roma, 1970.
Contran L. Giustino G. ” Le surmoi dans la pensée psychanalytique: concordances et différences” Revue Belge de Psychanalyse n 62, 2013
De Masi F. (1989), Il super-io. Rivista Psicoan., 35: 393-431.
De Masi F.(2002), Quale Super-Io nella clinica analitica?. Rivista Psicoanal., 48:517-535.
Meltzer D. (1973), Stati sessuali della mente, Armando, Roma, 1983
Freud S. (1894), Le neuropsicosi da difesa.O.S.F. 2.
Freud S. (1984), Ossessioni e fobie O.S.F. 2
Freud S. (1914), Introduzione al narcisismo. O.S.F. 7.
Freud S. (1915 b). Lutto e melanconia. O.S.F.8.
Freud S. (1921). Psicologia delle masse e analisi dell’io. O.S.F. 9.
Klein M. (1932), La Psicoanalisi dei bambini. Tr. It. Martinelli, 1970.
Klein M. (1935), Contributo alla psicogenesi degli stati maniaco-depressivi. In Scritti, Boringhieri, Torino, 1978.
Klein M. (1940), Il lutto e la sua connessione cogli stati maniaco-depressivi. In Scritti, Boringhieri, Torino, 1978.
Klein M. (1957), Invidia e gratitudine. Martinelli, Firenze, 1969.
Laplanche J., Pontalis J. B., (1967), Enciclopedia della psicoanalisi, Laterza, 1993.
Lacan J. (1938), I complessi familiari, Einuadi, 2001.
Lacan J. (1957-58), Le formazioni dell’inconscio – Il seminario libro V, Einaudi,
Lacan J. (1959-60), L’etica della psicoanalisi – Il seminario libro VII, Einaudi, 2001
Lacan J. (1966), Scritti, Einaudi, 2002.
Lacan J. (1969-70), Il rovescio della psicoanalisi – Il seminario XVII, Einaudi, 2002
Le Guen C. (2013) , Dizionario Freudiano. Borla, Roma , 2013
Rosenfeld H. (1971). A Clinical Approach to the Psychoanalytic theory of the Life and Death Instincts: an Investigation into Aggressive Aspects of Narcissism.Int. J. Psycho-Anal., 52:169-178 .
Aprile 2014
Tavistock (Il metodo): psicoanalisi e istituzioni
A cura di Mario Perini
Psicoanalisi e società
La psicoanalisi, nata con Sigmund Freud, si è presto sviluppata lungo tre direttrici principali:
-
come teoria del funzionamento della mente individuale
-
come metodo di esplorazione dell’inconscio
-
come strumento di trattamento dei disturbi psichici.
Non esisteva in origine una sociologia psicoanalitica o una teoria del comportamento sociale e del funzionamento istituzionale che utilizzasse le concezioni della psicoanalisi.
In verità Freud aveva aperto un fronte di riflessioni in questo campo con il suo saggio Psicologia delle masse e analisi dell’Io (1921), dove descriveva il funzionamento di istituzioni quali l’esercito e la chiesa ed esponeva una prima teoria psicodinamica della leadership e dei processi mentali nel gruppo allargato. Tuttavia questi spunti interessanti dovevano restare senza un seguito: nelle successive opere “sociologiche” (L’avvenire di un’illusione, 1927; Il disagio della civiltà, 1930; Mosè e il monoteismo, 1939) Freud non li riprenderà più ma svilupperà invece altre tematiche a lui più care, come l’origine della civilizzazione umana e il controllo dell’educazione sulle pulsioni istintuali.
L’interesse della psicoanalisi per le istituzioni rinasce soprattutto in Inghilterra con la Seconda Guerra Mondiale. Nella sua morsa tra totalitarismi e distruttività, olocausto e incubo nucleare, la guerra si è rivelata suo malgrado fucina di una serie di ricerche socio-analitiche che hanno prodotto illuminanti descrizioni delle dinamiche dei gruppi e delle organizzazioni sociali.
Un ruolo particolare in questo periodo e in questo campo di ricerca è stato svolto dal Tavistock di Londra. In Inghilterra fin dagli anni ‘20 operava la Tavistock Clinic, un centro di psicoterapia e formazione per terapeuti, educatori, insegnanti, consulenti di coppia, medici di famiglia e assistenti sociali. Negli anni ‘40 -’45 la Tavistock Clinic si occupa per conto del Governo di selezione del personale militare, riabilitazione sociale dei reduci, trattamento delle nevrosi di guerra, coinvolgendo diversi psichiatri, psicoanalisti e psicologi sociali che durante la guerra avevano prestato servizio nell’esercito, tra i quali Rickman, Sutherland, Bridger, Trist, Main, Turquet, Menzies e Bion.
Dopo la fine della guerra gli stessi personaggi collaborano con la Clinic cercando di re-investire in ricerca clinica e sociale le esperienze fatte nel contesto bellico. In particolareil Northfield Hospital, un ospedale militare per reduci presso Birmingham, doveva diventare nell’immediato dopoguerra la sede di sperimentazioni che avrebbero avuto importanti sviluppi futuri, tra i quali il lavoro pionieristico di Wilfred Bion sui gruppi e quello di Tom Main sulla Comunità terapeutica.
Nel primo dopoguerra il Tavistock si divide in due tronconi con due differenti filoni di ricerca:
-
la Tavistock Clinic rimane ancorata più all’area del trattamento psicologico e della formazione dei terapeuti, in particolare alla psicologia dello sviluppo infantile e adolescenziale, alle difficoltà delle coppie ed ai problemi dell’educazione.
-
una parte, più interessata alla dinamica delle istituzioni sociali, dà origine al Tavistock Institute of Human Relations, che si occuperà principalmente di relazioni umane all’interno delle organizzazioni.
L’approccio psicodinamico-sistemico: nascita del Metodo Tavistock
Nel corso degli ultimi 50 anni il Tavistock Institute e la Tavistock Clinic hanno sviluppato, sia in collaborazione sia separatamente, un’intensa attività di ricerca e intervento nell’area dell’analisi istituzionale e dello studio delle relazioni di gruppo, applicandone i risultati allo studio del funzionamento dei team di lavoro, all’analisi dei sistemi di cura e di sicurezza sociale, all’esplorazione delle professioni d’aiuto, alla consulenza aziendale e all’analisi dei processi organizzativi, con particolare riguardo all’autorità e alla leadership.
Nascono così
-
la concezione del funzionamento emotivo del gruppo sviluppata da Bion con la teoria degli “assunti di base” (attacco/fuga, dipendenza e accoppiamento);
-
la concezione dei sistemi sociali come difese dall’ansia, sviluppata da Elliott Jaques e da Isabel Menzies;
-
un’ampia messe di lavori sull’autorità, la leadership, i ruoli e i confini istituzionali, soprattutto per opera di Eric Miller e Kenneth Rice;
-
la scoperta di Gordon Lawrence del significato sociale del sogno (“Social Dreaming”);
-
il concetto di organizzazione-nella-mente di David Armstrong;
e più in generale gli studi sull’importanza delle emozioni nel lavoro umano e nella vita delle organizzazioni.
Un risultato importante di questa linea di ricerca è stato la creazione di un originale modulo formativo noto come “Group Relations Conference”, un seminario residenziale di diversa durata – da 3-4 giorni a due settimane – durante il quale i partecipanti esplorano le relazioni di gruppo, i propri ruoli, la leadership e l’autorità all’interno di gruppi di vario formato e con compiti differenziati, utilizzando processi di apprendimento basati quasi esclusivamente sull’esperienza.
Il prodotto complessivo delle ricerche suddette, che ha preso il nome di Metodo Tavistock o approccio psicodinamico-sistemico, è un paradigma concettuale di tipo eclettico, che riconosce le sue fondamentali matrici teoriche nella psicoanalisi (“psicoanalisi di gruppo” e “socioanalisi”) e nella teoria dei sistemi aperti. A queste matrici si affiancano contributi provenienti da varie altre discipline: la psicologia sociale, la sociologia dei gruppi e delle organizzazioni, le scienze politiche, l’economia, le teorie aziendali.
Il Metodo Tavistock è un metodo:
-
di analisi delle istituzioni (a scopi di ricerca o di diagnosi organizzativa);
-
di formazione di operatori, tecnici e dirigenti che lavorano nelle istituzioni;
-
di consulenza alle istituzioni in difficoltà o impegnate nel cambiamento.
Non è un sistema teorico chiuso e onnicomprensivo; non si propone una spiegazione integrale dei fenomeni e dei processi istituzionali; non si contrappone né intende sostituirsi alle più note e collaudate concezioni sulla gestione aziendale, sullo sviluppo organizzativo o sulla psicologia e sociologia del lavoro, dei servizi, delle pubbliche amministrazioni e dei processi industriali.
Ha i suoi fondamenti in una “teoria clinica” dell’organizzazione, che si basa sullo studio degli aspetti emotivi ed irrazionali del comportamento degli individui e dei gruppi all’interno di un’organizzazione, e del modo in cui essi ne influenzano il funzionamento. Muove dall’esperienza che in una qualsiasi organizzazione le strategie, per quanto accurate, supportate e fornite di ampio consenso, si rivelano spesso almeno in parte difettose o restano in maggiore o minor misura inapplicate, e postula che le cause del loro fallimento o del loro sabotaggio possano dipendere da fattori psicologici per lo più inconsci, inespressi e imprevedibili. In questo senso considera un mito l’idea della razionalità dell’organizzazione.
Poiché tali fattori per la loro stessa natura sfuggono ad un’analisi razionale, l’approccio psicodinamico-sistemico del Metodo Tavistock appare meglio attrezzato di altri non solo per riconoscerli e correggerli ma anche per utilizzare questa esperienza ai fini di un apprendimento organizzativo.
Tecniche corporee/Rilassamento
A cura di Diego Spiller
Il rilassamento, essendo un fenomeno al contempo corporeo e psichico, ha rivestito un notevole interesse in psicoanalisi fin dai suoi albori. Freud aveva sempre tenuto ben presente la centralità del corpo nello sviluppo psichico fino ad affermare che l’Io è “prima di ogni altra cosa un Io-corpo”. Il concetto di pulsione, basilare nella teoria freudiana, esprime proprio lo stretto legame tra processi somatici e processi psichici: le rappresentazioni psichiche derivate dall’eccitamento di specifiche zone del corpo, chiamate zone erogene, vengono investite di una certa quantità di energia. L’apparato psichico, tuttavia, regolato dal principio di dispiacere-piacere, tende ad evitare l’ingorgo di energie e a mantenere bassa la somma degli eccitamenti essendo la tensione, da essi prodotta, fonte di dispiacere e la distensione (rilassamento), derivante dalla scarica della pulsione, fonte di piacere. Il rapporto tensione-distensione, è stato successivamente approfondito da altri autori che, in modo diverso, lo hanno integrato nelle loro formulazioni teorico-cliniche (vedi Psicoanalisi e Rilassamento).
I metodi di rilassamento
Nel linguaggio corrente il rilassamento viene contrapposto al termine stress, così che essere rilassati significa non essere stressati, tesi, nervosi. Da questo punto di vista il rilassamento si può considerare un fenomeno spontaneo che ognuno ricerca nella vita quotidiana, con proprie modalità e strategie, allo scopo di allentare la tensione e recuperare le energie. Questo vale anche per gli esperti in questo campo i quali, tuttavia, attribuiscono alla parola un significato più specifico, riferendosi ai metodi da essi adottati. Si parla, infatti, di metodi o tecniche di rilassamento definendoli dei procedimenti che mirano a ottenere nell’individuo una diminuita tensione muscolare e psichica con l’aiuto di esercizi appropriati. Questi metodi, prevalentemente concepiti come forme di trattamento terapeutico, permettono di raggiungere un livello di distensione più profondo.
Schultz, all’inizio del secolo scorso si occupò d’ipnotismo e delle sue applicazioni nel campo dei disturbi di origine psichica. Egli notò che durante lo stato ipnotico si manifestavano spontaneamente, cioè senza alcuna induzione particolare del terapeuta, delle sensazioni di pesantezza e calore, alle quali non era stata data alcuna importanza essendo l’ipnosi considerata un processo essenzialmente psichico. Tali manifestazioni sono, a livello fisiologico, la conseguenza di una distensione muscolare e di un’iperemia da distensione vasale. Schultz ritenne queste manifestazioni non dei semplici effetti collaterali, ma gli elementi essenziali, l’espressione stessa della distensione. Queste osservazioni gettarono le basi del suo metodo: il Training Autogeno. Egli elaborò una serie di esercizi da compiersi sistematicamente che inducessero il vissuto della pesantezza e del calore in modo da raggiungere uno stato di distensione psicofisica profonda. La senso-percezione del calore e della pesantezza sono gli esercizi fondamentali del ciclo inferiore del training autogeno. All’incirca nello stesso periodo Jacobson, negli Stati Uniti, partendo da diversi presupposti teorici, mise a punto un metodo, da lui denominato Rilassamento Muscolare Progressivo, con l’obiettivo di raggiungere uno stato di rilassamento psicofisico attraverso esercizi di contrazione/decontrazione muscolare. Schultz e Jacobson quindi, agli inizi del ‘900, hanno ideato ed elaborato dei metodi che, per vie diverse, mirano entrambi al raggiungimento di uno stato di distensione neuromuscolare. Questi due metodi si possono considerare basilari: successivamente altri autori hanno utilizzato le concezioni e i principi teorici di Schultz e Jacobson elaborando dei propri metodi: l’Ipnosi Attiva Graduata di Kretschmer, la Psicoterapia di Rilassamento di Ajuriaguerra, la Regolazione Attiva del Tono Muscolare di Stokvis, il Rilassamento Statico-Dinamico di Jarreau e Klotz, la Desensibilizzazione Sistematica di Wolpe, il Metodo del Decondizionamento fondato sulla Tecnica del Training Autogeno di Rognant, il Rilassamento a Induzioni Variabili di Sapir, il Metodo del Movimento Passivo applicato ai bambini di Wintrebert, il Rilassamento Terapeutico nel bambino di Bergès e Bounes e altri ancora.
Aspetti basilari del rilassamento
Il rilassamento non è semplicemente uno stato, ma un processo, con uno sviluppo temporale. E’ una ricerca che richiede dedizione e costanza e che incontra ostacoli e resistenze oggetto di verbalizzazione e analisi nell’applicazione dei metodi. L’attenzione, in quasi tutti i metodi, è orientata al corpo: il soggetto si distacca sempre più dall’ambiente esterno i cui stimoli diventano più fievoli, mentre il vissuto somatico si fa più ricco. La monotonia degli stimoli contribuisce al progressivo isolamento dall’ambiente circostante. Nei metodi, infatti, si utilizzano dei movimenti ritmici e regolari o delle particolari formule verbali ripetitive per indurre il rilassamento. La concentrazione verso il corpo ha la caratteristica di essere passiva, vale a dire senza intervento della volontà. L’atteggiamento richiesto è cioè quello di “lasciar accadere”, “non imporsi”, in altre parole “non volere qualche cosa”. Potremmo dire che chi “vuol rilassarsi” ottiene l’effetto opposto. L’effetto fisiologico più evidente e percepibile del rilassamento è la riduzione del tono muscolare (ipotonia) dove per tono muscolare s’intende quel leggero stato di contrazione che presentano i muscoli normalmente inseriti e innervati. La decontrazione tuttavia non è solo un fenomeno muscolare ma è l’espressione somatica di uno stato che coinvolge l’individuo nella sua unità psico-fisica, per il quale è più appropriato il termine distensione.
Scopi del rilassamento
Poiché le tecniche di rilassamento mirano al riequilibrio del sistema neuro-vegetativo e a ridurre lo stato di attivazione dell’organismo, sono particolarmente indicate per la riduzione dell’ansia. Attraverso un allenamento costante e prolungato nel tempo si acquisisce la capacità di farsi coinvolgere meno da ciò che tende ad alterare l’equilibrio psico-fisico. L’ansia è anche in stretto rapporto con la prestazione: moderati livelli d’ansia migliorano la prestazione, livelli troppo elevati la peggiorano drasticamente. Le tecniche trovano allora una valida applicazione nel campo sportivo, professionale, scolastico e in generale in tutte le situazioni in cui è richiesta una concentrazione specifica per superare una difficoltà sul piano mentale o fisico. Il rilassamento è anche consigliato per recuperare le energie spese per un’attività psichica o fisica prolungata, per diminuire la sensibilità al dolore, per rafforzare le capacità mnemoniche e per raggiungere, con minor difficoltà, obiettivi prefissati.
L’applicazione delle tecniche di rilassamento può avere anche una finalità terapeutica, soprattutto con pazienti in cui vi è uno squilibrio nel funzionamento del sistema neuro-vegetativo, come nel disturbo d’ansia generalizzata, nell’insonnia e nella cefalea tensiva. Durante il processo guidato di esplorazione del vissuto tonico e somatico che conduce al rilassamento si manifestano spesso delle resistenze che ostacolano la distensione. Il presupposto teorico è che alla base delle tensioni somatiche e dei blocchi tonici vi siano conflitti di cui il paziente non è consapevole a livello cosciente. L’allentamento del tono e il corrispondente abbassamento delle difese psichiche può agevolare la comparsa di ricordi, pensieri ed emozioni che, una volta elaborati con l’aiuto del terapeuta, possono aiutare il paziente a risolvere i suoi conflitti inconsci e a pervenire a un maggior stato di benessere.
Psicoanalisi e Rilassamento
Dopo Freud, Ferenczi aveva osservato una relazione tra la capacità di rilassare la muscolatura e la possibilità del paziente di associare liberamente i propri contenuti di pensiero, che costituisce la “regola fondamentale” in psicoanalisi. Egli, con l’intento di trattare pazienti che non sembravano trarre beneficio dall’approccio psicoanalitico classico, introdusse, modificando il setting tradizionale, delle “tecniche attive” tra cui trovavano posto esercizi di rilassamento per superare le resistenze del paziente alla libera associazione. Poiché le tecniche attive si erano rivelate particolarmente adatte a trattare i disturbi del carattere, un allievo di Ferenczi, Reich, fu spinto ad ampliarle ulteriormente attraverso un approccio da lui stesso chiamato Analisi del carattere. Reich considerava le rigidità muscolari, che vanno a costituire la corazza o armatura caratteriale, non il risultato di disturbi emotivi ma la loro stessa espressione che contiene in sé il loro significato e la loro genesi. Sulla base di questi presupposti egli affiancò all’analisi “dall’alto” tipica della psicoanalisi tradizionale che fa uso dell’interpretazione verbale e delle libere associazioni, un’analisi “dal basso” centrata sul vissuto somatico, per allentare e sciogliere quelle rigidità muscolari che impediscono il libero flusso dell’energia vitale. Quest’ultimo orientamento fu ulteriormente approfondito ed esteso da un allievo di Reich, Lowen, che denominò il suo approccio Analisi e Terapia Bioenergetiche. Per tutti gli autori precedentemente citati il rilassamento, tuttavia, non costituisce l’obiettivo primario, ma l’effetto secondario o l’ausilio dello specifico approccio da essi adottato. E’ solo con Schultz che il rilassamento ha assunto un ruolo focale ed è stata sviluppata, per conseguirlo, una vera e propria tecnica. Agli inizi del ‘900 Schultz partecipò attivamente al movimento psicoanalitico, per poi distaccarsene elaborando una propria metodologia, il training autogeno, il cui ciclo superiore rappresenta una forma di psicoterapia. Negli anni Sessanta Ajuriaguerra, stimolato dagli studi di Wallon sulle variazioni del tono neuromuscolare, osservò che il fondo tonico, ossia l’alternarsi di stati di tensione e di distensione, varia in funzione della natura della relazione, e definì dialogo tonico la prima forma di comunicazione madre-bambino. Ajuriaguerra, sulla base di queste intuizioni, integrando la sua formazione psicoanalitica con gli studi di neuropsicologia, sviluppò una Psicoterapia di Rilassamento in cui le osservazioni e le verbalizzazioni che il paziente compie sul proprio vissuto somatico e tonico sono il principale oggetto nella relazione terapeuta-paziente. In questa forma di terapia il setting è funzionale all’esplorazione delle proprie percezioni corporee in presenza dell’altro: il paziente, disteso, e l’analista, seduto di fronte a lui, si possono osservare reciprocamente. Badoni, psicoanalista italiana contemporanea, pratica da diversi anni la Psicoterapia di Rilassamento dialogando con colleghi della società svizzera, italiana e francese che hanno preferito chiamarla, per distinguerla da altri approcci corporei, Psicoterapia Psicoanalitica Corporea. Badoni, pur non nascondendo le sue perplessità circa la collocazione di questa psicoterapia nell’ambito della teoria e della pratica psicoanalitica, ne riconosce la validità e ne promuove la ricerca in campo psicoanalitico avendone potuto sperimentare l’efficacia con pazienti che esprimono una sofferenza nella propria esperienza corporea. L’autrice propone tale approccio sia a pazienti che non hanno ancora intrapreso o non avrebbero potuto intraprendere un lavoro analitico, sia a pazienti già analizzati qualora sia riscontrabile un eccesso di intellettualizzazioni rispetto ad una scarsa competenza emotiva. Ciò non solo evidenzia l’importanza dell’esperienza corporea e dell’esplorazione del vissuto somatico nella relazione analitica, ma apre uno spazio di riflessione, di ricerca e di approfondimento sull’integrazione di altri modelli teorico-clinici nell’approccio psicoanalitico.
Bibliografia
Ajuriaguerra J. De (1960). Tonus corporel et relation avec autrui. L’experience tenique au cours de la relazation. Premier Congrès de Med. Psychosomat. Del langue fr. Vittel 8-10 julliet. Rev. De Méd. Psychosomatique Psychosom. , 2, 89-124
Badoni M. (2014). Corpo. Riv. Di Psicoanalisi, 4,917-932.
Bergès J. et Bounes M. (1974). Il rilassamento terapeutico nel bambino. Milano, Masson, 1978
Brenner H. (1992). Rilassamento progressivo e desensibilizzazione sistematica dell’ansia (2a ed.). Cinisello Balsamo (Milano), Paoline.
Durand De Bousingen R. (1979). Distensione e training autogeno: tecnica e pratica del rilassamento e dell’allenamento autogeno (3a ed.). Roma, Ed. Mediterranee.
Eberlein G. (2001). Le fiabe che rilassano, Il training autogeno per favorire la tranquillità e il benessere dei bambini. Como, red ed.
Freud S. (1922). L’io e l’Es. O.S.F. 9
Freud S. (1925). Psicoanalisi. O.S.F. 10
Freud S. (1905). Tre saggio sulla teoria sessuale
Hardy and Parfitt (1991). A catastrophe model of anxiety and performance. British Journal of Psychology, 82, 163-178.
Lowen A. (1958). Il linguaggio del corpo. Milano, Feltrinelli, 1978
Jacobson E. (1929), Progressive Relaxation, University of Chicago Press.
Peresson L. (a cura di) (1985). Trattato di psicoterapia autogena, vol.II°, Abano Terme (Pd), Piovan.
Raganato A. e Crovi E. (1983). Effetti del rilassamento sul comportamento e rendimento scolastico. Roma, Marrapese.
Reich W. (1933). Analisi del carattere. Milano, Sugarco, 1949
Sapir et al. (1979). Il rilassamento. Roma. Astrolabio, 1980
Schultz J.H. (1932). Il training autogeno: esercizi inferiori, vol 1. Milano, Feltrinelli, 1968
Schultz J.H. (1932). Il training Autogeno: esercizi superiori, Teoria del metodo, vol. 2. Milano, Feltrinelli, 1980
Spiller D. (2003). Le tecniche di rilassamento a scuola. Bergamo, Ed. Junior
Vollmar K. (2000). Training autogeno per bambini. Diegaro di Cesena (FC), Macro ed.
Dicembre 2015
Tomasi Di Palma Alessandra

Alessandra Tomasi Di Palma
Maestri della psicoanalisi italiana
A cura di Laura Lupo
Alessandra Tomasi Di Palma (Nizza, 1896 – Palermo, 1982)
Pioniera della psicoanalisi in Italia, ha partecipato attivamente alla costituzione della Società Psicoanalitica Italiana e alla sua successiva rifondazione negli anni del dopoguerra. È stata, ad oggi, l’unica donna a rivestire la carica di Presidente della Società Psicoanalitica Italiana. Ha avuto un ruolo attivo nell’organizzazione dei congressi nazionale ed internazionali. È stata Presidente onoraria del Centro di Psicoanalisi di Palermo.
La Vita
Alessandra Tomasi, Baronessa Wolff di Stomersee, Duchessa di Palma, Principessa di Lampedusa nacque a Nizza il 27 novembre del 1896. Trascorse i suoi primi anni di vita a Pietroburgo, nella sede del Palazzo d’Inverno, dove il padre, il barone baltico Boris Wolff Stomersee, era un alto dignitario dello zar Nicola II. La madre, Alice Barbi era un’apprezzata cantante lirica, di origini italiane.
Alla corte dello zar, insieme alla sorella Lolette, di due anni più piccola, la Principessa respirò un’aria colta e raffinata, sebbene all’ombra di uno splendore decadente della morente cultura zarista.
Nei primi del novecento, agli inizi della rivoluzione russa, la famiglia Wolff si trasferì al castello di Stomersee, nei pressi di Riga, dove nel 1918, all’età di 22 anni, un anno dopo la morte del padre, la Principessa sposò il barone Andrè Pilar.
Fu qui che la Principessa sentì parlare di Psicoanalisi, rimanendone subito attratta. Seguì la sua passione, arrivando a Berlino, intorno agli anni venti, dove iniziò a frequentare l’Istituto di psicoanalisi, fondato e diretto da Karl Abraham. Fece una prima analisi personale con Felix Boehm, una successiva analisi didattica con Max Eitingon, e una terza analisi di controllo (paragonabile, forse ad una supervisione) con Hans Liebermann.
Nel 1927, dopo una breve permanenza a Vienna, dove conobbe Freud, iniziò ad esercitare la psicoanalisi a Stomersee. Seguì alcuni pazienti anche a Londra, dove si recava in visita alla madre che, dopo la morte del marito, si era risposata con Pietro Tomasi della Torretta, nobile siciliano e ambasciatore italiano alla corte di S. Giacomo.
Fu qui che conobbe Giuseppe Tomasi di Lampedusa, spesso ospite dello zio. Ottenuto il divorzio dal barone Pilar, i due si sposarono nel Castello di Stomersee nel 1932, per trasferirsi un paio di anni dopo in Italia, dividendosi tra Roma e Palermo e lunghi periodi di permanenza, lontana dal marito, nel castello di Stomersee che dovette però abbandonare nel ’39, quando la tenuta familiare sarà definitivamente confiscata ed adibita a sede governativa.
Al castello portò avanti, tra le altre, anche l’analisi di S., di cui presentò un resoconto, per discuterlo nel ’36 con Edoardo Weiss, per l’ammissione alla Società Psicoanalitica. Di quest’analisi resta, come unica testimonianza, una lettera del 1937, in cui la Principessa racconta al marito con considerevole dovizia l’andamento dell’analisi e da cui si può evincere anche il suo modo di lavorare con i pazienti.
A Roma, la Principessa strinse subito rapporti con lo stesso Weiss e con il piccolo gruppo dei fondatori della recentissima Società di Psicoanalisi Italiana, in particolare con Cesare Musatti, Nicola Perrotti ed Emilio Servadio, diventando Membro ordinario e, in seguito, Membro didatta della SPI.
Negli anni del dopoguerra, operò attivamente per la rinascita della Società Psicoanalitica Italiana e per la ripresa della pubblicazione della Rivista di Psicoanalisi.
Fu l’unica donna a rivestire, dal 1954 al 1959, la carica di Presidente della SPI.
A Palermo, la Principessa non fu ben accolta e dovette scontrare, oltre che con l’ostilità e la diffidenza di una terra che, in quegli anni, era divenuta un deserto culturale e morale, anche con la suocera, donna Beatrice Mastrogiovanni Tasca di Cutò, imponente matriarca, possessiva e gelosa nei confronti del figlio. Sebbene ciò, la Principessa, insieme al marito, diede vita ad un’oasi culturale che lentamente si estese.
Dopo la morte di Giuseppe Tomasi, nel 1957, la Principessa si ritirò in parziale isolamento, continuando però a lavorare con i pazienti. Nel frattempo si occupò della pubblicazione e della diffusione dell’opera postuma del marito, riuscendo a far stampare il Gattopardo ed a sostenerne il successo divenuto poi mondiale. Seguì da vicino le riprese del celebre film di Visconti, tratto dal romanzo.
Si spense a Palermo il 22 giugno del 1982, all’età di 86 anni.
Solitaria, ombrosa e dai modi alteri, la Principessa fu una donna che si distingueva per la sua imponenza ed il suo temperamento, ma allo stesso tempo nostalgica e sofferente, generosa e disponibile con tutti, nutriva una passione smisurata per la Psicoanalisi e per i suoi pazienti. Alla Principessa va il merito di aver importato Freud in Sicilia e con esso un modello culturale e scientifico d’impronta europea. Francesco Corrao ne accolse l’eredità analitica, facendosi promotore nel 1978 della fondazione del Centro Psicoanalitico di Palermo, di cui la principessa fu, fino alla morte, Presidente Onoraria.

(1914) – La famiglia Wolff al castello di Stomersee, Da sinistra: il barone Boris, Alessandra, una sconosciuta, Alice, Lolette

(1931) – Giuseppe Tomasi e Alessandra al castello di Stomersee.

(1950) – La Principessa a Roma, al II Congresso della Società Psicoanalitica Italiana, con Nicola Perrotti ed Emilio Servadio.

(1952) – La Principessa a Roma, al Congresso degli Psicoanalisti di Lingue Romanze (alla sua sinistra, Cesare L. Musatti).
* (Le foto sono tratte dalla raccolta curata dalla D.ssa M. Vigneri – La principessa di Lampedusa: materiale iconografico)
Cronologia degli scritti
1. Tomasi di Palma A. (1936) Il caso S. presentato a Weiss nel 1936 e relazionato a Giuseppe Tomasi nella lettera del 25 settembre 1937.
2. Tomasi di Palma A. (1946). «Sviluppi della diagnostica e tecnica psicoanalitica». Psicoanalisi, 2.
3. Tomasi di Palma A. (1950). «L’aggressività nelle perversioni», lavoro letto al II Congresso della S.P.I., Roma 1950.
4. Tomasi di Palma A. (1956). «Le componenti preedipiche dell’isteria d’angoscia». Riv. Psicoanal., 2, 101-106.
5. Tomasi di Palma A. (1956). «Necrofilia e istinto di morte (Osservazioni su un caso clinico)». Riv. Psicoanal., 3, 173-186.
6. Tomasi di Palma A. (1960). «La spersonalizzazione». Presentato al XXI Congresso di Psicoanalisi di lingue Romanze (Roma 7-9 aprile 1960). Riv. Psicoanal., 1961, 1, 5-10.
Inediti
1. Tomasi di Palma A. (1975-1977). «Il caso del Licantropo». Dattiloscritto in originale, pubblicato (a cura di Malde Vigneri) nella Rivista di Psicoanalisi, 2/2008.
2. Tomasi di Palma A. (1980). «Uno spostamento e due meccanismi di difesa per il sorgere della nevrosi ossessiva», Presentato al Centro di Psicoanalisi di Palermo nel 1984, pubblicato (a cura di Malde Vigneri) con il titolo “Il patto con il diavolo” nella Rivista di Pasicoanalisi, 2/2008.
Bibliografia su Alessandra Tomasi Di Palma
Biancheri B. (2002). Il ritorno a Stomersee. Milano, Feltrinelli.
Caronia S., (a cura di) (1995). Licy e il Gattopardo. Lettere d’amore di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Roma, Edizioni Associate, 2004.
Corrao, F. (1982). Alessandra Tomasi di Lampedusa (1895–1982). Rivista Psicoanal., 28:455-459.
Gardona C. (1987). Lettere a Licy. Palermo, Sellerio.
Izzo S. (2005). La dama e il Gattopardo. Ed. Memori.
Orlando F. (1996). Ricordo di Lampedusa. Da distanze diverse. Torino, Boringhieri, 2001.
Petacchi G. (1985). Vita da Pionieri. In La cultura psicoanalitica, Trieste, Studio Tesi, 1987.
Tomasi Lanza G. (1998). Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Una biografia per immagini. Palermo, Sellerio.
Vigneri M. (2003-2004). La Principessa di Lampedusa. Rivista Sicilia, Flaccovio, 10 (99).
Vigneri M. (2006). Alessandra Wolff Tomasi. In Marinella Fiume (a cura di), Siciliane. Dizionario Biografico, Emanuele Romeo.
Vigneri M. (2008). Le origini della Psicoanalisi in Sicilia. La principessa di Lampedusa. In corso di pubblicazione.
Vigneri, M. (2008). La principessa di Lampedusa. Rivista Psicoanal., 54:389-425.
Vigneri, M. (2008). Premessa a «Il caso del licantropo», inedito di Alessandra Tomasi di Palma. Rivista Psicoanal., 54:427-432.
Vigneri, M. (2008). Premessa a «Il patto con il Diavolo», inedito di Alessandra Tomasi di Palma. Rivista Psicoanal., 54:447-454.
Collegamenti in Spiweb:
– Breve storia del Centro di Psicoanalisi di Palermo
– Ricordo di Francesco Orlando
Contributo alla psicoanalisi
Alessandra Tomasi ha avuto un ruolo cardine agli albori della psicoanalisi in Italia.
I suoi lavori, sebbene non numerosi, sono un esempio di rigore di metodo e di apertura dell’orizzonte epistemologico e tecnico, essendo peraltro forte ed indiscutibile la sua fedeltà al pensiero di Freud.
Fra i suoi contributi, merita particolare attenzione il lavoro, dal titolo Sviluppi della diagnostica e tecnica psicoanalitica, presentato nel 1946 al I Congresso Nazionale di Psicoanalisi, che la stessa aveva concorso ad organizzare.
In questo scritto la Tomasi anticipa il concetto clinico di struttura borderline, dimostrando come le nuove acquisizioni tecniche della Psicoanalisi abbiano consentito di trattare le Psicosi, le Psicopatie, le Criminosi ed i Borderlines. Dedica anche alcune pagine di questo lavoro ad una sorprendente trattazione della Psicoanalisi di gruppo, che sarà poi ampiamente sviluppata da Francesco Corrao.
Nel 1950 al II Congresso della SPI presenta un lavoro dal titolo: L’aggressività nelle perversioni, nel quale, estendendo e isolando la concezione dell’istinto di morte, enuncia i fondamenti per una teoria del narcisismo aggressivo, con un resoconto attento di un caso di necrofilia, pubblicato qualche anno dopo nella Rivista di Psicoanalisi.
Sulla scia di questo filone di ricerca, si colloca anche il famoso lavoro Il caso del licantropo, presentato prima a Roma e poi al Centro di Palermo. Qui, l’autrice, persegue l’obiettivo di dimostrare come la licantropia rientri tra le nevrosi e, richiamando il concetto kleiniano di identificazione proiettiva, conia il neologismo introiezione identificatoria.
Prima di morire (1980), scrive Il patto con il diavolo, che l’Autrice stessa definisce: «compendio di una vita dedicata alla Psicoanalisi». Qui l’Autrice, partendo da un’affascinante e avvincente disamina letterale, culturale e mistica della figura del demonio, si addentra verso un’analisi accurata e scientifica dei meccanismi psichici che entrano in gioco in quelle nevrosi ossessive, dove vi siano riferimenti al divino, al sacrilegio, alla bestemmia, fino ad arrivare alla figura del diavolo.

Pioneer of psychoanalysis in Italy, she has actively participated in the establishment of the Italian Psychoanalytic Society and its re-establishment during the years after the War. She has been the only woman to hold the position of President of the Italian Psychoanalytic Society. She played an active role in the organization of national and international conferences. She has been Honorary President of the Center of Psychoanalysis in Palermo.
The Life
Alessandra Tomasi, Baroness Wolff of Stomersee, Duchess of Palma, Princess of Lampedusa was born in Nice on November 27, 1896. She lived in St. Petersburg , in the Winter Palace, where her father, the baltic baron Boris Stomersee Wolff, was a high dignitary of Tsar Nicholas II. Her italian-born mother, Alice Barbi, was a famous opera singer.
The Princess grew up in the cultured and refined environiment of the Tsar’s Court, with her younger sister Lolette, although under the shadow of the decaying magnificence of the dying Tsarist culture.
At the beginning of the Twentieth Century, during the Russian Revolution, Wolff family moved to the Castle of Stomersee, near Riga where, in 1918, one year after her father’s dead, the Princess married the Baron André Pilar, at the age of 22.
In here the Princess knew about Psychoanalysis for the first time, and remained immediately attracted. Following her passion, she went to Berlin where, during the Twenties, started to attend at the Institute of Psychoanalysis, founded and directed by Karl Abraham. She made a first personal analysis with Felix Boehm, a training analysis with Max Eitingon, and a third control analysis (perhaps comparable to a supervision) with Hans Liebermann.
In 1927, after a short stay in Vienna, where she met Freud, she began to practice psychoanalysis in Stomersee . She had some patients even in London, where she used to go visiting her mother, who, after the death of her husband, married Pietro Tomasi della Torretta, a noble Sicilian and Italian ambassador to the court of St. James.
In London she met Giuseppe Tomasi di Lampedusa, guest of his uncle. Once obtained the divorce from Baron Pilar, the Princess married Giuseppe Tomasi in the Castle of Stomersee during 1932, and two year later they moved to Italy. She spent her time moving from Rome to Palermo, and she used as well to stay in Castle of Stomersee for long periods, far away from her husband. Unfortunately she had to leave the Castle in 1939, when the Government confiscated it, and used it as a Government’s seat.
At the castle she continued, among others, also the analysis of S., and in 1936 she presented a report, discussing it with Edoardo Weiss, for the admission to the Psychoanalytic Society. The only thing that witnesses this analysis is a letter that she wrote to her husband, in order to describe to him, with considerable wealth, the progress of the analysis and her own way of working.
In Rome, the Princess met Weiss and the small group of founders of the Italian Psychoanalytical Society, especially Cesare Musatti, Nicola Perrotti and Emilio Servadio. She became a ordinary member and, later, Member teacher of SPI.
In the postwar years she worked actively for the rebirth of the Italian Psychoanalytic Society and for the resumption of the publication of the Journal of Psychoanalysis.
She was the only woman who has ever been President of the SPI, between 1954 and 1959.
In Palermo, the Princess was not well received, having to collide, as she had to face the hostility and the mistrust of a land that, in those years, had become a cultural and moral desert, even with the mother-in-law, Donna Beatrice Mastrogiovanni Tasca di Cutò, imposing matriarch and possessive of her son.
Nevertheless she and her husband cultivated a cultural oasis that slowly grown.
After her husband’s death in 1957 she retired in partial isolation, continuing the clinical work with her patients. Meanwhile she managed to publish and release her husband’s work, the Gattopardo, supporting its global success. She followed the making of of the famous film by Visconti, based on the book.
She died at Palermo on June 22 , 1982 , at the age of 86 years old.
Solitary, shadowy and manner alter, the Princess was a woman known for her grandeur and her temper, but at the same time nostalgic and suffering, generous and helpful to all who, had a huge passion for Psychoanalysis and for her patients.
To the Princess goes the credit of importing in Sicily Freud and the European cultural and scientific model. Francesco Corrao accepted the analytic legacy, promoting in 1978 the foundation of the Psychoanalytic Center of Palermo, of which the princess was, until his death, Honorary President.
The contribution to psychoanalysis.
Alessandra Tomasi has played a pivotal role in the early days of psychoanalysis in Italy.
Her few works are an example of rigor and method and an opening to epistemological and technical horizon, with however a strong and indisputable loyalty to Freud’s thought.
Among her contributions, the work entitled Developments in diagnostic and psychoanalytic technique deserves special attention. It was presented in 1946 at the first National Congress of Psychoanalysis, that she had contributed to organize.
In this paper, Tomasi anticipates the clinical concept borderline, demonstrating how new techniques of psychoanalysis acquisitions have able to treat psychosis, the psychopathy, the criminal and the Borderlines.
She also devotes several pages to a discussion of the amazing Psychoanalysis of group, which will then be largely developed by Francesco Corrao.
In 1950, at the Second Congress of the S.P.I. she presents paper entitled: The aggression in the perversions, in which, isolating and extending the concept of the death instinct, placed the foundations for a theory of narcissism aggressive, investigating a case of necrophilia, published few years later in the Italian Journal of Psychoanalysis.
In the wake of this research, is placed the famous work The case of the werewolf, presented first in Rome and then to the Center of Psychoanalysis in Palermo. Here, the author aims to demonstrate how lycanthropy falls between neurosis and, recalling the Kleinian concept of projective identification, coined the neologism identificatory introjection.
Before her death (1980), she writes The pact with the devil, that she defined: “a compendium of a life dedicated to Psychoanalysis.” Here the author, starting with a fascinating and compelling examination literal, cultural and mystical of the figure of the devil, delves into a accurate and scientific analysis of the psychic mechanisms that come into play in the obsessional neurosis, where there are references to the divine, sacrilege, blasphemy, up to the devil.
Transculturale – Clinica
A cura di Anna Bassetti
Il termine transculturale [comp. di trans e culturale] è stato coniato per tradurre l’inglese cross-cultural (che indica più propriamente l’incrociarsi di varie culture), ed è usato nelle scienze sociali, specialmente in antropologia culturale e sociologia, con riferimento alla reciproca influenza che culture diverse hanno sui comportamenti individuali e collettivi (Vocabolario Treccani).
Il concetto di transcultura rimanda a qualcosa che attraversa la cultura. Pertanto, la transculturalità potrebbe riferirsi a tutto ciò che trascende la particolarità e la specificità delle singole culture, mirando all’individuazione degli elementi universali, comuni a tutti gli esseri umani, a prescindere dal colore della pelle, dalla lingua, dalle modalità di pensiero o dalla religione. Nei settori psicologici e psichiatrici l’attributo “transculturale” è ormai scientificamente consolidato (vedi i numerosi studi sulla “cross cultural psychology” o sulla psichiatria transculturale). Ancora più complicato, se non addirittura erroneo o fuorviante, è parlare di “transcultura” o di “transculturalità” in maniera astratta, senza specificare a cosa ci si riferisce. Le culture “non si attraversano” mai da sole, ma necessitano sempre di essere veicolate dai soggetti che ne sono portatori, dagli esseri umani.
L’approccio transculturale pone l’accento sull’individuo come dotato di un io culturale, una mente avviata alla cultura di appartenenza attraverso le norme tramandate dalla comunità. L’approccio transculturale favorisce la presa di coscienza del proprio atteggiamento di fronte all’esperienza della diversità.
Clinica transculturale
La clinica transculturale nasce prevalentemente nell’incontro con l’utenza straniera, con particolare riferimento a quella extracomunitaria, e solo ultimamente alcune correnti di pensiero stanno ampliando l’analisi e affrontando il ruolo che l’aspetto culturale riveste, anche per gli autoctoni, non solo nella malattia ma anche nel trattamento e nella guarigione. Tali riflessioni, in realtà, erano già sorte alcuni decenni fa, nell’ambito della psichiatria sociale post-basagliana, ed avevano dato luogo ad una serie di interventi terapeutici e riabilitativi che coinvolgevano il recupero degli elementi storico-culturali e il recupero della socialità per i pazienti come parte del trattamento terapeutico.
In Europa ed in Italia (altro è per gli Stati uniti) la posizione di psicologi, psichiatri e medici si differenzia in base a diversi approcci teorici, riconducibili sommariamente in due filoni principali, quello etnopsicologico (Devereraux, Nathan, Moro, Losi, Fleury; per l’Italia: Coppo, Beneduce, Inglese, Zorzetto) e quello transculturale (Freeman, Terranova-Cecchini, Inghilleri, Mazzetti). La scuola etnopsichiatrica, comprese tutte le varianti sviluppatesi nell’ultimo decennio, affronta le problematiche psicofisiche del paziente riportandolo (come il termine “etnopsichiatria” stesso indica) al centro della sua cultura d’origine ed utilizzando il sintomo come simbolo e come strumento primario per una lettura della storia e della sofferenza del paziente, utilizzando una chiave culturale “totalmente altra” da quella del contesto dove egli attualmente si trova a vivere. In quest’ottica, l’attenzione è prevalentemente rivolta alla costruzione o ricostruzione di un insieme di significati provenienti dal mondo simbolico della cultura d’origine. L’approccio della psicologia transculturale invece focalizza l’attenzione prevalentemente sulla comunicazione e sull’interazione tra la cultura d’origine del paziente e quella del paese ospitante. Comunicazione ed interazione che si pongono in atto a più livelli: sia nel momento in cui il paziente si relaziona con il medico o lo psicologo italiano; sia quando egli si interfaccia con altre persone e costruisce delle nuove relazioni sociali, amicali e lavorative; sia, ancora, all’interno della sua stessa psiche che introietta, rielabora, assimila, integra attivamente, significati e significanti del nuovo universo culturale in cui attualmente vive con il mondo di significati e significanti che ha costruito e portato con sé dal suo paese d’origine (Petruzzi-Riva 2002).
Per quanto riguarda il lavoro analitico, inoltre, T. Reid sottolinea come anche nelle diverse impostazioni psicoterapiche, ci possono essere conflitti inconsci tra i valori di riferimento culturali del terapeuta e del paziente, come pure tra i valori esposti, razionali, e quelli non consci di un paziente appartenente ad una diversa cultura da quella del terapeuta. Lo stimolo, quindi, ad essere sempre più attenti a consapevoli su similarità e differenze negli assunti culturali, nelle concezioni sottoculturali nascoste, tra terapeuti e pazienti, può permetterci di cogliere le modalità di “resistenza” del paziente che esprimono proprio tale conflitto tra fattori culturali inconsci e comportamenti manifesti.
APPROFONDIMENTI
Per una clinica interculturale
Bibliografia
Amati Mehler.J e all., (1990) La babele dell’inconscio, Raffaello Cortina editore, Milano
Obeyesekere, G. (1990) The work of culture. Symbolic transformation in psychoanalysis and anthropology. Chicago: Chicago University Press.
Mattingly C., Garro L. (Eds.), Narrative and the Cultural Construction of Illness and Healing. Berkeley: University of California Press.
C. Pain, R. Laniux, & E. Vermetten (Eds.) (2010), The impact of early life trauma on health and disease (pp. 234-241). UK: Cambridge University Press.
B. Drozdek, & J. P. Wilson (Eds.) (2007), Voices of trauma across cultures: Treatment of posttraumatic states in global perspective. (pp. 257-269). New York: Springer.
L. J. Kirmayer, R. Lemelson, & M. Barad (Eds.) (2007), Understanding trauma: Integrating biological, clinical and cultural perspectives (pp. 275-293). Boston: Cambridge University Press.
T. Baubet & M.-R. Moro (Eds.) (2003), Psychiatrie & migrations. Issy-les-Moulineaux Cedex, France: Éditions Masson.
Devereux G,1(967),De l’angoisseà la method dans les sciences du comportament,Champs essais.
Devereux G, (1973), Saggi di Etnopsichiatria generale, Armando Editore, Roma 1978
Dimen M a cura di, (2011),With culture in mind, RelationalPerspectives Book Series, Routledge, New York-London.
Good, Byron, Michael M. J. Fischer, Sarah S. Willen, Mary-Jo Del Vecchio Good, Eds. (2010) A Reader in Medical Anthropology: Theoretical Trajectories, Emergent Realities. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
Hahn, Robert A. and Marcia Inhorn (eds.) (2010) Anthropology and Public Health, Second Edition: Bridging Differences in Culture and Society.Oxford University Press.
Kleinman A. (1990) Rethinking Psychiatry: From Cultural Category to Personal Experience. New York: Free Press.
Kleinman A., Das V., Lock M. (Eds) (1997) Social suffering. University of California Press.
Kleinman A. (1997) Writing at the Margin. Discourse Between Anthropology and Medicine. University of California Press.
Nathan T, (1993), Principi di etnopsicoanalisi, Bollati Boringhieri, Torino, 1996Nathan T, Stengers I, 1995 Medici e stregoni, Bollati Boringhieri, Torino, 1996
Nathan Tobie, (1993), Fier de n’avoir ni pays ni amis, Quelle sottise c’était…. Edition La penséè Sauvage,Grenoble.
Ottobre 2013
Transfert

Rene Magritte_ decalcomania
Transfert: una traccia di lettura
A cura di Antonio Alberto Semi
Il transfert è considerato nel lessico comune un fenomeno di ripetizione nelle relazioni attuali di modalità relazionali derivate dall’esperienza con gli oggetti primari. Perché parlare allora di scoperta del transfert da parte di Freud? Un fenomeno di questo tipo fa parte delle osservazioni e delle conoscenze umane dalla notte dei tempi e non c’è alcun bisogno della psicoanalisi per notare che il Tale ha ‘preso’ da sua madre o da suo padre questo o quel modo di fare oppure che sta ripetendo ma con altre persone alcune modalità esistenziali tipiche degli oggetti primari (stessa incapacità di far affari, stessa tendenza ad isolarsi: ‘in quella famiglia sono tutti degli orsi’, stesso modo di trattare gli altri come è abituato a fare con i suoi…) oppure delle sue relazioni con essi. Il rischio è quello di confondere o fare tutto un mucchio del transfert e delle conseguenze dei processi di identificazione ma e soprattutto quello di banalizzare un fenomeno che, sia dal punto di vista della pratica clinica sia da quello della elaborazione teorica, è particolarmente ostico.
È importante, per cominciare a rivedere il fenomeno nella sua dimensione psicoanalitica, considerare innanzitutto la questione topica. Il transfert, infatti, non solo è un fenomeno inconscio – e lo è a molti livelli e in molti sensi, compreso quello dell’analista – ma è anche un fenomeno che mette in crisi il sistema conscio giacché in determinate situazioni i suoi derivati penetrano e informano questo sistema senza dar luogo all’altro fenomeno (sintomatico, secondo Freud, ma certamente essenziale per il trattamento psicoanalitico) che è quello della consapevolezza. Inoltre, il transfert si caratterizza innanzitutto per le importanti cariche (affettive) che implica, sia in quanto obbliga l’apparato a una continua opera di rimozione e repressione (con il risultato di un impoverimento affettivo conscio dell’individuo preda di questa dinamica nevrotica) sia in quanto, viceversa, conquistando la motilità, controllata dal sistema preconscio e conscio, produce effetti affettivi ‘esplosivi’ oppure angoscia. Secondo alcuni autori (ad es. Le Guen, 2008) il transfert è anzi essenzialmente un fenomeno affettivo, sicché “quando in psicoanalisi si parla di transfert, bisogna intendere il ‘transfert di sentimenti sulla persona del medico’” (Le Guen, p.1341). Più sfumata e articolata la posizione di Laplanche e Pontalis (1967) nella voce “Transfert” della loro Enciclopedia della psicanalisi.
È opportuno considerare il transfert non solo dal punto di vista delle sue principali manifestazioni cliniche ma anche da quello delle implicazioni che esso ha per il funzionamento dell’apparato. In quest’ultima ottica conviene innanzitutto considerare il rapporto tra rappresentazioni e affetti, visto che la ricomparsa di questi ultimi nella relazione analitica implica da un lato uno spostamento di cariche affettive da un insieme di rappresentazioni di oggetti con e su i quali primariamente quelle cariche affettive sono state investite e dall’altro un effetto di ‘eclissi’ di queste rappresentazioni primarie. È quest’ultimo un effetto dovuto solo alla rimozione o anche all’isolamento della rappresentazione dall’affetto? È necessario poter ricondurre – in analisi – i sentimenti alle rappresentazioni primarie e alle rappresentazioni delle relazioni con gli oggetti primari, riportando l’ hic et nunc all’ alibi et tunc anche se la battaglia si svolge in presentia (Freud, 1912)? E allora bisogna pur porsi il problema delle caratteristiche di queste rappresentazioni primarie, che possono essere e in genere sono molto differenti da quelle presenti nel sistema conscio e relative agli stessi oggetti. Così come sono in genere molto differenti gli affetti che si manifestano nel sistema conscio (e che possono essere fatti osservare al paziente) dagli affetti inconsci o preconsci. È noto del resto che un transfert positivo apparente può celare un transfert negativo inconscio e, viceversa, che sentimenti (transferali) negativi nei riguardi dell’analista possono servire a reprimere movimenti affettuosi teneri, avvertiti dall’Io del paziente come intollerabili (ad esempio anche da un punto di vista narcisistico).
Come si vede, una situazione non semplice sia dal punto di vista clinico sia da quello teorico, che per giunta va considerata anche in relazione alla applicabilità o meno del metodo psicoanalitico. I fenomeni di transfert sono spesso causa di resistenza al metodo analitico, bloccano il processo associativo polarizzandolo su certi temi o escludendone altri. L’interpretazione del transfert dovrebbe servire allora anche a ripristinare le condizioni di applicabilità del metodo. Se quest’ultimo si costituisce – nell’analista in primo luogo – come terzo rispetto a paziente e analista, le deviazioni dal metodo assumono rilevanza più semplicemente che nel caso in cui, viceversa, l’attenzione del terapeuta sia attirata dal contenuto del discorso (magari non più associativo) del paziente. In ogni caso, dal punto di vista del metodo le manifestazioni del transfert sono da (ri)collocare, nel corso del processo analitico, all’interno di catene associative che consentono di ricostruire il lavoro psichico effettuato dall’apparato a partire dalle rappresentazioni primarie, lavoro che si è svolto con le regole del processo primario e solo in un secondo momento con quelle del processo secondario e che ha portato alla elaborazione di formazioni (affettive e ideative) di compromesso assai lontane e differenti da quelle elaborate nei confronti degli oggetti primari.
Da un punto di vista tecnico, il problema è quello di cercare di favorire lo sviluppo di una nevrosi di transfert (Freud, 1914) la cui analisi – con il metodo delle libere associazioni – può consentire la risoluzione (sempre problematica) dei conflitti nevrotici patogeni.
Tutto quanto scritto finora descrive alcuni elementi di base del problema del transfert nell’ottica freudiana. Tuttavia nel corso della elaborazione di teorie differenti e/o alternative, sia il peso del transfert nella relazione analitica sia la sua interpretazione hanno assunto caratteristiche differenti. Nell’ottica kleiniana, ad esempio, il transfert assume un rilievo dominante e la sua interpretazione può avvenire molto precocemente, soprattutto ma non solo se esso assume caratteristiche negative (Klein, 1955; Rosenfeld, 1955). Anche nell’ottica lacaniana il transfert assume una connotazione diversa, ponendo in primo piano l’assunzione del desiderio dell’Altro (supposto sapere) come condizione necessaria per l’analista e del desiderio del desiderio dell’Altro nell’analizzante, tendendo a riportare dal registro immaginario a quello simbolico la vicenda – trasformata, deformata, forclusa – originaria (Silvestre, 1986).
Soprattutto, però, le cose si sono complicate (spesso utilmente) con l’accentuazione dell’importanza del controtransfert (a partire dalle discussioni londinesi del secondo dopoguerra – v. Semi 2012 – fino a Pontalis,1975) e con il riconoscimento del transfert dell’analista (Donnet, 1995, 2005, Gribinski e Ludin, 2005). Se il transfert in se stesso è un rivelatore della dinamicità dell’attività psichica e se la funzione del trasferire rimane attiva anche sciolti i legami conflittuali che la costringevano, come illudersi che l’analista non elabori transfert nei riguardi del paziente? E come assumere dunque che il transfert del paziente nell’analista non solo provochi un controtransfert ma si intrecci anche con il transfert dell’analista?
Questi interrogativi e la conseguente progressiva complessità teorica (Neyraut, 1974) necessaria per cercare di dar loro risposta rispecchiano (trasferiscono sulla teoria) la difficoltà, la intollerabilità ma anche la ricchezza della unicità apparente dell’essere umano, che sa di essere uno ma si scopre essere molti (è l’interrogativo di Edipo, che apre alla colpa ma anche alla responsabilità) e deve continuamente ristrutturarsi nel tentativo (sanamente) narcisistico di ricomporre una transitoria unità. Il transfert è, da questo punto di vista, ciò che in noi mostra continuamente la necessità dell’oggetto e la sua inafferrabilità frustrante e potenzialmente creativa.
Bibliografia
Donnet J.-L. (1995) Le divan bien tempéré. P.U.F., Paris.
Donnet J.-L. (2005) La situation analysante. P.U.F., Paris.
Freud S. (1912) Dinamica della traslazione. O.S.F., VI, 523-531.
Freud S. (1914) Ricordare, ripetere, rielaborare. O.S.F., VII, 353-361.
Gribinski M. e Ludin J. (2005) Dialogo sulla natura del transfert. Borla, Roma, 2006.
Klein M. (1955) La tecnica psicoanalitica del gioco: sua storia e suo significato. In: M. Klein et al.. Nuove vie della psicoanalisi. Il Saggiatore, Milano, 1966.
Laplanche J. e Pontalis J.-B. (1967) Enciclopedia della psicanalisi. Laterza, Bari, 1968.
Le Guen Cl. (2008) Dizionario freudiano. Borla, Roma, 2013.
Neyraut M. (1974) Le transfert. P.U.F., Paris.
Pontalis J.-B. (1977) Tra il sogno e il dolore. Borla, Roma, 1988.
Rosenfeld H. (1955) Note sulla psicoanalisi del conflitto con super-Io in un paziente schizofrenico acuto. In: M. Klein et al.. Nuove vie della psicoanalisi. Il Saggiatore, Milano, 1966.
Semi A. A. (2012) Metodo psicoanalitico e controtransfert. Riv. Psicoanal., LVIII, 2, 313-333.
Silvestre M. (1984) Il transfert nella direzione della cura. In: Lacan J. et al. (1986) Il mito individuale del nevrotico. Astrolabio, Roma.
APPROFONDIMENTI
Novembre 2014
Transfert Evolutivo

Francesco De Grandi, 2015
Transfert Evolutivo
in Psicoanalisi
(dimensione evolutiva del transfert, dimensione creativa del transfert, transfert di oggetto-sé).
A cura di Claudio Arnetoli
Il concetto di transfert evolutivo deve essere considerato come una ridefinizione estensiva del concetto di transfert di oggetto-sé, elaborato da Heinz Kohut in relazione ai bisogni narcisistici del Sé, che lo aveva condotto a formulare tre diverse forme di transfert di oggetto-sé: speculare, idealizzante e gemellare (1971,1977,1984).
Kohut considerava la scoperta del transfert di oggetto-sé come il suo contributo fondamentale all’ampliamento della teoria psicoanalitica: il transfert di oggetto-sé nella sua visione non ha una dimensione ripetitiva di spostamento di un oggetto su di un altro, ma una dimensione creativa attraverso la quale il paziente cerca il rapporto con un nuovo oggetto, il quale gli permetta di vivere le esperienze maturative mai vissute o frustrate all’interno delle relazioni disfunzionali con gli oggetti primari. Il concetto di transfert evolutivo consente quindi di chiarire teoricamente tutta l’area di riattivazione nel transfert analitico dei bisogni maturativi frustrati o mai validati (vedi Kohut, 1984, pag. 139).
Il lavoro di Kohut riassume, completa ed esplicita sia la primitiva intuizione di Freud di un transfert positivo irreprensibile (Freud, 1912), sia il successivo lavoro di autori quali Ferenczi, Winnicott, Balint, Bowlby, Bion i quali hanno tutti in vario modo sottolineato il valore evolutivo della relazione analitica dovuto al rapporto con un nuovo oggetto che permette di fare esperienze mutative variamente concettualizzate (holding, esperienze oggettuali di amore primario, relazione oggettuale mutativa, reverie ecc.) (vedi Moccia, 2007, 2017).
Il transfert evolutivo riguarda la mobilizzazione nel transfert analitico di tutte le aspettative inconsce di sviluppo e riparazione del Sé, una dimensione che deve essere vista in una relazione di figura/sfondo con il transfert di ripetizione (Stolorow, Lachmann, 1984). Attraverso il transfert ripetitivo si esprimono invece, sia gli schemi nevrotici e disfunzionali che tendono ad organizzare l’esperienza del paziente nella relazione analitica; sia la ricerca di soddisfacimento anti-simbolico di fantasie regressive e difensive, nell’area del narcisismo arcaico e in quella dei desideri pulsionali.
In analisi le due dimensioni del transfert ripetitiva ed evolutiva – tendono a manifestarsi in un’alternanza che richiede accoglienza e trattamenti diversi da parte dell’analista. Infatti il transfert creativo palesa nell’agieren, nei sogni, nei lapsus, nelle narrazioni e nelle libere associazioni i bisogni evolutivi inconsci, dissociati, rimossi o mai validati, con il loro patrimonio di affetti e di ambivalenza sempre presente. Esso tende a delinearsi sullo sfondo formato dai modelli interni ripetitivi, con la loro quota di coazione a ripetere. La coazione a ripetere si avvicenda con la possibilità di far emergere e di abbandonarsi alle spinte evolutive e alla relazione con il nuovo oggetto. Questa alternanza è dovuta a cause molteplici intrinseche sia alla organizzazione psichica del paziente, sia alla relazione intersoggettiva che si dispiega in analisi. Essa è quindi anche molto dipendente dal campo analitico e dal terzo intersoggettivo creato dalla intersezione dei mondi soggettivamente organizzati del paziente e dell’analista (Stolorow, Atwood, 1992). L’analista è implicato in questo processo sia per quanto riguarda la sua formazione teorica che la sua capacità personale di comprendere, accogliere, validare e interpretare le spinte evolutive del paziente permettendone l’attuazione maturativa in analisi.
Attraverso il transfert evolutivo, la molteplicità dei bisogni del Sé, narcisistici e oggettuali – di essere compreso e di comprendere, di essere rispecchiato, validato e aiutato a regolare ed elaborare il proprio mondo affettivo; di sentirsi attivo nel mondo, di sviluppare una forma di attaccamento sicuro con una corrispondente fiducia di base, di attraversare con successo lo sviluppo psicosessuale e la fase edipica – possono emergere in analisi. Essi possono trovare una risposta e una possibilità attuativa in un percorso che non è solo ripetitivo del passato, ma di costruzione di un’esperienza nuova e sconosciuta al paziente (Arnetoli, 2016). Il dispiegarsi della dimensione evolutiva del transfert viene resa possibile dalla capacità di comprensione empatica dell’analista, e dalla sua possibilità di creare insieme al paziente un campo intersoggettivo attraversato e attivato da circuiti affettivi di feedback nei quali l’analista possa e sappia inserirsi creativamente.
Il concetto di dimensione evolutiva del transfert si è andato sviluppando attraverso le varie scuole di relazione oggettuali e le correnti relazionali della psicoanalisi contemporanea, che hanno ampliato la visione dello sviluppo psichico, del ruolo delle emozioni e della comprensione emotiva, e quindi anche dei compiti dell’analista in analisi. Si sono precisate meglio le funzioni delle figure di accudimento e la parte giocata dalla matrice relazionale nella formazione del mondo psichico. Ciò ha permesso di integrare la classica posizione analitica con i suoi ineliminabili ingredienti conoscitivi volti a smontare gli aspetti ripetitivi del transfert (interpretazione), con i lati affettivi e poietici collegati al rapporto intersoggettivo tra analista e paziente (Arnetoli, 2017). Il cambiamento nell’area della conoscenza relazionale implicita con il conseguente sviluppo di nuovi schemi evolutivi, richiede qualcosa in più dell’interpretazione (Stern e coll., 1998) e risposte poietiche dell’analista attinenti alla relazione (Arnetoli, 2016). Tutto ciò può necessitare di una modulazione della posizione analitica di neutralità, astinenza e frustrazione, con un ampliamento personalizzato della responsività dell’analista (responsività ottimale, Bacal, 1985).
La relazione analitica ha da un lato il compito di smontare il transfert ripetitivo e, dall’altro, quello di montare il transfert evolutivo, dove sia in ogni caso chiaro che la dimensione creativa del transfert non coincide con il transfert positivo classicamente inteso. Il transfert evolutivo infatti si dipana attraverso inevitabili disruption dovute sia ai fallimenti empatici dell’analista che alle difese narcisistiche arcaiche del paziente, il quale può avere la pretesa di una fusione simbiotica e di una sintonizzazione assoluta con l’oggetto. Un ingrediente fondamentale della maturazione del Sé consiste proprio nella capacità della coppia analitica di ricucire cognitivamente e affettivamente i momenti di impasse, vivendo e comprendendo gli enactment e lo scivolamento in periodi di transfert negativo, con la possibilità di arrivare a concepire da parte del paziente l’alterità dell’oggetto, e di passare dal rapporto con un oggetto soggettivo alla accettazione della soggettività dell’oggetto.
Il concetto di transfert evolutivo ha comportato una ridefinizione anche di quello di regressione in analisi. Per Kohut infatti l’analisi non è tanto il luogo di una necessaria regressione a modelli arcaici di organizzazione mentale, ma una situazione esperienziale nella quale i bisogni arcaici fondanti lo sviluppo del Sé possano manifestarsi nella forma e al livello evolutivo necessari al paziente.
In sintesi appare necessaria l’attenzione dell’analista alle due dimensioni del transfert e la sua capacità di oscillare tra le due diverse configurazioni relazionali ed esperienziali che esse propongono. La stabilità e la ripetitività del setting analitico e le funzioni empatica e interpretativa giocano un ruolo sia nel proporre lo smontaggio del transfert ripetitivo che nella progressiva emersione e articolazione della dimensione evolutiva del transfert. Nella dimensione creativa diviene centrale, come evidenziato da Marilia Aisenstein (2015; cit. in La Scala, 2018), il transfert sul linguaggio, il quale permette di legare e articolare il pensiero primario, fondando le capacità evolutive e autobiografiche del Sé.
Questa è una funzione specifica della dimensione creativa del transfert e la possiamo descrivere come la possibilità di passare dalle rappresentazioni in parallelo degli stati ideo-affettivi (Bucci, 1997), proprie del conosciuto non pensato (Bollas, 1987), a rappresentazioni iconiche, e poi verbali nelle quali affetto e rappresentazione siano pienamente uniti, in un processo che chiamiamo di ‘simbolizzazione’, nel senso pieno con cui questo concetto è utilizzato in psicoanalisi.
Bibliografia
Aisenstein M. (2015). Pulsione, rappresentazione e richiesta di rappresentazione. In, a cura di, Levine H.B., Reed G.S., Scarfone D. Stati non rappresentati e costruzione del significato. Milano, Franco Angeli, 2015
Arnetoli C. (2016) Azione poietica e dimensione evolutiva del transfert. Riv. Psicoanal. 62, 3, 595-618.
Arnetoli C. (2017). Transfert evolutivo, sentimento d’amore e funzione di ‘loving’ in analisi. Relazione presentata al Convegno sulle Due dimensioni del Transfert: Dimensione evolutiva e dimensione ripetitiva, organizzato dal Centro Torinese di Psicoanalisi e dal Centro di Psicoanalisi Romano, Torino, 2017.
Bacal H. (1985). Optimal responsiveness and the therapeutic process. Progress Self Psychol., I, 202-227.
Bollas C. (1987). L’ombra dell’oggetto. Psicoanalisi del conosciuto non pensato. Roma, Borla, 1989.
Bucci W. (1997). Psicoanalisi e scienza cognitiva. Roma, Giovanni Fioriti Editore, 1999.
Freud S. (1912). Dinamica della traslazione. OSF vol. VI. Torino, Bollati Boringhieri.
Kohut H. (1971). Narcisismo e analisi del Sé. Torino, Bollati Boringhieri, 1976.
Kohut H. (1977). La guarigione del Sé. Torino, Bollati Boringhieri, 1982.
Kohut H. (1984). La Cura Psicoanalitica. Torino, Bollati Boringhieri, 1986.
La Scala M. (2018). La consultazione psicoanalitica istituzionale: trovare, ri-trovare, trasformare. Il metodo alla prova. Riv Psicoanal 64,1
Moccia G. (2007). Le memorie identificatorie nell’organizzazione del transfert. In Nicolò A. (A cura). Attualità del transfert. Milano, Franco Angeli.
Moccia G, (2017). Forme del transfert: Assetto analitico e Campo intersoggettivo. Relazione presentata al Convegno sulle Due dimensioni del Transfert: Dimensione evolutiva e dimensione ripetitiva, organizzato dal Centro Torinese di Psicoanalisi e dal Centro di Psicoanalisi Romano, Torino, 2017.
Stern D. N, Sander L, Nahum J, Harrison A, Lyons-Ruth K, Morgan A, Bruschweiler- Stern N, Tronick E (1998). Non-interpretive mechanisms in psychoanalytic therapy: The “something more” than interpretation. Int, J. Psycho-anal., 79, 903-921.
Stolorow R.D., Atwood G.E. (1992). I contesti dell’essere. Torino, Bollati Boringhieri, 1995.
Stolorow R., Lachmann F. (1984). Transference: The future of an illusion. Annual. Psychoanal., 12: 19-37.
Trauma migratorio

Aida Muluneh, The Morning Bride, 2016
A cura di Virginia De Micco
In che termini possiamo fondatamente parlare di un ‘trauma’ migratorio, il quale si configura essenzialmente come un trauma ‘identitario’, uscendo dalla generica percezione di una accentuata vulnerabilità psichica che accompagna l’esperienza migratoria?
Innanzi tutto varrà la pena di seguire un breve excursus storico che ripercorra alcune delle tappe significative che hanno costituito il nesso tra esperienza migratoria e sofferenza psichica. Riflessione che risulta tanto più significativa, e per certi versi indispensabile se si vuole costruire una posizione critica sull’argomento, in quanto si vedrà come storicamente si ripropongono alcune modalità paradigmatiche di impostare , o occultare, la questione di tale rapporto fondativo e delle poste in gioco che vi sono connesse.
Il modello della nostalgia-malattia
Prendiamo come punto di inizio la famosa Dissertatio medica in cui un giovane studente di medicina, Johannes Hofer, nel 1699 conia il termine ‘Nostalgia’ . Non che non esistessero già in epoche precedenti descrizioni e testimonianze soprattutto letterarie e poetiche di vissuti nostalgici legati alla lontananza dalla propria terra natia, sebbene il termine non esistesse ancora, ma quello che ci interessa cogliere è il momento in cui questa generica percezione si traduce invece in una concettualizzazione medica, in una ‘entità’ clinica: diventando così oggetto di un sapere che intende ‘fissarne’ i tratti e le caratteristiche ma soprattutto ripercorrerne le cause. Questione non da poco visto che la posta in gioco è rappresentata niente di meno che dalla stessa costituzione soggettiva dell’umano nel suo ‘legame’ alla sua Heim. , alla sua casa-patria, a ciò che gli è heimlisch, familiare , o, al contrario, a ciò che può essergli o diventare unheimlisch, non familiare o, meglio, in termini più strettamente analitici perturbante.
Il termine ‘nostalgia’ innanzi tutto traduceva nel linguaggio dotto della medicina quella esperienza della ‘Heimweh’, quel ‘dolore della casa’, della patria, di cui nelle valli svizzere si sapeva che si poteva morire. Come si ricorderà si trattava infatti di un grave stato di cachessia psicofisica che in maniera repentina e inspiegabile si impossessava in particolare dei giovani soldati di ventura svizzeri che servivano presso le varie corti europee fino a portarli a morte. Uomini nel pieno vigore fisico, che anzi proprio per il loro vigore fisico venivano scelti per esercitare la ‘professione’ di soldati di ventura, che invece in maniera incomprensibile per la medicina dell’epoca improvvisamente ‘cedevano’ proprio in quello che era il nucleo del loro essere: la forza fisica. Si intuiva che dovesse esserci qualcosa ‘nell’ambiente’ che improvvisamente veniva loro a mancare e si cercava di ripristinarlo attraverso una elementare logica restituiva: così si cercava di issarli con delle carrucole ad una certa altezza per fargli respirare un’aria più fina, più simile a quella delle valli natie: effetto quasi grottesco che in una apparente logica pseudoscientifica cancella il portato emotivo-affettivo-sensoriale della ‘Heim’ per ridurla ad una semplice questione ‘ambientale’. Non sarà forse un caso che nel passaggio dal sapere popolare ( Heimweh) a quello dotto (Nostalgia) è proprio il riferimento alla Heim che scompare. L’osservazione empirica costringe però anche l’occhio dello scienziato dell’epoca – ed è questo il nucleo della Dissertatio- a constatare come il ‘ritorno’ al paese natio, concesso a questi uomini in fin di vita per farli morire vicino alle loro famiglie, avesse invece il potere, quasi miracoloso, di farli completamente riprendere e ristabilire: così come inspiegabilmente si erano ammalati , e sarebbero giunti a morte certa, altrettanto inspiegabilmente guarivano. Fin dal suo apparire sulla scena medica dunque la nostalgia si presenta come una ben strana malattia che pur manifestando i suoi effetti, i suoi pesanti e irreversibili effetti, nel corpo degli individui, dunque sul piano bio-logico, può poi essere risolta efficacemente solo se si tiene conto di ciò che fa di quel corpo, di quel sostrato bio-logico, un ‘umano’ , ovverosia se si tiene conto del suo portato antropo-logico. Ancora oggi del resto, resta come tratto caratteristico delle popolazioni migranti l’espressione di insolute dinamiche di adattamento -e di quel ‘disagio nascosto’ così tipico dell’emigrazione- attraverso disturbi somatici tanto vaghi e difficilmente descrivibili quanto persistenti e addirittura invalidanti. Disturbi etichettati genericamente e semplicisticamente come ‘somatizzazioni’ ma che in realtà traducono un’esperienza molto più complessa e delicata di perdita di ‘solidarietà’ , per così dire, tra mondo interno e mondo esterno, tra quel corpo che è la mia patria e quella patria che è il mio corpo, che nella situazione migratoria sembrano parlare ormai linguaggi differenti, non mutuamente traducibili.
Il modello della nostalgia-malattia come griglia per pensare il disagio migratorio è stato successivamente pesantemente criticato da studiosi di formazione sociologica e storica (cfr. Delia Frigessi, 1982, 1993) che hanno evidenziato come si sia tentato attraverso la lente biomedica una operazione riduzionistica in cui veniva cancellata la costrizione socioeconomica come fattore decisivo rispetto alla ‘scelta’ migratoria e al conseguente malessere individuale e collettivo, riguardante a diversi livelli le comunità coinvolte, che ne conseguiva. Ma la connotazione ‘medica’ della nozione di nostalgia è in realtà più complessa e ricca di implicazioni dal momento che invece, a ben vedere, evidenzia al contrario come l’impalcatura organica non regga alla mancanza dei quell’intelaiatura simbolico-affettiva costituita dalla propria Heim (lingua-ambiente): una delle caratteristiche riportate nella Dissertatio era infatti che un violento ‘attacco nostalgico’ potesse essere scatenato dall’ascoltare suoni e canti appartenenti alla terra natia.
Ma il potenziale critico della nozione di nostalgia rispetto al nascente paradigma biomedico ( ci troviamo infatti ancora in un’epoca di medicina prescientifica , in cui cioè si sta giocando un partita capitale rispetto alla “nascita della clinica” come ci insegna Foucault) viene rapidamente disinnescato, tant’è vero che la nostalgia nell’arco di circa 150 anni uscirà rapidamente dai trattati medici ( assieme al mal d’amore) per andare a indicare quello struggente sentimento che pervade chi è lontano dal proprio mondo e dagli oggetti amati. (Cfr. voce Nostalgia-Spipedia ), mentre la figura paradigmatica del disturbo psichico connesso alla migrazione sarà rappresentato dalla figura de
L’alienèe migrateur
A metà circa dell’ ‘800 Achille Foville figlio, ‘alienista’ che presta servizio nella città di Le Havre, grande porto affacciato sull’Atlantico da cui partono masse di diseredati dall’Europa verso le Americhe, conia questa etichetta nosografica che intende, in un certo senso, dare ‘ordine’ e pensabilità rispetto ad un coacervo di osservazioni ed esperienze ‘disordinate’ , in cui appunto disordine sociale e disordine psichico appaiono sommarsi e confondersi.
Foville osserva le manifestazioni più disparate negli ‘alienati migratori’, dalle reazioni depressive a quelle ipomaniacali , dalla ‘follia ragionante’ ( paranoica) a quella più francamente delirante (paranoide), il cui unico comune denominatore sembra rappresentato da una ‘incoercibile’ necessità di partire, di migrare, di abbandonare le proprie terre. Ecco che già il nesso causale della sofferenza psichica connessa alla migrazione comincia a invertirsi completamente: non è la lontananza che fa ammalare (come nella nostalgia descritta da Hofer) ma, al contrario, è la malattia, la follia già costituzionalmente preesistente, che fa allontanare, che spinge a migrare. Dunque nella folla indistinta dei migranti che si accalcano per partire non bisognerà faticare particolarmente a trovare motivazioni che giustifichino profondi disagi psichici connessi con la dolorosa esperienza del migrare ma, al contrario, quelli che manifesteranno comportamenti bizzarri saranno semplicemente già alienati e la loro migrazione né più né meno che un ‘sintomo’ del loro stesso disturbo psichico. Anzi si andrà oltre nella costruzione di questa griglia di ‘coerenza’ etiopatogenetica della ‘alienazione psichica migratoria’, andando a rintracciare nella labilità del legame ai propri affetti e alle proprie origini le cause prime della successiva partenza: il migrante è dunque ‘costituzionalmente’ a rischio di una crisi psicopatologica proprio in quanto ‘migrante’, che diventa quasi una ‘stigmata’ psicopatologica.
Si prefigura dunque uno sfondo non esplicito ma esplicitabile all’occasione secondo cui in fondo tutti i migranti sono costituzionalmente più vulnerabili dal punto di vista psichico: è solo a questa condizione che si allontanano dalle loro famiglie, per cui non c’è da meravigliarsi troppo se poi, in seguito, si ammaleranno psichicamente: non si tratta di qualcosa di imputabile al contesto di accoglienza né tantomeno all’esperienza del migrare in sé, di cui viene totalmente espunta la ‘portata’ traumatica appunto, ma quasi di una ‘logica’ conseguenza della premessa della vulnerabilità costituzionale, integralmente giustificata in fondo dalla costruzione del migrare come un ‘sintomo’ e non come una dolorosa necessità a cui non ci si può sottrarre. Non sarà superfluo evidenziare come i cardini di questa impostazione di pensiero riemergano sotto mentite spoglie anche nelle odierne letture e reazioni agli imponenti flussi migratori verso l’Europa questa volta, e non dall’Europa.
Lo shock culturale
La psicopatologia dell’emigrazione continua ad accumulare osservazioni e dati in corrispondenza di altre consistenti ondate migratorie tra fine ottocento e inizio novecento, coniando gustose etichette nosografiche in cui confluiscono stigmatizzazioni etniche e attitudini pregiudiziali travestite da conoscenza scientifica: tanto per citarne qualcuna la “mania errabunda” degli scandinavi e la “follia masturbatoria” degli ebrei.
Ma è solo alle soglie degli anni ’60 del secolo scorso che comincia a farsi strada la teoria dello shock culturale : ovverosia si comincia a riconoscere il peso specifico di un improvviso e massiccio cambiamento del contesto culturale nello scatenamento di gravi ‘reazioni’ psicopatologiche.
Varrà la pena di ricordare ad esempio come il dibattito dell’epoca sulla possibilità o meno di individuare forme psicotiche integralmente ‘psicogene’ ruotasse spesso attorno a soggetti sradicati: la partita teorica ed epistemologica in gioco era cruciale dal momento che si trattava addirittura di stabilire se un’esperienza individuale ( un life-event) potesse rendere psicotico un soggetto che non lo era o non lo sarebbe diventato senza quella specifica esperienza psichica. Come si vede si tratta in realtà di una problematica molto complessa a cui non si possono dare risposte troppo semplicistiche o generiche. In questo acceso dibattito alternativamente si riproporranno le due posizioni paradigmatiche che abbiamo individuato in precedenza propendendo, di volta in volta, o per sovrastimare l’effetto del brusco cambiamento del contesto socio antropologico, con la perdita di ‘familiarità’ delle attitudini relazionali e delle modalità di espressione delle emozioni soprattutto, oppure per riscoprire il filo storico individuale e dunque le componenti strettamente personali , ivi comprese le determinanti inconsce, nel provocare una specifica reazione psicopatologica all’esperienza migratoria. In quest’ottica essa perderebbe la sua specificità, e mi riferisco alla sua specificità ‘traumatica’, per diventare né più né meno che uno dei molteplici esempi di grave evento ‘stressante’, le cui conseguenze dipenderebbero dunque essenzialmente dalle capacità di elaborazione individuale, riproponendo dunque di fatto il piano della ‘vulnerabilità’ individuale.
L’obiezione più semplice e immediata in sede clinica alle teorie dello shock culturale era infatti rappresentata dall’osservazione che solo una quota ridotta della popolazione migrante manifestava patologie psichiatriche, ergo ciò doveva dipendere da una ‘costituzionale’ fragilità psichica piuttosto che dalla rilevanza e dalla specificità dell’esperienza migratoria.
Ancora una volta sarà necessario allargare la visuale alla complessità di una dimensione antropologica, piuttosto che alla sola dimensione psico(pato)logica, per reimpostare la questione: il disagio psichico connesso alla migrazione è così diffuso e pervasivo -dal momento che coinvolge la stessa matrice psicoantropologica della quotidianità su cui dopo torneremo- da cristallizzarsi raramente in patologie psichiatriche conclamate. Quello stesso disagio potrà prendere forme ‘irriconoscibili’, nel senso che spesso il migrante non saprà più come esprimerlo e lo psichiatra occidentale non saprà come intenderlo, non potendo contare su modalità culturalmente condivise per manifestarlo. Basterà ricordare a tale proposito la prevalenza sempre riscontrata di patologie psicosomatiche: da manifestazioni gravi e potenzialmente mortali ( per un certo periodo una delle cause più frequenti di morte nei migranti meridionali verso la Germania è stata rappresentata dall’ulcera gastrica perforata) a patologie meno gravi ma facilmente cronicizzanti e potenzialmente invalidanti. Osservazione questa ancora riconfermata recentemente da Frighi e coll. (1988) che erano giunti a proporre una ‘psichiatria di liaison’, che affiancasse le altre branche mediche di base, come unica valida forma di assistenza psichiatrica per le popolazioni migranti.
Ma ancora, come già segnalava Gianfausto Rosoli negli anni ’70, non è semplice stabilire il costo psicologico della migrazione, forse non basta una generazione, bisogna attrezzarsi a valutarne gli effetti di lungo periodo, forse su due o tre generazioni per comprenderne davvero la profondità e la pervasività. Bisogna attrezzarsi a rilevarne gli effetti nascosti: quelli più insidiosi e costanti. Con le sorprendenti, e in un certo senso profetiche, parole di Michele Risso (1982) il compito di una psicopatologia della migrazione autenticamente capace di ricostruire le molteplici declinazioni del ‘trauma migratorio’ dovrebbe piuttosto capire cosa “avviene nella mente di chi emigra e non si ammala”, quali ferite psichiche nasconde, quali cicatrici relazionali lascia, quali fratture trans generazionali comporta quella apparente ‘integrazione’, che spesso costituisce solo una vernice superficiale nelle migrazioni cosiddette riuscite.
Ancora Risso giunge a descrivere lo stesso processo di ‘assimilazione’ , o di ‘integrazione’ con una dizione più moderna, come un “microtraumatismo quotidiano”, e su questo aspetto specifico di un ‘quotidiano’ che assume una qualità intrinsecamente traumatica dopo ritorneremo.
Il contributo italiano: la casistica psichiatrica e i legami spezzati
Varrà giusto la pena di osservare come fino a quest’epoca la storia, i metodi e i campi di interesse della psicopatologia delle migrazioni, pur nelle sue versioni più avvedute e attente anche alle variabili culturali, non abbia praticamente nulla a che fare con le metodologie e con l’ottica etnopsichiatrica. Non è questa la sede per approfondire criticamente i rapporti tra questi due indirizzi disciplinari ma vale la pena di ricordare che, come abbiamo visto, la psicopatologia delle migrazioni ha una lunga autonoma storia, in cui vengono elaborati schemi concettuali e modelli di interpretazione, da un lato, e vengono accumulate osservazioni cliniche dall’altro. Molto a lungo tali osservazioni, come abbiamo esposto, hanno risentito di attitudini pregiudiziali e di una sostanziale incapacità di andare oltre la categorizzazione nosografica ma è proprio nel secondo dopoguerra che ,invece, si fa strada una attitudine innanzi tutto molto più attenta alla casistica psichiatrica, piuttosto che a una statistica sempre molto fallace in questo campo ( Cfr. a tale proposito il lucidissimo “Le statistiche di Sisifo” in Frigessi e Risso, 1982). In questa rinnovata capacità di ricostruzione di quei tragitti antropologici sommersi che possono condurre da accelerati fenomeni di trasformazione sociale e culturale a vere e proprie derive psicopatologiche, un ruolo di assoluto rilievo hanno gli studi di alcuni psichiatri italiani ( Risso, Mellina, Frighi e altri) che tra i primi si confrontano con lo spaventoso costo psichico di questa nuova stagione storica della migrazione italiana, ivi compresa la massiccia migrazione interna , il cui bilancio in sede critica e storica sul piano delle conseguenze psicoantropologiche per intere aree del nostro paese è ancora tutto da scrivere.
Questo costo in termini psichici, a livello individuale-familiare, e in termini antropologici, per le conseguenze sulle comunità coinvolte, in particolare quelle di partenza, era rimasto spesso occulto. Gli studi sulle conseguenze psichiche delle migrazioni, sempre condotti nei paese di accoglienza, restavano inevitabilmente parziali e ciechi su una serie di aspetti, mentre forse per la prima volta in questo campo sono gli studiosi dei paesi di partenza che si ritrovano a ‘vedere’ tutto quello che era restato occultato In particolare gli studiosi italiani di fronte alle migrazioni interne, che hanno letteralmente ‘sovvertito’ il tessuto socioantropologico italiano, si ritrovano in una posizione eccezionale nel poter osservare in un ambiente relativamente ristretto dal punto di vista ‘geografico’ tutto l’arco complesso delle conseguenze psichiche delle migrazioni, le quali comportano non solo conseguenze su chi parte, ma anche su chi resta ( basterà ricordare le cosiddette ‘vedove bianche’ nel meridione d’Italia) e su chi accoglie, e poi ancora su chi ritorna. Tali conseguenze come abbiamo visto non è detto siano immediate, possono far sentire i loro effetti a lungo termine sulle seconde generazioni, non solo su quelle nate all’estero e lì rimaste, ma anche sui ragazzi nati all’estero e poi magari rientrati al seguito delle famiglie o ancora sui bambini rimasti in patria mentre i genitori erano lontani. Fenomeni che per decenni hanno riguardato intere aree del nostro paese, sebbene sempre in maniera piuttosto ‘sotterranea’ e che ora si ripropongono puntualmente nelle nuove migrazioni. E’ a questo che ci si riferisce quando si parla dei legami affettivo-simbolici spezzati dalle migrazioni , in cui consiste in gran parte la portata traumatica dell’esperienza migratoria: si tratta appunto non solo dei legami affettivi ma anche delle posizioni simboliche coinvolte, in particolare la funziona paterna risulta particolarmente depotenziata, in quanto si dimostra inefficace nel fungere da garante dell’ordine simbolico originario che risulta inevitabilmente minoritario e perdente rispetto a quello adottivo.
Per la sua stessa dinamica socioantropologica la migrazione attiva dei veri e propri cambiamenti catastrofici nelle comunità di partenza, mettendone quasi suo malgrado in discussione, fino addirittura a disarticolarla, la struttura simbolica profonda: i sistemi di valori, i sistemi di parentela etc. Anche i tentativi di irrigidimento misoneista di tali sistemi di valori , comprese le più recenti dinamiche di ricostruzioni ‘integraliste’ dei valori religiosi tradizionali, in realtà non costituiscono altro che una reazione a tale disarticolazione profonda, con effetti ancora più disfunzionali e patogeni sui soggetti e le comunità coinvolte com’è evidente. Insomma la stessa dinamica migratoria attiva le fonti traumatogene di cui resta vittima: la tematica del ‘tradimento’ delle proprie origini, fino a giungere ad elaborazioni francamente persecutorie, rappresentano una fonte costante di ‘traumatismo’ psichico per i migranti, stretti in questo senso tra angosce depressive e angosce persecutorie.
Questa serie di osservazioni cliniche, condotte con una profonda sensibilità antropologica, intesa come capacità di contestualizzare costantemente l’individuo nel suo ambiente relazionale affettivo e simbolico, sono assolutamente preziose e consentono di ‘temperare’ l’indubbio peso del brusco cambiamento culturale con l’inesausto lavoro di lutto che anche la migrazione più riuscita richiede .
Con la celebre immagine di Frigessi e Risso il migrante si ritrova sempre “a mezza parete”, come l’alpinista che resta a mezzo lungo la parete di roccia, ormai molto distante dal suo punto di partenza ma ancora non in vista di quello di arrivo, sempre in mezzo al guado sebbene apparentemente ‘approdato’ in un luogo sicuro.
E’ questa la condizione psichica in cui il migrante resta costantemente ‘sospeso’ anche per anni o per una vita intera, che ne logora giorno dopo giorno la struttura psichica e ne fragilizza la tenuta identitaria, costituendo quella condizione di traumatismo diffuso, tanto pervasivo quanto difficilmente rappresentabile, che resta costantemente attivo come sotterranea erosione del tessuto del quotidiano.
Un trauma ‘culturale’ ?
Ma allora come intendere la specificità, e la specificità psichica non genericamente sociale, del trauma migratorio, pur nelle sue differenti declinazioni? uscendo dalle secche della riproposizione sotto mentite spoglie dell’alternativa variabile ambientale/variabile costituzionale?
Leon e Rebeca Grinberg nel loro pionieristico studio sulla “psicoanalisi dell’emigrazione e dell’esilio” equiparavano l’esperienza migratoria ad una vera e propria “esperienza di rinascita”. Questa straordinaria intuizione ci aiuta a ricostruire la profondità psichica di un elemento traumatico che si radica nella necessaria disarticolazione , e dunque poi nella successiva ri-articolazione, di quel nesso fondativo tra psiche individuale, relazioni primarie ed intelaiatura culturale che le regge entrambe.
Dunque per comprendere la portata ‘traumatica’ dell’esperienza migratoria occorrerà innanzi tutto rifarsi alla dimensione costitutiva dell’esperienza culturale per la psiche individuale, in particolare all’interno di quelle relazioni primarie che danno letteralmente ‘corpo’ alla dimensione linguistico-simbolica che costituisce la dimensione culturale. La cultura è in questo senso corpo-affetto, dimensione letteralmente incorporata e che struttura la percezione/rappresentazione della propria corporeità/affettività e della stessa immagine di sé. Tobie Nathan parla a tale proposito di un vero e proprio “doppio culturale” in cui la struttura psichica interna si rispecchia e si reduplica nella struttura esterna: in questo senso il sistema di legami simbolici istituiti nel tessuto culturale non rappresenta un cerchio più esterno che ‘contiene’ la psiche individuale , costituendo una sorta di ‘abito’ culturale che sia dunque possibile cambiare all’occasione: si tratta piuttosto di un elemento strutturale che edifica la psiche costituendone una sorta di ‘connettivo’.
E’ per questo che l’autentica frattura culturale connessa alla migrazione non è tanto una frattura interpsichica, rispetto al contesto esterno, quanto una frattura intrapsichica in cui si altera un fondamentale senso di ‘continuità’ culturale. Quest’ultimo consente una sorta di ‘inavvertito’ e tacito rispecchiamento non soltanto in una dimensione ‘orizzontale’ di significati condivisi -quella dimensione che dunque struttura l’ovvietà del quotidiano per così dire- ma anche in una dimensione verticale, ovverosia in quella dimensione ‘genealogica’ che costituisce l’asse portante del sentimento di identità, sentimento radicato nel senso di appartenenza affettiva ad una comunità simbolica che lega le generazioni.
Come si ricorderà già Freud (1914) segnalava come ogni nuovo nato, ogni figlio, riceva una sorta di ‘premio narcisistico’ in quanto erede e discendente di una tradizione culturale, in quanto continuatore di una stirpe. In questa possibilità di rispecchiamento identitario, sul piano culturale-genealogico, tra genitori e figli, ma ancora di più tra antenati e discendenti, si situa quella dimensione verticale che conferisce profondità e solidità all’edificio narcisistico, costituendo in un certo senso le fondamenta del sentimento di identità.
L’esperienza migratoria inevitabilmente altera tali nessi strutturali, con modalità diversificate e specifiche tra prime e seconde generazioni in particolare: il trauma ‘migratorio’ per la sua particolare natura, infatti, non esaurisce i suoi effetti nell’arco di una generazione, ma necessariamente si ‘propagherà’ nelle successive, e questo esattamente per la sua natura di trauma ‘culturale’.
L’esperienza migratoria comporta dunque una sorta di riproposizione della condizione di Hilflosigkeit infantile, resa drammaticamente evidente proprio dalle più recenti ondate migratorie, in cui si ridiventa preda di bisogni primari che costringono a sperimentare nuovamente una condizione di inermità e di dipendenza. Non solo, l’estraneità al contesto linguistico costringe a ricadere letteralmente nella condizione dell’ infans, sperimentando nuovamente i frammenti pulsionali ed emotivi arcaici che abitano la lingua, mentre il processo di simbolizzazione primaria dell’esperienza deve essere in un certo senso ‘ripercorso’ e , almeno parzialmente, rifatto alla luce del nuovo codice simbolico in cui ci si ritrova immersi, con tutto il rischio che questo rinnovato processo di simbolizzazione psichica possa fallire. Vorrei sottolineare come si tratti proprio di rimettere in gioco aspetti della simbolizzazione primaria, che coinvolgono l’esperienza della corporeità e dell’affettività: non si tratta semplicemente di apprendere una nuova lingua e delle nuove consuetudini quanto piuttosto di un intero ‘modellamento’ degli habitus corporei , per usare l’espressione cara a Pierre Bourdieu, che modifica la stessa autopercezione e autorappresentazione dell’immagine di sé, così come sul piano affettivo si tratta addirittura di riuscire a ‘nominare’ configurazioni relazionali-affettive inedite.
Tra l’altro tali aspetti diventano tanto più evidenti proprio nelle più recenti ondate migratorie, in cui le massicce violenze di cui spesso i migranti sono stati vittime, assieme ai processi di desertificazione culturale già in atto nei paesi di provenienza, provocano una effrazione del guscio identitario, col risultato di trovarsi spesso di fronte a individui che hanno subito una violenta ‘deculturazione’ piuttosto che essere portatori di una presunta ‘identità’ culturale, solida e riconoscibile.
Si tratta dunque di un delicatissimo e incessante processo di riformulazione identitaria che rende i migranti costitutivamente a rischio di un ‘cedimento’ della struttura egoica, soprattutto laddove tale riformulazione appare il frutto di un rapido e massiccio processo di mimesi identitaria, piuttosto che di una autentica metabolizzazione introiettiva . Attitudine mimetica che del resto è indispensabile per assicurare una condizione di sopravvivenza psichica, in cui meccanismi di negazione e di scissione sono indispensabili per evitare il contatto con affetti intollerabili e rappresentazioni ingestibili, incompatibili col mantenimento dello statuto di soggetto.
E’ proprio questo l’intreccio traumatico, costantemente attivo, cui si riferiva Michele Risso a proposito del ‘microtraumatismo quotidiano’ cui il migrante è sottoposto:
a) perdita della ovvietà dell’esperienza quotidiana, che risulta costantemente attraversata da autentici ‘significanti enigmatici’ che devono essere incessantemente sottoposti a un lavoro interpretativo
b) frattura del legame fondativo con le origini, che diventano area di conflitto e di inesausta interrogazione; fonti entrambi di profonde angosce persecutorie e depressive
c) necessità di un continuo lavoro di rifondazione identitaria che si muove su di un crinale molto sottile, in cui si fa sentire con forza l’instabilità di quei referenti metapsichici e metasociali di cui parla Kaes. Se il soggetto ha bisogno di un corpo-gruppo per costituirsi, e soprattutto mantenersi come tale, si intuisce come il migrante sia in realtà costantemente a rischio di smarrire la sua dimensione ‘soggettuale’, restando costantemente a rischio di sperimentarne la costitutiva fragilità. Anche dopo molti anni di una migrazione di successo resta alta la probabilità di sviluppare gravi crolli depressivi, patologie psicosomatiche invalidanti , attitudini rivendicative subdeliranti.
Il trauma migratorio possiede dunque molteplici declinazioni, la sua complessità non si esaurisce affatto nel momento drammatico dello ‘sbarco’ nel paese ospite, si tratta in realtà di un ‘processo’ ramificato e pluristratificato capace di distendersi nel tempo, attraverso le generazioni, e di espandersi nello spazio, coinvolgendo le comunità di partenza e di arrivo.
Processo traumatico, dunque, costruzione soggettiva che ha bisogno di incontrare un ascolto attento, capace di intenderne le profonde eco attraverso i suoi molteplici travestimenti, in particolare le sue perfette mimesi in maschere di riuscita integrazione, le quali potrebbero subitaneamente dissolversi.
La migrazione richiede un incessante lavoro di lutto delle origini, che non si può mai compiere definitivamente, perché questo equivarrebbe a sottrarre definitivamente ai propri antenati la loro stessa discendenza, è per questo che anche il ‘processo’ traumatico che la accompagna non può mai essere davvero ‘elaborato’, dal momento che quella ‘ferita congelata’ è spesso l’unico segno residuo del legame ad una memoria altrimenti inattingibile.
Per i migranti, dunque, non si tratta tanto di sopravvivere al trauma quanto di continuare a sopravvivere nel trauma.
BIBLIOGRAFIA
Amselle J.L.( 1999), Logiche meticce. Antropologia dell’identità in Africa e altrove, Bollati Boringhieri, Torino
Arpin J., Comba L. e Fleury F. (a cura di), Migrazione e salute mentale in Europa, numero monografico della rivista “Antropologia Medica”, n.4, 1988, Grafo edizioni
Augé M. (2000), Il senso degli altri, Bollati Boringhieri, Torino (ed. orig. Le sense des autres. Actualité de l’anthropologie, Fayard, 1994)
Balandier G. (1991), Il disordine. Elogio del movimento, Dedalo, Bari (ed. orig. Le désordre, Fayard, Paris, 1988)
Barbato A. (1993), Servizi psichiatrici territoriali e immigrati: primi dati da un’indagine in corso a Milano, in De Micco V., Martelli P., (a cura di) , Passaggi di confine. Etnopsichiatria e migrazioni, Liguori, Napoli
Baubet T. et al. (2003), Soigner malgré tout. Trauma, cultures et soins, Ed. La pensée sauvage, Grenoble
Beneduce R.(1998), Frontiere dell’identità e della memoria. Etnopsichiatria e migrazioni in un mondo creolo, Angeli, Milano
Ben Jelloun, T. (1977). La plus haute des solitudes. Misère affective et sexuelle d’émigrés nord-africains. Paris, Éditions du Seuil.
Bourdieu P.(2003), Per una teoria della pratica, Cortina, Milano
Bourguignon E. (1979), Psychological Anthropology. An Introduction to Human Nature and Cultural Differences, Holt, Rinehart and Winston, New York (Trad. It. Antropologia psicologica, Laterza, Roma-Bari, 1983).
Campani G., Lapov Z. e Carchedi F. (2002), Le esperienze ignorate. Giovani migranti tra accoglienza, indifferenza, ostilità, Angeli, Milano
Cardamone G., Inglese S., Zorzetto S., a cura di (1999), DjonDjongonon. Psicopatologia e salute mentale nelle società multuculturali, Edizioni Colibrì, Paderno Dugnano (Mi)
Charuty G. (1992), Anthropologie et psychanalyse: le dialogue inachevé, in Althabe, Fabre e
Coppo P.(1996), Etnopsichiatria, Il Saggiatore, Milano
Dal Lago A. (1999), Non persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli, Milano
De Martino E. (1977), La fine del mondo. Contributo allo studio delle apocalissi culturali, a cura di C. Gallini, Einaudi, Torino.
De Micco V., Martelli P., (a cura di) (1993), Passaggi di confine. Etnopsichiatria e migrazioni, Liguori, Napoli
De Micco V., Le identità nomadi. Identità, migrazioni, fratture narcisistiche, in Cotrufo P., Pozzi R. ( a cura di), Identità e processi di identificazione, pp. 137-151, F. Angeli, Milano, 2014.
De Micco V., Trapiantare/tramandare. Legami e identificazioni nei transiti migratori in De Micco V. e Grassi L. ( a cura di) Soggetti in transito. Etnopsicoanalisi e migrazioni, numero monografico della rivista “ Interazioni. Clinica e ricerca psicoanalitica su individuo-coppia-famiglia”, n. 1- 2014 /39, F. Angeli, Milano
Devereux G., (1978), Saggi di etnopsichiatria generale, Armando Armando,, Roma,
Devereux G. (1984), Dall’angoscia al metodo nelle scienze del comportamento, Ed. dell’Enciclopedia Italiana Treccani, Roma
Diasio N.(1993), Diventare bianco: crisi di passaggio e riformulazione dell’identità in Delle Donne, Melotti e Petilli ( a cura di), Immigrazione in Europa. Solidarietà e conflitto, CEDISS, Roma
Diasio N. (2001), Patrie Provvisorie. Roma anni ’90: corpo, città, frontiere, Angeli, Milano
Douglas M.(1975), Purezza e pericolo , Il Mulino, Bologna (ed. orig., Purità and Danger. An analysis of concepts of pollution and taboo, Penguin Books, 1970)
Fabietti U. (1998), L’identità etnica, Carrocci, Roma
Fanon F.(1996), Pelle nera, maschere bianche. Il nero e l’altro, Marco Tropea, Milano (ed. orig. Peau noire masques blancs, Seuil, Paris, 1952)
Fanon F. (2000), I dannati della terra, Edizioni di Comunità, Torino (ed. orig. Les damnès de la terre, Maspéro, Paris, 1961)
Favaro G. e Napoli M, ( a cura di) (2002), Come un pesce fuor d’acqua. Il disagio nascosto dei bambini e dei ragazzi immigrati, Guerini, Milano
Freud S. (1914), Introduzione al narcisismo, OSF vol 7, Bollati Boringhieri, Torino
Freud S. (1919), Il Perturbante, OSF vol 9, Bollati Boringhieri, Torino
Freud S.,(1922) L’Io e l’Es, OSF, vol 9, Bollati Boringhieri, Torino
Freud S.,(1926) Discorso ai membri dell’Associazione B’nai B’irth, OSF, vol10, Bollati Boringhieri, Torino
Frigessi Castelnuovo D., Risso M. (1982), A mezza parete. Emigrazione, nostalgia, malattia mentale, Einaudi, Torino
Frigessi D. (1993), Il modello patologico dell’immigrazione, in – De Micco V., Martelli P., (a cura di) , Passaggi di confine. Etnopsichiatria e migrazioni, Liguori, Napoli
Frighi L e Cuzzolaro M., Il rischio psicopatologico in una popolazione di immigrati a Roma,in “Medicina e migrazioni”, Atti I conv. Internazionale, Roma, 1988
Foucault M. (1967), Nascita della clinica: un’archeologia delle scienze umane, ,Einaudi, Torino
Gallini C. ( a cura di), (2003), Patrie elettive. I segni dell’appartenenza, Bollati Boringhieri, Torino,
Geertz C., (1991), Mondo globale, mondi locali, Il Mulino, Bologna
Grinberg L. e Grinberg R. (1990), Psicoanalisi dell’emigrazione e dell’esilio, Angeli, Milano (ed. orig. Psicoanalisis de la migracion y del esilio, Alianza Editorial, Madrid, 1984)
Habermas J. (1998), L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica, Feltrinelli, Milano
Hannerz U., (1998), La complessità culturale. L’organizzazione sociale del significato, Il Mulino, Bologna
Kaes R.(2008), La trasmissione delle alleanze inconsce, organizzatori metapsichici e metasociali, in AA.VV., Generi e generazioni. Ordine e disordine nelle identificazioni, Angeli, Milano
Kaes R., (2009) Le alleanze inconsce, Borla, Roma, 2010
Khan M. (1988), Il concetto di trauma cumulativo, in Lo spazio privato del sé, Bollati Boringhieri, Torino.
Kilani M. (1997), L’invenzione dell’altro. Saggi sul discorso antropologico, Dedalo, Bari (ed. orig. L’invention de l’autre. Essais sur le discours anthropologique, Payot, Lausanne, 1994)
Kleinman A.(1980), Patients and healers in the context of culture, University of California Press, London
Inglese S. (1994), “La psicopatologia dell’emigrazione come momento di transizione teoretica alla fondazione dell’etnopsichiatria italiana”, “Inventario di psichiatria”, 14-15, 14-19
Inglese S. (1997), La psicopatologia dell’emigrazione: un’esperienza di cambiamento catastrofico individuale e collettivo, in S. Mellina, Medici e sciamani fratelli separati, Lombardo, Roma
La Cecla F. (1996), Il malinteso. Antropologia dell’incontro, Laterza, Roma-Bari
Lanternari V.,(1986), Identità e differenza. Percorsi storico-antropologici, Liguori, Napoli
Laplanche J. (2000), Il primato dell’Altro in psicoanalisi, La Biblioteca, Roma-Bari
Lévi-Strauss C. (1980), L’identità, Sellerio, Palermo (ed. orig. L’identité, Grasset et Fasquelle, 1977)
Littlewood R, Lipsedge R., (1982), Aliens and Alienists. Psychiatry and Ethnic Minorities, Unwin Hyman, London
Maher V. (a cura di), (1994), Questioni di etnicità, Rosenberg e Sellier, Torino
Mellina S. (1987), La nostalgia nella valigia, Marsilio, Venezia
Mesmin C. (sous la direction de) (1995), Psychothérapie des enfants de migrants, La pensée sauvage, Grenoble
Molino A. (a cura di), (2004) Culture Subject Psiche. Dialogues in psychoanalysis and anthropology, Whurr Publishers, London and Philadelphia
Nathan T., 1990, La follia degli altri, Ponte alle Grazie, Firenze
Nathan T. (1993), Modificazioni tecniche e concettuali recentemente apportate alla psicopatologia attraverso la clinica etnopsicoanalitica, in V. De Micco e P. Martelli (a cura di), Passaggi di confine. Etnopsichiatria e migrazioni, Liguori, Napoli
Nathan T. (1996), Principi di etnopsicanalisi, Bollati Boringhieri, Torino
Raison J.P., (1978), Migrazione, in Enciclopedia, 9, 258-311, Einaudi, Torino.
Remotti F. (1996), Contro l’identità, Laterza , Bari
Risso M. e Boeker W., (2000), Sortilegio e delirio. Psicopatologia delle migrazioni in prospettiva transculturale, a cura di V. Lanternari, V. De Micco e G. Cardamone, Liguori ,Napoli (I ediz. 1992). (ed.orig. Verhexungswahn, Karger, Basel, 1964)
Rosoli G., (1988), La condizione sanitaria dell’emigrante, in Atti del I convegno internazionale Medicina e migrazioni, Roma, 9-10 aprile 1988.
Sayad A. (2002), La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, Cortina, Milano (ed. orig. La double absence, 1999, Seuil, Paris)
Scotto J. C., (1988), Santé mentale et migration: evolution de la situation en France, in Atti del I convegno internazionale Medicina e migrazioni, Roma, 9-10 aprile 1988.
Signorelli A.(2000), Le molteplici singolarità di un processo di massa. Alcune riflessioni sullo studio antropologico delle migrazioni, in “Etnoantropologia”, numero monografico su “Migrazioni e dinamiche dei contatti interculturali”, 8/9, 1999-2000, pp.285-295, Argo, Lecce.
Terranova Cecchini R., Tognetti Bordogna M. (1992), Migrare, Franco Angeli, Milano
Todorov T. (1984), La conquista dell’America. Il problema dell’altro. (ed.orig. 1982), Einaudi, Torino
Winnicott D. W. (1974 [1971]), Gioco e realtà, traduz. di Giorgio Adamo e Renata Gaddini, Armando, Roma [ ediz. orig. Playing and reality, Tavistock Publications, London, 1971]
Winnicott D. W. ( 1995) , Esplorazioni psicoanalitiche, Cortina, Milano
Giugno 2017
Trauma precoce cumulativo

C. BOLTANSKI, 2015
A cura di Franco De Masi
Il concetto di trauma in psicoanalisi ha subito alterne vicende sia nella definizione sia nel rilievo attribuitogli come causa di malattia dell’adulto. In passato si considerava traumatico un evento unico, improvviso e violento. Attualmente si pensa che molti eventi, pur non avendo un carattere violento, siano fonti di futura patologia perché determinano una violazione dell’apparato psichico del bambino.
Esistono traumi che producono effetti catastrofici ad ogni età, ma non tutti gli eventi traumatici producono danni: l’effetto patogeno di un evento dipende, infatti, non solo dalla sua intensità, ma dall’età e dalla fase dello sviluppo dell’individuo che lo subisce. Ciò che è patologico ad una certa età può non esserlo in un’epoca successiva. Inoltre, occorre tener presente che un evento isolato può non avere sempre un effetto patogeno dato che una naturale capacità riparativa può limitare il danno.
Il trauma psichico, pertanto, consiste in un’azione, improvvisa o ripetuta, che risulta lesiva perchè non sono ancora pronte le difese necessarie alla protezione da un avvenimento schiacciante che non può essere compreso ed elaborato.
Tra i primi autori che hanno valorizzato l’importanza del trauma infantile nella sofferenza dell’adulto, Ferenczi (1929) ha messo in evidenza i modi in cui la sensibilità e la competenza del bambino possono essere insidiate dagli adulti quando questi intrudono con i loro bisogni nella sua area privata.
Balint (1968), psicoanalista ungherese e allievo di Ferenczi, ha parlato di difetto fondamentale (basic fault), qualcosa che accade nei primissimi mesi di vita e che porta a una mancata integrazione tra madre e bambino; le brecce traumatiche derivano dall’incapacità materna di adattarsi ai bisogni di base del piccolo.
Al pari della febbre reumatica infantile, che produce danni che compaiono solo successivamente nella vita adulta, gli effetti del trauma emotivo si manifestano in modo imprevedibile e a distanza.
Il concetto di membrana protettiva, formulato da Freud (1920) all’interno della concezione economica dell’apparato psichico, è stato arricchito in particolare dal contributo di Masud Khan (1963), con il concetto di trauma cumulativo. Egli applica coerentemente l’intuizione di Winnicott quando descrive un bambino che ha bisogno della madre e di una madre che fa parte del sé del bambino. Nel caso del trauma cumulativo il bambino risponde alle ripetute intrusioni materne con inibizioni o distorsioni dello sviluppo psicologico.
La funzione di membrana protettiva per la mente corrisponde alla competenza emotiva dei genitori che intuitivamente capiscono quali sono le esperienze psichiche che il bambino è in grado di tollerare.
È la madre, nella visione winnicottiana (unità duale tra madre e bambino) e in quella bioniana (contenitore-contenuto), che si costituisce come barriera contro l’eccesso di stimoli. Il trauma continuativo consegue alla mancanza della funzione materna di contenimento e, nei casi estremi, alle proiezioni dei genitori di loro contenuti psichici patologici nella mente del bambino. Masud Khan indica alcune delle possibili distorsioni derivanti dalla mancata funzione di membrana protettiva come, ad esempio un precoce e selettivo sviluppo dell’io in linea con una collusiva risposta alla madre, false identificazioni con l’oggetto primario e distorsioni nella percezione dell’io-corporeo.
L’ipotesi è che i precursori del pensiero e dell’affettività, che si formano tramite processi inconsapevoli, possano essere disturbati nella primissima infanzia da eventi traumatici ha preso un rinnovato vigore dopo l’introduzione del concetto di memoria implicita, cioè dell’esistenza di eventi nella primissima infanzia, impossibili da registrare e da ricordare.
E’ giusto ricordare che Anne-Marie e Joseph Sandler (1987) avevano già teorizzato l’esistenza dell’inconscio passato, formato da una serie di vicende inconsapevoli, impossibili da recuperare, e dell’inconscio presente, quello accessibile, che si forma più tardi sulla base di esperienze emotive rappresentabili. I neuroscienziati hanno messo in luce che l’assenza di ricordi che caratterizzano i primissimi anni di vita non è dovuta all’amnesia infantile, effetto della rimozione come ipotizzato da Freud, quanto dalla mancata maturazione delle strutture cerebrali deputate a immagazzinare i ricordi, in particolare l’ippocampo. Le conseguenze più rilevanti per la psiche deriverebbero dalla precocità dell’esperienza traumatica quando questa è in grado di disorganizzare ab inizio lo sviluppo delle strutture di base del comportamento.
Seguendo questa linea di pensiero, Fonagy (1999) ha sostenuto, ad esempio, che gli stati borderline derivano da traumi precoci, incorporati quando non esiste la possibilità di rappresentarli. I pazienti borderline e quelli psicotici sarebbero pertanto incapaci di mentalizzare, ossia di rappresentare le emozioni, gli accadimenti psichici e gli stati mentali di cui ignorano il significato.
Si potrebbe, pertanto, concettualizzare l’insieme delle risposte distorte capaci di condizionare in senso psicopatologico lo sviluppo infantile come trauma emotivo, o trauma nella relazione primaria (De Masi, 2012).
L’esperienza clinica conferma l’effetto traumatico delle distorsioni precoci della comunicazione emotiva tra la mente del genitore e quella del bambino.
Si tratta spesso non tanto di un’assenza emotiva, quanto dell’intrusione di parti malate, superegoiche o confuse, dell’oggetto primario. Parti dell’oggetto sono assimilate al sé con la conseguente creazione di un’identificazione patologica con un oggetto invasivo che viene a fare parte del sé del bambino (Williams, 2004).
In questo caso ci troviamo di fronte a un oggetto internalizzato che si comporta come se facesse parte del paziente; nelle patologie più complesse questi introietti lavorano contro il paziente, a volte seducendolo, a volte intimidendolo, ma soprattutto confondendolo.
Nel campo dei disturbi psichici più complessi è importante distinguere le strutture patologiche originate da un’intrusione precoce degli oggetti primari da quelle che presuppongono una costruzione attiva da parte del paziente.
Quello che balza in primo piano in alcuni casi non è una sofferenza traumatica vera e propria, ma l’assenza di strutturazione della mente nel corso della vita infantile.
Se il bambino vive in un mondo privo di risposte emotive da parte dei genitori, non può sviluppare quelle rappresentazioni che sono fondamentali per la costituzione del suo senso di realtà. A volte l’assenza psichica del genitore favorisce una fuga piacevole nel mondo dell’immaginazione a scapito del contatto con la realtà psichica. Questa è una delle ragioni per le quali un certo numero di pazienti, che pure ha avuto un’infanzia traumatica, non è assolutamente consapevole di questo fatto. Secondo il mio modo di vedere (De Masi 2012), due fattori ugualmente importanti, destinati a potenziarsi a vicenda, concorrono a favorire la psicopatologia dei pazienti più gravi: la mancanza d’empatia proveniente dall’ambiente e la costruzione da parte del bambino di strutture psicopatologiche che lo fanno deviare dallo sviluppo normale. Le strutture psicopatologiche, specifiche per ogni paziente, si sviluppano precocemente e, pur collegate al carattere degli oggetti primari e alla loro interazione con il paziente, acquisiscono nel corso del tempo una configurazione stabile e autonoma.
All’estremo dello spettro che mette in relazione la sofferenza psichica dell’adulto al trauma infantile si colloca la reazione vittimistica al trauma di alcuni pazienti che incontriamo nella nostra pratica clinica. Mentre la maggioranza dei pazienti, spesso, non hanno consapevolezza dei traumi emotivi infantili, che di solito emergono solo tardivamente in analisi, altri li comunicano sin dall’inizio della terapia. Essi fanno un’accurata descrizione del carattere dei genitori, delle loro mancanze e delle ingiustizie subite; sembra che annotino tutti i torti, quelli inevitabili e quelli occasionali, per eccitarsi in un rifugio mentale pieno di risentimento e di violenza. La partecipazione emotiva dell’analista non li conforta, anzi sembra aumentare l’entità delle lamentele; nel denunciare le sofferenze del passato, la posizione di vittima si alimenta e sviluppa un’aggressività crescente. Essi possono sviluppare un transfert in linea con questo risentimento nella dipendenza.
J. Steiner (1993) sostiene che specifiche organizzazioni patologiche sono alla base di questi stati di risentimento e rancore, che possono essere intesi come difese passive, masochistiche o maniacali, da sensi di colpa che il paziente non è in grado di accettare. Sentirsi cronicamente vittima di ingiustizie servirebbe a non mettere in discussione la propria parte di responsabilità e a non elaborare il lutto per il trauma sofferto e per quanto è stato perduto nel passato che non è più recuperabile. La sofferenza traumatica è trasformata in una guerra cronica in cui l’oggetto è torturato senza mai perdere la relazione con esso; la soddisfazione perversa che si ottiene eccitandosi nel circolo controaggressivo rende sempre più difficile il cambiamento.
Bibliografia
Balint M. (1968), The Basic Fault: Therapeutic Aspects of Regression, Tavistock, London trad.it. Il difetto fondamentale in La regressione, Cortina, Milano 1983.
De Masi F. (2012) Lavorare con i pazienti difficili. Bollati Boringhieri, 2012.
Ferenczi S. (1929), Il bambino indesiderato e il suo istinto di morte. Vol.4. Cortina “Opere”.
Fonagy P. (1999), Memory and therapeutic action, Int. J. Psycho-Anal., vol. 80, 215-223.
Freud, S. (1920) Al di là del principio del piacere. Vol. 9. OSF
Khan M. (1963), The Privacy of the Self, Hogart Press, London 1974. trad.it. Il concetto di trauma cumulativo in Lo spazio privato del sé, Bollati Boringhieri, Torino 1979.
Sandler J.; Sandler A. M. (1987), The past unconscious, the present unconscious and the vicissitudes of guilt. Int. J. Psycho-Anal., vol. 68, 331-441.
Steiner J. (1993), Psychic Retreats. Pathological Organisations in Psychotic, Neuroticand Borderline Patients. Routledge, London. [tr. it. I rifugi della mente. Bollati Boringhieri, Torino 1996.]
Williams P. (2004), Incorporation of an invasive object. Int. J. Psycho-Anal. vol. 85, 1333-1348.
Luglio 2014
Trauma/Psicoanalisi

Charcot lectures at La Salpetriere by Pierre-Andre Brouillet (1857-1914)
A cura di Giampaolo Kluzer
Il trauma in psicoanalisi
La nascita della teoria psicoanalitica coincide in Freud con l’inizio della sua riflessione sul significato possibile dei sintomi nevrotici, da lui osservati nella pratica clinica. In questa riflessione, il ruolo del trauma rappresenta fin dall’inizio, e continuerà a rappresentare nel corso di vari decenni, l’elemento fondante. Freud sembra avere ereditato dal famoso neurologo francese Charcot, suo maestro a Parigi per qualche mese alla fine del 1885, l’interesse per le varie forme d’ isteria traumatica, conseguenti a eventi emotivamente molto intensi e non associati a lesioni organiche significative. Freud mantenne negli anni il termine di nevrosi traumatica per indicare una sintomatologia polimorfa, caratterizzata da assillo invasivo del ricordo dell’evento traumatico subito, da incubi notturni ripetitivi, da inibizione psicomotoria, ansia etc. Di questa forma nevrotica, che si manifesta subito dopo un chiaro evento traumatico, con il quale mantiene una chiara connessione di causa effetto, Freud si occupò particolarmente a proposito dell’apporto che la psicoanalisi poteva dare alla comprensione delle nevrosi di guerra, molto frequenti durante e alla fine della prima guerra mondiale. L’aspetto però innovativo dell’apporto freudiano, rispetto alla concezione charcotiana, consistette nell’estensione del ruolo determinante del trauma alla genesi di tutte le psiconevrosi, o nevrosi di tranfert, secondo la sua nuova definizione. In queste manifestazioni psicopatologiche il rapporto fra causa traumatica scatenante ed effetto sintomatico (isterico, fobico, ossessivo o altro) appare molto meno evidente, soprattutto perché l’azione patogena si svolgerebbe in due tempi distinti. Il primo riferimento di Freud a questo particolare meccanismo di azione del trauma (1895), da lui denominato “nachtraglichkeit” ( “azione differita” in italiano, o “après coup” in francese) afferma : “ Troviamo sempre che viene rimosso un ricordo che è diventato un trauma solamente più tardi ”. Secondo questa definizione un evento traumatico diventerebbe veramente tale per un soggetto solo in un momento di successiva elaborazione intrapsichica, che prima non sarebbe stata possibile. L’accento della dinamica traumatica si sposta quindi dalla fattualità esterna alla risonanza intrapsichica che essa può suscitare nel soggetto.
Etimologicamente, dal greco, trauma significa ferita, lacerazione. Il riferimento oggi più frequente a questo termine rimanda invece all’evento capace di produrre tale effetto di ferita. Il trauma, nella teoria freudiana e nel suo sviluppo post freudiano, è concepito come un evento isolato e unico, oppure ripetuto nel tempo, che produce una quantità di eccitazione psichica in grado di lacerare un precedente assetto elaborativo, e di imporgli un ulteriore lavoro di ristrutturazione, che potrà portare a un’organizzazione difensiva patologica, il cui modello classico sarebbe la rimozione. L’assetto psichico, che viene investito e disorganizzato dal trauma, potrebbe essere inteso come una trama rappresentativa che il soggetto, sia consapevolmente sia a livello inconscio, continuamente elabora e aggiorna, per assicurare a se stesso e al mondo circostante una coerenza e una continuità di identità. La riflessione freudiana sul trauma non procede nei decenni in maniera lineare ma presenta continui sviluppi e ritorni su posizioni precedenti, tutti centrati intorno alle varie modalità di influenzamento reciproco fra eventi esterni fattuali e attività fantasmatica e rappresentativa intrapsichica, condizionata dalla dinamica pulsionale.
In un primo tempo, e fino al 1897, Freud identifica in un comportamento di seduzione sessuale infantile, da parte di un adulto perverso, la causa traumatica primaria di successive manifestazioni nevrotiche. A partire da questa data il ruolo patogeno svolto dalle figure di questa seduzione esterna viene sostituito da quello che avrebbero le fantasie infantili attive, di tipo edipico e incestuoso, che verranno in seguito raggruppate da Freud sotto il termine di fantasmi originari (seduzione, castrazione, scena primaria). Con questo nuovo orientamento teorico il primitivo scenario traumatico sessuale perse d’importanza e lasciò, per così dire, in primo piano la sessualità infantile come potenziale situazione traumatica per eccellenza. Al posto della seduzione infantile perversa apparve però, nella riflessione freudiana, il riferimento a situazioni di seduzione precoce e normale, inevitabilmente messe in atto dall’accudimento corporeo del bambino molto piccolo da parte della madre. Questa retro datazione e questa universalizzazione di situazioni potenzialmente “traumatiche” sarà ulteriormente ripresa e sviluppata nello scritto: Inibizione sintomo e angoscia (1925).
In questo scritto l’elemento traumatico, responsabile della genesi del sintomo nevrotico, viene attribuito alla rottura della barriera protettiva contro stimoli esterni o interni eccessivi, già descritta qualche anno prima in Al di là del principio di piacere (1920). L’attenzione è meno posta, qui, su singoli eventi traumatici che non su “situazioni traumatiche” ubiquitarie, che hanno tendenza a manifestarsi in momenti particolari dello sviluppo individuale, di passaggio da una fase maturativa all’altra, quali la nascita, lo svezzamento, l’apprendimento del controllo degli sfinteri etc.
L’apporto più innovativo alla teoria traumatica, contenuto in Inibizione sintomo e angoscia, è rappresentato, a mio avviso, dal rilievo dato al ruolo che la perdita, la mancanza, la condizione di impotenza soprattutto infantile (hilflosigkeit) hanno nella genesi della situazione traumatica. Questa condizione di assenza e di mancanza si contrappone a quella di presenza violenta, intrusiva, seduttiva e disorganizzante che aveva finora caratterizzato lo scenario traumatico.
Le nuove aperture sulla teoria traumatica, contenute in Inibizione sintomo e angoscia, stimoleranno la successiva e più significativa riflessione psicoanalitica su questo argomento.
Winnicott, Masud Khan, Bion, Aulagnier, Green, Bollas, sono alcuni fra gli autori più rappresentativi che hanno ripreso, con sfumature personali diverse, il tema di carenze assistenziali, non necessariamente vissute immediatamente come drammatiche, ma che si ripetono e si prolungano nel tempo, con effetti traumatici. Questa modalità traumatica “strisciante” (vedi concetto di traumi cumulativi di M. Khan) passa per lo più inosservata ed è trascurata sia dal soggetto colpito sia dall’ambiente che lo circonda.
Laplanche, infine, ha ulteriormente sviluppato il tema della seduzione, e della sua retrodatazione e universalizzazione nella genesi del trauma, già iniziato da Freud. Il termine da lui coniato di “seduzione generalizzata o originaria” si riferirebbe a una condizione costitutiva della nascita e dello sviluppo dello psichismo umano, inevitabilmente condizionato dal trauma-ferita costituito dal limite della sua capacità comprensiva dell’ ”altro”, in quanto presenza-assenza sempre misteriosa, enigmatica e mai totalmente afferrabile.
Bibliografia
Freud S. (1895). Progetto di una psicologia. O.S.F. 2.
Freud S. (1920). Al di là del princioio di piacere. O.S.F. 9
Freud S. (1925). Inibizione, sintomo e angoscia. O.S.F. 10.
Khan M. (1963). The concept of cumulative trauma. In: The Privacy of the Self. Hogarth Press, London.
Laplanche J. (1987). Nouveaux fondements pour la psychanalyse. Presses Universitaires de France, Paris.
Aprile 2014
Turillazzi Manfredi Stefania

Giovanni Fattori
Stefania Turillazzi Manfredi (Grosseto 1929- Firenze 2015)
A cura di Chiara Matteini
Note biografiche
Stefania Turillazzi nasce a Grosseto il 20 giugno 1929. Si laurea in medicina e si specializza in medicina legale. Sposata con Mario Manfredi, ha avuto due figli Gianna e Matteo.
Si forma a Roma, dove è in analisi con Emilio Servadio, in supervisione con Nicola Perrotti, e la prima allieva di Eugenio Gaddini, come lei stessa ricorda nel necrologio per il maestro sulla Rivista di Psicoanalisi (Turillazzi Manfredi, 1986). Nel 1959 diventa psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana, appena quarantenne ottiene le funzioni di Training. Trasferitasi a Firenze, è tra i fondatori del Centro Psicoanalitico di Firenze, insieme a Arrigo Bigi, Giovanni Hautmann, Giordano Fossi, Franco Mori. Dal 1972 al 1976 è stata segretario scientifico del Centro Psicoanalitico di Firenze e dal 1982 al 1986 vicepresidente della Spi. Muore a Firenze il 6 luglio 2015.
Coniugava la conoscenza profonda della storia del pensiero psicoanalitico con una costante apertura ai contributi contemporanei e al dibattito internazionale. Nel 1974 pubblicò sulla Rivista di Psiconalisi una traduzione del lavoro di Strachey sulle interpretazioni mutative,”La natura dell’azione terapeutica della psicoanalisi”, letto alla Società britannica nel 1933 e pubblicato sull’International Journal of Psichoanalysis nel 1934. Un lavoro che aveva avuto grande risonanza all’estero, ma era poco conosciuto in Italia. Curiosa ed attenta ai contributi internazionali è lei a diffondere in Italia il pensiero di Willy e Madeleine Baranger, curando con Antonino Ferro l’edizione italiana de La psicoanalisi come campo bipersonale. La psicoanalisi argentina, non solo quella dei Baranger ma anche quella di Pichon-Rivière, Racker, Etchegoyen, rimane nel suo lavoro teorico e clinico costante punto di riferimento.
Ha sempre cercato di intercettare lo junctim freudiano fra teoria e clinica, con grande attenzione ad alcuni fattori fondamentali: la storia dei concetti attraverso l’evoluzione del pensiero teorico, i cambiamenti nella tecnica, il lessico psicoanalitico (sottolineandone aporie e incongruenze), la formazione degli analisti e il rapporto fra psicoanalisi e psicoterapie. I suoi contributi si sono soffermati costantemente attorno ai temi centrali del dibattito psicoanalitico di quegli anni: interpretazione, identificazione proiettiva, controtransfert, campo analitico, acting, enactment, intersoggettivitá, sempre esercitando il suo sguardo acuto sulle contraddizioni del dibattito in corso e le possibili aperture sul futuro della psicoanalisi.
Dall’interpretazione al campo:
Sull’interpretazione lavora a lungo, partendo dalla traduzione del lavoro di Strachey sulle interpretazioni mutative e arrivando a definire il lavoro interpretativo come collegato a “fantasie di razza mista” che permeano il campo analitico. Come lei stessa precisa nella nota introduttiva con cui ripubblica nel 1994 “Interpretazione dell’agire e interpretazione come agire”, pubblicato originariamente nel 1978 sulla Rivista di Psicoanalisi, il suo percorso parte da un vertice legato prevalentemente al modello kleiniano per poi spostarsi, attraverso la riflessione sugli autori latino-americani, sull’interpretazione come condensatore di correnti transferali e controtransferali, un luogo nel quale si incontrano le parole del l’analista e le parole del paziente, per generare il frutto del lavoro comune dell’analisi. L’interpretazione data all’interno del campo analitico diviene dunque non più solo un’interpretazione di transfert, ma un’interpretazione nel transfert, che coglie quel particolare momento del lavoro analitico nel quale la ripetizione di qualcosa consente un’apertura a nuovi significati. Nella parola interpretativa compare inesorabilmente il precipitato del vissuto controtransferale e diviene allora necessario lavorare a lungo sulla possibilità di riconoscere e nominare tutte le matrici del campo analitico. Il rischio altrimenti è che l’interpretazione divenga un acting espulsivo, che non alimenta la possibilità di pensiero e favorisce vissuti persecutori nel paziente (Turillazzi Manfredi,1978b). Eppure nel 1998, pur rivedendo l’idealizzazione un tempo accordata all’interpretazione mutativa, ritiene che sia ancora l’interpretazione di transfert il luogo elettivo del lavoro analitico. Scrive in uno dei Seminari Milanesi che nell’interpretazione di transfert si condensano molti aspetti del campo: “l’ascolto, la memoria, il silenzio, la pazienza e l’attesa, il contenimento e il condividere, la tolleranza e il controtransfert, le teorie del paziente e quelle fluttuanti dell’analista, il recupero degli affetti perduti e la loro nominazione, l’antico e il nuovo del transfert, le ricostruzioni, la speranza del cambiamento, il malinteso e la suggestione ed infine il cambiamento stesso (…) In conclusione ci sono più cose nell’interpretazione di transfert di quante ne possano prevedere le nostre teorie.” (Turillazzi Manfredi, 1998, p.110).
Dall’identificazione proiettiva al controtransfert
La riflessione di Stefania Turillazzi Manfredi è costantemente alla ricerca dello junctim, nella convinzione che alla costante evoluzione delle esperienze cliniche corrispondano lacune teoriche, che lasciano una porzione di esperienza muta. Così, a partire da un concetto cardine della teoria psicoanalitica kleiniana come quello di “identificazione proiettiva”, l’autrice avvia un costante lavoro di “messa alla prova” dei concetti più utilizzati nella teoria psicoanalitica dell’epoca. In un lavoro del 1985 “L’unicorno: saggio sulla fantasia e l’oggetto nel concetto di identificazione proiettiva” scrive: “Il termine ‘identificazione proiettiva’, questa specie di unicorno di kleiniana memoria, mi è sembrato emblematico di certi problemi del nostro linguaggio: noi usiamo parole di cui abbiamo smarrito il senso, che tendono a sbalzare chi ci ascolta in una dimensione magica e che costituiscono ormai una cinghia di trasmissione che garantisce la riproduzione, sempre meno consapevole, di una certa ideologia permanente.” (Ibid. p.92). Emerge la necessità di poter collocare i concetti in un orizzonte teorico preciso e condiviso, così l’identificazione proiettiva necessita di essere ripensata alla luce del concetto di campo, e delle riflessioni sul controtransfert.
Ostacoli e appigli: transfert, controtransfert, intersoggettività
Molto lavori di Turillazzi Manfredi saranno dedicati alla teoria del controtransfert a partire dal 1989. In parte questi articoli sono raccolti ed integrati nella seconda parte de Le certezze perdute della psicoanalisi clinica. Un lavoro teso costantemente a mettere alla prova ciò che emerge e lavora nella relazione analitica.
L’autrice parte da una riflessione storica e teorica profonda del concetto di controtransfert, dalla comparsa del Gegenübertragung nel corpus freudiano, alle riflessioni di Ferenczi, Winnicott, Heimann, Little, Racker fino ai lavori allora più recenti, come quelli di Kernberg e di Faimberg. Analizza con precisione tutte le differenti tendenze che si sono succedute rispetto alla lettura del controtransfert, dapprima ostacolo pericoloso alla neutralità analitica, poi luogo di condensazione delle proiezioni del paziente, infine accolto come risorsa ineludibile dell’analisi. Turillazzi Manfredi sottolinea la necessità di tollerare il controtransfert, ritenendo impossibile comprenderne interamente ogni aspetto, ma indispensabile considerarlo costantemente una delle forze in campo. E’ in questa possibilità di tollerare quel che emerge dalla relazione che si ristabilisce l’indispensabile asimmetria della relazione analista-paziente. Perché si suppone che l’analista abbia gli strumenti e la responsabilità di saper gestire ciò che per il paziente può essere a lungo intollerabile, e di saper riconoscere nel tempo gli ostacoli e gli appigli che il campo presenta. E’ da questa posizione che Turillazzi Manfredi riflette anche sui concetti di self-disclosure, enactment e sulle nuove teorie intersoggettive, sottolineando sempre la posizione di un’analista che lavora in un assetto mentale di ascolto, del paziente e di sé, e di contenimento, per giungere infine ad una parola i cui frutti, se ci saranno, emergeranno nel campo attraverso le risposte del paziente, magari a distanza di tempo. Scrive in uno dei Seminari Milanesi: “Paul Valery (…) diceva di guardare il mondo della vita quotidiana come una mucca che guarda passare il treno. Questa è l’autentica meraviglia dalla quale nascono nuovi significati. Penso che lo psicoanalista dovrebbe guardare a ciò che dice il paziente come un animale guarda al mondo umano: con una pacifica perplessità.” (Turillazzi Manfredi, 1998, p. 74).
Sul cambiamento
Un altro dei nodi attorno ai quali Turillazzi Manfredi lavora a lungo è quello del cambiamento. Nel 1991 partecipa al XXXVII Congresso Internazionale di Psicoanalisi (Buenos Aires 1991), il suo intervento sul cambiamento sarà poi pubblicato nel 1992 con il titolo “Cambio y reparacion” sulla Revista de Psicoanálisis e in quello stesso anno sulla Rivista di Psicoanalisi (Turillazzi Manfredi, 1992). Nel volume del 1994 dedica un capitolo all’argomento intitolato “Cambiamento e riparazione” (Turillazzi Manfredi, 1994). Incentra la sua riflessione sul cambiamento partendo da un dubbio: la psicoanalisi è una teoria del cambiamento psichico o una teoria degli ostacoli al cambiamento psichico? Ancora una volta si sofferma su un concetto cardine della teoria psicoanalitica kleiniana, la riparazione, per smontarne l’uso consunto e ormai automatico. Propone un allargamento winnicottiano, immaginando una riparazione che muova dal “to be concerned”, dalla capacità di preoccuparsi per l’oggetto maltrattato e odiato, per tentare infine di ripararlo. Ritornando sul tema nel 2008, in un intervento inviato al Congresso SPI “Identità e cambiamento”, Turillazzi Manfredi sottolinea l’idealizzazione eccessiva depositata nel corso del tempo sulle possibilità di un cambiamento strutturale, definito e certo. Ricorda come il cambiamento sia certo desiderato, ma anche temuto, vissuto a volte come la fine del mondo, di quell’unico mondo in cui era possibile riconoscersi, e allora l’analista può essere a volte percepito come l’agente occulto di un cambiamento in vitro, vissuto come alieno. Non esiste però il cambiamento, ma tanti differenti cambiamenti, interni ed esterni all’analisi. Quello analitico ha certo a che fare con la relazione e con ciò che in quella relazione si produce. Scrive nella relazione del 2008: “Credo che non si introiettino oggetti ma interazioni. Detto in altro modo, se l’analista ha un buon rapporto con alcuni aspetti del paziente, il paziente introietta questo suo buon rapporto: questa è la riparazione. Vorrei concludere dicendo che sono convinta che la riparazione sia soprattutto uno stato della mente e che la mente sia come un’officina dove si ripara in permanenza, fino a quando, a un certo punto, il ritmo diventa insufficiente.” (Turillazzi Manfredi, 2008).
La parola al lavoro:
Non è un caso se il seminario organizzato dal Centro Psicoanalitico di Firenze e dal Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti per ricordare il lavoro di Stefania Turillazzi Manfredi è stato intitolato “Il lavoro della parola nella Psicoanalisi di Stefania Turillazzi Manfredi”. L’importanza della parola, e dell’ascolto analitico come terra di emersione di possibili parole, è stato costantemente al centro della riflessione dell’autrice. La parola interpretativa, che raccoglie e ricompone il lavoro del campo per porgerlo al paziente, ma anche la parola come luogo di deposito e raccolta del “lessico famigliare” di quello psicoanalista in quel momento di quell’analisi e della sua vita: “Nelle nostre interpretazioni infatti compaiono e ricompaiono spesso le parole usate da altre persone significative per noi, le parole della nostra infanzia e della nostra adolescenza, le parole lette nei libri, le parole del nostro analista, le parole di quel paziente e di altri pazienti, come se fossero resti diurni”. (Turillazzi Manfredi 1994, p. 57). Da ricordare anche l’importanza costante da lei attribuita al lessico analitico, alla sua qualità a volte magica di “unicorno”, in cui ciascuno, da un proprio personalissimo vertice teorico, vede qualcosa di differente, con il rischio di una babelizzazione di gergalità autoreferenziali, che smarriscano le possibilità di una lingua condivisa.
In questa sensibile attenzione alla parola nella sua qualità polisemica, sterile o feconda, distruttiva o speranzosa, riparatrice o confondente, Turillazzi Manfredi pare depositare la convinzione che senza accedere alle aporie dei nostri linguaggi e dei nostri silenzi, quelli della comunità analitica e quelli della stanza di analisi, non ci sia accesso al cambiamento. Nei Seminari Milanesi cita i versi di Heine amati da Freud: “Di rado mi avete compreso/ di rado anch’io vi ho compreso,/ soltanto quando ci incontrammo nel fango/ci siamo subito compresi”.
Bibliografia essenziale:
Articoli:
Turillazzi Manfredi, S. (1970), “Alcune considerazioni sul trattamento psicoanalitico dei pazienti psicosomatici”, Rivista di Psicoanalisi, 16, pp. 117-130.
Turillazzi Manfredi, S. (1974), “Dalle interpretazioni mutative di Strachey alle interpretazioni delle relazioni fra gli oggetti interni”, Rivista di Psicoanalisi, 20, pp. 127-143.
Turillazzi Manfredi, S. (1978a), “Interpretazione dell’agire e interpretazione come agire”, Rivista di Psicoanalisi, 24, pp. 223-240.
Turillazzi Manfredi, S., Mancia, M. (1978b), “Interpretazione dell’acting e interpretazione come acting”, Rivista di Psicoanalisi, 24, pp. 452-454.
Turillazzi Manfredi, S., Mancia, M. (1982), “Due scopi per la psicoanalisi: verità e cambiamento”, in di Chiara G. (a cura di), Itinerari della psicoanalisi, Loescher, Torino.
Turillazzi Manfredi, S. (1983), “Il senso del dolore fisico”, Rivista di Psicoanalisi, 29, pp. 571-575.
Turillazzi Manfredi, S., Nissim, L. (1984), “Il supervisore al lavoro”, Rivista di Psicoanalisi, 30, pp. 587-607.
Turillazzi Manfredi, S. (1989), “La nuova teoria del controtransfert”, Rivista di Psicoanalisi, 35, pp. 616-644.
Turillazzi Manfredi, S. (1985), “L’unicorno: Saggio sulla fantasia e l’oggetto nel concetto di identificazione proiettiva”, Rivista di Psicoanalisi, 31, pp. 462-477.
Turillazzi Manfredi, S., Pazzagli, A. (1986), “Acting-out”, Rivista di Psicoanalisi, 30, pp.93-105.
Turillazzi Manfredi, S. (1989), “The New Theory of Countertransference”, Rivista di Psicoanalisi, 35, pp. 616-644.
Turillazzi Manfredi, S. (1992), “Sul cambiamento”, Rivista di Psicoanalisi, 38, pp. 157-175.
Turillazzi Manfredi, S.(1999), “Sull’opportunità di insegnare la psicoterapia negli istituti di Training”, Rivista di Psicoanalisi, 45, pp. 85-91.
Turillazzi Manfredi, S., Ponsi, M. (1999), “Transfert-controtransfert e intersoggettività. Contrapposizione o convergenza?”, Rivista di Psicoanalisi, 45, pp. 697-719.
Turillazzi Manfredi, S. (2006), “Il transfert dai nostri giorni a Freud”, Rivista di Psicoanalisi, 52, pp. 351-399.
Turillazzi Manfredi, S. (2008), “Cambiare rimanendo se stessi”, Relazione letta al XIV Congresso SPI “Identità e cambiamento. Lo spazio del soggetto”, Roma 23-25 maggio.
Volumi:
Turillazzi Manfredi, S. (1979), La linea d’ombra della psicoterapia, Del Riccio, Firenze.
Turillazzi Manfredi, S. (1994), Le certezze perdute della psicoanalisi clinica, Cortina, Milano.
Turillazzi Manfredi, S. (1998), I seminari milanesi di Stefania Turillazzi Manfredi, Quaderni del Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti, La Tipografia Monzese, Monza.
Convegno:
“Il lavoro della parola nella psicoanalisi di Stefania Turillazzi Manfredi”, a cura del Centro Psicoanalitico di Firenze e del Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti. Firenze, 3 dicembre 2016.
Anna Ferruta, Introduzione.
Franco Borgogno, Stefania Turillazzi mafredi e Luciana Nissim Momigliano: un tandem propulsivo per la mia formazione.
Stefano Calamandrei, La parola psicoanalitica e il cambiamento.
Stefania Nicasi, Rileggere “Il piacere della Traumdeutung”.
Paolo Chiari, L’insegnamento delle parole.
Benedetta Guerrini Degl’Innocenti, Conclusioni.
Vallino Dina

Dina Vallino
A cura di G. Maggioni[1]
[1] Ringrazio Marco Macciò per la preziosa rilettura del testo
Dina Vallino (1941-2014)
LA VITA
Dina Vallino nacque a Cagliari nel 1941, da madre di origine sarda e da padre piemontese. Trascorse l’infanzia in una sorta di famiglia allargata, con i nonni materni e due zii conviventi. In seguito a un fallimento economico il padre, quando Dina aveva 11 anni, fu costretto a lasciare la propria famiglia per ritornare in continente e questo distacco fu particolarmente traumatico per Dina che condivise queste tristi esperienze familiari con la sorella Fiorenza, minore di sette anni e di cui ritroviamo traccia nel particolare interesse di Vallino per la tematica del rapporto fraterno.
Gli anni della formazione universitaria
Conseguita la maturità nel 1959, Dina frequentò Filosofia a Milano, dove insegnavano Musatti e Fornari e progettò, una volta laureata, di frequentare la Scuola di Specializzazione in Psicologia. Si sposò con Marco Macciò e ebbero un figlio. Marco condivise con Dina l’orientamento e gli interessi filosofici e le teorie sugli sviluppi della mente. Questo permise loro molti anni dopo la scrittura comune di alcune opere ( Vallino D., Macciò M.2010 ) . Entrambi seguaci di Enzo Paci, si interessarono alla Fenomenologia di Husserl e in particolare al concetto di intenzionalità secondo il quale non esiste un Io in sé, come fosse una cosa: l’Io risiede nell’intenzionalità che è un tendere verso l’altro, avere coscienza di qualcosa, non poter rinunciare a dare significato. Così nel pensiero di Dina, anche il fragile e immaturo lattante possiede una sua intenzionalità che deve essere riconosciuta e rispettata dalla madre perché in lui possa insediarsi il senso di esistere.
Negli stessi anni Dina coltivò un interesse sempre più vivo per la Psicoanalisi e lesse con profondo interesse le opere di S.Freud e di M.Klein. Si laureò nel 1967, con una tesi su Merleau-Ponty. Successivamente si iscrisse alla Scuola di Specializzazione in Psicologia diretta da M. Cesa Bianchi e Musatti. ( 1967-1970). Furono gli anni del Sessantotto e della contestazione studentesca. Insieme a Anna Ferruta, Riccardo Steiner e altri studenti, Dina formò un gruppo che rivendicava più insegnamenti di orientamento psicoanalitico. Durante questi anni, Dina iniziò una analisi personale con Lina Generali e i primi tirocini di cui i più significativi furono con Zapparoli, Berrini e con Oxilia. Successivamente il lavoro, prima a Sondrio, poi a Bergamo nei Consultori medico psico-pedagogici, dove Dina ebbe l’opportunità di arricchirsi di molta esperienza clinica di consultazione e di psicoterapia.
Il contatto con numerose patologie connesse a deprivazione affettiva e ambientale la indussero a scrivere con Anna Ferruta la tesi di specializzazione sull’importanza delle emozioni per la nascita del pensiero infantile. In questo lavoro le autrici non si rifacevano solo alla teoria kleiniana ma anche ad alcune tesi di Bion, precorrendo con coraggio l’interesse per un autore ancora poco presente nel panorama italiano.
Il training psicoanalitico
Nel 1969 Dina iniziò la propria analisi con Lina Generali e nel 1974 venne accettata come candidata nella Società Psicoanalitica Italiana, nella quale si associò sul finire degli anni ‘70. A fianco della sua formazione con gli analisti della Società, e in particolare con Adda Corti, Pierandrea Lussana, Giuseppe Di Chiara, Mauro Morra, Luciana Nissim, si recò a Londra dove ricevette supervisioni da Hanna Segal, Ruth Riesenberg, Betty Joseph, Martha Harris, Edna Oshaughnessy, Esther Bick. Nel 1978 con Anna Motta partecipò con una osservazione personale al primo seminario milanese di Infant Observation, condotto da Lina Generali con la partecipazione di M. Harris e D. Meltzer. Si formò così un gruppo di analisti interessati alla esperienza dell’Infant Observation, che rappresentò un evento nella storia della psicoanalisi di quegli anni. Dina proseguirà la pratica dell’Infant -Observation come conduttore di Seminari di formazione per tutta la sua vita, non solo per gli psicoanalisti della Società Psicoanalitica Italiana, ma anche per Istituti Universitari di Neuropsichiatria Infantile, per il corso Tavistock e presso il suo studio dove molti colleghi hanno avuto il privilegio di svolgere una esperienza osservativa, sotto la sua guida intransigente e appassionata. In quegli si arricchì anche la sua esperienza clinica, in particolare con il trattamento di bambini gravi rispetto ai quali ben presto mostrò le sue doti eccezionali di terapeuta. Purtroppo nel 1975 si manifestò per la prima volta una malattia autoimmune, che tormentò poi periodicamente la sua vita fino alla fine dei suoi giorni.
A tal proposito Dina disse : “ La malattia riporta in primo piano il fatto che, nonostante la nostra perizia o il sapere pregresso, ogni senso di sicurezza e di “ scontato “ nella vita quotidiana, viene a cadere. La malattia mi ha aiutato a sostenere, come elementi significativi della cura, la tenerezza e l’attenzione.( D. Vallino 2005)” Dina sviluppò una qualità particolare nel rispetto del paziente e di tutti coloro che vivono una condizione di fragilità nei confronti della vita.
Gli anni della maturità
Tra gli anni ‘70/ 80, il Centro Milanese di Psicoanalisi brulicava di figure di grande rilievo. Inoltre l’attività culturale era arricchita di analisti stranieri che venivano invitati allo scopo di tenere conferenze e supervisioni. La complessità del pensiero psicoanalitico che si produsse nacque da un confronto approfondito tra analisti di diverse formazioni e idee. Nel 1992 uscirà l’opera collettiva, “L’ Esperienza Condivisa”( Robutti A., 2001) che esprime la fertilità di quegli anni. Tra il 1985 e il 1987, inoltre, nella sede del Centro Milanese cominciò ad operare un piccolo gruppo di studio di analisi infantile con Antonino Ferro, Claudia Artoni, Maria Pagliarani, Giuliana Boccardi, a cui Dina Vallino contribuì assiduamente. Dal gruppo nacque, nel 1993, l’Osservatorio di psicoanalisi dei bambini e degli adolescenti, promosso anche da Marta Badoni, dove reciproca era la supervisione per i casi clinici di bambini e adolescenti.
Negli anni ’90, il sodalizio intellettuale con Franco Borgogno e l’interesse comune per l’area delle identificazioni patogene e alienanti e la lettura di S. Ferenczi, portò al lavoro “Dialogo tra due analisti” dedicato alla tematica degli “spoilt children” concetto coniato dallo stesso Franco Borgogno ( Borgogno Vallino D. 2005 ). Pure di fondamentale importanza fu l’amicizia con Parthenope Bion, con la quale, dall’inizio degli anni 90 fino alla sua tragica scomparsa, Dina intrattenne un confronto sul proprio materiale clinico. In quegli anni venne via via elaborando importanti innovazioni nella tecnica della Psicoanalisi Infantile, che verrà illustrato nel paragrafo successivo.
Sempre di quegli anni, è l’acquisizione delle Funzioni di Training che testimoniano la passione per la trasmissione della psicoanalisi ma l’impegno di Dina non si giocò solo all’interno della Società Psicoanalitica ma nel costante lavoro di formazione di terapeuti di bambini e genitori nelle varie Istituzioni Universitarie e territoriali. Fu una instancabile maestra di psicoanalisi fino alla fine dei suoi giorni, nonostante la insidiosa malattia con la quale si trovò a combattere. Alla sua morte (2014), è nata una associazione che porta il suo nome, che raccoglie colleghi di diverse generazioni, e ha lo scopo di trasmettere la preziosa eredità scientifica e culturale che Dina Vallino ci ha lasciato, fecondandola di nuove esperienze.
Alcuni contributi di Dina Vallino
La ‘Storia’ di Dina Vallino (1998) è una tecnica terapeutica di lavoro con i bambini, i quali,spontaneamente, raccontano storie per esprimere i loro vissuti. Questa tecnica ha radici teoriche nell’interesse al pensiero di Bion, quale strumento di trasformazione verso la pensabilità, offre un superamento della precedente rigorosa formazione kleiniana, raccoglie esperienze cliniche acquisite da Dina stessa e ha punti di convergenza con la tecnica narrativa di Antonino Ferro. Tale tecnica aiuta a dar voce ai bambini, permettendo anche all’analista di trovare parole adeguate per raggiungerli ( Maggioni G. 2016). Non si tratta infatti dell’analista che racconta una storia al bambino ma, al contrario, è l’analista che chiede al bambino di raccontargli la sua propria storia.
In particolare i bambini sofferenti vivono intensamente esperienze e sentimenti di non esistenza, un dolore che non può essere condiviso perché ancora non ha significato e vivono imprigionati in un altrove, in uno stato di allucinosi inavvertibile dall’esterno e che impedisce il contatto emotivo. Dina chiama questo altrove“ Luogo immaginario”. La Storia che raccontano nella stanza con l’analista permette di visualizzare ad entrambi i membri della coppia questo ambiente mentale abitato dalle paure e di ‘giocarlo’ insieme. Noi possiamo così accedere al Luogo immaginario e ai suoi abitanti: questa condivisione permette di trasformare l’atmosfera terrificante in cui è immerso il bambino. La Storia finisce quando il bambino sente di meritare attenzione, quando le sue allucinazioni, persecuzioni e angosce espresse, condivise e trasformate nella Storia, possono essere nominate a poco a poco e prendere posto come “ pensieri accanto a altri pensieri”. (Vallino D,. 1998)
Significativo è l’impegno e il rigore di Dina Vallino nell’Infant-Observation. Approfondendo la metodologia di Esther Bick, e di altri autori come Ferenczi, Balint e Winnicott per l’importanza data all’ambiente, Dina (2007,2008) fu critica rispetto ad alcuni capisaldi della cultura psicoanalitica, come il concetto di narcisismo primario, di aggressività e di invidia innate e regolatrici nella relazione del lattante con la madre e della convinzione che esista un neonato sensoriale, un “ neonato dimezzato” nel quale solo in un secondo tempo si insedierebbe la mente.(Vallino D., Macciò M. 2004) Dina crede, invece, che il neonato sia fin dall’inizio dotato di una mente e per esistere ha bisogno di una madre che lo riconosca. Qui sentiamo confluire il contributo di Bion (1963) quando l’autore afferma che il pensiero narrativo ha i suoi derivati narrativi e i suoi derivati figurali, ossia segni facciali, gestuali, cenestetici, visivi, mimici che rimandano ai vissuti inconsci del bambino piccolo. Conseguentemente, l’osservazione deve essere una osservazione partecipe deve cioè utilizzare le emozioni dell’osservatore in funzione della comprensione di ciò che viene osservato. Osservare la relazione della madre con il neonato ci può permettere di imparare a distinguere quando la madre opera una incomprensione inevitabile del suo lattante, che però può essere tollerata dal bambino, dal fraintendimento grave e ripetuto, frutto di una identificazione patologica dei genitori. L’osservatore deve accordarsi con il tempo mentale della madre e del piccolo, imparando da un lato ad attendere che la scena si illumini, dall’altro ad esercitare una raffinata attenzione che gli permetta di intercettare anche minime trasformazioni. L’Infant Observation non è finalizzata a dare consigli, tuttavia l’osservatore apprende come, pur conservando la sua neutralità, può con semplici domande o commenti riportare l’attenzione della madre sul bambino. “ Se dovessi sintetizzare il mio percorso di pensiero, dovrei fare riferimento a un paradossale salto dall’osservazione puntuale e il più possibile vicina alle influenze dell’ambiente e della famiglia sul soggetto, a una posizione del tutto eccentrica rispetto all’osservazione piuttosto visionaria e immaginativa.” (Vallino, 2005:8) Inoltre, la capacità di immergersi nell’atmosfera emotiva familiare ( voci, movimenti, sguardi, tonalità sonore che producono anche sensazioni fisiche nell’osservatore), permette di intercettare i fraintendimenti presenti e di come lo sguardo, possa svolgere una funzione di contenimento, favorendo per esempio la possibilità per la madre di ‘vedere il proprio bambino’ e per l’osservatore sviluppare un’attitudine ad una comunicazione adeguata al contesto.
La Consultazione partecipata
Attraverso questa lunga esperienza, Dina Vallino pensò di estendere alcune caratteristiche dell’Infant Observation alla consultazione bambino genitori e chiamò questo nuovo tipo di lavoro, “Consultazione partecipata.”(Vallino D.2009) La Consultazione partecipata prevede che il terapeuta incontri i genitori una prima volta da soli e poi alternativamente insieme al bambino, secondo un preciso setting che è stato ampiamente illustrato. (Vallino D. 2009) Dina Vallino ha aperto le porte della sua stanza di analisi ai genitori i quali, divenendo osservatori partecipi della relazione tra sé stessi e il figlio, possono accorgersi del loro fraintendimento e delle loro attese incongrue. Non si tratta solo di tecnica ma di una esperienza che si radica nei vissuti di ciò che noi siamo e siamo stati. E’ nella nostra infanzia che abbiamo conosciuto i primi fraintendimenti ma, se abbiamo imparato a riconoscerli, essi possono diventare l’ingrediente di una rinnovata attenzione adulta ai bimbi e ai loro genitori. Nel cuore della Consultazione partecipata vi sono le sedute congiunte e il successivo colloquio con i soli genitori.
Nella stanza con genitori e figli, già dalle prime battute, da alcuni silenzi, imbarazzi, occhiate fuggevoli possiamo cogliere l’atmosfera familiare. Spesso abbiamo l’impressione che i genitori non sappiano parlare con il bambino per capire che cosa prova ma parlino del bambino quasi come se non fosse presente. Altre volte sono pieni di attese nei confronti del figlio, ed esercitano una certa pressione perché si mostri bravo ed adeguato, assumendo una posizione direttiva nel gioco, e sostituendosi al bambino, altre volte al contrario non riescono a giocare con lui. La nostra funzione allora consiste, attraverso interventi semplificanti la complessità, dare voce al bambino permettendogli lo sviluppo di una rappresentazione. Succede di sovente che, al termine di una seduta particolarmente difficile ed enigmatica, il bambino riesca con un disegno, con un gioco o una storia a rappresentare in modo sorprendente la natura del fraintendimento familiare e a mostrare la propria sofferenza.
La Consultazione partecipata può essere anche soltanto preventiva per evitare che un disturbo reattivo per effetto del fraintendimento possa degenerare in altra patologia. Oppure, se il fraintendimento è grave e complesso, la Consultazione partecipata diviene allora una sorta di introduzione ad una terapia e permette di avvicinare un’altra possibilità di funzionamento della mente e la speranza di dare senso ai sintomi e alla sofferenza mentale.
Nota bibliografica
Dina Vallino (1941-2014) Psicoanalista con funzioni di Training, appartenente al Centro Milanese di Psicoanalisi, ha espresso un pensiero creativo e coraggioso. Dina Vallino ha svolto un incessante e appassionato lavoro di psicoanalista con bambini e genitori sviluppando preziose innovazioni nella teoria e nella tecnica, talvolta espresse con uno stile evocativo e poetico. La sua attività svolta nel profondo rispetto della sofferenza umana è stata permeata da una intensa valenza etica.
Bibliografia
Associazione Dina Vallino http://associazionedinavallino.it
AA.VV( 2001) L’Esperienza Condivisa ( a cura di Robutti A.) R.Cortina, Milano
AA.VV (2017) Una mente a più voci sulla vita e sull’opera di Dina Vallino ( a cura di Borgogno F., Maggioni G.) Mimesis, Milano
Borgogno F., Vallino D. ( 2005) << Spoilt Children>>: un dialogo tra psicoanalisti. In Quad. Psicoter.Inf.,52, Borla, Roma
Maggioni G. ( 2016) Una Storia raccontata. Fare psicoanalisi con Dina Vallino. Mimesis, Milano
Vallino D. ( 1998) Raccontami una Storia. Dalla consultazione all’analisi dei bambini. Borla, Roma
Vallino D. Macciò M.(2004) Essere Neonati. Borla
Vallino D. ( 2005) Autobiografia. Inedito.
Vallino D.( 2009) Fare Psicoanalisi con Genitori e Bambini. Borla
Weiss Edoardo

Edoardo Weiss
A cura di Rita Corsa
Maestri della psicoanalisi
Weiss, Edoardo (Trieste, 21 settembre 1889 – Chicago, 14 dicembre 1970)
Edoardo Weiss – definito da Freud l’«autentico, tenace pioniere» della psicoanalisi italiana (1930) – si impegnò ad introdurre la “novella scienza”, misurandosi sin dagli inizi con l’ostilità degli ambienti medico-scientifici, religiosi e politici. Weiss ebbe lo straordinario merito di aver voluto e saputo perseguire con fermezza il progetto per lui imprescindibile di diffondere le idee freudiane e di riorganizzare la Società Psicoanalitica Italiana. Un traguardo realizzato fronteggiando la durezza dei tempi e le proprie personali fragilità. Non vi è dubbio che il primo periodo della psicoanalisi italiana s’identifichi con il pensiero e l’opera di questo indomito antesignano.
La vita
Edoardo Weiss, nato a Trieste il 21 settembre 1889, era il terzogenito dei nove figli (quattro maschi e cinque femmine) della triestina Fortuna Jacchia, di origine sefardita, e di Ignazio Weiss, un imprenditore oleario di origine ebraico-boema, ben assimilato alla comunità locale.
La famiglia d’origine di Edoardo Weiss
(In piedi, da sn. a dx.: Paola, Giorgina, Ottocaro, Ida, Gemma, Edoardo;seduti, da sn. a dx.: Ernesto, la madre Fortuna, il padre Ignazio e Amalia;manca il minore dei figli maschi, Giorgio, morto in giovane età)
L’educazione dei giovani Weiss, perfettamente bilingui (italiano e tedesco), fu perfezionata all’estero, secondo le consuetudini delle altre famiglie della borghesia mercantile ebraica triestina.
Edoardo si trasferì a Vienna nel 1908 per studiare medicina. Nelle aule universitarie incontrò la futura moglie, Vanda Shrenger – un’ebrea croata che divenne la prima pediatra di formazione psicoanalitica ad esercitare in Italia e che contribuì attivamente alla creazione del movimento psicoanalitico nel nostro Paese. Negli anni universitari Edoardo e Vanda frequentarono, insieme, le lezioni svolte da Sigmund Freud presso l’ateneo viennese.
Il 7 ottobre 1908, nello studio di Berggasse 19, Edoardo Weiss fece la conoscenza personale del Maestro, che gli suggerì di entrare in analisi con Paul Federn, uno dei suoi primi e più fedeli discepoli. L’analisi cominciò nel marzo del 1909 e durò circa un anno e mezzo a sei sedute settimanali; proseguì, poi, per altri 2-3 mesi a tre sedute alla settimana (Roazen, 2005). Il rapporto analitico si trasformò ben presto in una collaborazione professionale e in una forte amicizia, destinate a durare per tutta la vita.
Nel 1913, prima ancora di conseguire la laurea (1914), Weiss entrò a far parte della Società Psicoanalitica Viennese, di cui rimase membro sino al 1932, l’anno in cui spostò l’iscrizione alla Società Psicoanalitica Italiana, da lui appena rinnovata a Roma.
Allo scoppio della Grande Guerra, lo psicoanalista triestino fu richiamato nell’esercito austro-ungarico, ed inviato come ufficiale medico al fronte orientale, destino comune ai cittadini dell’Impero di nazionalità italiana. Pare certo, comunque, che Edoardo condividesse sinceramente quell’attaccamento all’Italia che prevaleva nella borghesia triestina, inclusa quella di ascendenza israelita (Archivio Livio Saranz, Trieste).
Edoardo Weiss con il fratello minore, Ottocaro, in divisa militare (Radkersburg, 5 novembre 1916)
Nel 1917, in pieno conflitto mondiale, Edoardo e Vanda contrassero matrimonio e nell’ottobre dell’anno successivo nacque il loro primogenito, Emilio, che vide la luce nel tumulto e nel disordine estremi che seguirono alla disgregazione del potere imperiale.
Edoardo e Vanda Weiss, nei primi anni Venti
Nell’autunno del 1919, subito dopo la fine delle ostilità, i coniugi Weiss rientrarono a Trieste, divenuta italiana. Il 4 ottobre 1919 Edoardo fu assunto come psichiatra (“medico secondario”) nel reparto maschile del locale frenocomio civico, “Andrea di Sergio Galatti”, inaugurato da circa un decennio. Nel contempo aprì uno studio privato in Via San Lazzaro 8, dove avviò l’esercizio della psicoanalisi, sotto la diretta supervisione di Sigmund Freud e di Paul Federn (Weiss, 1970).
L’esperienza frenocomiale
Inaugurazione a Trieste del Frenocomio Civico ed Ospizio (“Andrea di Sergio Galatti”) per malati di mente, costruito su progetto del goriziano Ludovico Braidotti (Novembre 1908).
All’epoca dell’arrivo di Weiss, nell’ospedale triestino imperava il modello organicista, anche se prevaleva un umanitarismo illuminato sul diffuso custodialismo di matrice lombrosiana, ratificato dalla legge del 1904 sui manicomi e sugli alienati. Il direttore dell’Istituto era Luigi Canestrini, un luminare della psichiatria locale, celebrato dallo stesso Italo Svevo nella Coscienza di Zeno (1923). Alla morte di Canestrini, avvenuta nel 1926, dopo un breve interregno di Guglielmo de Pastrovich, subentrò Giovanni Sai, un medico dagli ideali riformisti, che però dovette scontrarsi con le pesanti limitazioni introdotte dal regime fascista, che gradualmente impose ai dipendenti pubblici, medici compresi, di iscriversi al partito e di italianizzare il loro cognome. Nella seconda metà degli anni venti anche Weiss risentì duramente dell’appesantirsi del clima politico.
Edoardo Weiss ha lasciato modestissime tracce epistolari del primo lustro trascorso nel manicomio cittadino. Nelle sue memorie e nel carteggio con Freud (Sigmund Freud as a consultant, 1970) non vi è alcun richiamo in merito; qualche informazione è reperibile, a partire dalla metà degli anni Venti, soprattutto nelle lettere scambiate con Paul Federn e conservate nell’Archivio Weiss dell’A.S.P.I. (Università Milano-Bicocca) (1). È rimasta, invece, una ricca testimonianza clinica del suo passaggio ospedaliero: si tratta di oltre 340 cartelle cliniche, custodite nell’Archivio di Stato di Trieste (Corsa, 2013 e 2014). Nel redigere le cartelle sanitarie, egli mantenne sempre una posizione fermamente neurologico-psichiatrica, seppur nobilitata da una grande vivacità descrittiva e da una raffinata cura nella ricostruzione anamnestica – prezioso lascito della nosologia psichiatrica tedesca e della corrente fenomenologica francese. La sua già solida formazione psicoanalitica non emergeva in alcuna pagina (2). D’altronde i neuropsichiatri di Trieste, laureatisi quasi tutti a Vienna, a Graz o a Berlino, pur conoscendo i saggi di Freud, li accolsero con diffidenza, diversamente da quanto avvenne nell’enclave culturale e letteraria cittadina, catturata dalle idee rivoluzionarie della nuova scienza. Weiss patì profondamente l’isolamento cui fu condannato come psicoanalista dalla medicina ufficiale cittadina. Ma, nonostante il conflitto umano e professionale che lo attanagliava, egli continuò a professare con rigore e competenza il mestiere di psichiatra. I direttori che si succedettero alla guida del frenocomio apprezzavano il suo operato e, ogni anno, gli rinnovavano il contratto ospedaliero, come testimoniato da altre carte amministrative custodite negli Archivi di Stato locali. Nel 1927 ricevette una promozione a “medico di sezione”, motivata dal “lodevole servizio prestato fin dal 1919 quale medico secondario”, e nel 1928 gli venne proposto di ricoprire il ruolo di primario neuropsichiatra, ma alla condizione di italianizzare il suo cognome, come imposto dalle normative fasciste inerenti il pubblico impiego. Weiss controbatté con grande coraggio e dignità ai diktat fascisti e all’opposizione delle istituzioni scientifiche e mediche: si licenziò dall’ospedale e si rifiutò di cambiare il cognome, distinguendosi da tanti altri colleghi giuliani dal cognome tedesco o slavo, che non esitarono ad obbedire alle umilianti direttive del regime. Nel gennaio 1929 abbandonò definitivamente l’istituzione, non solo per soddisfare un sentimento di decoro e di coerenza etica, ma anche per potersi dedicare completamente alla divulgazione delle teorie freudiane in Italia.
Lettera di accoglimento delle dimissioni di Edoardo Weiss (gennaio 1929 – Provincia di Trieste)
Questa decennale, fondante esperienza ospedaliera consentì tuttavia a Weiss di sviluppare un pionieristico interesse per i disturbi psichici severi, grazie pure alla decisiva influenza di Paul Federn, che lo sensibilizzò ai problemi teorico-clinici connessi alla struttura dell’Io e alle psicosi. La ricca casistica frenocomiale gli offrì lo spunto per indagare le dinamiche narcisistiche e i meccanismi introiettivi e proiettivi nelle psicosi, avventurosamente descritti in due articoli degli anni Venti, che per importanza e originalità spiccano nella sua produzione scientifica e che anticipano diversi concetti cardine della sua successiva teoretica.
Nel periodo ospedaliero, Weiss pubblicò inoltre diversi elaborati d’argomento psichiatrico e psicoanalitico su periodici specialistici italiani, in particolare sulla rivista di Levi Bianchini, l’Archivio Generale di Neurologia, Psichiatria e Psicoanalisi (3). Questi contributi avevano specialmente finalità divulgative e di difesa dagli attacchi sferrati dalle “autorità consacrate” italiane alla nuova disciplina freudiana (Weiss, 1921, 1922, 1923-24 e 1926). Tra essi risalta Psichiatria e Psicoanalisi (riassunto nel 1925, poi ampliato nel 1926), in cui egli cerca di proporre una nutriente osmosi tra le due discipline, nel tentativo, forse, di sanare quella feroce dicotomia che egli stesso sperimentava quotidianamente nel suo ambiente lavorativo.
A Trieste, invero, il futuro cofondatore della psicoanalisi italiana non riuscì mai a radunare intorno a sé una cerchia di allievi. L’unica, solida figura che ebbe sempre al suo fianco fu la moglie, medico a sua volta. Vanda sostenne il marito in tutte le sue difficili, e a volte drammatiche, scelte professionali e di vita, lo soccorse nei momenti di bisogno, gli fece da contrappunto teorico e professò anch’ella la psicoanalisi, prima donna nel nostro Paese, rimanendo tuttavia sempre all’ombra del grande consorte.
Degli ultimi anni trascorsi a Trieste resta la raccolta di cinque conferenze di psicoanalisi tenute da Weiss dal febbraio al giugno del 1930, su invito dell’Associazione Medica Triestina, unica concreta manifestazione d’interesse da parte dell’establishment scientifico cittadino nei confronti della nuova dottrina (4). I seminari triestini ricevettero un riscontro assai positivo e vennero allora riuniti da Weiss in un manuale, Elementi di psicoanalisi, summa del pensiero freudiano. Furono stampati dall’editore Hoepli nel 1931, con una benaugurale prefazione di Sigmund Freud (1930).
Nello stesso periodo egli fu inoltre impegnato nel soddisfare la richiesta dell’allora «ministro dell’istruzione Prof. Giovanni Gentile», che l’aveva invitato «a redigere per l’imponente “Enciclopedia italiana” le voci “Freud” e “la psicoanalisi” (e pure 20 righe sulla ψα dei sogni, sotto la voce “sogno”» (Weiss a Federn; Trieste, 26 novembre 1930). La stesura di questi lemmi per la Treccani favorì il primo contatto tra lo psicoanalista triestino ed Emilio Servadio, che faceva parte del corpo redazionale dell’Enciclopedia e che si era prodigato per ottenere la collaborazione di Weiss.
Weiss dovette però lasciare Trieste, dove mancavano proseliti e la nomenclatura medica manteneva un atteggiamento d’ostilità. Nei primi anni Trenta, inoltre, il clima politico nella città giuliana era diventato greve, a causa del manifestarsi di forme esasperate di nazionalismo, che si traducevano in campagne xenofobe nei confronti soprattutto delle componenti slave, di cui faceva parte anche la consorte croata. Sconsolati e con qualche problema economico, nel settembre del 1931 i coniugi Weiss si trasferirono a Roma, preferita agli altri centri italiani per le promettenti prospettive lavorative prefigurate dal grande cattedratico Sante de Sanctis e per i proficui contatti già avviati da Edoardo con Servadio.
Gli anni romani e l’America
Nella capitale, ben presto Weiss raccolse uno sparuto gruppo di seguaci e, già nell’anno successivo, ricostituì insieme a Vanda Shrenger, Perrotti, Servadio, Musatti e pochi altri, la Società Psicoanalitica Italiana – già fondata nel 1925 con Marco Levi Bianchini – e dette vita alla Rivista Italiana di Psicoanalisi, ambedue con sede in Via dei Gracchi 328-A, l’abitazione privata dei Weiss. Lo psicoanalista triestino fu il primo Presidente della rinata Società e il primo Direttore della Rivista.
Edoardo Weiss, Emilio Servadio e Nicola Perrotti (Congresso Internazionale di Lucerna, 1934).
Negli anni romani, l’impegno dei coniugi Weiss e dei pochi membri della SPI fu intenso e costantemente teso a radicare la nuova disciplina nel tessuto medico, psicologico e culturale della capitale, con frequenti riunioni scientifiche, pubblicazioni originali su periodici italiani e stranieri, traduzioni dei testi freudiani e di saggi dei maggiori psicoanalisti europei, attività di formazione per gli aspiranti soci e la partecipazione ufficiale a tre congressi internazionali di psicoanalisi (Wiesbaden nel 1932, Lucerna nel 1934 e Marienbad nel 1936) (5). L’infaticabile dinamismo del gruppo freudiano ebbe come esito l’ammissione della Società Psicoanalitica Italiana all’Associazione Psicoanalitica Internazionale (IPA), nel 1936.
Ma i tempi erano funesti. Nello stesso periodo, infatti, la SPI dovette far fronte a un’opposizione crescente della chiesa cattolica – che tacciava la psicoanalisi di “immoralità” e di “pornografia” – e del regime fascista, contrario alla sua espansione in quanto dottrina proveniente da un paese straniero, sostenuta da scienziati di origine ebraica e orientata politicamente a sinistra. Già nel 1934 la Rivista Italiana di Psicoanalisi fu obbligata a chiudere i battenti e, nel 1938, la stessa SPI fu sciolta, con la motivazione ufficiale di essere affiliata all’IPA – sospettata di svolgere attività politica clandestina. A nulla valsero i contatti di Edoardo Weiss con alcuni rappresentanti delle alte gerarchie del regime. Weiss aveva, infatti, in analisi da molti anni Concetta Forzano, la figlia del drammaturgo Giovacchino Forzano, l’apologeta del Duce e, per un breve periodo, anche un nipote di Mussolini (6). Soprattutto Forzano aveva in più occasioni intercesso a favore di Weiss e del movimento psicoanalitico italiano, anche chiedendo l’interessamento diretto di Galeazzo Ciano (Zapperi, 2013). Ma tanti sforzi risultarono vani e, con la promulgazione delle leggi razziali nel 1938, il gruppo italiano si disperse.
Nel gennaio 1939 Edoardo Weiss migrò per sempre in America, portando con sé il figlio Emilio, studente di medicina; il 2 ottobre 1939 la moglie Vanda li raggiunse col secondogenito, Guido (nato a Trieste nel dicembre 1929). Pochi giorni dopo la famiglia Weiss, finalmente ricongiunta, raggiunse Topeka (Kansas), la cittadina nel cuore degli Stati Uniti dove Edoardo, grazie all’appoggio di Alexander e di Brill (che gli aveva generosamente fornito l’affidavit per l’espatrio in America), aveva ottenuto un posto di psicoanalista presso la celebre Menninger Clinic.
Edoardo Weiss con i figli Emilio e Guido (Chicago, primi anni Cinquanta)
Nel 1942 la famiglia Weiss (7) si spostò definitivamente a Chicago, dove Edoardo entrò a far parte del gruppo docente del Chicago Institute of Psychoanalysis, guidato da Franz Alexander. Dal 1959 al 1961 Weiss fu Visiting Professor al Dipartimento di Psichiatria dell’Università Marquette di Milwaukee. Proseguì con generosità e lealtà intellettuale la sua professione di psicoanalista sino al 1970, l’anno della morte.
Il contributo teorico di Edoardo Weiss
Edoardo Weiss è stato fondamentalmente un clinico, con un’incrollabile fiducia nello strumento curativo della psicoanalisi, sia per il trattamento delle patologie nevrotiche che di quelle psicotiche.
Nei primi anni della sua produzione scientifica, egli fu soprattutto occupato a propagandare il pensiero freudiano, come testimoniato da alcune traduzioni dei saggi del Maestro e dalla raccolta delle sue lezioni triestine nel volume Elementi di psicoanalisi (1931), la prima opera sistematica apparsa in Italia. Ma l’intimo sodalizio umano e scientifico con Paul Federn portò Weiss ad approfondire le dinamiche relazionali d’oggetto e l’approccio fenomenologico alla struttura dell’Io e alle malattie tipiche dell’Io, i disturbi narcisistici e le psicosi. Tali interessi si espressero già nei suoi scritti degli anni manicomiali (Su una fase non ancora descritta dell’evoluzione verso l’amore eterosessuale, 1925 e Il delirio di veneficio alla luce dei processi di introiezione-proiezione, 1926). Lo studio di un eccezionale caso clinico manicomiale, in cui sintomi melanconici coesistevano con sintomi paranoidi, permise a Weiss di indagare la «dinamica introiettiva» che, per l’inconscio, equivale ad una «incorporazione orale». Tanto il melanconico che il paranoide sono fermamente convinti di essere perseguitati da qualche cosa di introiettato (l’«introietto» weissiano): la stessa melanconia, infatti, può essere concepita come un delirio di persecuzione, dove il malato si trova ad essere perseguitato dalla propria coscienza. In questo scritto Weiss utilizzò per la prima volta nella letteratura psicoanalitica il termine di «identificazione proiettiva», anticipando di circa un ventennio le concettualizzazioni kleiniane.
Tali osservazioni furono riproposte da Weiss in un articolo tardivo, Vicissitudes of Internalized Objects in Paranoid Schizophrenia and Manic-depressive State (1963), dove l’autore sviluppò ulteriormente i concetti di identificazione e di passaggio attraverso l’Io, attinti in buona parte dalla Psicologia dell’Io di Federn. Per Federn e Weiss, i limiti egotizzati dell’Io sono mobili e flessibili e demarcano le frontiere corporee e mentali, interne ed esterne dell’Io. Nelle psicosi, l’Io è debole e danneggiato, e le frontiere dell’Io sono fragili e inadeguate a costituire «una barriera insormontabile alle forti pressioni interne degli stimoli psichici», provenienti dall’Es e dalla realtà esterna (Federn, 1952).
Tuttavia, i più noti contributi clinico-dottrinali dello psicoanalista triestino hanno come oggetto l’intima struttura e l’eziologia dell’asma bronchiale e dell’agorafobia.
Il suo articolo Die Psychoanalyse eines Falles von nervòsem Asthma (Psicoanalisi di un caso di asma nervosa), risalente al 1922, lo segnala come un precorritore della medicina psicosomatica. L’interpretazione del sintomo asmatico offerta da Weiss in una cornice teorica rigorosamente freudiana diventò un punto di riferimento nelle successive ricerche di Alexander, il padre della psicosomatica, con il quale Weiss collaborò negli anni americani.
Nel 1936 Weiss pubblicò Agorafobia, isterismo d’angoscia, dove marcava le differenze tra l’isteria e l’agorafobia in un’ottica ancora pulsionale. A differenza delle altre fobie Weiss, per primo, considerò i sintomi agorafobici non solo e non tanto in relazione ad un contenuto rimosso, bensì determinati da una situazione soggettiva, da un’organizzazione della personalità stessa e dell’Io, inquadrabili all’interno del complesso concetto di nevrosi d’angoscia.
Nei successivi studi, Agoraphobia in the Light of Ego Psychology (1964) e La formulazione psicodinamica dell’agorafobia (1966), Weiss integrò i suoi classici principi teorici con gli assunti della psicologia dell’Io di Federn, proponendo un modulo interpretativo estremamente attuale di decodifica della problematica agorafobica.
La sua opera più significativa e completa, Structure and dynamics of the human mind (1960), maturo compendio della propria metapsicologia, pare rappresentare proprio l’estremo sforzo di concepire un nuovo, comprensivo, modello psicoanalitico, dove la teoretica dell’Io di Federn tentava una conciliazione con le tesi freudiane, favorendo innovative ricadute anche a livello di tecnica analitica.
Un cruccio, quello di rimanere fedele ad entrambi i Maestri, che accompagnò Edoardo Weiss per tutta la vita.
Note
(1) Il carteggio tra Edoardo Weiss e Paul Federn è conservato tra le Papers di Weiss (Edoardo Weiss Papers), presso i Freud Archives della Library of Congress di Washington, che ha consentito all’ASPI – Archivio Storico della Psicologia Italiana – di digitalizzarlo e di renderlo consultabile on-line. L’epistolario tra Weiss e Federn è riprodotto in lingua originale (tedesco). Le sottolineature riportate in alcuni passaggi sono di Edoardo Weiss.
(2) L’autorevolezza di Weiss in campo psicoanalitico gli fu ampiamente riconosciuta già nell’ottobre del 1923, quando l’Associazione Italiana di Psicologia lo invitò a tenere una conferenza sulla psicoanalisi in occasione del Congresso di Firenze. Freud approvò con entusiasmo l’intervento dello psicoanalista triestino, profetizzando grandi fortune per la psicoanalisi in Italia, grazie al prezioso e competente apostolato promosso da Weiss (lettera di Freud a Weiss del 1° novembre 1923; in Weiss, 1970).
(3) Il professor Marco Levi Bianchini, dapprima direttore dell’Ospedale Psichiatrico di Nocera Inferiore e, poi, di quello di Teramo, fu tra i primi divulgatori della psicoanalisi in Italia.
Nel 1920, a Nocera Inferiore, Levi Bianchini dette origine alla Rivista Archivio Generale di Neurologia e Psichiatria, che doveva servire come organo di informazione e di ricerca in queste speciali branche. Nel 1921 il periodico si trasformò nell’Archivio Generale di Neurologia, Psichiatria e Psicoanalisi, e cominciò a raccogliere contributi di carattere psicoanalitico, italiani e stranieri. Pubblicò le traduzioni di diversi saggi freudiani e ospitò molti articoli di Edoardo Weiss.
Levi Bianchini fu inoltre il primo fondatore della Società Psicoanalitica Italiana. La SPI nacque a Teramo il 7 giugno 1925, su sua iniziativa e con la partecipazione di altri 12 medici, tra cui Edoardo Weiss, che fu eletto Presidente. Levi Bianchini ricoprì la carica di Segretario. Nel 1926 l’Archivio Generale di Neurologia, Psichiatria e Psicoanalisi divenne l’organo ufficiale della neonata Società Psicoanalitica Italiana e dedicò un numero monografico a Freud, in occasione del suo settantesimo compleanno.
Dotata di misere risorse economiche ed umane, collocata in una regione periferica, costituita per lo più da psichiatri del tutto digiuni di psicoanalisi, la SPI non esercitò alcuna influenza rilevante nella cultura del tempo e, nel maggio del 1928, sospese ogni attività, sino all’ottobre del 1931, dopo il trasferimento della sede sociale a Roma.
(4) A Trieste la psicoanalisi si presenta ufficialmente nel settembre del 1925, quando la città ospita il XVII Congresso Nazionale della Società Freniatrica Italiana. Edoardo Weiss viene invitato dallo stesso Enrico Morselli, «il celebre, anziano psichiatra di Genova» (Weiss, 1970), al tempo presidente della Società Freniatrica Italiana, a esporre una relazione sulla psicoanalisi. L’intervento di Edoardo Weiss porta l’emblematico titolo Psichiatria e Psicoanalisi. La relazione desta molto interesse, eppure al termine della seduta congressuale di Weiss, Morselli si comporta malamente, chiudendo il dibattito con delle critiche pesanti a Freud e alla psicoanalisi e alterando quei concetti che lo psicoanalista triestino gli aveva ripetutamente spiegato anche in un loro precedente, fitto carteggio. «Lo psichiatra triestino ed insieme a lui altri psichiatri presenti al Congresso, tra cui in primo luogo Marco Levi Bianchini, fervido quanto instancabile sostenitore di Freud, furono molto irritati dall’atteggiamento scorretto di Morselli, che Weiss non esita a definire nei suoi ricordi “ipocrita” e “falso”» (Accerboni Pavanello, 1985).
(5) Si segnala che, dal settembre 1937 a tutto l’anno seguente, Edoardo Weiss si sottopose ad un’altra tranche analitica con Ernest Bernhard, l’analista junghiano di estrazione israelita, trasferitosi a Roma nei primi mesi del 1937. Vanda Shrenger svolse la sua analisi personale con lo stesso Bernhard, dal 2 febbraio 1937 al 9 marzo 1939.
(6) «Al momento ho un paziente molto interessante: (per inciso: il nipote di quel signore, al quale Freud mandò il suo libro con dedica)» (Lettera di Weiss a Federn; Roma, 11 gennaio 1934).
Qui Weiss allude all’ormai notissimo e assai discusso episodio che vide Freud far pervenire a Mussolini una copia con dedica del suo libro Warum Krieg? (1933). Il Maestro viennese consegnò il volume a Giovacchino Forzano, quando costui aveva accompagnato la figlia, insieme a Weiss che l’aveva in analisi, per un consulto da Freud.
Il caso di Concetta Forzano viene ampiamente descritto da Weiss nel saggio Agoraphobia and its relation to hysterical attacks and to traumas (1935) e in La formulazione psicodinamica dell’agorafobia, pubblicato nel 1966 sulla Rivista di Psicoanalisi, dove l’identità della giovane viene celata dietro il nome di Ethel.
Per approfondimenti rimando allo stesso Weiss dell’epistolario con Freud (1970), ad Accerboni (1988), Carloni (1989), Roazen (1992 e 2005), Zapperi (2013) e Corsa (2014).
(7) Nel 1951 Vanda ed Edoardo adottarono Marianna, una nipote di 9 anni. La notte dell’antivigilia di Natale del 1941, i militanti dell’Ustasha – il movimento nazionalista croato di estrema destra, fondato da Ante Pavelić negli anni Venti, che si opponeva al Regno di Jugoslavia dominato dall’etnia Serba – irruppero in Pakrac, la città croata dove ancora vivevano i familiari di Vanda Shrenger, e deportarono gli ebrei nei campi di concentramento di Djakovo e di Jasenovac, dove morirono trucidati o di stenti. I membri della famiglia Shrenger colà residenti non scamparono all’eccidio: il fratello maggiore di Vanda, Jacques (Jacob), e sua moglie furono tra le vittime, così come i due loro primogeniti adolescenti. La terzogenita, Marianna, era nata da meno di due settimane (10 dicembre 1941); si salvò perché fu affidata ad una zia acquisita non ebrea, che la portò a Zagabria, dove venne cresciuta da un’altra zia paterna. Nel 1951, fu fatta migrare negli Stati Uniti, dove fu accolta da Vanda ed Edoardo, divenendone la terza figlia («fully adopted daughter») (Corsa, 2014 e 1015).
Cronologia essenziale degli scritti di Edoardo Weiss
Weiss E. (1914). Totemmaterial in einen Traume. Internationale Zeitschrift für Ärztliche Psychoanalyse, 2, 159-164.
Weiss E. (1914). Zur vergleichenden Anatomie des Facialiskerns. Arbeiten Neurologische Institute, Wiener Universität, 21, 51-78.
Weiss E. (1915). Beobachtung infantiler Sexualäusserungen. Internationale Zeitschrift für Ärztliche Psychoanalyse, 3, 106-109.
Weiss E. (1920). Italian Literature. Int. J. Psycho-Anal., 1, 455-456.
Weiss E. (1921). La “psicoanalisi selvaggia” di Sigmund Freud. Archivio Generale di Neurologia, Psichiatria e Psicoanalisi, 2, 113-119.
Weiss E. (1922). Psychoanalyse eines falles von nervösem asthma. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, 8, 440-455.
Weiss E. (1922). Alcuni concetti fondamentali della psicoanalisi. Rivista Sperimentale di Freniatria, XLV, 329-407.
Weiss E. (1923-1924). Su alcuni concetti psicologici fondamentali della psicoanalisi. Archivio Generale di Neurologia, Psichiatria e Psicoanalisi, III-IV, 23-38.
Weiss E. (1923-24). Su alcune critiche di autori italiani in tema di psicoanalisi. Archivio Generale di Neurologia, Psichiatria e Psicoanalisi, 4-5, 129-139.
Weiss E. (1924). Zum psychologischen Verständnis des “arc de cercle”. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, 10, 4, 438-439.
Weiss S. (1925). Psichiatria e Psicoanalisi. Quaderni di Psichiatria, 12, 206-208.
Weiss E. (1925). Über eine noch nich beschriebene Phase der Entwicklung zur heterosexuellen Liebe. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, 11, 429-443.
Weiss E. (1926). Unübertragharkeit der Impfmalaria durch Anophelen. Wiener klinischen Wochenschrift, 52, 1-2.
Weiss E. (1926). Der Vergiftungswhan im Lichte der Introjektion und Projektionvorgänge. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, 12, 466-477.
Weiss E. (1926). Il simbolismo psicoanalitico. Archivio Generale di Neurologia, Psichiatria e Psicoanalisi, 7, 121-153.
Weiss E. (1926). Psichiatria e psicoanalisi. Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale delle alienazioni mentali, 50, 442-472.
Weiss E. (1929). Le origini dei sentimenti sociali e religiosi dal punto di vista psicoanalitico. Archivio Generale di Neurologia, Psichiatria e Psicoanalisi, 10, 1, 19-47.
Weiss E. (1929). L’XI Congresso Psicoanalitico Internazionale (Oxford, Inghilterra, 27-31 Luglio 1929). Archivio Generale di Neurologia, Psichiatria e Psicoanalisi, 10, 308-315.
Weiss E. (1931). Elementi di psicoanalisi. Milano, Hoepli (Pordenone, Studio Tesi, 1985).
Weiss E. (1931). Il castigo nell’educazione. Archivio generale di Neurologia, Psichiatria e Psicoanalisi, 12, 208-216.
Weiss E. (1932). Il delitto considerato come equivalente dell’autoaccusa. Giustizia penale, I, 36-39.
Weiss E. (1932). Libido ed aggressione. Rivista Italiana di Psicoanalisi, 1, 3-19.
Weiss E. (1932). Il delitto, conseguenza psicologica del bisogno di confessione. Rivista Italiana di Psicoanalisi, 2-3, 167-175.
Weiss E. (1932). Alcune considerazioni sulle resistenze psichiche. Rivista Italiana di Psicoanalisi, 2-3, 114-130.
Weiss E. (1932). Di alcuni casi particolari di traslazione. Rivista Italiana di psicoanalisi, 4, 213-217.
Weiss E. (1932). Dolore fisico e dolore psichico. Rivista Italiana di Psicoanalisi, 6, 381-394.
Weiss E. (1932). Fondamenti della psicoanalisi. Giustizia Penale, I, 281-287.
Weiss E. (1933). Il Super-Io. Rivista Italiana di Psicoanalisi, 1, 27-41.
Weiss E. (1933). L’analisi di un caso di ereutofobia. Rivista Italiana di Psicoanalisi, 2, 99-110.
Weiss E. (1933). Clinical Communications—A Recovery from the Fear of Blushing. Psychoanal. Q., 2, 309-314.
Weiss E. (1933). Albert Einstein und Sigmund Freud. Warum Krieg?. Rivista Italiana di Psicoanalisi, 2, 142-145.
Weiss E. (1934). La parte inconscia dell’Io. Rivista Italiana di Psicoanalisi, 1, 3-23.
Weiss E. (1934). Bodily pain and mental pain. Int. J. Psycho-Anal., 15, 1, 117-129.
Weiss E. (1935). Todestrieb und Masochismus. Imago, 21, 393-411 (Istinto di morte e masochismo. Riv. Psicoanal., 1, 69-93, 1972).
Weiss E. (1935). Agoraphobia and its Relation to Hysterical Attacks and Traumas. Int. J. Psycho-Anal., 16, 59-83.
WEISS E. (1936). Saggi di psicoanalisi in onore di Sigmund Freud. Biblioteca Psicoanalitica Internazionale. Serie Italiana, 8, Roma, Cremonese.
Weiss E. (1936). Agorafobia, Isterismo d’Angoscia. Roma, Paolo Cremonese.
Weiss E. (1939). The psychic presence. Bulletin of the Menninger Clinic, 3, 177-183.
Weiss E. (1942). Emotional memories and acting out. Psychoanal. Q., 11, 4, 477-492.
Weiss E. (1942). Psychic defence and the technique of its analysis. Int. J. Psycho-Anal., 23, 2, 69- 80.
Weiss E. (1944). Clinical aspects of depression. Psychoanal. Q., 13, 4, 445-461.
Weiss E. (1947). Projection, extrajection and objectivation. Psychoanal.Q., 16, 357-377.
Weiss E. (1951). Paul Federn’s scientific contributions: In commemoration. Int. J. Psycho-Anal., 32, 283-290.
Weiss E. (1952). History of metapsychological concepts. In: Alexander F., Ross H. (Eds.), Dynamic Psychiatry. Chicago, University of Chicago Press.
Weiss E. (1952). Introduction. In: Federn P., Ego psychology and the psychoses (edited and with and introduction by E. Weiss, 1-21). New York, Basic Books (Psicosi e psicologia dell’Io. Torino, Boringhieri, 1976).
Weiss E. (1953). Federn’s Ego Psychology and its Application to Agoraphobia. J. Am. Psychoanal. Assn., 1, 614-628.
Weiss E. (1957). The phenomenon of “Ego passage”. J. Am. Psychoanal. Assn., 5, 2, 267-281. Weiss E. (1958). Bisexuality and Ego structure. Int. J. Psycho-Anal., 39, 2-4, 91-97.
Weiss E. (1960), The Structure and Dynamics of the Human Mind. New York-London, Grune & Stratton (Struttura e dinamica della mente umana. Milano, Cortina, 1991).
Weiss E. (1963). Vicissitudes of Internalized Objects in Paranoid Schizophrenia and Manic depressive States. Psychoanal. Rev., 5, 588-603 (Vicissitudini degli oggetti internalizzati nella schizofrenia paranoide e nelle affezioni maniaco-depressive. Psiche, II, 1, 1965).
Weiss E. (1964). Agoraphobia in the Light of Ego Psychology. New York-London, Grune & Stratton.
Weiss E. (1966). Paul Federn (1871-1950). The theory of the psychosis. In: Alexander F., Eisenstein S., Grotjahn M. (Eds.), Psychoanalytic pioneers. New York, Basic Books.
Weiss E. (1966). La formulazione psicodinamica dell’agorafobia. Riv. Psicoanal., 3, 239-251.
Weiss E. (1970). Sigmund Freud as a consultant. New York, Intercontinental Medical Book (Sigmund Freud come consulente. Roma, Astrolabio, 1971).
Bibliografia essenziale sulla vita e l’opera di Edoardo Weiss
Accerboni Pavanello A.M. (1985). Nota bibliografica – Scritti di Edoardo Weiss. In: Weiss E. (1931), Elementi di psicoanalisi. Pordenone, Studio Tesi.
Accerboni A.M. (1988). Pychanalyse et fascisme: deux approches incompatibles. Le role diffile d’Edoardo Weiss. Revue Internationale d’Histoire de la Psychanalyse, 1, 15-29.
Accerboni A.M. (1997). Marco Levi Bianchini e Edoardo Weiss: un insolito sodalizio alle origini della psicoanalisi in Italia. In: Di Chiara G., Pirillo N. (a cura di), Conversazione sulla psicoanalisi. Napoli, Liguori.
Accerboni A.M. (1998). Vittorio Benussi e Edoardo Weiss a confronto sull’inconscio. Riv. Psicoanal., 4, 813-833.
Accerboni A.M. (2002). Trieste nella psicanalisi. Trieste, Lint.
Accerboni Pavanello A.M., Corsa R. (1987). Tra psichiatria e psicoanalisi: il contributo teorico e clinico di Edoardo Weiss. In: Accerboni A.M. (a cura di), La cultura psicoanalitica. Atti del Convegno. Trieste 5-8 dicembre 1985. Pordenone, Studio Tesi.
Andri A., Catalan T., Urso S., Verrocchio A. (2007). Le carte dei Weiss. Una famiglia tra ebraismo e impegno politico. Trieste, La Mongolfiera Libri.
Bellanova P. (1982). Le due Gradive. Roma, C.E.P.I.
Carloni G. (1989). Freud e Mussolini, un dramma in due atti, un interludio e cinque personaggi. In: Novelletto A., Viola E.G., Rovigatti F. (a cura di), L’Italia nella psicoanalisi. Catalogo della Mostra tenuta a Roma nel 1989. Roma, Istituto della Encliclopedia Italiana.
Corsa R. (2012). Edoardo Weiss e la Grande Guerra. Cartelle dal manicomio (Trieste, 1919/1928). In: Al di là della rimozione: segnali dall’inconscio non rimosso. Psicoanalisi e Metodo. XI, Pisa, ETS, 195-228.
Corsa R. (2013). Edoardo Weiss psichiatra a Trieste. Inediti dagli archivi manicomiali e dal carteggio con Paul Federn. Riv. Psicoanal., 2, 437-460 (Edoardo Weiss, psychiatrist in Trieste, Italy. Unpublished material from the asylum archives and from his correspondence with Paul Federn. The Italian Psychoanalytic Annual, 2014, 8, 113-133).
Corsa R. (2013). Edoardo Weiss a Trieste con Freud. Alle origini della psicoanalisi italiana. Roma, Alpes.
Corsa R. (2014). I NO che segnarono le origini della psicoanalisi italiana. Psiche, 2, 515-528.
Grotjahn M. (1970). Introduzione. In: Weiss E., Sigmund Freud come consulente. Roma, Astrolabio, 1971.
La Scala M. (2004). Edoardo Weiss, Trieste, la Rivista. Riv. Psicoanal., 1, 61-65.
Pollock, G.H. (1971). Edoardo Weiss, M.D-1889-1970. The Psychoanal. Q., 40, 708-709.
Roazen P. (1992). Questioni di etica psicoanalitica: Edoardo Weiss, Freud e Mussolini. In: Haynal A., Falzeder E., Roazen P., Nei segreti della psicoanalisi e della sua storia. Roma, Borla, 2008.
Roazen P. (2005). Edoardo Weiss. The house that Freud built. New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.), Transaction Publishers.
Servadio E. (1970). Edoardo Weiss (1970). Riv. Psicoanal., 1, 5-10.
Servadio E. (1971). Prefazione all’edizione italiana. In: Weiss E. (1970). Sigmund Freud come consulente. Roma, Astrolabio, 1971.
Servadio E. (1980). Come ricordo Weiss. In: Servadio E., Federn E., Voghera G., Edoardo Weiss. Commemorazione tenuta il 6 dicembre 1980 nella sede del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste. Trieste, Moderna.
Spacal S. (1982). Il contributo psicoanalitico di Edoardo Weiss. Riv. Psicoanal., 1, 97-118.
Voghera G. (1980). Gli anni della psicanalisi. Pordenone, Studio Tesi.
Zapperi R. (2013). Freud e Mussolini. La psicoanalisi in Italia durante il regime fascista. Milano, Franco Angeli.
Fonti Archivistiche
ASTs (Archivio di Stato di Trieste), Archivio Ospedale Psichiatrico Provinciale di Trieste, «Cartelle cliniche – Uomini», 1919-1929, buste 320-332.
ASTs (Archivio di Stato di Trieste), Archivio Ospedale Psichiatrico Provinciale di Trieste, «Cartella Personale di Edoardo Weiss», busta 920.
ASTs (Archivio di Stato di Trieste), «Prefettura – Generali», class. 3212/1929, busta 217.
Biblioteca Civica di Trieste per la consultazione del quotidiano “Il Piccolo” (Raviz Evelina. Ricordo di Edoardo Weiss, scienziato e neurologo di fama mondiale. Il Piccolo, 3 febbraio 1971).
Sitografia
Per il Carteggio Weiss/Federn:
ASPI (Archivio Storico della Psicologia Italiana). Archivio di Edoardo Weiss
www.archiviapsychologica.org/index.php?id=537
www.centroscp.altervista.org/edoardo-weiss-tenace-pioniere-della-psicoanalisi-
Per notizie riguardanti la famiglia Weiss:
Archivio Livio Saranz, Trieste
www.istitutosaranz.it/?page_id=121
Per la figura di Vanda Shrenger Weiss:
www.aspi.unimib.it/index.php?id=1802&no_cache=1&sword_list[]=Shrenger
Pavanello G. (2013). Weiss, Edoardo. Il Contributo italiano alla storia del Pensiero – Scienze.