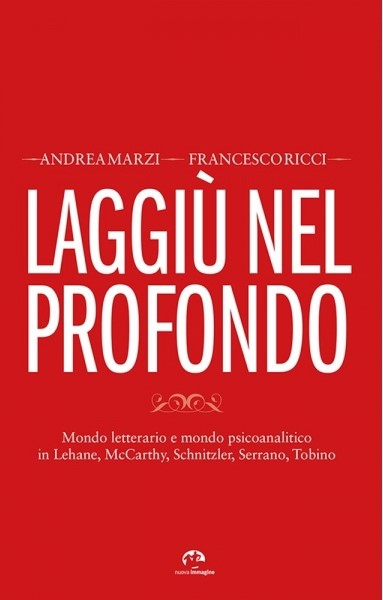
Andrea Marzi, Francesco Ricci (2017)
Laggiù nel profondo.
Mondo letterario e mondo psicoanalitico in Lehane, McCarthy, Schnitzler, Serrano, Tobino
Nuova immagine editrice, pp. 127
Recensione di Laura Contran
Il duplice approccio letterario e psicoanalitico è senza dubbio ciò che rende “Laggiù nel profondo” un libro originale. Lo scopo che si propongono gli Autori, misto a una certa sfida, non è solo quello di illuminare i testi presi in esame, ma di creare uno scambio e una “collaborazione creativa” feconde su entrambi i versanti. Come scrive nell’introduzione Andrea Marzi, non si tratta di psicoanalisi applicata alla letteratura, ma piuttosto di “una continua esperienza emotivo-affettiva che esperisce il testo, lo sostanzia di senso, lo scambia e lo relaziona con due vertici di lettura, per nulla contrastanti ma omogenei nella collaborazione creativa”(11). Si potrebbe piuttosto parlare di una psicoanalisi “implicata” in un discorso letterario.
La scelta che accomuna tra loro questi cinque romanzi, lontani nel tempo, nella cifra stilistica e nelle specifiche tematiche affrontate, è la materia oscura dell’umano. Cercherò di darne un tratteggio essenziale, di offrire qualche personale riflessione, lasciando al lettore la scoperta delle molteplici sfumature che lo sguardo letterario e psicoanalitico riescono a mostrare.
Il primo romanzo, che ha la struttura del thriller, è “Shutter Island” di Dennis Lehane ma, come viene propriamente definito, è un romanzo sull’angoscia – aggiungerei – nel suo rapporto con la verità. Il protagonista, un ex agente federale, si trova sul un’isola inquietante, di fatto un manicomio criminale, per indagare sulla scomparsa di una donna. Con il trascorrere del tempo però si troverà ad essere oggetto di indagine più che indagatore, sensazione accompagnata da un’inquietudine a cui non riesce ancora dare un significato. Sapremo, infatti, che egli stesso è un paziente ricoverato sull’isola-manicomio affinché sia in grado di ricordare quanto è accaduto nel suo passato, rimosso in quanto inaccettabile. In una dimensione onirica, che a tratti assume i contorni di un incubo, tracce di una consapevolezza di sé sbrecciano la falsa identità che “Teddy Daniels, cioè Andrew Laeddis in realtà”, si è costruito. Sempre di più i frammenti di una sua vita precedente, della morte della moglie e dei figli, di una realtà tragica e traumatica, riemergono nonostante i meccanismi dissociativi che l’hanno portato al “completo smarrimento della propria identità e […] all’occultamento […] della verità del proprio Io” (20). Ma come sosteneva Nietzsche “Quanta verità può sopportare un uomo?” Teddy/Andrew non può e non vuole sapere/vedere questa verità. Sceglierà alla fine di tornare nell’oblio.
Se il romanzo di Lehane ha come nucleo centrale la “cancellazione” della memoria, “La strada” di Cormac McCharty è, all’opposto, la necessità di mantenere viva la memoria dentro di noi.
In un paesaggio apocalittico, in cui della terra è rimasta solo cenere, morte, distruzione, un Padre e un Figlio cercano la strada verso possibili luoghi di vita. Attraverseranno l’orrore e vedranno ciò che resta di una umanità completamente perduta.
La memoria e la “capacità di prendersi cura” sono gli elementi fondamentali che i due Autori mettono in evidenza seppure da due diverse prospettive. Per A. Marzi è il prendersi cura dei legami con la propria storia, degli affetti perduti, delle parole e dei nomi delle cose da ricordare e quindi da trasmettere all’altro. Ma è soprattutto il saper prendersi cura – senza mai abbandonarla – della fiducia in rapporto forte e commovente che il Padre difende senza tregua. Padre e Figlio sono “oggetti d’amore reciproci” e nel loro percorso diventeranno portatori di “ quel fuoco simbolico” che rappresenta la creazione e la vita anziché il fuoco distruttivo della follia.
In un diversa prospettiva, non meno intensa e rimanendo nell’ordine della continuità vita-morte, Ricci ricorda che è dalla cultura che nasce la capacità di prendersi cura dei nostri morti, di “non dimenticarli”. Pierre Fédida scriveva a questo proposito “[…] Se siete stati negligenti nei confronti dei vostri morti, potrete dare loro sepoltura con i vostri sogni; sarà un sogno a poterli ospitare. La memoria cosciente che avete dei vostri morti non conta un granché; i morti sono esigenti, chiedono che sia data loro una sepoltura che faccia parte della sostanza dell’uomo, del materiale dell’uomo. (Fédida, Umano/Disumano, 2007). Potremmo dire che è la capacità di sognare (sostanza dell’umano) che salva i due protagonisti del romanzo di MacCharty.
Come dicevo all’inizio “Laggiù nel profondo” è un libro sulla follia nelle sue forme diverse e i successivi due romanzi ne mostrano altre facce. Uno degli autori più “competenti” – dal punto di vista letterario – è senza dubbio Arthur Schnitzler di cui gli Autori hanno scelto “Fuga nelle tenebre”. E’ risaputo quanto lo stesso Freud vedesse nello scrittore austriaco un rivale (sosia) temibile dal momento che “al pari di lui, aveva avuto il coraggio e l’abilità di scandagliare il fondo oscuro della psiche” (Ricci, 55).
Ricci si sofferma sui momenti più significativi del romanzo che vedono Robert, il protagonista, precipitare in un delirio che sovverte “l’impossibile ordine” che si era costruito in modo ossessivo al fine di arginare dentro di sé un crollo psichico ormai imminente. Secondo Ricci in questo romanzo “[…] l’arte dello scrittore viennese è pervenuta a un tale grado di perfezione che tra il contenuto e la forma non si produce più alcun attrito” (63).
Le osservazioni di Marzi, scritte in una chiave psicoanalitica, rimandano invece alla clinica degli stati limite e lo scivolamento verso la psicosi. Robert si trova “ […] in un condizione depressiva di perdita non risanabile […]” (65). Con un breve riferimento alla teoria di Bion, Marzi lascia aperta l’ ipotesi che la solitudine nella quale si rinchiude il protagonista e che esita nella persecutorietà e nel delirio paranoideo, abbia origini antiche “[…] una solitudine causata dall’assenza non tanto di una madre edipica ma di una madre molto più primordiale […] è un solitudine abbandonica, fallimentare, e il vuoto che crea si riempie di una non-madre, di un non-seno che cambia di segno , diviene cattivo e alla fine persecutorio, perché non riesce ad essere tollerato e mentalizzato, non elaborato né padroneggiato” (69).
Ritornando alla memoria nonché alla storia di una generazione a cui molti di noi psicoanalisti appartengono, l’altro romanzo sulla follia e la sua “cura” è “Le libere donne di Magliano” di Mario Tobino. La durezza dell’esperienza psichiatrica vissuta da Tobino per trent’anni in un OP prima della legge 180, ha trovato nella sua trasposizione letteraria il tentativo di fare della follia una poetica anche se – come precisa A. Marzi – non c’è nulla di poetico nel reale implacabile della psicosi. Ma la testimonianza di Tobino ha una visione etica: non esistono categorie psichiatriche, ma esiste il particolare, l’unicità della persona colpita dalla follia. In “Le libere donne di Magliano”, ogni personaggio descritto ha un nome, un volto, un passato e una sua terribile tragica bellezza. Sono passati anni luce, e la realtà psichiatrica è radicalmente cambiata dal punto di vista clinico e farmacologico. L’etica della cura rimane una prospettiva aperta che va continuamente rivista e ripensata grazie alle nuove risorse, a condizione, tuttavia, che queste sappiano ampliare gli orizzonti e non diventare metodi contrapposti che dimenticano la stoffa della soggettività umana.
L’ultimo romanzo, che per certi aspetti si discosta dai precedenti, è “Dieci donne” di Marcela Serrano. E’ senza dubbio il più “psicoanalitico” date le conoscenze (l’uso del linguaggio, della tecnica) che la scrittrice dimostra in questo ambito. Racconta di nove donne che si si incontrano in una lunga psicoterapia di gruppo (la decima è Natasha la psicoterapeuta). Ognuna di loro ha alle spalle vicende dolorose: lutti, perdite, violenze, traumi. Sullo sfondo la tragedia del Cile e dei desaparecidos.
Ognuna di loro, attraverso un monologo, parla del suo rapporto con il tempo, l’attesa, la pazienza – nell’accezione di sopportare e patire – mentre i ricordi degli affetti perduti accompagnano una quotidianità fatta di un presente “da correggere” per tollerarlo meglio, di fantasie in cui perdersi. Ricci rievoca “l’enigma della femminilità” di cui parlava Freud definendo il libro “una bellissima pioggia di luce” (79).
Marzi mette invece l’accento, a costo di risultare non politically correct, sul funzionamento del gruppo psicoterapeutico che sembra privilegiare la comune “sorellanza” e appartenenza di genere, (sostenute controtransferalmente da Natasha) piuttosto che lo strutturarsi di una cura che possa aprire a nuove identificazioni e possibilità.
Concludo la recensione con un invito a leggere questo libro e senz’altro (per chi li avesse mancati) i romanzi proposti con cura e passione dai due Autori, convinta che da “laggiù nel profondo”, come spesso capita nell’esperienza psicoanalitica, dei bagliori di luce, dei nuovi pensieri, delle emozioni, possano raggiungere la “superficie”.
Settembre 2017
