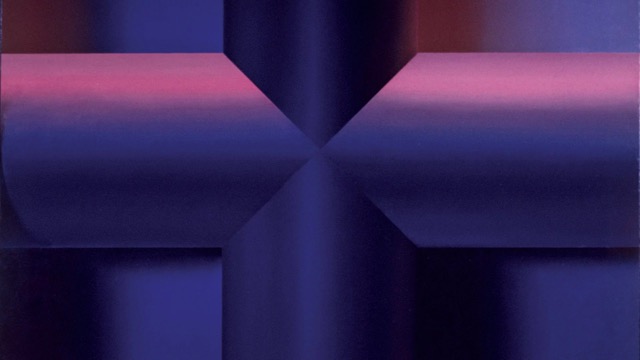
SAMIA HALABY 1969
NEGAZIONE
di S. Lombardi
Freud usa il termine verneinung o, talvolta, il suo equivalente di origine latina negation, per indicare un’operazione psichica e linguistica di respingimento: 1) dalla coscienza, di rappresentazioni rimosse quando affiorano nella cura analitica; 2) dall’apparato psichico in formazione, delle percezioni che suscitano dispiacere.
La definizione del concetto avviene nel saggio[1] del 1925.
In esso si apprezzano gli esiti di una speculazione sul riscontro della presenza nel pensiero e nella comunicazione di fenomeni di esplicito rifiuto.
Nell’ottica di una comprensione della rimozione nella strutturazione nevrotica, sono riconoscibili come meccanismi difensivi, che potenzialmente aprono la strada verso l’acquisizione di contenuti inconsci: il soggetto, con un atto intellettuale e con gli artifizi della razionalizzazione, nega gli possano appartenere nel momento in cui ne coglie l’imbarazzante esistenza. E’ in questo modo (una cognizione, ma non un’elaborazione affettiva) che l’Uomo dei topi prende le distanze dall’ambivalenza nei confronti del padre.
Il rapporto tra rimozione e negazione era sempre stato esplorato da Freud negli anni precedenti il 1925: ne fanno mostra le recise opposizioni di Dora alle sue interpretazioni dell’innamoramento per il padre e per il signor K [2]; ma anche le trasformazioni nel contrario in cui trova espressione la rimozione attuata dall’Uomo dei lupi di un’eccitazione che, con l’emissione delle feci , assume un significato negativo e svalutativo[3].
L’interesse epistemologico nasceva dalla scoperta che nel sistema Inconscio non esiste la negazione né il dubbio né livelli diversi di certezza[4] . Questi vengono istituiti dalla censura, attiva fra Inc. e Prec.. Il contrasto, la contraddizione, il contrario rimangono necessariamente confinati in unità di significato ambivalente, che ci trasmettono il senso di un’assurdità , manifestazioni di inibizione, pensieri di scherno o sarcasmo, come nel sogno[5]; o in certe parole primordiali che riuniscono opposti concettuali[6].
La negazione, messa a punto nel 1925, ribadisce essere questa un sostituto della rimozione ad un livello più vicino alla coscienza. Il disvelamento del rimosso è ancora solo intellettuale. Trova la sua forma nel simbolo linguistico del “no”.
Freud procede, poi, a fini metapsicologici facendone lo strumento costitutivo del giudizio nella formazione dell’apparato psichico. Il pensiero può, infatti, funzionare più liberamente se sgravato dalla rimozione. Le “ tre antitesi” che dominano la vita psichica (soggetto-oggetto, piacere-dispiacere, attivo-passivo) [7]discendono dal rifiuto (il più antico è di marca cannibalica) che il neonato decide di esprimere di fronte al mondo esterno, optando, quindi, per un’inclusione o un’esclusione. Se l’Io-piacere-originario può decidere quanto è buono e quanto è cattivo e, dunque, delineare una prima distinzione fra dentro e fuori, l’Io-realtà-definitivo dovrà, invece, stabilire se la rappresentazione dell’oggetto può essere confermata nella realtà. Talvolta, come nella psicosi, il negativismo ostinato esita in una scissione del soggetto.
Lavorando intorno al giudizio di attribuzione ed al giudizio di esistenza, Freud avvia, suo malgrado, la tessitura di una rete concettuale[8]. E’ difficile, infatti, non cogliere uno scivolamento dalla negazione al rinnegamento, concetti ai quali aveva destinato termini ed usi diversi: verneinung e verleugnung.
Nel 1923[9] aveva auspicato che restassero separati, al pari della rimozione e del disconoscimento[10] (della castrazione femminile) nell’ambito del complesso di evirazione, per poter spiegare il prototipo della perversione: il feticismo.
Da questo crocevia si dipartono le strade percorse dagli epigoni: Klein, Bion, Winnicott, ciascuno nell’ambito del proprio paradigma, fino alla psicoanalisi contemporanea.
Se, infatti, la negazione, nel discorso freudiano, istituisce un limite generativo di simboli, segni e rappresentazioni, essa è anche il vertice di condensazione della pulsione e della mancanza o dell’assenza. A tal proposito A. Green (2003)[11] , il cui concetto di negativo non è circoscritto alla psicopatologia, ha osservato che Freud ha scritto il lavoro del 1925, avendo ormai riconosciuto come fondativa dell’umano l’esistenza della pulsione di morte. Egli osserva anche che la posta in gioco è il rapporto con il linguaggio, ovvero con il simbolico: nel rinnegamento della percezione, questo rapporto non c’è.
[1] Freud S. (1925) La negazione, O.S.F. 10
[2] (1901) pp. 347-349, O.S.F. 4
[3] (1914) p. 555 nota, O.S.F. 7
[4] (1915) Metapsicologia O.S.F. p. 70
[5] (1899) L’Interpretazione dei sogni O.S.F. 3 p. 293-300-310; (1900) Il Sogno O.S.F. 4 p.29; (1915-1917) Introduzione alla psicoanalisi O.S.F.8 p.348
[6] (1910) Significato opposto delle parole primordiali O.S.F.6 p.185
[7] C. Le Guen (2013) Negazione, denegazione, diniego p.800 in Dizionario freudiano, Roma, Borla
[8] T. Bokanowski (2022) Le “je … ne … pas”. Dénégation et clinique contemporaine, R.F.P. 2023 LXXXVII-2
[9] L’organizzazione genitale infantile, p.565 nota, O.S.F. 9
[10] Feticismo (1927), O.S.F. 10
[11] A. Green (2003) Negativo e negazione in psicoanalisi in La clinica del negativo a cura di A. Baldassarro, 2023, Roma, F. Angeli
