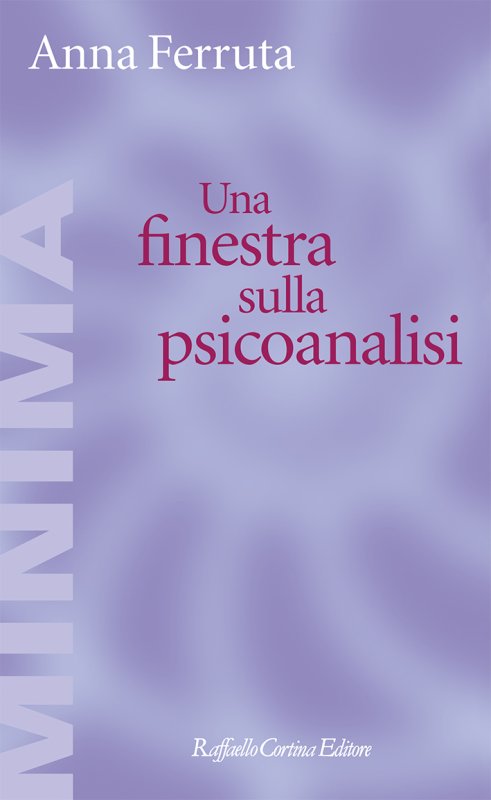
Una finestra sulla psicoanalisi.
Anna Ferruta
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2024
Fulvio Mazzacane
Il titolo del libro evoca un’immagine che accompagnerà il lettore nell’intero percorso: l’importanza che lo sguardo psicoanalitico contempli la presenza di una o, come risulterà dalla lettura, più finestre, per evitare che la cultura psicoanalitica venga coltivata nell’isolamento e nell’autoreferenzialità. Dalla finestra entra l’aria che consente il rinnovarsi delle nostre idee e la luce delle discipline con cui ci confrontiamo: le neuroscienze, la filosofia, l’epistemologia, la letteratura e la musica, tutte presenze importanti nel libro. La finestra consente anche agli altri di guardarci e l’immagine di psicoanalisi che Anna Ferruta mostra è fatta di partecipazione emotiva, curiosità, comprensione della sofferenza.
Scrive l’Autrice che le diverse persone e le dinamiche emozionali che l’hanno accompagnata lungo questi anni è come se sostassero alla porta della sua mente, ribellandosi all’oblio e all’insignificanza. L’immagine che Anna Ferruta ci offre è potente, ricorda quella evocata da Pirandello nella prefazione dei Sei Personaggi in cerca di Autore, con i personaggi che bussano alla porta dell’Autore chiedendo di essere raccontati, non accettano la non rappresentabilità della loro sofferenza. Nel libro incontriamo i colleghi, con le quali l’Autrice ha condiviso momenti diversi della sua carriera, i maestri e i compagni di viaggio, le esperienze istituzionali in ambito psichiatrico e psicoanalitico, gli allievi, i grandi autori (soprattutto Freud, Winnicott e Ogden) ma soprattutto le tante persone che si sono rivolte a lei ricevendo aiuto e ripagandola con moneta “umana”.
La gratitudine appare come la motivazione più importante alla scrittura del libro, il bisogno di restituire alla comunità psicoanalitica il patrimonio di esperienze che si sono accumulate nel corso del tempo e vengono presentate nella loro umanità, il debito di riconoscenza che ogni analista dovrebbe avere nei confronti di chi ci ha concesso di condividere un pezzo di vita. L’Autrice, consapevole dell’importanza della clinica, si pone il problema della pubblicabilità delle vicende della stanza d’analisi che, nel libro, vengono pennellate rispettando l’intimità della coppia ma riuscendo comunque a farci vedere due persone impegnate intensamente nell’avventura analitica. Viene sottolineata sempre la gratitudine verso “i miei pazienti che hanno pagato per insegnarmi”.
E’ un libro ricco, ognuno può leggerlo ricavandone qualcosa. Alcuni dei personaggi che l’Autrice chiama sulla scena appartengono anche alla mia storia (Dario De Martis e la scuola di specializzazione in Psichiatria di Pavia) alle comuni esperienze (gli SPDC milanesi e le supervisioni nelle istituzioni psichiatriche), al ricordo del training (le lezioni di Anna Ferruta sono state il mio primo contatto con il pensiero di Winnicott). Al di là della risonanza di esperienze e Maestri in comune, la chiarezza e la profondità del libro ha un Lettore Ideale: l’analista in formazione che viene immerso in un’atmosfera di curiosità e di chiarezza nell’approcciarsi ai temi importanti della cultura psicoanalitica.
L’analista più esperto troverà invece nel libro una sfida: Anna Ferruta presenta, nei dodici capitoli, delle coppie che descrivono polarità all’interno di concetti psicoanalitici, spesso contrapposte e sfida se stessa e il lettore a creare ponti o strategie di convivenza. Ognuno è “costretto” a collocarsi all’interno dello spettro creato dai parametri che contrappone, utile esercizio per una buona manutenzione di sé, di chiarimento di posizioni culturali. Dodici capitoli che cercano di tenere insieme prospettive diverse, tra conflitto e possibile convivenza, cercando la soluzione nella capacità negativa, nell’astensione da giudizi assoluti, nell’accettazione del paradosso nel senso di Winnicott, paradosso che non deve essere risolto ma deve rimanere come stimolo a creare pensiero.
Due preoccupazioni sembrano attraversare l’intero libro, la prima riguarda il rapporto corpo/mente: per l’Autrice è importante affermare che lo psichismo nasce all’interno di un corpo che sente. Le unità dello psiche-soma stanno insieme dinamicamente. La personalità emerge da multiple relazioni emotive senso motorie precoci che si organizzano e trovano la loro rappresentazione grazie all’attività psichica che le rende uniche. L’origine relazionale dello psichico è un incontro “sessuale”, le crisi sono inevitabili ma, come accade nel sogno di un paziente che viene riportato, se si è in mare aperto anche le temute meduse possono essere evitate se affrontate con calma.
L’attenzione è a tutto quello che si costituisce come ponte tra corpo e mente: il sogno innanzitutto, che crea mondi, immagina soluzioni, apre orizzonti e si struttura all’interno di legami, quelli che si creano in una mente incorporata e quelli che nascono all’interno delle relazioni, luoghi di scambio vitale tra narcisismo e relazionalità.
Anche il linguaggio è un luogo di transito tra mente e corpo. La parola si poggia sulla sua caratteristica sensoriale di suono, e sulla sua funzione di simbolo e di legame sintattico grammaticale. L’”ascolto assoluto”, immagine che Anna Ferruta propone utilizzando una metafora musicale è il punto di partenza di un assetto terapeutico capace di cogliere l’altro lì dove non ha potuto costituirsi liberamente, attento a cogliere l’importanza di alcune parole “condensate”, frutto dell’interazione tra inconsci.
Nella coppia analitica c’è una continua ricerca di nuovi assetti in un continuo movimento, la qualità dell’incontro deve mantenere la dimensione sessuale, di gioco e di incastro reciproco, l’obiettivo è diventare se stessi nel legame, nell’incontro con qualcosa di non ancora conosciuto, da scoprire progressivamente. Nella difficile articolazione tra avventuree bisogno di certezze, la stabilità può avere qualità diverse: radicata come le piante, nomade come nelle migrazioni, immobile (o forse in fuga continua per paura, come in Narciso), infinita e disperata come Odisseo per il quale la fine del viaggio non può non corrispondere all’inizio di una nuova avventura.
La seconda preoccupazione dell’Autrice ha a che fare con il rapporto sé/altro. Anna Ferruta segnala la fatica dell’analista nel sentirsi coinvolto in situazioni di turning point esistenziali, in cui non solo il paziente ma anche l’analista si trova a gestire l’oscillazione tra la scoperta di parti nuove di sé e la stabilità. L’emergere del perturbante, l’incontro con l’alterità nella situazione analitica è incontro con l’alterità di sé, con parti che neanche noi sappiamo di avere e può essere devastante. Si sopravvive all’isolamento se c’è Wilson, personaggio fondamentale nel libro, tratto dal film Cast away che rappresenta l’importanza di un interlocutore che, nella lotta per la sopravvivenza, contenga tracce delle buone esperienze e della vitalità.
Anna Ferruta affronta poi alcuni temi importanti per definire lo stile di un analista del XXI secolo: il modo di concepire il Terzo, che per l’Autrice è una neoformazione, così come viene pensato nel concetto di spazio transizionale di Winnicott e di terzo analitico di Ogden, in cui è sempre fondamentale differenziare quello che è del paziente e quello che è dell’analista. L’importanza di avere in mente l’esistenza di quello che Winnicott definisce nucleo autopoietico, luogo di delirio e di creatività. La psicoanalisi acquisisce la qualità di gioco che crea mondi attraverso un contatto tra autopoiesi, corpo e relazione.
L’argomento delle Estensioni del metodo è un altro dei temi importanti, già sviluppato in un volume curato con Tiziana Bastianini. La sfida per l’analista è di tenere insieme modernità, nei diversi contesti in cui lo psicoanalista si trova a operare. L’ascolto analitico è comunque garante di un’esperienza profonda “stabile” che consente l’avventurarsi nell’ignoto.
L’idea è quella di pensare a quanto varie possono essere le Esperienze psicoanalitiche se si creano dispositivi analizzanti che favoriscono incontri liberi in un quadro ambientale “limitato, immediato, sicuro” con l’ascolto di comunicazioni verbali e non verbali in un clima che favorisca le libere associazioni che coinvolgono anche la soggettività dell’analista per l’identificazione del core problem: la configurazione relazionale dominante che è alla base della sofferenza
Nel ripensare il rapporto tra Individuo e gruppo, l’Autrice presenta diverse situazioni: da un lato c’è l’inevitabile Pluralità dell’individuo, le sue moltitudini, avendo come sfondo la gruppalità sociale. Dall’altro lato c’ è la funzione delle istituzioni e il loro difficile equilibrio tra bisogno di stabilità ed evoluzione, la dimensione gruppale e individuale non sempre convivono in maniera commensale. Il libro, ma anche la storia dell’Autrice, porta a valorizzare la dimensione della responsabilità ma anche della gratitudine che va provata per la casa che ci accoglie e questo è prezioso se pensiamo che Anna Ferruta ha partecipato con varie cariche alla gestione della vita scientifica della Società Psicoanalitica Italiana.
In conclusione, la Psicoanalisi per l’Autrice è una “disciplina del vivente”, in cui la scoperta dell’unità e dell’originalità del soggetto è il principale obiettivo, l’essere vivi attraverso la relazionalità e la sua componente di gioco che rimanda all’onirico come qualità inconscia, artistica del corpo-mente. Tenendo insieme nel concetto di “vivente” l’ambiente, implicando quindi una dimensione ecologica e scientifica. I vari riferimenti a Darwin e a Rovelli non hanno a che fare con un approccio scientista ma con l’inserire l’umano all’interno di conoscenze che evitano che il pensiero psicoanalitico diventi ineffabile.
Che idea di analista viene fuori dal libro? Un Analista sempre a rischio di ammalarsi, sempre ingaggiato in un rapporto ad alta intensità emotiva, consapevole della responsabilità nei confronti dei pazienti, attento a non indottrinare. Un Analista che, come insegna Winnicott, usa l’interpretazione per far conoscere all’analizzando i propri limiti, che rispetta la meta fondamentale dell’analisi: aiutare il paziente a diventare se stesso. Un Analista consapevole che alla base della sua motivazione ha anche il “bisogno di esistere per conto terzi”, attraversato da una vena di solitudine, una sensibilità che deve essere messa a disposizione dell’analisi.
Le varie dimensioni temporali che il libro di Anna Ferruta ci offre ci parlano della storia della psicoanalisi, dei suoi autori più importanti e dei suoi concetti fondamentali, del lavoro quotidiano con i pazienti, della speranza che la psicoanalisi mantenga la vitalità che l’Autrice ci mostra.
