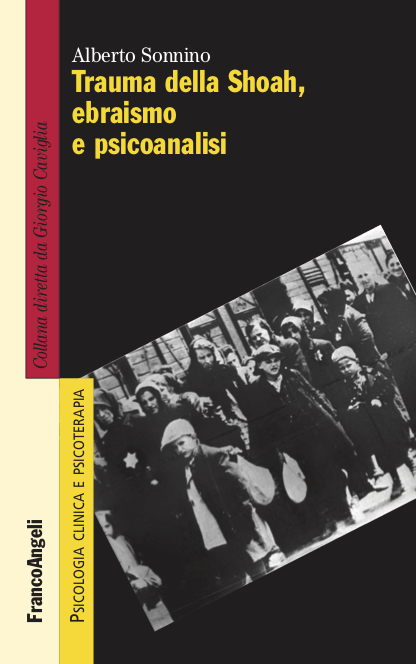
Trauma della Shoah, ebraismo e psicoanalisi
di Alberto Sonnino
(FrancoAngeli ed., 2021)
Recensione a cura di Daniela Scotto di Fasano
Tre, a mio parere, i grandi filoni che caratterizzano l’interesse e la scrittura di Alberto Sonnino negli otto lavori, pensati per occasioni diverse e qui riuniti, che costituiscono il libro.
Una scrittura, va detto a premessa, limpida, affettivamente densa, evocativa ma al contempo lucida, che di Trauma della Schoah, ebraismo e psicoanalisi fa un libro ‘piacevole’ e di facile lettura, sebbene questo suoni come un paradosso dati i temi trattati.
Il primo importante filone, sottolineato anche da Giorgio Caviglia nella Prefazione, è la traccia inseguita con la solerzia di un cane da tartufo di quanto risulta caratterizzare tanto la Psicoanalisi quanto l’Ebraismo. Forse, sembra suggerire l’Autore, data l’origine ebrea di Sigmund Freud, ma forse non solo. Entriamo nel dettaglio e elenchiamone, tra i molti, qualcuno. Uno degli elementi individuati è la domanda che sta alla base della Psicoanalisi ma, dichiara autobiograficamente Sonnino nell’Introduzione, si rivela anche una chiave di lettura delle caratteristiche dei percorsi identitari. La domanda ‘Chi sono?’ conduce i pazienti all’analisi, e la domanda ‘Che voleva dire essere ebreo? Cosa mi rendeva [in adolescenza] diverso dai miei coetanei non ebrei, sebbene pur sempre uguale a loro?’, apre le riflessioni di un ragazzo nato ebreo in un mondo di gentili. Dunque, l’interesse per ‘chi sono?’ è al centro della questione ‘identità’ in Ebraismo e Psicoanalisi. Sebbene il filone di quanto risulta caratterizzare tanto la Psicoanalisi quanto l’Ebraismo sia indagato in particolare in alcuni capitoli più che in altri, esso ‘impregna’, per così dire, tutte le 127 pagine che costituiscono il libro. Con quali argomentazioni? Ne cito alcune. Innanzitutto, a me pare quella della creatività, sebbene essa non sia dall’Autore esplicitata in tale significato. Ma Sonnino la mette come in scena; infatti, a pagina 31 (per non fare che un esempio), con le parole di Giaconia e Racalbuto, scrive: «solo la “creatività” reperita all’interno della relazione analitica permette la trasformazione del trauma “corpo estraneo” – oggetto concreto e sordo, che occupa lo spazio del preconscio – in rappresentazione virtuale.». Lo stesso accade quando, a pagina 46 e 47 (ma in più punti lo esplicita e sottolinea), in relazione al silenzio di Dio, scrive: «Allora non possiamo che ricorrere all’aiuto della Cabala e al concetto dello “zitztzum”. Il ritrarsi di Dio, necessario per permettere la creazione […] sulla quale nemmeno Dio stesso può interferire. ».
È a proposito della creazione che sento la trasformazione del trauma “corpo estraneo” – oggetto concreto e sordo -” nella creatività della vita che prende il sopravvento sulla pulsione di morte e consente finalmente di mettere in parole l’indicibile e pensare l’impensabile. Ne parlano due libri che ho amato molto proprio perché mostrano con estrema lucidità la violenza con cui la vita “impone”, letteralmente, di “vivere comunque, vivere nonostante”. Parlo di Il bambino nella neve, di Wlodek Goldkorn, e di Le madri salvate, di Colombe Schnek, che confermano l’ipotesi, più volte enunciata da Sonnino, quando per esempio afferma, a pagina 32, con le parole di Wardi, che mettere al mondo nuovi bambini, divenne il simbolo della vittoria sui nazisti, perché avere un figlio significava tentare di risanare un mondo interno vuoto e in rovina.
La creatività, insomma, il creare, che prelude e garantisce la possibilità di riparare, è uno dei temi condivisi da Psicoanalisi e Ebraismo, assieme a il riconoscimento della natura bisessuale dell’uomo (ribadita fin dalle prime pagine della Bibbia), e la compresenza delle due pulsioni fondamentali per la vita fin dai primordi dell’esistenza, che necessitano del loro impasto, l’impasto pulsionale teorizzato da Freud nell’Io e l’Es fin dal 1922 e riformulato da Melanie Klein nei termini del raggiungimento, nel corso dello sviluppo, della posizione depressiva. Ma, ancora, il fatto che secondo il Talmud, nella loro genesi, lo Jetzer raha, l’inclinazione al male, sarebbe presente fin dalla nascita, precedendo lo Jetzer hatov, l’inclinazione al bene (pagina 78). E ancora: l’attitudine a riflettere introspettivamente, al pensare prima di agire, all’osservanza della regola, e, infine, l’importanza data al ritorno alla propria condizione preesistente – la Teshuvà -, in Psicoanalisi il lavoro sulla storia del paziente, ma, anche, il perturbante “ritorno del rimosso”.
Potrei andare avanti a lungo sulle preziose similitudini messe in luce da Sonnino con un lavoro paziente e meticoloso, ma, per ragioni di spazio, passo a riflettere sul secondo tema che ho trovato estremamente interessante per i percorsi di indagine che promuove.
Si tratta di quel sentimento che definirei di “disagio del diverso” che caratterizza la “natura”, per così dire, dell’ebreo. Sonnino si interroga su tale questione in più di una pagina, ad esempio a pagina 53 connette, con Claudio Modigliani, la compressione dell’aggressività alla quale gli ebrei, storicamente minoranza perseguitata, sono dovuti ricorrere, che li ha portati a rivolgerla contro il Sé, così da albergare al proprio interno un perenne sentimento di colpa. Sonnino lo definisce un sentimento quasi ontologico, mancando nell’ebraismo il sollievo della confessione, della penitenza e dell’assoluzione. Mi chiedo, e gli chiedo, se si possano leggere in tal senso molte questioni. Ad esempio, il fatto che (come si può forse arguire dal diario di Etty Hillesum) spesso le stesse vittime che sarebbero state poi portate nelle camere a gas non avrebbero potuto/voluto comprendere la gravità delle minacce cui stavano andando incontro (pagina 36). E dunque, possiamo chiederci, se, potendosi intendere la Psicoanalisi, come dice Caviglia citato da Sonnino a pagina 54, come «una tecnica laica di elaborazione del senso di colpa», Freud non abbia creativamente creato la Psicoanalisi proprio in ragione di tale persecutorio senso di colpa. Basti pensare all’episodio del padre, costretto a scendere dal marciapiede e per di più a raccogliere il proprio cappello dal rigagnolo davanti agli occhi di Freud bambino.
Moltissime nel libro le suggestioni in tal senso. Che suggeriscono, a mio parere, un’altra serie di scomode domande: l’ombra dell’oggetto che nella proposta freudiana di elaborazione del lutto cade sull’Io è, nella loro storia, la persecuzione fatta propria dagli ebrei, sempre, ovunque, “scomodi”, “altri”? È questa la matrice del perturbante teorizzato nel ’19 da Freud? Forse in rapporto a tale prospettiva per così dire “strabica” Sonnino ha avuto e ha il grande merito di rivolgere la propria attenzione anche alla posizione oltremodo scomoda, per non dire terribile, dei figli e dei nipoti di padri o nonni, conosciuti magari come teneri e amorevoli in famiglia, che in rapporto alla Shoah si sono macchiati di azioni inconcepibili (pagina 46 e 104 e seguenti). A proposito della forza che può caratterizzare il diniego, mi piace evocare il film di Atom Egoyan (2015) Remember, dove un aguzzino nazista arriva, complice il morbo di Alzheimer, a credersi e di conseguenza comportarsi come un ebreo perseguitato scampato ai campi di sterminio. Non a caso Sonnino apre il proprio intervento letto al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni per la Giornata della memoria il 27 gennaio 2020 (che costituisce l’Appendice I del libro), con questa frase: «Signor Presidente, autorità politiche, figlie e figli dei deportati, figlie e figli dei persecutori».
Infine, il terzo grande tema è quello inerente l’importanza della realtà materiale anche nel lavoro di noi psicoanalisti, poco abituati a lavorare con tale dimensione perché allenati ad avere a che fare con i fantasmi della mente. Silvia Amati Sas, che ha lavorato con i sopravvissuti alle torture del regime fascista in Argentina, parla del ruolo dell’analista come quello del “testimone” di una realtà che, se non riconosciuta e trattata in analisi come tale, rischia di creare nel paziente un trauma ulteriore. Sonnino ripetutamente nel libro torna sul rischio – sia per la salute mentale individuale sia per quella di una società civile – del silenzio, dell’omertà, del negazionismo, vere ferite infette nella psiche in grado di ammalare, generazione dopo generazione, la collettività. A pagina 113, con le parole di Bohleber, sottolinea l’importanza che ci sia anche un discorso sociale sulla verità storica degli eventi, sulla loro negazione e ripudio difensivo. E, citando Peter Singer, aggiunge che tutti noi non siamo responsabili solo di quello che facciamo, ma anche di quello che avremmo potuto impedire o che abbiamo deciso di non fare.
A proposito dell’importanza della realtà materiale, voglio brevemente ricordare una cittadina del Limosino, Oradour-sur-Glane, che il 10 giugno 1944 i nazisti accerchiarono, radunando gli abitanti in piazza; gli uomini (190) furono fucilati, le donne (247) e i bambini (207) rinchiusi in chiesa e all’edificio fu appiccato il fuoco. Il 10 maggio 1946, De Gaulle dichiarò il borgo monumento storico. Le rovine del paese sono tuttora visibili: case in rovina, negozi sventrati. Ma quei resti, notò la storica Tarpino, proprio mentre esibiscono il martirio della Francia in guerra, si prestano a occultare la storia, non meno tragica, delle divisioni interne: le violente lacerazioni maturate negli anni della Repubblica di Vichy sotto la guida del maresciallo Pétain. Che cosa rappresentò, nell’esperienza dei Francesi, Vichy? L’ombra di un passato per lo più taciuto, rimosso: maceria invisibile tra le macerie visibili nel memoriale di Oradour? Cioè, le complicità del governo con il regime di Pétain, erettosi a collaboratore volontario delle strategie hitleriane, per cui Tarpino conclude, con Paul Valery, che la guerra fu perduta durante la pace. Non dimenticare, il monito che emana dagli spettrali resti del borgo. Paxton, infatti, ha parlato di Vichy 1940-1944 come del regime del disonore. Un ricordare che sostiene il dimenticare: Oradour è in tale luce simbolo di un’unità nazionale virtuale?, si chiede Tarpino. Noi potremmo dire, psicoanaliticamente: Oradour è un ricordo di copertura? Nel 1951, L’Assemblea nazionale votò l’amnistia (che, secondo l’etimologia greca, significa ‘dimenticare’) per i cosiddetti reati di ‘indegnità nazionale’, e il processo di Bordeaux, che nel 1953 doveva giudicare i colpevoli del massacro di Oradour, fu pesantemente condizionato dal clima generale, caratterizzato appunto dal bisogno di dimenticare: nel 1958, anche i pochi responsabili che furono condannati, vennero liberati. Per Oradour il processo di Bordeaux segnò un secondo trauma, Oradour moriva di nuovo, e con lei la sua memoria, ha detto Tarpino; che aggiunge: lo scandalo, ancora in corso, di una memoria immemorabile.
Oradour, di fronte a questo nuovo insulto, restituì la Croce di guerra ricevuta nel 1947 e si rifiutò di trasportare le ceneri dei morti nell’ossario di Stato; inoltre, fu interdetta ai rappresentanti del Governo la partecipazione alle commemorazioni in Oradour. Però, sottrarsi alla vita fu l’imperativo dominante nei codici di quella comunità travagliata, votata al culto dei propri morti, dove l’esistenza non fu all’insegna della vita, bensì della morte. Come accade, a livello individuale, quando nel rifugio segreto, nei nascondimenti della psiche, è impossibile riconnettersi a parti di sé tradite, umiliate, impossibili da mentalizzare.
Ho evocato questo tragico evento della storia francese perché in linea con tutto l’impianto e lo sviluppo del bel libro di Alberto Sonnino e dei rischi da lui additati se colludiamo con un bisogno di dimenticare che in realtà è bisogno di negare. Infatti, a pagina 118, Sonnino sostiene che la difficoltà di elaborazione per i sopravvissuti non può non aver risentito della vera e propria mancanza di un mondo circostante disponibile ad ascoltare e accogliere, anzi, attivamente volto alla rinuncia dell’esercizio del giudicare (si pensi all’amnistia voluta da Togliatti).
Eppure, Sonnino non fa della Shoah un accanimento, non ne “celebra” l’orrore, anzi, a conclusione del libro, a pagina 127, cita Yehoshua Ben Hananiah che, dopo la distruzione del Tempio, afferma: «Non affliggersi affatto non è possibile…ma affliggersi troppo è pure impossibile».
