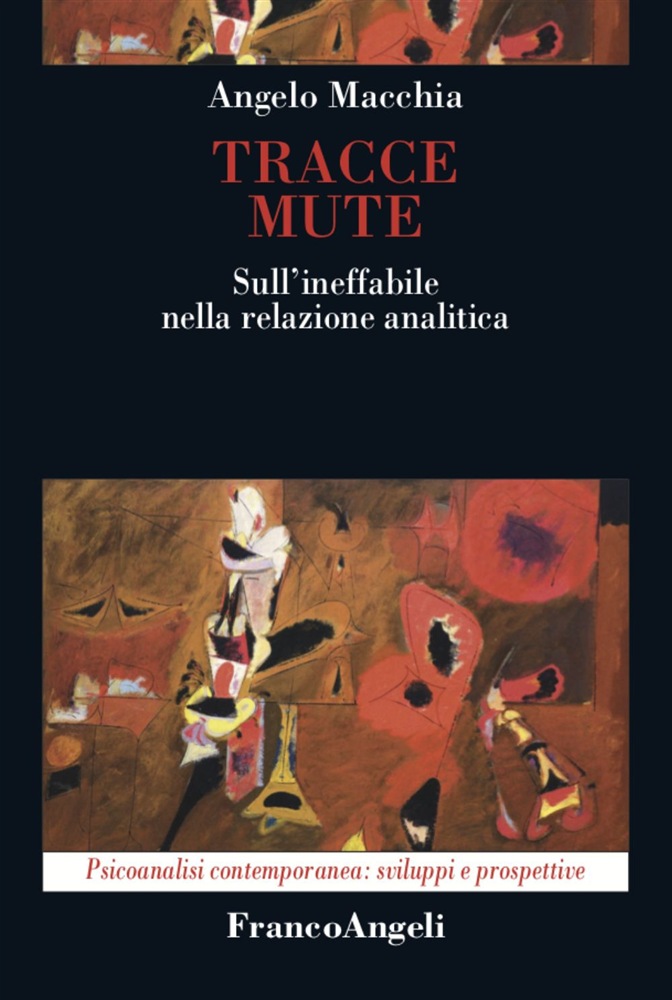
“Tracce mute. Sull’ineffabile nella relazione analitica”
di Angelo Macchia
(FrancoAngeli, 2020)
Recensione a cura di Angelo Moroni
Man mano che mi addentravo nella lettura de libro “Tracce mute” di Angelo Macchia, mi si andava gradualmente creando nella mente l’immagine di uno di quei ponti tibetani fatti di corde, sospesi su profonde vallate. Pagina dopo pagina, sono spesso tornato su tale rêverie evocata in me da questa esperienza di lettura, per capirne meglio il senso associativo e le sue plurime diramazioni di significato. Su quale solco, o abisso sono sospese le corde del ponte costruito dall’Autore? Quali le sponde che esso tenta di collegare? Perché proprio il Tibet, metafora di una cultura orientale che sembra in apparenza così lontana dall’Occidente della psicoanalisi, che tutti gli analisti frequentano quotidianamente? Credo che tale immagine si sia in me appalesata innanzitutto perché “Tracce Mute” si pone il non facile obiettivo di sondare quella complessa faglia teorica che è definibile con il concetto di “inconscio non rimosso”, mettendo tale concetto costantemente in dialogo con la tradizione, soprattutto italiana, ma non solo, della Field Theory. Il libro è costituito da una raccolta, molto ben selezionata, di scritti dell’Autore ripresi in gran parte da appunti di lezioni agli allievi dell’Istituto di Training della Società Psicoanalitica Italiana, oltre che da altri scritti inediti. Da questo punto di vista si sente l’intento e la passione verso la trasmissione del sapere psicoanalitico alle nuove generazioni. Si percepisce anche la continuità di un lavoro pensato e sedimentato in anni di esperienza clinica e di elaborazione teorica, e questo è un altro aspetto che credo muova e spieghi la mia rêverie relativa agli intrecci di corde del ponte tibetano: molti sono infatti i nodi e gli snodi di pensiero che Angelo Macchia descrive, intreccia e sviluppa con rigore e finezza stilistica nelle pagine del suo libro. Se penso ad un “cuore” di questo testo, ad una campata portante del “ponte” che Macchia costruisce, lo ritroverei certamente in una nota frase di W.R. Bion, che troviamo in Trasformazioni (1965), a cui l’autore di “Tracce mute” si richiama più volte, e che occorre testualmente citare: “Qualche cosa avvenne durante la seduta – ‘i fatti in sé’ della seduta. Quali siano ‘i fatti in sé’, non si potrà mai sapere; quindi li indicherò con il segno O” (Bion, 1965, 31). Macchia, acutamente, e innovativamente, fa risalire il concetto bionioano di O a quell’”ombelico del sogno” di cui parla già Freud nella Traumdeutung (Freud,1899, p. 479-480). O è infatti, eminentemente, “un concetto psicoanalitico” (Ogden, 2005), e non tanto filosofico, teologico o matematico, come altri Autori lo considerano. Considerarlo come nozione extra-analitica implica infatti, per Macchia “sottrarsi all’aspetto più angoscioso della definizione di Bion: quel “non si potrà mai sapere”, di cui Freud aveva lucidamente parlato a proposito dei sogni” (p. 50). Considerare invece O come un operatore concettuale intrinsecamente psicoanalitico, ci può aiutare ad avvicinarci proprio a quell’”ineffabile” “inconscio non rimosso” che trapela epifanicamente, a tratti, nelle interazioni della coppia analitica al lavoro, quando la mente dell’analista sa disporsi a vivere l’autenticità di un unisono. Ma in cosa consiste questa “ineffabilità” (dal latino in-effabilis, “che non si può dire”)? Sentiamolo dalle parole dell’autore: “Cosa succede in analisi quando non ci sono parole, per quelle esperienze prive di voce perché senza parole? Parliamo di aree dell’esperienza psichica che si riferiscono a un periodo preverbale, inscrizioni che si collocano ad un livello così precoce dello sviluppo da essere al di qua della rappresentazione, al di là della nevrosi (Levine, 2013)” (p. 62). E ancora: “(…) una fase in cui la consapevolezza del non-me è insopportabile e devastante per la continuità ontologica del bambino. (…). Il riferimento è a una trama che inizia a tessersi tra la madre e il prodotto del concepimento sin dalla vita intrauterina come linguaggio che si esprime attraverso messaggi biofisici e chimici (…) (p. 29). Tali aree di esperienza preverbale presuppongono “per la madre e per l’analista la capacità di oscillare tra uno stato in cui un insieme integrato si riunisce all’interno dei confini corporei dell’individuo e uno stato dell’essere in cui non ci sono confini, ma solo fluidità” (p. 29).
Ho detto più sopra che questo libro mette in dialogo il concetto di “inconscio non rimosso” con la Field Theory, soprattutto di derivazione italiana (vedi in particolar modo autori come Corrao, Gaburri, Ferro, Civitarese). Anche qui Macchia cerca di annodare fili per tessere l’ordito di un ideale ponte teoretico (ecco ancora una volta l’immagine del ponte di corde…), che lo porta però a riconoscersi in una Teoria del Campo non “radicale” come quella che Macchia identifica nell’attuale modellizzazione di Ferro (2007) o di Civitarese (2019). Pur considerando importanti e preziosi i contributi della scuola pavese del campo post-bioniano, Macchia sembra sentire una maggior sintonia con Autori come Ogden e Bollas, nel definire un suo personale concetto di Campo. Il concetto di Campo descritto da Macchia guarda cioè verso quella che vorrei definire una “psicoanalisi dell’Essere”, “del Sentire”, nel senso del termine di Estetica, e del suo etimo greco, “Aisthanomai”, cioè “Percepire attraverso la mediazione dei sensi”. Nell’accezione di Ogden (2006), per altri versi definibile come una “Psicoanalisi ontologica”. Una psicoanalisi cioè dove l’analista innanzitutto ha in mente il prendersi cura della continuità dell’Essere del paziente, e così si assume, sempre, la responsabilità dì essere-con-il-paziente, più che di essere uno spettatore o un ermeneuta. Un analista cioè disponibile, in senso winnicottiano a farsi promotore dell’analisi come “uso dell’oggetto” da parte del paziente stesso. Un analista disposto a transitare quell’area dell’ineffabile traumatico perdendo temporaneamente i propri confini, favorendo l’emergere di un’area di unisono che non prevede “confini ma solo fluidità”. Sono questo movimento e questa disposizione mentale dell’analista a consentire al paziente di trovare-creare in analisi quella continuità dell’Essere spezzata da traumi e deprivazioni precoci, che non sono mai stati consci, che non possono essere ancora rappresentati. Si tratta, come si vede di una psicoanalisi che si prende cura dell’Essere più che della parola o del linguaggio, e che evoca intrecci complessi tra psicoanalisi ed esperienza estetica.
Mi è capitato raramente di imbattermi in un testo nel quale teoria e clinica dialogano e si integrano così bene, e in una cornice coerente e simultaneamente, appunto, poetica. “Tracce mute” è infatti un libro che parla di ciò che mi verrebbe da definire la “poesia dell’unisono”. Non è un caso che, nel testo, Macchia riprenda e citi i versi di molti poeti. Al di là dei densi riferimenti teorici, sono infatti presenti nel libro lunghe vignette cliniche capaci di trasmettere molto efficacemente, in modo toccante, l’idea di unisono che Macchia indaga e svela lungo le pagine del suo libro. In queste pagine, parlando di “fluidità”, si ha come l’impressione che, davvero, le sequenze cliniche riportate dall’Autore, fluidamente e ritmicamente “creino-trovino” la teoria, e che, al contempo, la teoria illumini e dia parola alle “tracce mute” ma operanti nell’interazione clinica. Questo tipo di andamento della scrittura di Macchia mi pare molto ben espresso nel passo seguente, in cui l’A. ci parla dell’analisi di Ada: “Ho un senso di fiducia nel tempo che passiamo assieme. Mi sta usando in un modo che mi sfugge ma mi sembra importante rispettare questa forma di autarchia. Se facessi di più sarei come la madre che la obbliga a mangiare e invece lei sta nutrendosi come crede. Talvolta mi sento frustrato dall’essere collocato in una posizione così periferica dello scambio: sembra fare tutto da sola. Nel gioco incrociato delle identificazioni patogene che popolano la relazione analitica, Ada sembra identificarsi con l’aggressore-madre che vive con fastidio l’essere messa in crisi correlato all’essere in relazione con l’altro e fa provare a me come deve essersi sentita lei nel rapporto con la madre, un ingombro (…) e neppure sembrava essersi accorta di quanto le era mancato il sentirsi voluta” (p. 68).
Questa sequenza clinica mi pare rappresenti bene e con rara sintesi, quella “poesia dell’unisono” di cui dicevo più sopra, poesia dello scambio intersoggettivo che coglie il divenire di O. Un altro caso di cui ci parla l’A., molto emblematico di questo tipo di trasformazioni in O, è quello di Gino, nel quale il “fatto” costituito dal cadere di una penna dal grembo dell’analista, a fine seduta, viene visto come “gesto psichico”, nell’accezione di Sapisochin (2013).
Il theoretisieren di Angelo Macchia, il suo costruire ponti tra modellizzazioni psicoanalitiche differenti, mai perdendo di vista il legame con la clinica, intreccia e interroga simultaneamente Freud, Bion e il modello di Campo, il pensiero di Ogden, ma non dimentica i lavori di Bollas. In relazione allo psicoanalista inglese, Macchia, non a caso, si sofferma sul tema del “conosciuto non pensato” (1987) sottolineandone le sintonie con il pensiero orientale (Bollas, 2013), un pensiero “maggiormente orientato ad estendere le forme dell’esperienza, la forma del sé nell’ordine presentativo (di matrice materna)” (p. 64). Torna qui, al termine di questa recensione, la mia rêverie iniziale del “ponte tibetano”, nel suo irradiarsi verso l’Oriente come metafora dell’Essere, e di una psicoanalisi che coglie l’esistere del soggetto come dimensione inter-soggettiva. Una psicoanalisi che ha cioè il coraggio di affermare che la “soggettività è da intendersi al plurale” (p. 72), e che consideri “il silenzio come una matrice di comunicazione piuttosto che una forma di resistenza” (p. 65).
Riferimenti bibliografici
Bion, W.R. (1962), Apprendere dall’esperienza, Armando, Roma, 1972.
Bion, W.R. (1965), Trasformazioni, Armando, Roma, 1973.
Bion, W.R. (1970) Attenzione e interpretazione, Armando, Roma, 1973.
Bollas, C. (1987), L’ombra dell’oggetto. Psicoanalisi del conosciuto non pensato. Borla, Roma, 1989.
Bollas, C. (2013), La mente orientale. Psicoanalisi e Cina, Raffaello Cortina, Milano.
Civitarese, G. (2019), I nomi di O:Bion è un mistico? In Riv. Psicoanal. 65, 281-302.
Ferro, A. (2007), Evitare le emozioni, vivere le emozioni, Raffaello Cortina, Milano.
Freud, S. (1899), L’interpretazione dei sogni, O.S.F. Bollati Boringhieri, 1979.
Levine, H.B. (2013), Unrepresented States and Construction of Meaning. Clinical and Theoretical Contribution, Karnak, London.
Ogden, T.H. (2005), L’arte della psicoanalisi, Raffaello Cortina, Milano, 2008.
Ogden, T.H. (2006), Holding e contenimento, essere e sognare, L’annata psicoanalitica internazionale, 2:153-169, Borla, Roma.
Sapisochin, G.(2013), Second thoughts on Agieren: Listening to the enacted, in Int. J. Psychoan., 94, 967-991.
Winnicott, D.W. (1969), The use of an object, in Int. J. Psychoan., 50:, 711-716.
