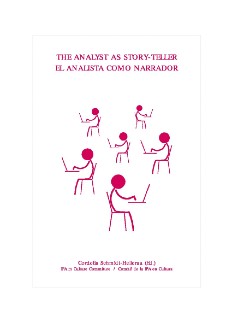
International Psychoanalytical Association
2021 Short Story Contest
Racconto selezionato per la pubblicazione nel libro The Analyst as Storyteller / ‘El Analista como Narrador’
“Un assassinio senza pretese”
di Gemma Zontin
Si è infilata nella mia vita in silenzio. Senza chiedere, senza parlare, senza aspettative né speranze. La quarantena l’ha scacciata dal regno di mezzo che si era costruita sugli scalini del palazzo tra la facciata ottocentesca e i giardini che la circondano. Un posto sicuro tra la casupola attraversata dalla strada e le case con il parquet di legno e il verde intorno.
Il giorno in cui ognuno si è chiuso ermeticamente dentro lei è scivolata fuori. Fuori dalla casupola, dai gradini, dalla paura. E si è infilata nel mio giardino. Non so dire da dove. Forse dal cancello lasciato aperto per un momento, forse dalla porta dischiusa per una consegna, un pacco lasciato a terra prima di una fuga precipitosa. Da allora è sempre lì. Mi gira intorno già dalla mattina. Sparisce, ritorna. Quando lavoro la sento giocare con i cani. Il tonfo della palla che colpisce il muro del giardino, l’abbaiare allegro dei cani, il suo mutismo assoluto. Quando non lavoro mi stringe piano il braccio e mi guarda. Niente parole. Solo quello sguardo acuto e fisso. Vorrei scrollarmela di dosso. Vorrei togliermi da torno il suo aspetto dimesso, i capelli arruffati, l’odore greve. Vorrei non sapere, non capire, non intuire la storia senza storia che la segue dovunque vada. Ma non posso staccare la mano ferma, le dita scure con cui circonda il mio polso. Posso solo tacere anche io. Non parlarle, non chiedere, sperando che sparisca dalla stessa fessura in cui si è infilata. Perché se è lì, i miei pensieri si sfrangiano. E di questo ho una gran paura. Più del corpo che cede al “rompete le righe” della vecchiaia. Più dell’epidemia. Più del silenzio irreale che mi circonda. Ma lei non se ne va. Un po’ per volta mi rassegno alla sua stretta, la lascio fare. Un po’ per volta diventa la vita in mezzo a tanta morte. Una vita testarda, resistente, anonima, eppure vita.
A mano a mano che la primavera avanza insieme ai morti raggrumati nelle rianimazioni e al virus, innocente e letale, l’aspetto. Dividiamo il giardino e il sole precocemente caldo. Io leggo, lei gioca con il mio polso.
La sua presenza mi sfinisce, la sua assenza mi immalinconisce. Infine le ho dato un nome: Claudia. Per via di un’andatura dondolante e perché non so il suo. E neppure lo voglio sapere. So però che non appena cala il buio sparisce. Non so perché ma va via di corsa. Scompare nella strada che attraversa la sua casupola, muta e rapida, come un sogno di cui non afferri le immagini.
Quando lei se ne va so che è ora. È ora che io vada al cancello e aspetti. Aspetto mia figlia, anestesista e rianimatore. Ci vediamo dalle sbarre, io di qua, lei di là. Per via del virus, dice lei. Non ci vuole contagiare. Il padre ed io siamo anziani. Arriva di corsa, alta e scorbutica, faccia da bandito dietro mascherine e cappucci. Sorride, racconta storie serene, storie di chi ce la fa, storie buffe di colleghi che non sanno indossare le tute da contenimento biologico, storie di persone al margine tra vita e morte. Ma siamo a metà aprile e le storie serene ormai cominciano a scarseggiare. Aprile, si sa, è il mese più crudele. E lei stavolta ha un’aria preoccupata.
“Mamma, ho visto la bambina che sta sempre qui con te” – dice tutto di fila come temendo di essere interrotta.
“Dove?” – chiedo interdetta. Che importanza potrà mai avere dove va Claudia quando sparisce dal giardino o da casa. È un pezzo di storia per cui non ho curiosità. Claudia è la bambina delle ore stanche e perse, delle ore di mezzo tra un prima e un poi.
“In strada” – insiste lei superando la mia domanda sfaccendata – “Spingeva un carrello con dei sacchetti della spazzatura. Insomma va in giro per le case a raccogliere i rifiuti e poi li va a gettare nei bidoni sulla strada. La gente le dà qualche soldo per questo servizio. Perciò va via non appena cala il buio”.
“Capisco” – dico io. E mi riferisco all’odore e alle dita annerite alla punta. Ma non afferro la furia di mia figlia.
“No, non capisci” – continua infatti lei – “Va in giro per le case. Quindi può essere contagiata e contagiare te. E tu puoi contagiare papà. Non devi sottovalutare questa faccenda, mamma.”
E noi siamo anziani e a rischio. Lei non lo ha detto. Ci vuole bene. Ma so che è questo che pensa. È la verità. Ma mi indispettisce comunque.
“Non sottovaluto proprio nulla” – ribatto in fretta – “Ma se lei vuole stare con me non sarò io a impedirglielo”.
“Le vuoi bene…” – dice mia figlia con un sorrisetto.
“No… Sì… Non lo so” – rispondo io infastidita. E davvero non lo so. So che non posso più pensare ad una giornata al sole senza Claudia che giocherella con il mio polso mentre leggo.
“Falle disinfettare le mani, comunque” – dice mia figlia sospirando – “Tanto non te lo levi dalla testa. Sei testarda, lo sai? Te lo hanno mai detto?”
Faccio segno di sì. Me lo hanno detto molte volte. Ma non mi è mai importato. Insistere sulle cose mi è stato sempre utile.
Con un altro sospiro mia figlia mi porge dalle sbarre qualcosa. Un pacchetto piatto, mi pare.
“E falle mettere queste” – conclude scuotendo un sacchetto di plastica trasparente pieno di mascherine.
Lo afferro dalle sbarre del cancello. Ci mandiamo baci a distanza. Poi lei sale a casa sua, nel mio stesso palazzo, dall’avvocato che è lì che pensa a lei.
Passo la sera a pensare al discorso da fare a Claudia sulla questione mascherine e disinfettante. Non le ho mai parlato e non so da che parte cominciare. Stare con lei mi piaceva proprio per questo mutismo che ci univa: una donna anziana e una bambina legate dall’intento di far passare il tempo ognuna persa nelle sue cose, ognuna chiusa nei suoi pensieri. Non mi viene in mente nulla che possa avere senso per lei. O per me, se è per questo.
Il giorno dopo la trovo seduta sullo sgabello che le ho messo all’ombra degli alberi. Il lettino sul quale mi stendo a prendere il sole è perpendicolare allo sgabello in modo che lei possa circondare con le dita il mio polso. Ormai è la nostra posizione.
Le porgo il disinfettante e la mascherina senza dire nulla. Claudia si pulisce con cura le mani. La mascherina invece non se la mette. Prende però lo sgabello e lo tira di fronte al lettino. A suo modo ha messo in atto il distanziamento. Così però non può giocare con il mio polso. Si limita a stare lì mentre leggo. Abbiamo ripreso la nostra vita. Però la stretta delle dita mi manca e così di tanto in tanto la guardo. Ma oggi lei non guarda me. Ha gli occhi fissi sulla terrazza di fronte. Mi incuriosisco e comincio a guardare anche io. Ci sono tre ragazze. Parlano, ridono, si tengono per mano. Poi le espressioni cambiano. Si oscurano. Le voci si spengono. I gesti si irrigidiscono. Infine le ragazze scompaiono.
Per qualche giorno le abbiamo osservate. Sono lì che ridono e poi è come se capitasse qualcosa di oscuro che le scaccia via dal loro terrazzo. Quando se ne vanno Claudia gira sempre lo sguardo come se qualcosa turbasse anche lei. Mi viene voglia di sapere cosa fa fuggire le ragazze e disturba lo sguardo fisso e acuto di Claudia. Così giro la telecamera di sorveglianza del giardino, quella che dà sul cancello di ingresso. È proprio di fronte al loro terrazzo. Dovrebbe aiutarmi a capire che succede lì su.
E prima del tramonto, prima che Claudia fugga via, guardiamo al computer le immagini. Claudia è serissima. Si siede vicino a me e tiene gli occhi fissi sullo schermo. Le immagini scorrono. Non sono chiarissime e non mostrano granché. Le ragazze, i vestiti leggeri, il muretto, i fili del bucato. E un’ombra scura, alla fine, che si allunga sul pavimento. Poi le ragazze scompaiono e l’ombra pure. E il terrazzo si svuota.
Quando la bambina se ne va e io resto sola, traffico con le immagini. Ingrandisco, contrasto, ritaglio. L’ombra si definisce. Un uomo direi. Un uomo le fa fuggire via, le disperde come foglie di autunno.
Due giorni dopo la nostra attività di spionaggio si conclude. Il tonfo all’alba, le sirene, la polizia, l’ambulanza. Un uomo si è buttato da un terrazzo, dice la gente dai balconi. Perché non sopportava più la quarantena. Succede. Questa situazione ormai è diventata intollerabile. Ma si è buttato di testa come un tuffatore dal trampolino. Il viso era intatto. Solo il cranio era in pezzi. L’ambulanza ha portato via il corpo in fretta. Niente chiesa, né funerali. Cosa sarà mai un suicidio ora che c’è il virus, ora che i morti sono tanti? Una corsa al cimitero senza messa né corteo funebre ed è tutto finito.
Un suicidio? Questa storia di uno che si butta giù di testa mi pare strana. È una possibilità infinitesima nei suicidi da defenestrazione. La gente in genere si getta nel vuoto saltando frontalmente, non di testa. Ma non vado oltre. Non ci voglio andare.
Il mattino dopo le ragazze sono di nuovo sul terrazzo. Parlano a bassa voce. Si scambiano sorrisi come di nascosto. Si guardano intorno furtive. Io sono certa che non fuggiranno più dai fili del bucato in mezzo ai quali giocano. Che non ci saranno più ombre a distendersi sul pavimento rosso per cacciarle via dal loro rifugio. E infatti il loro giorno trascorre tranquillo in cima al loro mondo pacificato.
Però devo sapere.
“Prendi la spazzatura anche da loro?” – chiedo a Claudia. E mi rendo conto che sono le prime parole che le dico.
Lei fa cenno di sì.
“Ieri l’hai presa?” – continuo io.
Scuote il capo in segno di diniego.
“Vai stasera e portala qui. Ok?” – le chiedo.
Sorride attenta e mi stringe le dita.
È sera inoltrata quando bussa alla porta. Ha un sacchetto scuro nella mano. Ci nascondiamo in giardino e apriamo il sacchetto alla luce delle lampade esterne. Le boccette di barbiturico sono al fondo nascoste in un involto di carta che sa di candeggina.
Non so perché le ho conservate. Aprile è passato. Maggio si è presentato caldissimo e assolato. Ormai si comincia ad uscire e il terrazzo non ci interessa più. Ogni sabato Claudia ed io abbiamo preso l’abitudine di andare in giro per la città. Le ho comprato dei vestiti nuovi online e prima di uscire la infilo nella doccia. Lei è molto fiera di questo pezzo di vita sua con me. Arriva puntualissima al mattino. Si allunga sotto il getto caldo dell’acqua. Poi sceglie un vestito con grande cura e infine è pronta per uscire. Usciamo con il cuore in gola. Le regole ci spaventano e forse anche questa nuova anormalità. Ma noi ogni sabato andiamo verso la nostra personale avventura. Eppure nella borsa mi porto sempre dietro le boccette. Quattro.
E un sabato le incontriamo: le tre ragazze e la madre. Mi fermo di fronte a loro e loro si bloccano di colpo. Rovisto nella borsa e tendo le boccette. La donna mi guarda spaventata e comincia a torcersi le mani.
“Quattro” – dico come parlando tra me – “Non ci ho pensato subito. Ma quattro aveva un senso. Una boccetta per ognuna delle ragazze. E una per lei.”
Spalancano gli occhi atterrite. Poi la madre apre la bocca come per dire qualcosa. Io le prendo la mano e ci infilo le boccette.
“Le frantumi” – dico guardandola fisso. Poi afferro la mano di Claudia, volto le spalle e mi incammino per la stradina assolata. Non sono a caccia di confessioni. Non sono a caccia di altro dolore. E poi la candeggina ha cancellato ogni prova e a giudicare non sarò io. Il loro personale tormento lo farà al posto mio. Claudia ed io abbiamo altro da fare. Lei deve occuparsi della mia vita logora. Io della sua vita senza storia.
Gemma Zontini psichiatra e psicoanalista SPI con funzioni di training. Autrice di numerose pubblicazioni su riviste e libri italiani e stranieri. In particolare ha curato alcune antologie tra cui Scalzone F. e Zontini G (a cura di). (1999). Perché l’isteria? Napoli, Liguori; e Scalzone F. e Zontini G. (a cura di). (2013.) Il linguaggio delle afasie. Napoli. Liguori. Alcuni dei suoi articoli più recenti sono: Réflexions sur la dimension de l’idéal dans les troubles psychiques liés au travail. In Travailler, 2018, 40, 65-75; Silence as a tool for the analyst In The Italian Psychoanalytic Annual 2018/12 pp. 44-63; Fondamenti inconsci del soggetto ‘presoggettivo’”, in Notes n. 16, (2021) vol. 2, pp. 83-94.
