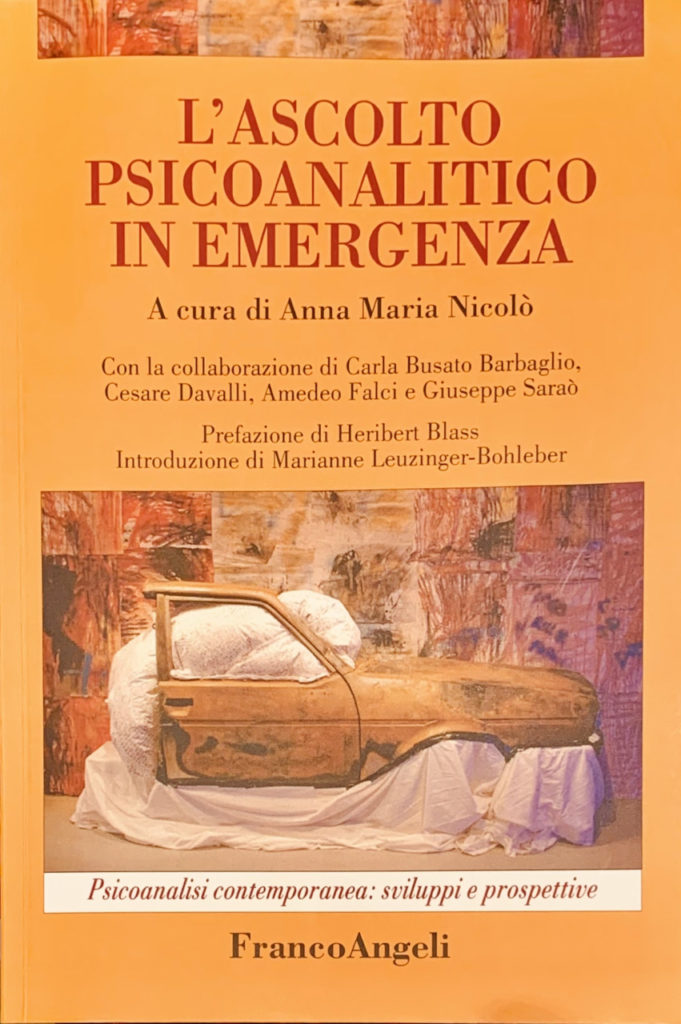
Parole chiave: ascolto, setting, emergenza
L’ASCOLTO PSICOANALITICO NELL’EMERGENZA
A cura di Anna Maria Nicolò
Con la collaborazione di Carla Busato Barbaglio, Cesare Davalli, Amedeo Falci e Giuseppe Saraò
Prefazione di Heribert Blass
Introduzione di Marianne Leuzinger-Bohleber
(Franco Angeli ed., 2021)
Recensione a cura di Maria Antoncecchi
“Laddove la psicologia individuale è fin dall’inizio psicologia sociale”
Freud,1921,OSF,9
All’inizio della pandemia, nel marzo 2020, la comunità psicoanalitica si chiedeva quale contributo avrebbe potuto dare al diffuso senso di malessere che aveva colpito gran parte della popolazione. In modo tempestivo, da aprile 2020 fino a fine giugno 2020, sotto la Presidenza di Anna Maria Nicolò, in accordo con il Ministero della Salute, è stato istituito un Servizio di Ascolto gratuito per offrire un aiuto psicologico a tutti coloro che ne avessero fatto richiesta. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di circa quattrocento psicoanalisti provenienti da tutte le regioni d’Italia che hanno risposto a circa 1500 persone. Una discesa in campo della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) che ha espresso coraggiosamente la sua funzione sociale offrendo, in una situazione drammatica, uno spazio gratuito all’interno del quale la sofferenza potesse trovare ascolto. Il distanziamento sociale e il confronto diretto con la morte hanno causato una rottura dei legami sociali che ha sicuramente costituito un terreno fertile per lo svilupparsi del malessere psichico slatentizzando vecchie patologie e/o acutizzando sofferenze presenti.
Il libro, curato da Anna Maria Nicolò, intitolato “L’ascolto in emergenza” raccoglie i numerosi contributi relativi al lavoro svolto da un gruppo di colleghi analisti durante il Servizio di Ascolto e contiene numerosi spunti di riflessione su un’esperienza che possiamo definire unica. Come sottolinea Marianne Leuzinger-Bohleber, nell’introduzione del libro, la SPI ha fornito ‘alla psicoanalisi un modello globale di come alla conoscenza psicoanalitica possa essere permesso di lasciare la sua torre d’avorio psicoanalitica in un modo nuovo durante crisi acute come la pandemia.’
Questa esperienza, nata in una situazione eccezionale come quella della pandemia, ha avuto il merito di sperimentare una modalità d’intervento inusuale per il metodo psicoanalitico, e messo alla prova l’utilizzo di strumenti psicoanalitico lontano dalla stanza d’analisi. Come si può evincere dalle riflessioni contenute nei numerosi contributi degli autori, la creazione di un setting specifico, delimitato nel tempo e nello spazio, non ha impedito agli analisti di attivare quella ‘funzione analizzante’ (Bastianini, 2018) che ha permesso l’elaborazione, in un breve arco di tempo, di esperienze emotive intense attivate dalla situazione traumatica. Un ascolto che ‘rivolge il proprio inconscio come un organo ricevente verso l’inconscio del malato’(Freud, 1912, p. 536) al fine di ‘trasformare l’esperienza emotiva in termini di tollerabilità e pensabilità’(Lussana, 2021). Anna Maria Nicolò, che ha posto la sua attenzione sulla qualità dell’ascolto effettuato dagli analisti, lo ha definito un ‘ascolto elaborativo’ per la capacità dell’analista di accogliere e contenere il dolore trasformandolo in pensieri condivisi, consentendo ai pazienti di passare da una situazione di impotenza ad una maggiore capacità di gestire i propri vissuti emotivi.
Tutti i lavori presenti nel libro hanno voluto evidenziare come la specificità della formazione analitica abbia determinato la qualità dell’ascolto, che ha reso gli interventi degli analisti ‘trasformativi piuttosto che supportivi’ (Filograna). La capacità dell’analista di essere aperto all’ascolto di stati mentali non rappresentati, e memorie emerse a causa del trauma collettivo, ha permesso la costruzione di nuovi collegamenti e nuovi significati sbloccando, nella maggioranza dei casi, una condizione di paralisi, riattivando la ricerca di un nuovo equilibrio (Colella, Davalli, La Torre, Mondini). Mi pare importante rilevare dalla lettura dei numerosi e interessanti casi presentati che l’ascolto analitico non ha potuto prescindere dall’individuazione ‘di un abbozzo di una relazione transferale-controtransferale’ (Giuliana Rocchetti, Fabrizio Rocchetto), presente durante i colloqui che, sebbene non analizzabile, ha avuto una funzione orientativa delle dinamiche presenti nella relazione.
Un aspetto significativo del Servizio di Ascolto è stata la dimensione temporale del nuovo setting concepito per adattarsi a nuova realtà sociale e per fornire ai pazienti uno ‘spazio potenziale’, un luogo d’incontro tra due menti che potesse consentire alle persone di uscire da una solitudine emotiva e di arginare l’invasività del trauma (Rizzitelli). Diversamente dalla struttura temporale dell’analisi classica costituita da un tempo definito (della seduta analitica) e da un tempo indefinito (la durata del trattamento) gli incontri, avvenuti da remoto, hanno avuto una durata che poteva oscillare da uno a quattro volte. Un ascolto a termine (Scotto di Fasano), sintonizzato con le comunicazioni inconsce del paziente all’interno di una cornice chiara e condivisa all’interno del quale l’analista ha potuto modulare i suoi interventi fornendo ‘interpretazioni lievi’(Cocchiarella, Cocozza di Montanara, Galeota, Gentile, Ligozzi, Petrì, Rinaldi, Zontini) ovvero ‘tese a promuovere le risorse presenti nell’individuo’. Alcuni lavori hanno evidenziato che ‘l’ orizzonte temporale limitato si è rivelato un potente organizzatore della relazione transferale direzionando la qualità degli interventi dell’analista in ascolto, spingendo analista e paziente ad incontrarsi il più rapidamente possibile’(Pini).
Questo rimodellamento del setting si inserisce su una riflessione più ampia sull’estensione del metodo psicoanalitico che, grazie alla sua diffusione e all’evoluzione della teoria e della tecnica, si è rivolto a contesti clinici sempre nuovi alla ‘periferia dell’analizzabile’(Pellizzari, Moroni, 2019). Il Servizio di Ascolto, che ha funzionato come un vero e proprio ‘laboratorio di psicoanalisi sociale’ anche per la presenza dei gruppi di lavoro (Cardia, Genovesi, La Torre, Lisciotto, Siragusa) ha accolto, focalizzando i suoi interventi, le richieste dei genitori relative al disagio manifestato dai bambini, degli adolescenti e degli anziani entrambi particolarmente colpiti, anche se in modo differente, dalla pandemia (Alessi, Busato Barbaglio, Comandini, Risso).
E’ bene ricordare che il ricorso alla modalità in remoto è stato oggetto di un corposo dibattito che continua ancora oggi in quanto ha sostituito, durante il lockdown, il lavoro analitico classico che altrimenti avrebbe subito una lunga sospensione. Un cambiamento transitorio e necessario che, pur con le inevitabili perplessità, ha dimostrato l’efficacia e la plasticità dello strumento psicoanalitico.
Un altro elemento distintivo di questa esperienza è stata l’assenza della presenza fisica che, secondo alcuni autori, ha reso il canale acustico (tono, ritmo, silenzi) un veicolo importante di trasmissione di contenuti significativi. ‘L’ascolto al buio’ come è stato definito da alcuni autori, ha consentito all’analista di rivolgere l’attenzione alle componenti non verbali della comunicazione provenienti dall’incontro con il paziente. La voce ha evocato ‘immagini corporee dense di significati affettivi precoci’ (Nanetti, Pesce) stimolando immagini e fantasie ricomposte dall’analista nel linguaggio degli affetti. Lavorare al buio senza l’immagine corporea del paziente non ha determinato una minore intensità ma un’amplificazione del canale sonoro-preverbale che, per riprendere le parole di Mancia (2004, p. 54)” attiva intensi sentimenti transferali e controtransferali dell’incontro” e “ richiama le primissime esperienze endouterine e post natali con la madre archiviate nella memoria implicita e in alcune parti dell’inconscio non rimosso.”
Infine vorrei segnalare l’importanza dei gruppi di lavoro che, come alcuni lavori all’interno del volume segnalano, si sono costituiti allo scopo di condividere e riflettere sull’esperienza del Servizio di Ascolto. Il lavoro del gruppo, oltre ad essere un momento di approfondimento clinico, ha avuto la funzione di sostenere l’impatto violento che l’esperienza della pandemia ha avuto sui pazienti attraverso il contenimento dell’emotività e ha aiutato gli analisti ad elaborare le complesse dinamiche transferali e controtransferali legate anche a simmetrie inconsce (Cara, Giannini, Malgherini, Fiorelli, Evangelisti, Corda) determinate dall’essere entrambi immersi nella stessa ‘atmosfera emotiva’. Il gruppo di ascolto è stato una risorsa straordinaria per confrontarsi su una nuova modalità di intervento e per valorizzare ‘la funzione psicoanalitica della mente’ che, come una bussola, ha indicato nuovi percorsi e nuove prospettive ( Saraò, Masoni, Pappa, Ramacciotti).
Il libro si conclude con un’interessante postfazione di Amedeo Falci che sottolinea i punti centrali dei contributi e suggerisce ulteriori approfondimenti.
Bibliografia
Bastianini T.(2018), “Lo specifico della cura psicoanalitica nelle estensioni del metodo”. In Bastianini T., Ferruta A. (a cura di), La cura psicoanalitica contemporanea, Giovanni Fioriti, Roma
Freud S. (1912), Consigli al medico nel trattamento analitico. O.S.F.,6.
Mancia M.(2004), Sentire le parole, Archivi sonori nella memoria implicita e musicalità nel transfert, Bollati Boringhieri, Torino.
