
Parole chiave: Psicoanalisi; Freud; Filosofia; Odio; Passione; Eros; Ogden
“La passione dell’odio. Il pozzo avvelenato”
Mirella Galeota, Renata Rizzitelli (a cura di)
(Franco Angeli ed., 2024)
Recensione a cura di Angelo Moroni
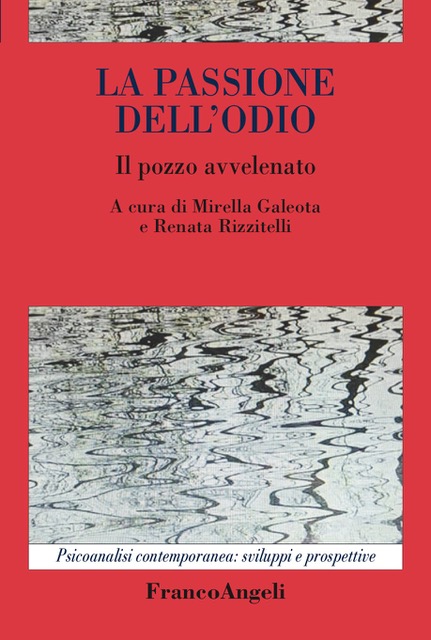
Credo che sia proprio il caso di dire che questo volume collettaneo, egregiamente curato da Mirella Galeota e Renata Rizzitelli, si “prenda cura” dell’odio inteso come “passione”, ma anche come tipologia specifica di legame affettivo, di tensione, seppur distruttiva, verso l’oggetto, di spinta epistemofilica. E’ una passione scientifica infatti, un guardare all’ ἐπιστήμη che, paradossalmente, l’odio promuove, a muovere a sua volta il gruppo di colleghi coordinato da Galeota e Rizzitelli, sugli impervi e dolorosi sentieri di un’area di ricerca psicoanalitica davvero difficile. I nove capitoli che costituiscono l’opera – preceduti da una raffinata introduzione di Luisa Masina, e seguiti da una postfazione delle stesse curatrici – guardano al tema della distruttività umana da differenti prospettive nonché da un vertice sia storico che filosofico (lo evidenziano i capitoli di Eveline List, docente di Storia della Psicoanalisi presso l’Università di Vienna, e quello di Marcella D’Abbiero, Storica della Filosofia presso l’Università “La Sapienza” di Roma). Sentieri dissestati e dolenti, sentieri interrotti, “Holzwege”, come li chiamerebbe Heidegger (1950), ma sui quali non viene mai perduto l’obiettivo della ricerca, dell’ ἐπιστήμη. Utilizzo qui questo termine greco nel senso platonico del Teeteto, in particolare nell’interpretazione che Heidegger dà di questo concetto, oggi molto presente in Psicoanalisi, soprattutto nel dibattito scientifico corrente che riguarda la distinzione ogdeniana tra “psicoanalisi epistemologica” e “psicoanalisi ontologica”. E’ proprio da questa prospettiva che vorrei cogliere i maggiori pregi di questo volume, cioè dalla portata che definirei “gnoseologica” di questo testo, al di là dei differenti apporti teorici dei diversi Autori che vi scrivono. Nell’affrontare una “passione” come quella dell’odio, della violenza verso l’oggetto (sia esso l’oggetto primario, che, nel transfert, l’”oggetto” analista e il suo “uso”), è infatti l’”attacco al legame” (Bion, 1957) come attacco al pensiero, a porre lo psicoanalista di fronte ad una sorta di inattingibilità di tale oggetto di studio. Tale inattingibilità è ottimamente richiamata dal sottotitolo, “Il pozzo avvelenato”: immergersi come sommozzatori-ricercatori negli abissi di un pozzo avvelenato, è intanto un’esperienza perturbante, se non propriamente pericolosa per la stabilità mentale dei ricercatori stessi. Ciò che colpisce innanzitutto degli interventi di ciascun Autore è invece la capacità di mantenere, e saper rendere nella scrittura, una giusta distanza, un assetto interno, un aplomb emotivo che consente di mantenere viva una tensione gnoseologico-psicoanalitica sempre molto generativa di pensiero. Luisa Masina, nella sua Introduzione paragona emblematicamente il testo ad una “falda acquifera” che “presenta incroci, deviazioni e confluenze, capaci di rendere il terreno fecondo per il pensiero e per lo sviluppo di ulteriori riflessioni su un tema così vasto e controverso” (p. 12). Un “pozzo avvelenato”, certo, se guardiamo all’odio solo nel suo muoversi morti-fero. Ma fondale che può diventare anche “falda acquifera (…) capace di rendere il terreno fecondo”, se messo in una giusta tensione, appunto, gnoseologica. Tale afflato si dispiega mirabilmente a partire dal capitolo di Tonia Cancrini che intreccia il tema dell’odio con quello del senso di colpa, in un’ottica eminentemente kleiniana (la Klein che interpreta l’odio nel suo noto scritto “Alcune riflessioni sull’Orestiade” di Eschilo). Seguono poi le prospettive ferencziane di Martin Cabré, quella più vicina a Winnicott e Masud Khan di Renata Rizzitelli e Maria Pia Corbò, quella che si apre alle teorie gruppo-analitiche di Daniele Biondo, nonché la prospettiva sull’odio in adolescenza di Maria Grazia Fusacchia e dello stesso Biondo. Per motivi di spazio non posso naturalmente addentrarmi nei dettagli di ciascun capitolo. Vorrei invece soffermarmi su ciò che mi sembra accomunare le visioni dei singoli Autori, cioè appunto la loro comune passione per la ricerca, tema che riguarda sia la concettualizzazione psicoanalitica dell’odio come “passione”, sia, a mio avviso, il metodo e la Weltanschauung della psicoanalisi contemporanea in generale. Il valore perspicuo di questo testo è a mio avviso proprio il suo rimandare continuamente all’importanza di un’etica della conoscenza dell’odio. Tensione che, curiosamente, contraddistingue quella caratterizzante il cambio di paradigma conoscitivo del mondo insito nel passaggio evolutivo adolescenziale. In questo l’adolescenza è espressione prototipica (archetipica?) della modalità del “conoscere” dell’Essere umano in generale: modalità che contiene, come un’aporia, Amore e Morte, ma è, al tempo stesso, necessità di un rovesciamento della concezione filosofica della conoscenza classicamente, positivisticamente intesa. Come si vede, ci troviamo nel cuore della mission etica e scientifica della stessa psicoanalisi. Si tratta infatti della necessità, per la psicoanalisi, di aprirsi al pensare a nuovi paradigmi che facciano coesistere Odio e Amore, e li sappiano cogliere in un unico movimento, li sappia integrare. Il libro curato da Rizzitelli e Galeota invita a considerare come “luogo delle origini” di questa aporia fondativa dell’umano, la relazione primaria, che è anche coniunctio oppositorum, contrasto e contraddizione creativa tra Conoscenza, Amore e Morte, elementi che stanno al cuore della vita stessa di ciascuno di noi. Il Conoscere umano – sembra suggerirci questo libro, così polifonico e pluristratificato – è necessariamente fondato sull’affetto, sulla “passione”, come ci ricorda peraltro anche Heidegger, nella sua analisi del Teeteto di Platone. Cosa integra “passione” e “conoscenza”, di cui Platone parla nel Teeteto, e lo porta a definire la conoscenza come legame emotivo-affettivo – proprio come il procedere della psicoanalisi – secondo Heidegger? Scrive il filosofo tedesco, con parole chiare e mirabili:
“τὸ αἰσθάνεσθαι, l’esser percepito, non riguarda nient’altro se non ὃ φαίνεται, ciò che si mostra, cosicché abbiamo l’equazione: αἰσθάνεσθαι = φαίνεσθαι, esser percepito = mostrar-si. Platone designa questo mostrante-si senz’altro come φαντασία. Questa equivalenza di αἰσθάνεσθαι con ὃ φαίνεται (φαντασία) si trova nel dialogo (152 c 1)” [1]
E’ il “mostrarsi” dell’odio, il suo essere dolorosamente percepito (αἰσθάνεσθαι) così come fantasticato (φαίνεται-φαντασία) sul palcoscenico del mondo, a muovere dunque, paradossalmente, la passione per la conoscenza, per l’approfondimento, che non può che assumere la forma della “tonalità emotiva” (Heidegger, 1926). Ma il momento in cui si manifestano i primi segni di questa “individuazione” del Sé dell’uomo come tensione al conoscere coincide al contempo con il manifestarsi di Eros, essenza dell’Anima platonica. La tensione alla conoscenza come “episteme”, è una manifestazione di Eros così come scrive Heidegger nella sua interpretazione del Teeteto platonico:
“Essa è (…) quella tensione in cui facciamo prevalere come misura e legge ciò che rende possibile e regge dalle fondamenta l’esser-ci in quanto tale. Questa tensione dell’essere Platone la chiama anche ἔρως “ [2].
Tener vivo questo slancio alla contiinua ricerca, questo tèlos orientato da Eros, è il compito ultimo della psicoanalisi, la sua cifra etica e terapeutica distintiva. Esso solo può consentire allo psicoanalista, così come all’homo sapiens sapiens di uscire dal “pozzo avvelenato” dell’odio.
Riferimenti bibliografici
Bion, W.R. (1957). Attacchi al legame. In: Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico. Roma, Armando, 1970
Bion, W.R. (1962a). Una teoria del pensiero. In: Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico. Roma, Armando, 1970.
M. Heidegger (1931-1932), Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet (Freiburger Vorlesung WS 1931/32), in Gesamtausgabe, Band 34, hrsg. von H. Morchen, Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M. 1988; tr. it. di F. Volpi, L’essenza della verità. Sul mito della caverna e sul «Teeteto» di Platone, Adelphi, Milano 1997.
Heidegger, M. (1926), Essere e tempo, Milano, Longanesi, 2005.
Heidegger, M. (1950), Holzwege. Sentieri erranti nella selva, Milano, Bompiani, 2014.
Ogden, T.H., (2004) This art of psychoanalysis, in International Journal of Psychoanalysis, 85/4, pp. 857-887.
Ogden, T.H. (2008), L’arte della psicoanalisi. Sognare sogni non sognati, Milano, Raffaello Cortina Editore.
Ogden, T. H. (2019), Ontological Psychoanalysis or “What Do You Want to Be When You Grow Up?”, in The Psychoanalytic Quaterly, 88:4, 661-684
[1] M. Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet (1931-1932)., p. 163; tr. it. p. 194.
[2] M. Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet (1931-1932), cit., p. 216; tr. it. p. 248.
