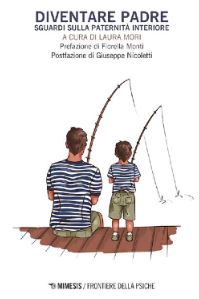
“Diventare padre” di L. Mori
“Diventare padre. Sguardi sulla paternità interiore”
A cura di Laura Mori
(Mimesis Edizioni, 2021)
Recensione di Paolo Meucci
Il presente volume è il risultato del lavoro di un gruppo di studio che per diversi anni ha discusso intorno alla paternità, ed è dedicato alla memoria di Franco Mori, che -come ricorda la curatrice – ha partecipato al lavoro del gruppo, svolgendovi per età e per storia, una funzione paterna.
Dopo tantissimi libri, articoli e convegni che in questi anni hanno indagato intorno al “tramonto” e alla “evaporazione” della figura del padre – spesso con tonalità apocalittiche, stile oracolare e contenuto passatista- abbiamo un volume che si occupa di paternità con uno spirito conoscitivo, volto ad esplorare all’interno della mente e del mondo degli uomini che vivono l’esperienza di avere un figlio.
Tale compito viene assolto grazie all’intreccio di tanti contributi in cui gli autori utilizzano la propria esperienza clinica, vari riferimenti psicoanalitici e testi letterari.
Nei primi tre capitoli M.R. Ceragioli, E. Fattirolli, A. Luperini, L. Mori e G. Smorto lavorano su vario materiale letterario. Nel quarto capitolo L. Cresti, I. Lapi e L. Mori definiscono la cornice teorica all’interno della quale si muove il gruppo. Nel quinto capitolo M. Cenerini e D. Messina sviluppano la loro riflessione intorno all’esperienza di conduzione di gruppi di preparazione alla nascita composti da neo-padri. Nel sesto capitolo L. Cresti, A. Fiori ed I. Lapi utilizzano i protocolli dell’ Infant Observation. Nel settimo capitolo C. Italiano riporta la propria esperienza di lavoro clinico con padri all’interno della Terapia Intensiva Neonatale. Nell’ottavo capitolo E. Fattirolli, A. Fiori, I. Lapi, L. Mori e C. Pratesi affrontano i fallimenti relativi al desiderio di paternità. Nel nono capitolo E. Fattiroll, I. Lapi e L. Root Fortini utilizzano vario materiale clinico per descrivere paternità difficili. Nell’appendice C. Casavecchia fa una panoramica di varie rappresentazione di padri nei libri per l’infanzia.
Ogni capitolo ha una sua specificità e può essere anche letto come un lavoro a sé, ma è ben chiaro che i tanti contributi sono il frutto non solo dei singoli autori, ma di un lavoro di gruppo che ha prodotto – come dice il sottotitolo del libro- vari sguardi sulla paternità interiore.
Si tratta di una ricerca che sposta l’attenzione dalle funzioni e ruoli paterni per concentrarsi sui processi psichici interiori che portano alla costruzione della paternità e la connotano (p. 18). Lavoro necessario, visto che -come giustamente segnala L. Mori- parallelamente ai tanti richiami sull’assenza o evanescenza del padre si assiste anche a significative spinte aggregative di padri alla ricerca di una diversa posizione paterna (p. 17).
Il gruppo di studio si è mosso in continuità con un precedente gruppo, a suo tempo promosso da Gina Ferrara Mori, che aveva esplorato i processi mentali che si attivano nelle gestanti e che aveva prodotto un volume uscito nel 2008, Un tempo per la maternità interiore. Come ricordano le autrici del 4° capitolo – che avevano collaborato anche al precedente volume- abbiamo denominato Maternità Interiore il processo di sviluppo della identità femminile materna e di elaborazione delle rappresentazioni mentali. Un aspetto centrale in tale processo è la costituzione di uno spazio interno, contenitore di fantasie, emozioni, desideri, nuovi legami, e di quel bambino fantasticato che diventerà, con la nascita, il bambino reale esterno (p. 59).
In analogia con queste concettualizzazioni, L. Mori, definisce la Paternità Interiore quell’esperienza psichica costituita dall’insieme delle dinamiche psicologiche e delle fantasie che si attivano nell’uomo fin da prima della nascita di un figlio o una figlia e che possono avere influenza sul rapporto con il figlio reale e sul cambiamento dello statuto identitario del futuro padre (p. 20).
Nel 1° capitolo, analizzando le impressioni, i pensieri ed vissuti di Levin – personaggio dell’Anna Karenina di L. Tolstoj – a contatto con il figlio da poco nato, le autrici individuano uno dei fattori centrali della Paternità Interiore, il Nuovo campo di vulnerabilità.
Come riassume L. Mori il Nuovo campo di vulnerabilità si riferisce a quello stato psicologico che il padre sperimenta nel momento in cui accoglie il suo ruolo … Comporta la capacità di mettersi nei panni del piccolo, coglierne la vulnerabilità e, al contempo, assumersi pienamente la parte di uomo adulto responsabile e protettivo proiettandosi verso il suo futuro. Si fa strada una prospettiva creativa e vitale che bilancia la vulnerabilità del bambino, del padre e del momento (p. 21).
Tale campo si va costituendo già da prima della nascita del bambino e nel 2° capitolo viene utilizzato il romanzo di J. Fante Full of Life per recuperare una vivida illustrazione dei processi di costruzione dell’identità di padre a partire dalla gravidanza fino alla nascita del bambino (p. 41). Di questo giovane padre vengono descritti sia i vissuti (di esclusione, di gelosia, di sentirsi una comparsa, di turbamento per le trasformazioni corporee della propria compagna gravida) sia alcune fantasie inconsce (di tipo paranoico e fusionale).
In stretta relazione con il Nuovo campo di vulnerabilità -che descrive lo stato psichico del padre, fatto di assunzione di responsabilità e funzione protettiva- le autrici del 1° capitolo collocano la Volontà riparatrice, sentimento che viene recuperato, anche in questo caso, grazie a materiale letterario, Il ritorno del figlio di G. Stuparich. Volontà riparatrice che mi sembra rimandare al pensiero di D. Meltzer.
Come ben riassume B. Golse (a cui fa riferimento anche F. Monti nella prefazione) secondo D. Meltzer il ruolo paterno consiste nell’intervenire a protezione e a difesa del bambino contro la posizione depressiva e contro l’impatto generato in lui [dal conflitto estetico] … Il padre sarà sempre destinato a rappresentare per il bambino … un oggetto – totale o parziale, a seconda dei casi- chiamato a proteggere il bambino dall’enigma materno in due modi diversi: da un lato attenuando questo enigma grazie al proprio ruolo di sostentamento della diade … dall’altro distanziando il bambino dall’oggetto materno totale e aiutandolo a scinderlo in diversi oggetti parziali. In questo modo il padre meltzeriano si rivela al tempo stesso separatore e riparatore, vale a dire preedipico e insieme postedipico … [capace di riunire] all’interno di una stessa dinamica, un processo di sostentamento preedipico e un processo di distanziamento postedipico (B. Golse, 2006, p. 136,137).
Mi sembra che si muovano su questa linea le autrici, che nel 4°capitolo individuano le due aree fondamentali in cui si definiscono le caratteristiche centrali della Paternità Interiore: l’area intrapsichica, in cui prende forma un Nuovo Campo di Vulnerabilità e l’area relazionale in cui il neo-padre trova una Posizione laterale.
Sempre utilizzando materiale letterario – in questo caso La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin, di E. Ianniello, che descrive lo sguardo strabico di un padre- le autrici del 1° capitolo sottolineano l’importanza che ha nella dinamica familiare la Posizione laterale assunta dal padre rispetto alla coppia madre-figlio, posizione che gli permette di assolvere alle sue funzioni sia separative che riparative.
Riguardo alle funzioni materne e paterne – per non fare equazioni improprie tra genere e funzioni- trovo utile riprendere quanto dice L. Emanuel (2008) – citato dagli autori nel 5° capitolo- per puntualizzare che ognuno dei genitori incarna dentro sé stesso sia la funzione materna sia quella paterna, come una coppia genitoriale combinata interna (cit. p. 72). Per cui è la modulata combinazione di queste funzioni -che possono essere assolte da varie figure- che permette ai bambini di crescere in modo equilibrato anche in famiglie non monogamiche ma variamente composte.
Però non è delle funzioni paterne che si occupa primariamente il volume, riportando l’attenzione all’area intrapsichica, nel 4° capitolo le autrici sottolineano come i nuovi padri delle ultime generazioni siano sempre più coinvolti e partecipi nell’accudimento primario del figlio e come tale coinvolgimento emotivo e corporeo solleciti oltre alla mobilitazione delle parti maschili di sé e all’identificazione con il padre, anche una condivisione con una parte femminile di sé, rigettata dalla cultura tradizionale. I nuovi padri sono chiamati sempre di più a questo compito psichico, a tollerare i vissuti regressivi che può comportare, e a confrontarsi con tutto il complesso di identificazioni con le proprie figure femminili e infantili (p. 62).
In questa mobilitazione di identificazioni, nel 2° capitolo viene evidenziato come nella costituzione della paternità sia rimessa in gioco anche la relazione con il proprio padre interno e reale. Nel racconto di J. Fante, il crollo della propria casa viene evitato grazie al recupero di un buon padre che aiuta il giovane uomo ad utilizzare una funzione riparatrice. Ecco che il padre del futuro padre fa il suo ingresso per dare una mano a bonificare il percorso del figlio verso la paternità (p. 46). È grazie a questo passaggio di testimone, grazie alla capacità del proprio padre di mettersi da parte, grazie alla capacità del protagonista di reggere il senso di colpa per avere spodestato il padre dal suo posto, per vederlo rimpicciolire e ormai vecchio (p. 47), che può compiersi il processo di assunzione della paternità.
Per concludere, il concetto di Paternità Interiore oltre ad avere la specificità che gli autori del volume hanno definito -come lo stato intrapsichico specifico dell’uomo che diventa padre- mi sembra essere particolarmente adatto anche a descrivere una forma che la paternità è andata prendendo negli ultimi decenni nella nostra cultura. In genere non si ha più a che fare con famiglie patriarcali, in cui il ruolo di padre viene sancito da un principio di autorità, perlopiù i padri il proprio ruolo se lo debbono conquistare. In una condizione di fluidità di ruoli e funzioni, grazie alla accettazione del muoversi in un campo di vulnerabilità, grazie alla capacità di attivare uno sguardo laterale sembra possibile per i neo-padri trovare una loro specificità e centralità nel vivere la paternità, che non è più né individualmente esibita né socialmente asseverata ma è appunto primariamente una paternità interiore.
Il gruppo di colleghi che hanno lavorato a questo libro hanno dunque dato un contributo significativo nell’esplorare alcuni aspetti della paternità, hanno introdotto concetti importanti, che però debbono sicuramente essere approfonditi, individuando differenze e sovrapposizioni con concetti già utilizzati all’interno della teoria psicoanalitica. A titolo di esempio, mi sembra particolarmente interessante il riferimento degli autori del 5° capitolo al Lavoro di semplificazione che spesso viene svolto dai padri, modalità di funzionamento che può essere vista come espressione di superficialità o solo nella sua componente difensiva ma che sembra invece svolgere una importante funzione adattiva, utile a liberare spazio mentale all’interno della famiglia.
Una ricerca dunque che deve proseguire, sulla scia di quanto dice L. Mori, ci poniamo idealmente a nostra volta come parte di un più vasto gruppo costituito dai lettori che potranno portare avanti la nostra ricerca (p. 23).
