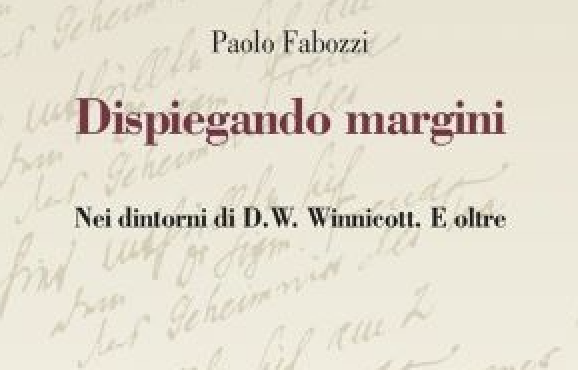
Parole chiave: Psicoanalisi; Freud; Winnicott; Oggetto transizionale; Holding; Squiggle; Psiche-Soma; Illusione
“Dispiegando margini. Nei dintorni di D.W.Winnicott. E oltre”
di Paolo Fabozzi
(Franco Angeli, 2024)
Recensione a cura di Giuseppe Di Chiara
Libro interessante, questo di Paolo Fabozzi, principalmente per due motivi. Il primo è quello di un’accurata revisione dell’opera di Winnicott, che viene così sottratta da una deriva centrifuga e
riportata nel percorso centrale della psicoanalisi e della sua evoluzione. Il secondo è il conseguente
rimaneggiamento in crescita dei modelli clinici e teorici della psicoanalisi, con un occhio attento
alla realtà italiana del panorama psicoanalitico.
La cospicua Introduzione fa una carrellata sul volume, ricordandone l’origine nelle
considerazioni fatte sull’incontro tra i concetti winnicottiani e le esperienze cliniche, riuscendo così
a raddrizzare alcuni malintesi, come quello della madre reale, storica e dell’ambiente, e a
confermare le scoperte di Winnicott, il playing, il sapere resistere alla aggressività dell’oggetto, il
primo incontro con l’altro, il ruolo del controtransfert, l’importanza del teatro psicoanalitico (22),
l’indipendenza di Winnicott , e il suo sapersi sottrarre al massimalismo radicale con il suo
soffocante riduzionismo.
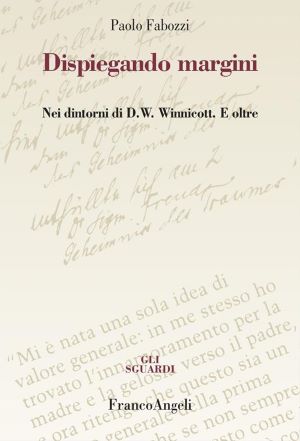
Quella di Winnicott è indicata come “una silenziosa e radicale rivoluzione futura” nel primo
capitolo che contiene una magistrale esposizione delle radici del pensiero winnicottiano : lo
spettacolo teatrale nel sogno di una paziente (37), la rivalutazione dello Junktim freudiano di teoria
con clinica (43). Non un Winnicott radicalmente ambientalista, ma piuttosto la sottolineatura
dell’efficacia degli scambi inconsci tra quelli che Riolo ha chiamato “i due viandanti sulla via
dell’analisi” (45).
Segue una riuscita rivisitazione storica e scientifica degli anni delle Controversial
discussions e dello sviluppo del pensiero winnicottiano, che si affida all’imparare dal paziente e
dalla relazione umana. Troviamo qui un esame attento di Fabozzi su quel termine utilizzato in modo
particolare da Winnicott, illusione. Essa viene avvicinata a una sovrapposizione tra una percezione
di realtà esterna e una rappresentazione interiore – che mi ricorda le preconcezioni di Money-Kyrle,
e poi Bion- . Lo sviluppo del processo analitico è determinato da “una rete di movimenti inconsci
tra soggetto ed oggetto che segnano l’andamento del processo analitico” (62), così come segnano lo
sviluppo della psiche del bambino.
Sviluppo precoce del bambino al quale è dedicato il terzo capitolo, che analizza “Gli stati
precoci dell’essere”, “l’illusione e l’oggetto soggettivo” e la “nascita del sè”. Winnicott non propone
una teoria forte e conclusa, ma segue percorsi osservativi e congetture. Segnala la propria
insoddisfazione per il termine narcisismo, così come impiegato comunemente (68) ed evidenzia
“una solitudine intrinseca fondamentale e inalterabile” (69) , assistita e soccorsa dall’oggetto
materno (70), con l’aspetto propulsivo della “preoccupazione materna primaria” ( 71).
Il quarto capitolo è dedicato al cruciale concetto di playing, usato da Winnicott. Noto che in
tutto il volume playing è adoperato prevalentemente nel senso di gioco, e non viene accostato allo
Spielen freudiano, che comprende la rappresentazione teatrale. Certamente deriva dall’uso che se ne
fa nella “stanza dei giochi”, una libera associazione non di parole, ma di materiali, nella quale è al
lavoro-io proporrei- un precoce “costruttore psicoanalitico”. Vi è una descrizione poetica dell’uso
del gioco e del suo significato, della sua rilevanza, del suo declinare spontaneo nella narrazione e
nella rappresentazione.
Dedicato all’ “Uso di un oggetto tra distruttività e creatività” è il quinto capitolo. Capitolo
difficile, ma assai rilevante. Il lavoro venne presentato da Winnicott nel novembre del 1968 ai
colleghi di New York. Fu “una serata scientifica leggendaria”! (107). Probabilmente con una radice in movimenti transferali profondi. E’ centrale nell’argomentazione di Winnicott portare l’oggetto, la
madre per prima, fuori dell’onnipotenza. Si parla di “una fisiologica esperienza di onnipotenza”
(111), attraverso la quale il bambino impara ad adoperare l’oggetto (108). Mi sembra che si tratti di
transitare da una onnipotenza, che gira a vuoto, ad una potenza effettiva, che richiede al bambino il
suo massimo sforzo, per realizzare “un oggetto pienamente altro da me, in grado di nutrirmi, ma
soprattutto dotato di una vita autonoma, indipendente da me e dal mio controllo, un’entità a sé
stante” (112). Sembra proprio che sia il soggetto, il bambino, che insegna all’oggetto, la madre, ad
essere tale ! E qui Fabozzi si chiede : “perchè Winnicott non ricorre alla figura paterna ?” (ivi) Lo
riprenderà più avanti. Qui conclude che non siamo in presenza di una semplice accettazione della
realtà ma piuttosto di fronte a “un processo attivo di istituzione dell’oggetto come esterno al proprio
sé”, creando in tal modo un mondo di realtà condiviso (113). Una reciproca modulazione tra
bambino e madre che realizza una diade funzionale allo sviluppo.
La seconda parte del lavoro è dedicata alla aggressività, l’origine della quale è indovata nella
motilità. Il termine “distruttività” è per Winnicott inadeguato (115). E’ un distruggere potenziale,
che non è distruzione (117), una distruzione che non distrugge (126). Winnicott resta con la sua
“irrinunciabile critica al costrutto freudiano di pulsione di morte”, così come a quello kleiniano di
invidia innata (108). E’ chiaro che è richiesto un lavoro alla madre per sintonizzarsi su questi
registri! Così come allo psicoanalista, che per riuscirvi deve praticare una “soggettività temperata”,
matura, deve sapere essere “vivo e reale”. Alla fine Fabozzi riprende il tema del padre, del quale
Winnicott ebbe un’intuizione sulla sua funzione, quando scrisse, due mesi dopo il seminario
newyorkese, “L’uso di un oggetto nel contesto dell’uomo Mosè e la religione monoteistica”. Fu però
un’intuizione che fece fatica a portare avanti (128).
I capitoli che seguono sviluppano quell’ “Oltre”, che è nel titolo del libro. Illuminati dalle
scoperte winnicottiane esplorano aree di frontiera della ricerca psicoanalitica.
Il sesto capitolo racconta di “Irruzioni, ritiri, sparizioni. Esplorazioni tra narcisismo e
distruttività”. In esordio un riassunto di vissuti psicotici e traumatici della mitologia per mettere in
luce come, seguendo Laplanche, il piccolo dell’uomo, come l’umanità originaria, non abbia gli
strumenti per governare tutto questo. Individui e società custodirebbero un fondo spaventoso e
ingovernabile, che si trasmette nel tempo. Fabozzi propone anche l’esistenza di un ambiente
assolutamente sfavorevole, un ambiente pestifero (136). Così le difese sono assenze e irruzioni , che
alla fine provocano disconnessioni, ritiri, sparizioni. Solo dopo molto lavoro nella cura ricompaiono
elementi dell’Essere (come in scritti di Steiner, Colombi e De Masi). Fabozzi si interroga e si
impegna in una rivisitazione critica di alcuni capisaldi freudiani. Dubita della pulsione di morte,
come Winnicott (143); trova infelice la metafora freudiana dell’Ameba per il narcisismo primario;
indica come complice di questa infelicità il freudiano “principio di costanza”, per il quale la psiche
tende a liberarsi di qualsiasi stimolo. Tutto contro l’oggetto. E giustamente ci ricorda come un’altra
realtà ci è mostrata dalla infant observation. Si confronta anche con Bion, indicando il rischio che
egli corre d’essere, talvolta, “un analista che sa troppo” e che non fa uso della capacità negativa.
(144). Conclude il capitolo l’evidenza nella clinica della ricomparsa di quei frammenti di “essere”
nel contatto del paziente con l’analista, che riesce ad “essere l’oggetto che ha anche la capacità di
essere”, secondo Winnicott (150).
Ed è con la “mente dell’analista e i fatti clinici”, che si apre il capitolo settimo sulla
“Genesi dell’interpretazione”, nel quale l’autore studia “il complesso rapporto tra clinica, teoria e
tecnica che presiede alla genesi dell’interpretazione” (154). Realizzare la situazione analitica “non
in una cornice di mera simmetria” (159), nella quale la persona dell’analista, attraverso la sua analisi
personale e la sua formazione, è attivo e presente” (155), in un’ottica di continuo sviluppo e
aggiornamento di teorie e di tecniche, senza perdere le conquiste fatte, ma aggiungendone nuove. Si
chiama, questa dell’analista, “soggettività temperata”(156), che è ampliamento della recettività,
cogliendo i messaggi più diversi dei pazienti con i quali essi esprimono “una inconscia richiesta di
lavoro analitico”( come il bebè esprime la richiesta di un’attività materna). Il paziente cerca di
essere “confermato nella propria identità” (157). (Funzione che l’analista assolve attraverso il
proprio ‘narratore psicoanalitico’, Di Chiara, 2022, 2024). Nell’ascolto analitico si realizza labcollaborazione dell’analista con il paziente che cerca l’incontro (158), utilizzando la “funzione
segnale” del controtransfert (159), posizionandosi nell’ “area intermedia”, distante e diversa dal
‘sapere oracolare’, ma anche “da un relativismo che sfocia nella simmetrizzazione tra paziente ed
analista” (160). E’ così che è possibile “ospitare l’estraneità”(161), utilizzando idonee tecniche di
ascolto (162). E qui si arriva alla interpretazione nel senso teatrale, al dare vita a personaggi e
vicende, ricordando il Phantasieren freudiano (163-164).
L’esplorazione dell’inconscio non rimosso è diventata attuale nella psicoanalisi contemporanea. Fabozzi non la affronta come una messa in crisi delle tecniche della psicoanalisi, ma, al contrario, con un loro perfezionamento. Esso è tale, perchè non venne rimosso, togliendogli le parole, ma perché le parole non le ebbe mai e gli vanno date. Ad esso è dedicato l’ottavo capitolo.
Fabozzi indica due particolari forme di difesa impiegate dai pazienti, e che sono molto incisive sul
controtransfert, quella ‘silenziosa’ e quella ‘rumorosa’. E proprio di questa dà un esempio clinico
veramente interessante. La paziente raccontata dà in clamorose escandescenze, innescate da un
intervento dell’analista sulla libera associazione della paziente, che dice : “ ieri sono stata a disagio
in compagnia di una coppia !” E l’analista dice : “che abbia a che fare con la sessualità !” Dopo il
difficile attraversamento della procella, la paziente approda al racconto di come dormì nella camera
da letto dei genitori dalla nascita ai sei anni, quando nacque un fratello.
Nel capitolo nono, conclusivo, vengono presentate quattro sorprendenti situazioni cliniche,
caratterizzate da una accurata descrizione dei vissuti controtransferali. Con esse la proposta di
suddividere il controtransfert in tre forme cliniche e teoriche, distinguibili anche per i loro effetti sul
funzionamento psichico e sullo psiche-soma dell’analista. La prima è il controtransfert “che veicola
perlopiù contenuti rimossi nella accezione di P. Heimann” e che “si fonda sull’intuizione freudiana
della comunicazione tra l’inconscio del paziente e l’inconscio dell’analista” (201), La seconda è il
“controtransfert riconducibile alla identificazione proiettiva, che veicola contenuti scissi e si basa su
un canale in cui lo scambio avviene tra un soggetto e un oggetto” (ivi). E un terzo tipo “in cui viene
trasmesso il modo in cui l’ambiente primario si è diffuso e ha pervaso e impregnato di sé il bambino
durante i suoi stati di quiete e di potenzialmente fisiologica fusione con l’ambiente” (ivi). Potrebbe,
questo terzo tipo di controtransfert, rispondere a un transfert di “sentimento oceanico”, da cui Freud
si teneva lontano ? (202). In questo caso una traccia della situazione ambientale primaria
riprenderebbe vita nella stanza dell’analisi !
