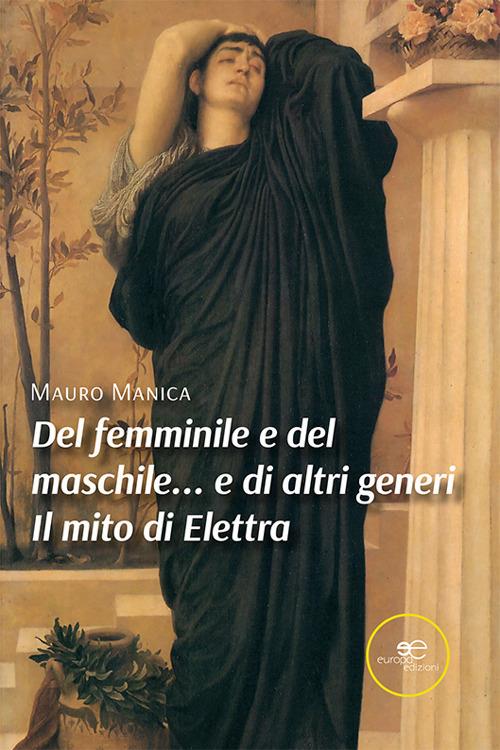
Parole chiave sono: Psicoanalisi, Identità, Genere, Identificazione, Mito.
“Del femminile e del maschile… e di altri generi. Il mito di Elettra”
di Mauro Manica
Con un saggio conclusivo di Anna Bassetti e Sandro Panizza
(Europa ed., 2022)
Recensione a cura di Maria Giuseppina Pappa
Il libro di Mauro Manica, “Del femminile e del maschile… e di altri generi. Il mito di Elettra”, di recente pubblicazione, sin dalle prime pagine si presenta come un testo di particolare interesse, e speciale da vari punti di vista, oltre che per i suoi ricchi e originali contenuti. Innanzitutto è stato concepito ed è nato nella mente dell’Autore in uno stato di “attenzione liberamente sospesa” (Freud, 1912), e di “rêverie” (Bion, 1962), a partire dalla rilettura di alcuni classici della letteratura greca come le tragedie di Sofocle, di Eschilo e di Euripide, l’Iliade e l’Odissea di Omero, e dalla lettura dell’Odissea di Nikos Kazantzakis (1957). Si tratta di un libro il cui asse portante, nelle varie parti che lo compongono, è il mito, che, così come viene concepito da Bion, ha la sua centralità nell’ambito del pensiero non come oggetto, bensì in quanto strumento di interpretazione, assumendo un valore decisivo pure nella ricerca e nel metodo della psicoanalisi (De Matteis, 2020). Nel collocare la metapsicologia psicoanalitica in linea con la metafisica e l’ontologia, Bion considera clinicamente i miti “sistemi deduttivi scientifici” a pieno titolo, ritenendo anche la scienza un mito, poiché si basa ragionevolmente sui “sensi” (Grotstein, 2007). Bion infatti evidenzia come l’interpretazione efficace concerna gli elementi psicoanalitici nelle tre dimensioni corrispondenti alle estensioni nel campo del senso, del mito, e della passione (Bion, 1970). La conoscenza e l’uso dei miti sono fondamentali per l’analista, permettendo di individuare, afferrare e comprendere universi inconsci. I miti hanno rilevanza sia nello sviluppo del pensiero del singolo, così come i sogni, i ricordi, e le fantasie, sia in quello dell’umanità: sono trame narrative che funzionano come canovacci relazionali di base, in modo da poter garantire un ordine alla conoscenza del mondo. Così come lo scienziato si avvale di un metodo di indagine basato sulle formule matematiche, l’analista dispone di una gamma di miti, attraverso cui dare avvio a libere associazioni: “I miti offrono una visione narrativa dei problemi, in cui i diversi personaggi nella loro interazione sviluppano il dramma dell’uomo e del gruppo alla ricerca della verità, specialmente quando ricerca e curiosità si riferiscono alla conoscenza di se stessi” (Grinberg, Sor, Tabak De Bianchedi, 1991).
Nella sua approfondita e raffinata rilettura dei classici in chiave psicoanalitica, Manica si concentra sul mito di Elettra, la figlia che uccide la madre, Clitemnestra, per vendicare l’assassinio dell’amato padre, Agamennone. Il personaggio di Elettra, al di là i suoi rimandi alla figura di Edipo, ha spinto il pensiero dell’Autore verso la questione del femminile e del maschile. “Sognando” il personaggio di Elettra, attraverso le tragedie di Eschilo, Euripide e Sofocle, Manica si trova a considerare quanto potrebbe esserci di Elettra in ciascuno di noi, e quanto le nostre identità debbano fare i conti con una dimensione traumatica, che può trasmettersi attraverso le generazioni. La riflessione dell’Autore sul femminile e sul maschile, si è andata poi intrecciando con il tema dell’identità di genere, creando i presupposti per una domanda cruciale: “identità di genere o modalità dell’ essere?”. Se il nostro vertice di osservazione è la “modalità dell’essere”, abbiamo il compito di tutelare il diritto, inviolabile per ciascuno di noi, di scoprire e di diventare ciò che veramente è” (p. 8). A tal proposito Manica, attraverso la breve storia di Agnese, protagonista di un articolo di giornale dedicato al diritto di dotarsi di un’identità alias, cioè, al diritto di assumere un’identità anagrafica divergente da quella associata al genere sessuale di nascita, arriva a immaginare un incontro con l’altro che rispetti la verità della sua esperienza emotiva e identitaria, qualunque essa sia. Al termine del libro, Anna Bassetti e Sandro Panizza dialogano con l’Autore, indagando sul tema dell’identità intrecciato a quello del mito, rivolgendo il loro pensiero a Le Metamorfosi di Ovidio.
Addentrandoci nel mito di Elettra, di cui abbiamo tre versioni, quella di Eschilo, quella di Sofocle e quella di Euripide, possiamo considerare la tragedia di Elettra come la versione al femminile di una triangolazione che nel mito di Edipo riguarda il maschile? Jung aveva pensato al complesso di Elettra come al corrispettivo femminile dell’Edipo, diversamente da Freud, introducendo una significativa simmetria nei due sessi nella triangolazione familiare originaria. Manica sottolinea come il mito di Elettra abbia a che fare con complesse articolazioni tra femminile e maschile, tra essere e fare, sollevando temi profondi e attuali, che hanno a che fare con l’identità. Mentre Edipo è inconsapevole del fatto di aver ucciso il proprio padre, e solo successivamente se ne renderà conto, scoprendo di essere il responsabile della pestilenza, Elettra è immediatamente consapevole del suo destino, conosce le ragioni della propria sofferenza e sa di quali colpe si dovrà macchiare. Edipo agisce, fa, senza sapere chi è. Elettra, invece, sa chi è e perciò si sente obbligata ad agire, a fare. Nel soffermarsi a descrivere e ad analizzare il suggestivo blocco marmoreo del “gruppo Ludovisi”, con Oreste ed Elettra, dello scultore Menelao (I sec. A.C.), di cui viene riportata l’immagine nel libro (p. 14), l’ Autore nota come la figura di Elettra sovrasti quella del fratello, oltre che per la statura, per l’imponenza e la qualità maschile degli abiti, del taglio dei capelli, del profilo del viso, sorprendentemente simile a quello di Oreste. Sembra che qui l’artista, Menelao, colga il femmineo di Oreste, rappresentato come un giovinetto, poco più che adolescente, e il virile di Elena, ovvero l’intrecciarsi di elementi femminili e elementi maschili che, come le pieghe del marmo, si intrecciano nella personalità di ciascun essere umano. Dunque Elettra e Oreste potrebbero ben rappresentare i diversi aspetti del Sé di uno stesso individuo, il femminile e il maschile di un’unica persona. Infatti quando nella tragedia di Euripide Oreste vacilla nel compiere l’azione fatale di colpire al cuore della propria madre, è Elettra a impugnare il “brando”, e forse potrebbe essere la stessa mano, che prima indugia e poi agisce. Sulla base della straordinaria intuizione di Winnicott, della presenza di “elementi puramente femminili” e di “elementi puramente maschili” nella composizione di ogni personalità, viene da pensare che in questo caso, il femminile e il maschile, prima dissociati, ora trovino una loro integrazione. Più in particolare Winnicott (1966) concepisce l’elemento femminile “puro” come una manifestazione dell’Essere, che costituisce la base indispensabile per la scoperta di sé, del senso di sé, e di un senso di esistere, e, a partire da questo, alla capacità di sviluppare un interno, di essere un contenitore, di avere la capacità di usare i meccanismi di proiezione e di introiezione, e di entrare in rapporto con il mondo in termini di introiezione e proiezione. L’elemento maschile “puro”, riguarda invece il Fare, cioè ogni forma di attività, quindi -secondo Winnnicott- anche le concezioni relative al trovare, all’usare, alle pulsioni, all’erotismo orale, al sadismo orale, agli stadi anali, etc. La completezza di un essere umano è data dalla possibilità di esprimersi sia degli elementi femminili, che di quelli maschili, pena una mancanza a Essere, o, eventualmente a Fare. Del resto Jung (2009) afferma: “L’essere umano è però sia maschile che femminile, non è soltanto uomo o soltanto donna. Della sua anima non puoi dire di quale sesso sia”. Bion amplia ulteriormente gli aspetti relativi alla completezza dell’essere umano, a partire dalla sua concezione della configurazione contenitore-contenuto, per cui ogni aspetto del nostro funzionamento mentale è riconducibile alla relazione tra un contenitore e un contenuto, cioè tra un elemento femminile e un elemento maschile, tra un’anima e un animus. Sono la capacità di rêverie (Bion, 1962) e la capacità di sognare della madre, così come la capacità di sognare dell’analista a favorire lo sviluppo dei contenitori mentali, necessari per trasformare esperienze emotive traumatiche e intollerabili in emozioni che si possono vivere e che possono dare significato alla vita. La narrazione che ha come protagonista il personaggio di Elettra, ci mostra come un trauma invivibile, possa essere contenuto, pensato, sognato, e trasformato in un mito, cioè un patrimonio degli essere umani. Come sappiamo, la configurazione contenitore-contenuto proposta da Bion, oltre a rivoluzionare il modello freudiano della mente, estende le potenzialità cliniche del metodo psicoanalitico, collocando nell’intersoggettività il cuore del processo analitico. Nella prospettiva bioniana l’analista non deve convertire il paziente alla religione delle proprie teorie, ma “deve consentire al paziente di sviluppare la “religione” (Mancia, 1987) della sua mente, di re-ligare, di creare quelle connessioni tra soggettività e alterità, tra passato e presente, (tra memoria implicita e memoria esplicita), che permettano di aprirsi al mondo e al futuro” (p. 22). Mauro Manica lancia un potente stimolo alla riflessione, nell’aprire la domanda “perché Elettra siamo ‘noi’?”. Questo perché veniamo al mondo in una condizione di impotenza fondamentale, di Hilflosigkeit, di protratta neotenia, ma anche animati da un’insopprimibile spinta a esistere. Ma Elettra ci parla anche di quell’impotenza di fronte al fato che ognuno di noi si trova a dover tollerare quando eventi straordinari, a carattere luttuoso e traumatico sollecitano i nostri apparati per sognare, per pensare e per vivere le emozioni: la nostra possibilità di trasformare sconvolgenti sviluppi traumatici in sorprendenti progressioni oniriche (Manica, 2014). Elettra siamo “noi” perché a volte veniamo al mondo con destini pre-scritti, che non ci appartengono e siamo costretti a compiere, sinché non ci appropriamo del nostro destino. Questo ci pone di fronte alla questione del trauma che attraversa le generazioni, ovvero il problema della trasmissione della vita psichica tra le generazioni (Kaës, Faimberg, Enriquez, Baranes, 1993). All’inizio la psicoanalisi freudiana ha costruito il proprio modello del “traumatico” intorno all’idea di un conflitto intrapsichico rimosso, cioè reso inconscio, in cui il mito di Edipo è divenuto il complesso fantasmatico centrale di ogni esperienza traumatica. Nella concettualizzazione del complesso edipico Freud ha considerato esclusivamente Edipo, piuttosto che considerare gli altri personaggi e le implicazioni transgenerazionali. Nel corso del tempo si è andata diffondendo la tendenza a rivedere il mito di Edipo, analizzandone tutti gli elementi costitutivi, compreso il versante figlicida da parte di Laio. In questa prospettiva Edipo non è soltanto l’assassino del padre, animato dal desiderio di possedere la madre, ma è anche un bambino vittima delle esigenze narcisistiche di un padre che si è sentito minacciato dalla sua nascita. Edipo parricida, ma anche Oreste ed Elettra matricidi, appaiono come vittime di proiezioni genitoriali distruttive, tutti e tre alle prese con la terribile necessità di trasformare degli oggetti interni persecutori (la Sfinge, le Erinni) in Eumenidi, nelle “benevole”, cioè in funzioni genitoriali buone e contenitive. Pertanto l’Elettra di Euripide non può non uccidere, ma è prima e unica fra gli Atridi ad assumersi fino in fondo la responsabilità e la colpa.
Riprendendo il filo delle questioni identitarie, e dell’identità di genere, Manica esplora questo ambito scegliendo la prospettiva che privilegia la “modalità dell’essere”, avendo come riferimenti teorici il pensiero di Bion e di Winnicott. “Perché la nostra vera essenza rappresenta quella scintilla di divino che si trova dentro ciascuno di noi. E qui propongo di assumere l’idea della presenza di un’ “essenza divina” negli esseri umani in una prospettiva che non è religiosa, ma informata dalla psicoanalisi bioniana. E questa prospettiva presuppone che ogni esperienza si declini nel mondo esterno oppure nel mondo interno di ciascuno di noi, ma anche in un terzo mondo che, nella concezione di Bion (Bion, 1965, 1970), è il mondo di O..” (p. 44). Questa idea di “divinità”, in termini laici, potrebbe avere a che fare con un nucleo identitario essenziale, “sacro” e “inviolabile”, che dovrebbe essere “preservato dalla comunicazione” (Winnicott, 1962), nel senso di non essere alterato dalla comunicazione e dalle pressioni dell’ambiente, familiare, sociale, culturale, e libero di esprimersi spontaneamente. Come analisti sappiamo che diventare se stessi è un processo che si protrae per l’intero corso dell’esistenza, come frutto di un lavoro psicologico conscio e soprattutto inconscio, che auspicabilmente porti a sognare se stessi come sempre più protagonisti della propria esistenza (Ogden, 2009). La questione di poter considerare le diverse modalità dell’essere come espressioni di differenti identità di genere, nella sua complessità e delicatezza, è una questione fondamentale dal punto di vista psicoanalitico, nella pratica clinica, e nel rapporto con il mondo esterno, con una realtà sociale e culturale caratterizzata da molteplici e tumultuosi cambiamenti, in modo da contrastare in modo più efficace posizioni discriminatorie. Attualmente stiamo assistendo a un fenomeno in espansione, quale quello di adolescenti e giovani adulti che chiedono di scegliere o ridefinire il proprio genere sessuale e che conseguentemente chiedono un aiuto psicologico, per affrontare la transizione, o la scoperta e l’espressione del loro sé autentico. Tutto questo si svolge in una società che ha costruito due generi sessuali rigidamente separati, e in cui la fluidità dell’identità di genere e sessuale non sembra trovare posto. Come analisti siamo profondamente coinvolti, chiamati ad aprire nuove aree di conoscenza e a sviluppare un’attitudine ancora più fine alla cautela, al tatto, e all’ascolto, offrendo approcci specifici per ogni singolo individuo, nel tentativo di favorire il processo di soggettivazione. Manica ricorda la testimonianza in prima persona di Lucy Renée Mathilde Schwob, nota come Claude Cahun (1894-1954), che è stata un’artista, scrittrice, che attraverso le sue immagini e i suoi scritti, sembra rivendicare il diritto di essere ciò che si è: “Maschile? Femminile? Ma dipende dai casi. Neutro è il solo genere che mi si addice sempre” (p. 49).
Nella seconda parte del libro Anna Bassetti e Sandro Panizza, in dialogo con Mauro Manica, esplorano il tema del cambiamento, della trasformazione, e dell’identità di genere, scegliendo di partire da una rilettura, in chiave analitica, de Le Metamorfosi di Ovidio, un testo in cui, di volta in volta, il cambiamento di identità, ora di genere, come nella vicenda di Tiresia, ora ontologica, come nella maggior parte delle situazioni di vita, si presenta come soluzione benefica, sia per gli umani che per le divinità. Gli Autori si pongono due domande cruciali. La prima è se e in che modo identità di genere e identità ontologica siano strettamente legate fra loro, se quei fattori intersoggettivi di sviluppo (Winnicott, 1945), che forgiano un’identità, un sé ontologico unico nel suo genere, non influiscano anche nella costituzione e nelle variazioni del genere. “Se il crollo dell’intersoggettività o una sua profonda mutazione, non siano alla base delle trasformazioni identitarie e di genere” (p.85). Segue poi la domanda se l’identità trasformativa, assunta nel mito, non sia l’unico modo che l’eroe o l’eroina può assumere, per sopravvivere, e rimanere nell’esistenza (Heidegger, 1927), anche se sotto le specie di una forma diversa. Infine è possibile che la forma finale assunta dall’eroe, non abbia le sue radici in una forma psichica inconscia preesistente nel cuore del protagonista, o della protagonista, e che venga slatentizzata grazie all’intervento di un nume?”. Nella narrazione mitica che ruota intorno a Demetra, Persefone, Zeus e Ade, vediamo come la scelta identitaria, in tutte le sue declinazioni, dipenda dall’intreccio delle dinamiche narcisistiche e oggettuali familiari. Persefone è la dea della mescolanza tra l’identità bambina e l’identità adulta, tra la simbiosi e l’individuazione, tra la dea delle tenebre e la dea della luce. È un richiamo al divenire continuo della nostra identità, un’ emblema della pluralità di sé che ci abitano e che prendono la scena a seconda del momento. La psicoanalisi ontologica di Winnicott e Bion (Manica, 2021) e la filosofia dell’esistenza di Heidegger (1927) sembrano suggerirci che il mondo delle trasformazioni esperienziali è l’unico autentico. Il viaggio che conduce ciascun essere umano a tentare di diventare “chi” (quella persona che) autenticamente è, porta l’Autore a ripercorrere il vagare di Odisseo, alla ricerca di se stesso, sul “dorso del mare”. E questo vagare gli si presenta come la metafora dello sviluppo di una mente, dell’evoluzione da un funzionamento mentale caotico e disorganizzato alla capacità di sognare e di pensare. Concluderei con i bellissimi versi di Kazantzakis (Odissea, Canto XXIV, 1391-1393):
La grande mente balza sulla vetta del suo riscatto;
un ultimo frullo di ali vuote, poi, ritta nel vento,
si alza in volo, esce dall’ultima gabbia, la libertà.
Riferimenti bibliografici
Bion, W.R. (1962), Apprendere dall’esperienza, tr. it. Armando, Roma 1972.
Bion, W.R. (1965), Trasformazioni, tr.it. Armando, Roma 1973.
Bion, W.R. (1970), Attenzione e interpretazione, tr. it. Armando, Roma, 1973.
De Matteis T. (2020), Bion. Istruzioni per mantenersi vivi, Armando, Roma.
Freud, S. (1912), Consigli al medico nel trattamento psicoanalitico, OSF, 6.
Grinberg, L. Sor, D. Tabak De Bianchedi, E., (1991), Introduzione al pensiero di Bion, tr. it. Raffaello Cortina, Milano, 2017, (1993).
Grotstein, J.S. (2007), Un raggio di intensa oscurità. L’eredità di Wilfred Bion, tr. it. Raffaello Cortina Editore, Milano, 2010.
Heidegger, M. (1927), Essere e Tempo, Longanesi, Milano, 1960
Jung, C.G. (2009), Il libro rosso. Liber novus, tr. it. Bollati Boringhieri, Torino, 2010 e 2012.
Kaës, R., Faimberg, H., Enriquez, M., Baranes, J.-J. (1993), Trasmissione della vita psichica tra generazioni, tr. it. Borla, Roma, 1995.
Kazantzakis, N. (1957), Odissea, tr. it. Crocetti Editore, Cles (TN) 2020.
Mancia, M. (1987), Il sogno come religione della mente, Laterza, Roma-Bari.
Manica, M. (2014), Intercettare il sogno. Sviluppi traumatici e progressione onirica nel discorso psicoanalitico, Borla, Roma.
Manica, M. (2021), E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Il dialogo di Bion con la psicoanalisi, Armando, Roma.
Ogden, T.H. (2009), Riscoprire la psicoanalisi, attraverso la lettura creativa. Tr. it. Mimesis, Milano-Udine 2021.
Winnicott, D.W. (1945), Sviluppo emozionale primario, tr. it. in Dalla pediatria alla psicoanalisi, Martinelli, Firenze, 1974.
Winnicott, D.W. (1962), Comunicare e non comunicare: studio su alcuni opposti, tr.it. in Sviluppo affettivo e ambiente, Armando, Roma, 1970.
Winnicott, D.W. (1966), Sugli elementi maschili e femminili scissi, tr. it. in Esplorazioni psicoanalitiche, Raffaello Cortina Editore, Milano 1995.
Vedi anche:
