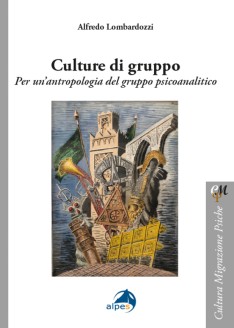
“Culture di gruppo” di A. Lombardozzi
Culture di gruppo
Per un’antropologia del gruppo psicoanalitico
di Alfredo Lombardozzi
(Alpes ed. 2021)
Recensione a cura di Daniele Biondo
L’Autore presenta in Culture di gruppo alcune originali riflessioni sul tema da lui interpretato in senso allargato rispetto alla proposta bioniana. Tali riflessioni sono accompagnate dalla descrizione di importanti esperienze realizzate in diversi contesti di gruppi psicoterapeutici ed esperienziali a conduzione psicoanalitica: gruppi di adulti, gruppi di bambini e preadolescenti e gruppi istituzionali nell’ambito dell’esperienza delle Migrazione. L’aspetto più originale del libro di Lombardozzi è la presentazione della dinamica di gruppo all’interno di un processo di trasformazione continua, in cui l’intrapsichico e la cultura sociale sono costantemente annodati configurandosi come fattori identificativi di un campo sempre aperto. L’analisi dell’intreccio fra la dimensione interna e quella esterna del piccolo gruppo analitico è fortemente alimentata dalla coesistenza all’interno di tutto il lavoro di Lombardozzi di un doppio vertice epistemologico: la psicoanalisi di gruppo e l’antropologia, che testimonia una capacità binoculare particolarmente preziosa per l’ambito di studio.
Nella sua bella prefazione al libro di Lombardozzi, Bruni sottolinea come il piccolo gruppo analitico abbia una specifica potenzialità a funzionare come un “sincizio pensante”: una mega cellula pensante con molti nuclei, un sintonizzatore sui diversi livelli di frequenza della mente umana, da quelli più “primitivi” e viscerali fino a quelli più notoriamente “culturali”. A sua volta Corrente sottolinea, nella seconda prefazione che introduce il libro, centrata sul tema a lui caro della migrazione, la funzione del gruppo come un contenitore per la trasformazione e alla cura degli aspetti del Sé danneggiati che coinvolgono l’intera personalità, nonché la capacità del gruppo di promuovere le “migrazioni-separazioni” che tutti sperimentiamo nel corso della vita.
Lombardozzi nella sua documentata proposta epistemologica presentata nella prima parte del volume, più che mai preziosa per affrontare la sfida culturale del nostro secolo, tenta di fondare un’antropologia del gruppo psicoanaliticointesa come “un mondo che costruisce una rete di rapporti, mitologie, racconti, metafore e forme della trasformazione psichica” . Per realizzare tale importante operazione scientifica Lombardozzi ha bisogno di ampliare la funzione della Cultura di gruppo orientandola non solo, come fa Bion, alla funzione di mediatore di conflitti interni al gruppo, ma anche in direzione di una mediazione tra la dinamica individuo/mentalità di gruppo e gli assetti extra-analitici. Assetti questi ultimi che entrano in relazione con il gruppo in quanto rappresentano molteplici forme di umanità come declinazioni di culture macro-sociali. Tale allargamento del concetto di Cultura, che nella proposta di Lombardozzi dovrebbe aggiungersi alle altre tre dimensioni della psicoanalisi individuate da Bion, Senso, Mito e Passione, permette all’Autore di cogliere la potenziale fluidità creativa del gruppo come ‘forza’ relativamente autonoma, potente e generativa. Una forza che permette di attraversare le diverse strutture, sistemi e funzioni del campo gruppale, considerato come fortemente dinamico e continuamente in movimento.
Oltre che ampliare e proseguire la proposta bioniana, Lombardozzi amplia il concetto freudiano di rinuncia pulsionale, alla base del patto sociale che fonda la Civiltà, considerandolo come solo uno dei meccanismi che l’umanità dispone per organizzare le pratiche sociali e le dimensioni simboliche che attengono alle più diverse forme di aggregazione.
Alla dimensione sociale e culturale del gruppo, Lombardozzi non manca di esplorare la dimensione della cura. Facendo tesoro dei contributi dei maestri italiani della psicoanalisi di gruppo, Francesco Corrao, Anna Baruzzi, Eugenio Gaburri, Francesco Siracusano, Claudio Neri, l’Autore esplora i diversi modi psicoanalitici di ‘curare’ in gruppo. Il debito ai concetti di Corrao di funzione gamma, koinodinia e koinonia è forte in Lombardozzi: sono concetti-strumenti fondamentali e fondanti che gli permettono di avvicinare con sicurezza il dolore che ogni membro del gruppo consegna al gruppo stesso affinché venga trasformato. Ma Lombardozzi non manca di testimoniare, anche quando attraversa l’ambito gruppale strettamente clinico, la propria vocazione sociale che lo spinge incessantemente ad ampliare il discorso verso prospettive extra-psicoanalitiche di tipo culturale, istituzionale, storico, che promuovono “un’ottica complessa, o polioculare, alla dimensione clinica”.
E’ grazie alla prospettiva “multipla” – che sempre di più mi sembra caratterizzare la psicoanalisi moderna, che ha nella nozione di “multistrato” (Margherita 2012) il suo episteme di riferimento – , che l’Autore riesce a mettere a fuoco un oggetto, il gruppo, che sfugge a griglie interpretative troppo strette e unidirezionali, a seconda anche delle istituzioni in cui il singolo gruppo è inserito. A tal proposito è molto interessante l’analisi delle diverse forme istituzionali che l’Autore realizza nella seconda parte del volume. Istituzioni che rappresentano molteplici ‘stili di vita’ e oscillano dagli stati più sociali e creativi a quelli più problematici che danno corpo “ai peggiori incubi di un totalitarismo che dissolve il senso di libertà dell’individuo e del gruppo” (p. 39). Un punto centrale per analizzare la dinamica istituzionale sembra essere per l’Autore quello del rapporto tra istituzione e organizzazioni o istituzione e compito. A tal proposito Lombardozzi afferma che: “quando gli aspetti organizzativi, pur necessari, o quelli troppo vincolati a compiti predisposti, prevalgono su assetti esperienziali più liberi si rischia una sclerotizzazione degli aspetti creativi dell’istituzione” (p.44). Gli studi antropologici di Lombardozzi gli permettono di approfondire il rapporto tra politica, potere e pratiche quotidiane della relazione sociale all’interno delle istituzioni inserite in determinati contesti culturali, per continuare a difendere con convinzione l’aspetto creativo della relazione fra individuo, gruppo e istituzione.
Nella terza parte del volume dedicata alle Migrazioni ed in particolare al lavoro con i gruppi di operatori di rifugiati e con i rifugiati stessi, Lombardozzi presenta alcune esperienze con equipe che gestiscono i centri di accoglienza. All’interno di questo contesto di “supervisione antropologica”, l’Autore approfondisce il rapporto tra diverse identità/alterità culturali e le forti emozioni che attraversano l’istituzione. In una delle esperienze presentate il conduttore del gruppo deve attivare un lavoro di differenziazione dei ruoli e delle culture di appartenenza, sia della componente africana che di quella italiana per aiutare il gruppo a superare la rigidità che inizialmente lo caratterizzava. Lombardozzi, coerente con l’impostazione generale del volume, propone il concetto di ‘individualità’ che unisce il vissuto personale con il flusso dei processi di identificazione gruppali e culturali. La babele linguistica del gruppo viene superata grazie alla koinonia gruppale che attiva un campo emotivo ‘sonoro’ armonico/disarmonico. Nella prima fase di lavoro gruppale tale confusione viene superata grazie all’attivazione della continuità dell’esperienza nell’auto-rappresentazione del gruppo “che è l’esito di processi sensoriali, mimetici e rappresentativi connessi in un campo relazionale assimilabile al concetto di Semiosfera, proposto da Claudio Neri (1995)” (pp. 58-59). Grazie alla conquista dell’appartenenza gruppale è possibile affrontare e superare i conflitti all’interno del centro, inerenti ad esempio la provenienza degli ospiti da diversi paesi in contrapposizione fra di loro (nigeriani contro quelli del Gambia a della Sierra Leone), o l’applicazione e il rispetto delle regole di convivenza, il rapporto con la burocrazia dello Stato italiano ecc.. Grazie all’impostazione antropologica di Lombardozzi, è possibile affrontare tali conflitti alla luce dei ‘costumi’ e dei modi relazionali che caratterizzano le diverse culture dei partecipanti al gruppo che orientano l’espressione dei loro sentimenti. Il gruppo diviene così “il luogo della negoziazione tra alterità”, in cui abitano i confini tra lo psichico e il culturale, tra le emozioni dolorose individuali e il contenimento gruppale delle stesse, tra la violenza del trauma migratorio e la pensabilità dello stesso, tra la ri-traumatizzazione prodotta dal lungo processo burocratico di attribuzione del ruolo di rifugiato e l’occasione di riscatto offerta dai rituali di gruppo. Attraverso il passaggio nell’esperienza catastrofica, trasformativa, afferma Lombardozzi “si riformula la ‘realtà traumatica’ in nuove possibili dimensioni di Tempo e Racconto” (p. 64).
Nella quarta parte del libro dedicata ai gruppi in età evolutiva Lombardozzi, in profonda sintonia con il pensiero e l’esperienza clinica di Lucilla Ruberti, utilizza le diverse tecniche della psicoanalisi infantile (gioco, interazione spontanea, disegno) all’interno di una varietà di configurazioni “plurilogiche, multifocali e polisemiche” caratterizzate dalla velocità e dal caos delle dinamiche gruppali. Lombardozzi fa tesoro della lezione della Baruzzi per tollerare il non-senso, stazionare nell’area transizionale e riuscire così a creare un contenitore dove attivare il pensiero emotivo. Tale conquista, afferma Lombardozzi, è permessa dalle diverse “forme di comunicazione simbolica” che a loro volta attivano il processo di trasformazione.
Nell’avvicinarsi ai gruppi di preadolescenti Lombardozzi sente la necessità di avvicinare gli elementi mitici a carattere dionisiaco nella loro interazione con i miti sociali contemporanei inerenti la condivisione e la ritualizzazione di ‘scene sessuali’ proposte/imposte dalla rete, dai social network e di videogiochi. L’Autore documenta clinicamente come il gruppo possa evolvere grazie alla condivisione della dimensione rituale del gioco, della parola e dell’esperienza gruppale, che permette l’elaborazione “di aspetti mitici, o ‘mitologemi’, che altrimenti si manifestano come elementi di pensiero emotivo a carattere rigido e non trasformabile” (p. 102).
Il volume si chiude con una Postfazione di Beneduce, il quale interroga la psicoanalisi su quanto essa sia capace di situare le “differenze culturali” sulla scena di una teoria dell’Inconscio non colonizzato, indocile, da cui poter far emergere fantasmi, miti e resti di altre strutture familiari, di altre cosmopratiche, di altre economie. Alla luce di tale interrogativo Beneduce trova convincente la proposta di Lombardozzi, proprio perché sfugge alle generalizzazioni, e aiuta a pensare in modo diverso le produzioni dell’inconscio, le dinamiche dei gruppi e la pratica analitica stessa. Un modo diverso permesso dalla sua impostazione etnologica, antropologica e storica, che sente “l’urgenza di una psicoanalisi che finalmente apprenda ad ascoltare e guardare dal lato degli oppressi, degli ultimi” (Beneduce, p. 114).
