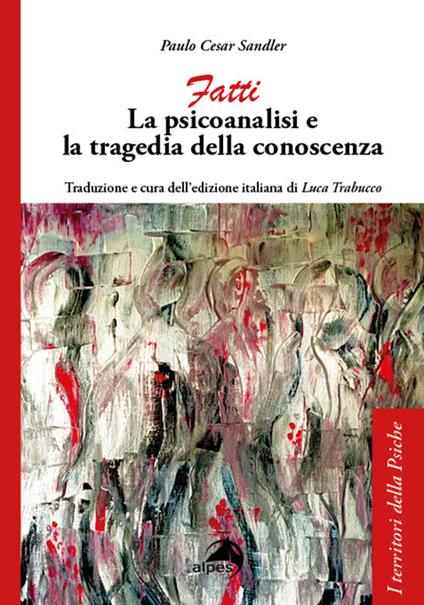
Parole chiave: Psicoanalisi; Bion; Conoscenza; Verità
Presentazione del libro Fatti La psicoanalisi e la tragedia della conoscenza di Paulo Cesar Sandler.
Traduzione e cura dell’edizione italiana di Luca Trabucco
(Alpes ed., 2022)
Il Centro Psicoanalitico di Firenze presenta:
Dialogo con l’Autore: Paulo Cesar Sandler
Interventi di: Carmelo Conforto, Gregorio Hautmann, Luca Trabucco
Venerdì 11 novembre 2022, il Centro Psicoanalitico di Firenze ha organizzato la presentazione del libro “Fatti. La psicoanalisi e la tragedia della conoscenza”, di Paulo Cesar Sandler. In questa occasione hanno dialogato con l’Autore Carmelo Conforto, Gregorio Hautmann, Luca Trabucco. Al centro del dialogo è stato posto il ripensamento operato da Bion dei concetti basilari della psicoanalisi, così come sono stati scoperti da Freud e Klein, principalmente. Sandler considera l’ipotesi che la psicoanalisi abbia le proprie origini nel riconoscimento della necessità umana di conoscere e tollerare la tragedia della conoscenza, la cui invarianza è la Verità, quel qualcosa cioè, come ci dice Bion, di cui la mente ha bisogno per poter crescere.
Vi riportiamo il contributo dell’Autore, Paulo Cesar Sandler, e i contributi di: Carmelo Conforto, Gregorio Hautmann, Luca Trabucco.
Intervento di Luca Trabucco
Il mio incontro con l’opera di Sandler è avvenuto alcuni anni fa, quando lessi il primo volume di A clinical application of Bion’s concept, pubblicati da Karnac. Ho trovato un’opera che si occupa di clinica senza ricorrere a un affastellamento di più o meno ben riuscite rendicontazioni di casi, ma con una chiara e omogenea idea di come funziona la clinica, su cosa si fonda, e quali ne siano i fondamenti ineludibili, che mi ha dato la sensazione di aver trovato, finalmente, quello che andavo cercando, anche se prima non sapevo che dovesse essere proprio così.
Il riferimento articolato a una tradizione di pensiero, ha permesso di chiarire un elemento che per me è sempre stato centrale, anche se mai è arrivato ad avere una chiarezza sufficiente, ovvero il riferimento al pensiero critico kantiano e post-kantiano (p.e. Cassirer), che avevo trovato ben esplicito nelle formulazioni di Bion, in parte in Freud e implicito in Klein. La chiarezza del suo scritto mi ha suscitato un’emozione e un interesse straordinario, e per ciò ho sentito la necessità di manifestare la mia gratitudine attraverso una mail. Già in passato era capitato di trovarmi in situazioni simili, sia con analisti italiani, magari già conosciuti da anni, sia stranieri, e nessuno aveva mai risposto. Paulo invece mi ha risposto il giorno stesso, e da lì è iniziato un rapporto che si è andato via via approfondendo. Avendo trovato nella bibliografia una sua opera dal titolo As origens da psicanalise na obra de Kant (L’origine della psicoanalisi nell’opera di Kant), ho voluto condividere questo mio interesse con lui, e nelle sue successive comunicazioni mi confortava in questo mio convincimento quando mi scrisse che il suo amico, James Grotstein, gli diceva che secondo lui non si poteva comprendere Bion, ma nemmeno la psicoanalisi, se non si sapeva qualcosa di Kant. Dopo poco tempo ricevetti questo volume direttamente da lui, insieme a quello successivo Turbulência e Urgência (Sturm und Drang). Il particolare non trascurabile che io non conoscessi il portoghese, contrapposto allo straordinario interesse che quel libro mi suscitava, ha fatto sì che imparassi il portoghese, dapprima attraverso l’ausilio dei traduttori elettronici, e poi con lezioni e “conversação”.
Il volume che ho tradotto rappresenta una sorta di preambolo metodologico al suo pensiero, e in particolare alla sua opera A apreensão da realidade psiquica (L’apprensione della realtà psichica), che consta di sette volumi pubblicati, da Imago tra il 1998 e il 2003, e due inediti, in cui Sandler, attraverso un excursus che partendo dal pensiero greco arriva da un lato a Klein e Bion, e dall’altro alla fisica relativistica e quantistica, pone le basi di una psicoanalisi “scientifica”, nel senso in cui la pensava Bion, come espressione dello sforzo umano di apprendere la realtà, psichica e materiale.
L’accento particolare che si pone in questo volume, Fatti, sulla coesistenza ineludibile di funzioni legate all’amore per la verità e all’odio per la verità, sviluppo del pensare e sviluppo del non-pensare, nella formulazione che Sandler propone funzione-α e funzione anti-α, rappresenta la base concettuale delle vicissitudini che la funzione psicoanalitica della mente attraversa dal suo sorgere nell’impresa di compiere una apprensione della realtà materiale e psichica, e delle difficoltà che il pensiero-senza-pensatore psicoanalisi incontra nel suo divenire, concreto, clinico, sia nel paziente che nell’analista.
La maggiore o minore capacità di tollerare il paradosso, di muoversi liberamente nella oscillazione PS<->D, traccia il percorso del pensiero filosofico e scientifico che Sandler rintraccia nei volumi di A apreensão, un riferimento epistemologico fondamentale, che, come si può chiaramente intendere, non è una epistemologia astratta, di una filosofia accademica che si avvolge su se stessa, ma l’epistemologia concreta dell’uomo che vive e cerca di comprendere la realtà, materiale e psichica, e dei mezzi che utilizza per operare questa conoscenza, o non conoscenza. Nello sviluppo dell’opera A apreensão da realidade psiquica, è questa capacità di tollerare il paradosso l’elemento discriminante nel fissare le “tappe” attraverso cui il pensiero si sviluppa, o regredisce. La maggiore capacità di tollerare il paradosso sarà quell’aspetto che determina una maggiore capacità di stare in contatto con la realtà/verità, funzionando secondo il principio di realtà e non secondo il principio di piacere/dispiacere. Platone, Kant, Shakespeare, Hegel, sono quelli che maggiormente rappresentano questa possibilità, e poi nella contemporaneità di Freud, Schopenhauer e Nietzsche coloro che più si avvicinano a questa situazione “ideale”. (L’ottavo volume della Apreensão, Formulazione della psicoanalisi. Schopenhauer, Brentano, Nietzsche e Freud, sarà per la prima volta pubblicato, nella mia traduzione italiana, fra qualche mese, sempre da Alpes).
Sandler rappresenta a mio avviso l’autore che in modo più rigoroso ha studiato, esplicitato e sviluppato il pensiero di Bion, partendo in particolare dall’opera che maggiormente, credo, rappresenti la libertà rigorosa del pensiero di Bion: Memoria del futuro. Nei tre volumi ad essa dedicati – Introdução a Memoria do futuro de W.R. Bion, Imago 1988, e i due volumi di An introduction to A memoir of the future by W.R. Bion, Karnac 2015, che egli utilizzava anche come punto di partenza per l’introduzione del pensiero di Bion con i candidati della Sociedade Brasileira. Questo mi pare indicare come Sandler sia riuscito ad avere il contatto più profondo con il carattere più creativo del pensiero di Bion.
Questo credo sia uno dei caratteri più notevoli, di questo libro, Fatti, e dell’opera di Sandler in generale. Egli non scrive in un modo “modaiolo”, non cerca l’effetto suggestivo attraverso fantasiose formulazioni, ma il suo pensiero parte da Invarianze, e le sviluppa. Penso che l’impressione, che a molti ha dato la lettura di questo volume, di freschezza e paradossale “semplicità”, sia il motivo per cui il suo lavoro è al di fuori da una considerazione temporale: il libro è stato scritto più di 30 anni fa, ma sembra scritto ieri.
Intervento di Gregorio Hautmann
Afferma Bion nel primo dei Seminari Italiani (1983): “È’ davvero molto difficile dire quale sia la componente sensoriale della psicoanalisi. In quanto pretendiamo di avere una prospettiva scientifica, si presume di solito che ci debbano essere delle prove che la confortano. Il punto che vorrei toccare qui è quello dell’importanza che ci sia una base di fatto e di come questi fatti debbano venire da noi osservati.” Specifica poi poco più oltre: “Penso che ciò che prova il paziente sia la cosa più simile ad un fatto -così come in genere io lo intendo- che egli sia in grado di sperimentare. La stessa cosa vale anche per me.” Sempre nel medesimo seminario, Bion dice anche: “Ricorrendo ad una metafora, si potrebbe dire che quando secerniamo un’idea, oppure quando produciamo una teoria, sembra che contemporaneamente emettiamo del materiale calcareo, diventiamo calcificati, l’idea diventa calcificata, ed allora abbiamo un’altra importante cesura da cui non si riesce a sfuggire.”Da rimarcare in quest’ultimo passo bioniano, (oltre, certo, al linguaggio fortemente sensoriale /corporeo: “secernere un’idea”, “calcificare”, la mente quindi come una ghiandola esocrina, tra secreti e calcificazioni), l’avverbio “contemporaneamente”; e la ragione di questa sottolineatura apparirà evidente con l’andare avanti del nostro discorso. Il libro, consente, a mio parere, di gettare un ponte, o quantomeno di tracciare un percorso tra questi due ordini di affermazioni bioniane, a prima vista distanti fra loro: da un lato l’esigenza di individuare quali sono i fatti da osservare, se vogliamo considerare la psicoanalisi alla stregua di una disciplina scientifica -il che significa stabilire cos’è un fatto psicoanalitico rispetto a quanto si intenda per fatto nell’accezione comune-, dall’altro la inevitabilità della calcificazione di un’idea, una volta che essa sia stata concepita. Nel seguire il suo percorso di pensiero, che ci aiuta, dicevo, a congiungere i due ordini di questioni, Paulo Cesar Sandler, brasiliano di San Paolo, psicoanalista importante ed autore straordinariamente prolifico e creativo- come ci informa Luca Trabucco nella sua bella presentazione dell’edizione italiana- ma in Italia meno conosciuto di quanto meriterebbe (e quindi doppiamente apprezzabile è l’impegno di Trabucco di tradurre e far pubblicare questo libro), riparte -si potrebbe dire- da dove era partito anni prima Meltzer , nei due lavori che figurano in appendice all’edizione italiana del terzo volume di “Lo sviluppo kleiniano” (1978): in altre parole dai due concetti bioniani di inversione della funzione alfa e di trasformazione in allucinosi, formulati rispettivamente da Bion in “Apprendere dall’esperienza” (1962) e in “Trasformazioni” (1965). Meltzer in quei lavori, attraverso esemplificazioni cliniche dettagliate, anche se filtrate, per la verità, attraverso il suo consueto linguaggio fortemente impregnato della teorizzazione kleiniana e bioniana, e quindi non propriamente immediato, intendeva mostrare la straordinaria utilità pratica dei due concetti bioniani in questione. Il concetto di inversione della funzione alfa (quel processo per cui le esperienze emotive cominciano ad essere trasformate in elementi alfa, cioè sognate e pensate, ma poi i pensieri, i sogni, gli elementi alfa stessi vengono cannibalizzati verso uno stato molto primitivo, simile agli elementi beta, che degli elementi alfa originari mantengono solo tracce di struttura eroica/superegoica, gli “oggetti bizzarri”, appunto) ed il concetto ad esso strettamente intrecciato, ma appartenente ad un livello molto più prossimo alla pratica clinica, osservativa, di trasformazione in allucinosi (per il quale i pensieri sono indistinguibili dalle realizzazioni, ed equiparati a fatti, che in quanto tali possono essere sperimentati solo come fonte di piacere/dispiacere) consentivano secondo Meltzer di osservare e dare conto nel materiale clinico di uno specifico disturbo del pensiero che modellizzazioni precedenti (fondate in particolare su scissione ed identificazione proiettiva negli oggetti interni) non avrebbero consentito di cogliere o quantomeno di comprendere altrettanto bene. Si tratta di un disturbo centrato su una forma tutt’affatto particolare di rigidità ed apparente restrizione cognitiva (povertà immaginativa, la definisce Meltzer ) che comporta essenzialmente: 1) che il significato delle cose risulta assolutamente dato, ciò che si percepisce ed il suo significato non sono cioè differenziati, le cose significano quel che appaiono. Non è all’opera una capacità di intuizione, e tantomeno si tratta di onniscienza, scrive Meltzer, 2) è proprio che manca totalmente la consapevolezza della capacità a pensare, esattamente in virtù del fatto che ciò che si sperimenta é sentito come un dato già evidente di per sé. E’, secondo Meltzer, un disturbo più frequente di quanto non si creda, ma nelle persone non psicotiche figura come “un’ aberrazione occasionale”- sono queste le sue testuali parole- che si verifica soltanto in condizioni emotive particolari. Anni più tardi definirà il peculiare modo di parlare di questi pazienti in seduta, estremamente fluente, grammaticalmente e sintatticamente corretto, ma privo di significato, “tessuto beta”. Sandler definisce, nel nostro libro, fenomeniche simili come un parlare “da realismo sovietico”). Fin qui Meltzer. Sandler imbocca, credo si possa dire, una strada analoga a quella di Meltzer; nel solco di una comune matrice freudiana/ kleiniana/ bioniana, riparte da dove si era mosso Meltzer e, per sua stessa ammissione, si dispone con trepidazione uguale a quella con cui Meltzer dichiarava di essersi accinto, prima di lui, ad esplorare le idee bioniane: ma procede oltre. Vediamo in che senso. È ragionevole concettualizzare, scrive Sandler, una funzione anti-alfa. (Questo è, a mio parere, il nocciolo del suo ragionamento in questo libro). La funzione anti-alfa “trasforma in dati sensoriali ciò che originalmente era un concetto mentale“. (Naturalmente su questo “originalmente” dovremmo intenderci: esiste un evento davvero primariamente mentale? I pareri, si sa, sono discordanti: esiste prima l’elemento alfa o l’elemento beta? -come si chiede Grotstein, (2007)-. E l’elemento beta è un dato fisico o già prementale? Ad ogni modo sembra chiaro che Sandler voglia semplicemente affermare che un evento mentale può essere trasformato -o ritrasformato- in un livello sensoriale. Si sa, prosegue Sandler, che “le persone hanno difficoltà a sopportare le incertezze e gli avvenimenti invisibili, non tangibili: ebbene attraverso la funzione anti alfa un’esperienza, un pensiero, un sentimento, un’intuizione possono raggiungere uno stato di concretezza, facendoli diventare realizzazioni che sono parziali, scisse, distorte [nel senso che] non mantengono nessuna invarianza riconoscibile con l’O da cui provengono (sono cioè trasformazioni in allucinosi)”. “Prendendo spunto da un modello della fisica potremmo in fondo dire che è come se le persone potessero trasformare energia in materia……è come se noi esseri umani fossimo dotati di una capacità Einsteiniana rovesciata” chiarisce ulteriormente Sandler (per inciso non si può non notare che siamo abituati, fin dalla metapsicologia freudiana, ad usare la metafora energetica in modo diverso, anzi, quasi nel senso opposto, i processi di rappresentazione equivalendo al passaggio da energia libera ad energia legata). Ancora, Sandler puntualizza “la funzione anti-alfa ha il potere di congelare istantaneamente ciò che in precedenza era vivo: esso concretifica e sensorializza ciò che non è né concreto né sensoriale.” Allora, tanto per fare degli esempi, vivere diventa sopravvivere, l’amore diventa sesso, il nutrimento diventa cibo, la famiglia casa, l’uomo pene, la donna vagina, la memoria-sogno memoria-riproduttiva, i sogni allucinazioni, la constatazione della realtà leggi causa-effetto, la realtà fatti, la psicoanalisi teorie psicoanalitiche e istituzioni psicoanalitiche, ecc.ecc….. e potremmo andare avanti. Ciò che ho tentato qui di riassumere brevemente servendomi di alcune sue citazioni, Sandler nel libro lo mostra e lo fa, per così dire, toccare con mano attraverso numerosi resoconti clinici, ora semplici vignette, ora descrizioni più estese di vere proprie tranches di analisi, sicuramente chiarificanti del suo pensiero, senza per questo essere appesantiti da eccessi teorizzanti. Ma, giunti a questo punto, possiamo chiederci: perché parlare di funzione anti-alfa, e non di inversione della funzione alfa, come già formulata da Bion? “ L’operatività della funzione anti-alfa – aggiunge ancora Sandler – non implica di per sé la distruzione della funzione alfa in quanto capacità e potenzialità, semmai corre parallela, [sia pure in senso inverso, viene da precisare], in alcuni casi la mette in ombra o la può dislocare, ma non arriva a sostituirla necessariamente per intero.” (D’altronde si potrebbe ricordare che anche la lettura, che Meltzer fa dell’inversione della funzione alfa, non esclude la conservazione di una qualche capacità simbolica). Però, Sandler specifica, – e questo mi pare il passo decisivo- non si deve pensare la funzione anti-alfa “ come un disturbo della funzione alfa, ma come una funzione essa stessa”, anzi “una delle funzioni di base della mente”, “una funzione che procede verso-K”, cioè non verso il conoscere la realtà ma, si potrebbe dire, verso il determinare una realtà (ovviamente alternativa), appunto verso il regno del minus. Non si tratta affatto, cioè, ci dice Sandler, di una dimensione patologica, essa fa invece parte della normalità, almeno dal punto di vista statistico, sempre che il concetto di normalità continui ad avere senso in ambiti come questo. È proprio la sua ubiquitarietà a renderla poco riconoscibile; ed è a sua volta la sua scarsa riconoscibilità ad aumentarne ulteriormente la forza. Con una certa enfatizzazione immaginifica Sandler paragona la funzione anti-alfa alla bomba ai neutrini: sotto la sua azione ciò che resta è solo il guscio, mentre la vita, cioè il significato, se ne va. Ciò che resta, infatti, sono solo “prodotti irreali, onnipotenti e fantastici” -queste le parole di Sandler- che hanno la qualità di elementi beta. Con il passaggio da inversione della funzione alfa a funzione anti-alfa, allora, Sandler sembra compiere un’operazione concettuale non nuova nella storia delle idee psicoanalitiche, anzi un’operazione -l’operazione, direi- che è alla base dell’evoluzione del pensiero psicoanalitico tout-court: la scoperta che un meccanismo psichico sottende uno specifico quadro patologico apre la strada ad un’estensione di tale meccanismo a funzionamento generale dello psichismo (ovviamente resta sempre da valutare se l’estensione quantitativa non trascini con sé anche una trasformazione qualitativa). Così il processo della conoscenza è da concepirsi per Sandler come la tragica risultanza (“la tragedia della conoscenza” che figura nel sottotitolo) di una funzione che dà significato, legando esperienza sessuale, emozione e contenuto ideativo in trirelazione, da un lato (funzione alfa); e di una funzione che invece svuota di significato, slegando i tre componenti della congiunzione costante, dall’altro lato (funzione anti-alfa). Da cui, appunto, quel “contemporaneamente” di cui parla Bion nella citazione riportata all’inizio: significazione e designificazione dunque in permanente instabile equilibrio; legamento e slegamento, pulsione di vita e pulsione di morte secondo altre teorizzazioni. Ma se, come già scriveva Meltzer nei lavori sopra ricordati -e Sandler in questo suo libro condivide- uno dei requisiti idonei a conferire utilità ad un nuovo apporto teorico, é che esso apra all’osservazione di fenomeni, altrimenti non visibili, il postulare la funzione anti-alfa, con le caratteristiche sopra descritte, di quali fenomeni, prima non visibili, ci schiude la visione? E’ questo ciò che allora ci domandiamo. Spiega Sandler: le allucinazioni divengono realtà -almeno apparentemente- allorquando sta operando una collusione tra membri di un gruppo o tra gruppi: eppure non per questo esse non appartengono più alla dimensione della menzogna, non per questo sono cioè effettivamente realtà. I prodotti della funzione antialfa, che è ubiquitaria, divengono facilmente accettati socialmente e condivisi, trovando quasi naturalmente recettori adeguati. E’ molto frequente che essi appaiano perciò dell’ordine degli elementi alfa, cioè appartenenti all’ordine del significato: restano comunque invece elementi beta, “incomprensibili, scissi, massicciamente incoerenti”. Sandler chiama questi elementi beta, che hanno l’apparenza di elementi alfa, elementi beta intelligibili, ove appunto l’apparente intelligibilità dice qualcosa circa la loro fenomenica e la loro condivisione sociale, rispetto a come per lo più tendiamo a pensare gli elementi beta, cioè del tutto inintelligibili. Questi elementi beta intelligibili non si presentano affatto dunque come oggetti bizzarri, quali sono i prodotti dell’inversione della funzione alfa: ma sono da essi effettivamente differenti o lo sembrano soltanto perché vengono visti attraverso quella parte della mente di ciascuno in cui la barriera di contatto, lo schermo alfa, non funziona? Sandler sembra propendere per la prima ipotesi, lascia comunque al lettore il compito di risolvere il dubbio. L’utilità di postulare l’esistenza di un’ autonoma funzione anti-alfa, -argomenta Sandler-, ci permette quindi di individuare e dar conto di qualcosa che proprio per apparire molto intelligibile, facilmente potrebbe sfuggire alla riconoscibilità; non si tratta, come invece ipotizza Meltzer, di un disturbo specifico, quanto di un ben più vasto campo di fenomeni, rilevabile sia a livello dei gruppi sociali -comprese le istituzioni psicoanalitiche-, sia a livello delle idee e delle teorie scientifiche, incluse le teorie psicoanalitiche-, sia a livello infine della pratica clinica psicoanalitica. La trattazione e l’interpretazione di questo ampio campo di fenomeni, osservabili a questi tre livelli, costituisce il cuore del libro. Per ragioni di tempo, su questo mi limiterò ad accennare che: A) a livello dei gruppi sociali, sono proprio gli elementi beta intelligibili che risultano, assumendo una sorta di esistenza di fatto, indispensabili per gli interessi dell’establishment. B) a livello delle idee e delle teorie scientifiche, essi sono alla base dell’impercettibile slittamento di significato per cui l’impalcatura viene scambiata per la costruzione, la teoria per l’esperienza che la teoria stessa dovrebbe rappresentare. A questo proposito Sandler mostra che quegli stessi modelli kleiniano-bioniani che sta utilizzando per svolgere questo suo ragionamento, per esempio il meccanismo dell’identificazione proiettiva, corrono il rischio di devitalizzarsi sotto i nostri stessi occhi, così come avviene – ce ne dà convincenti esemplificazioni- negli scritti di Autori importanti da lui stimati e apprezzati come maestri (Rosenfeld, Segal, Etchegoyen, Joseph). C) a livello della pratica clinica, gli elementi beta intelligibili sono alla base del fenomeno che Sandler definisce “la malintesa lealtà verso il discorso esplicito dell’analizzando”, come se i fatti raccontati in seduta fossero la realtà “o come se i sentimenti creati fossero sentimenti veri” “(senza distinguere, cioè, sentimenti da sensazioni). Che poi il postulare una funzione anti-alfa nei termini descritti, sia davvero un avanzamento, e non qualcosa di già implicito nel pensiero di Bion, o di altri Autori (per esempio Segal, con il suo concetto di equazione simbolica), è un punto che Sandler molto modestamente lascia decidere ai lettori. Comunque sia, è evidente che la funzione anti-alfa, per tornare ai due ordini di affermazioni di Bion che citavo all’inizio, sia in grado di dare ragione sia della deriva delle idee verso la calcificazione, sia parallelamente della tendenza a ridurre la realtà ai fatti: se ne deduce che i fatti da osservare in psicoanalisi -ciò che prova veramente il paziente, ciò che prova veramente l’analista-, non siano quelli appartenenti alla dimensione dei sensi, i quali sono da intendersi, invece, alla stregua di niente di più che di elementi beta intelligibili, bensì qualcosa di altro, che si situa al di là di questo piano, forse definibile soltanto in negativo. Sandler scrive in uno stile piano, fluido e discorsivo, anche se non sempre semplice. Nel suo andare avanti ed indietro sugli argomenti, anche a costo di ripetersi, o in certe sue radicalizzazioni polemiche, pare di sentirlo parlare; tanto che la differenza tra il testo del libro, e la trascrizione della registrazione di un suo seminario tenuto a Porto Alegre, che pure figura in appendice al libro stesso, è davvero poca. Nella sua forma espressiva certo comunica, a proposito della devitalizzazione e calcificazione di cui tratta, a contrariis, la vivezza ed anche una certa libertà con cui le teorie, freudiane, kleiniane e bioniane risuonano in lui, vivezza e libertà che cerca a sua volta di trasmettere ed evocare nel lettore. Al di là dell’uso di un tipo di linguaggio fortemente contrassegnato dal modello kleiniano-bioniano, come si evince da questo sommario, l’attenzione, che il libro sollecita, alla necessità di individuare i vari livelli di rappresentazione non solo per come emergono diacronicamente, ma per come sincronicamente interagiscono, così come alla necessità di distinguere i vari usi che delle differenti forme fenomeniche di rappresentazione si possono fare (parole che agiscono, teorie che difendono, o all’opposto azioni che rappresentano), costituisce un tema di interesse ineludibile per tutti noi, indipendentemente dagli orientamenti teorici di riferimento.
VALUTARE LE IMPRESSIONI
(inseguendo i pensieri di Bion e Sandler)
Intervento di Carmelo Conforto
Mi azzardo a riferire brevi osservazioni che riguardano il tragico tema esplorato da Paulo Sandler nel suo scritto “FATTI”[1] , iniziando dall’ironico invito che l’autore propone:
”Bene, ho l’impressione che il problema della conoscenza possa interessarvi”.
Ritorno cosi a riflettere intorno ai nostri analitici tentativi di dare significato all’ignoto del paziente nei diversi modi del nostro incontrarlo, all’interrogarci riguardo al bisogno-desiderio-timore che variamente lo abitano nel disporsi a essere il contenuto del contenitore che a lui offriamo.
Ho pensato di iniziare con quel paradossale ‘stare insieme’ proposto da Bion, testimonianza dei tentativi del paziente “di distruggere i propri legami con la realtà e in particolare con quella realtà che collega gli oggetti vivi gli uni agli altri” (Cogitations, [2]p.220).
Prendo l’avvio da una esperienza clinica che Bion descrive (Cogitations p.204): “Il paziente è in grado di creare un’impressione. Il mio tentativo di comprenderlo va a buon fine in quanto ricevo un’impressione, ma fallisce nel senso che non sono in grado di valutare l’impressione che ricevo. Il paziente parla: << Beh, mi sembra di non avere niente da dire…niente, non mi sembra proprio niente…Devo per forza aver fatto qualcosa di sbagliato…no, è inutile>>. Queste affermazioni vengono fatte come se fossero indirizzate a me. Ogni gruppo di parole è seguito da una pausa, come se mi invitasse a rispondere”.
Bion non ha risposte, aggiunge nello scritto le ipotizzate ragioni del rendersi incomprensibile del paziente:
“…c’è un attacco alle Posizioni, perché esse sono un fattore vitale della conversione dell’ignoto in noto. Vale a dire che la capacità di apprendimento dell’individuo dipende durante tutto l’arco della sua vita dalla sua capacitò di tollerare la posizione schizo-paranoide, la posizione depressiva e la continua alternanza tra le due”.
Allora la domanda al lavoro analitico: in che modoriconosco, riconosciamo neipazientila verità della richiesta, la pretesa di essere accolti da un contenitore che ha il compito di compiere quello che non è stato fatto o che è stato demolito, la traduzione dei grumi Beta in sogni, pensieri, elementi Alfa?
Una mia esperienza.
Mi sono da molti anni interrogato[3] su un frammento di colloquio che una Educatrice di Comunità Terapeutica ebbe con Piera, donna di circa 60 anni dimessa, dopo 25 anni , da un Ospedale Psichiatrico con diagnosi di Psicosi parafrenica e in contatto con lei perché inserita in un corso di rialfabetizzazione.
DIALOGO:
Piera: Non mi lasciano sognare!
Educatrice: Ci sono i sogni della notte quando dormiamo e quelli del giorno quando sogniamo a occhi aperti. Di quali sogni parla?
P: Voglio sognare anch’io che sono Piera e appena si potrà voglio anch’io che sono Piera che si vedano i miei occhi di nuovo.
E: I tuoi occhi parlano per te, io vedo quando sei triste, quando stai bene, se sei arrabbiata o se sei contenta.
P: Anche i tuoi, Maestra, parlano di te? E il tuo lavoro fa vedere con gli occhi?
E: In un certo senso, si.
P: Io, che sono Piera, ho per disgrazia gli occhi ammalati, hai il tuo territorio curativo in tasca? Te lo ricordi?
E: Ricordo “la pietra che cura”
P: Tutti i mali passano soltanto dopo aver lavorato nel territorio delle cure curative.
E: Fammi un esempio di territorio curativo.
P: Aver lavorato nel territorio curativo vuol dire di nuovo malata. Quando ero malata, io, che sono Piera, non capivo niente.
E: E cosa auguri agli ospiti della C.T.?
P: Lunga vita e che si facciano passare i nostri mali e che si veda di nuovo negli occhi
con gli occhi, sono la dottoressa Piera.
Cercammo allora di valutare[4] il significato di quelli che chiamai frammenti perché definiti dall’affiorare, forse iniziare a prendere forma (con un greve alone di indeterminatezza) elementi psichici che potrebbero suggerire l’avvio nella paziente della richiesta della loro riconoscibilità.
Uno stimolo inviato sotto forma di “una vaga turbolenza sensoriale” (Levine,[5] p.60) a cui ci è possibile rispondere dando credito (fede) all’intuizione, senso al sentire, modo che, scrive Chuster può consentire “il legame tra l’intuizione analitica e il linguaggio dell’effettività” ([6]p.147).Frammenti di un’antica, smarrita memoria, la memoria del possibile riconquistare il pensare-sognare, di accedere quindi al simbolico, al rappresentato, espressione di una assente, perduta, funzione Alfa che per riaccendersi ha bisogno di un contenitore che ne accolga i frammenti, nuclei dispersi della preconcezione, e che avvii con Piera funzioni trasformative.
Piera fa davvero domande? Ogni frase, ogni interrogativo è davvero un invito a rispondere?
Non risolvemmo con Piera l’enigma, ebbe la meglio la Sfinge.
Piera mi aiutò a riavvicinarmi alla domanda: cosa può spingere un umano a rinnovare l’attesa, la ricerca di un contenitoreche assolva le funzioni, le preconcezioni, un tempo intuite e deluse? Come è possibile per un osservatore (hanno domandato a Bion[7]) dire se un’altra persona sta pensando dei pensieri o se non sta pensando dei pensieri, o, infine, se non è ancora disponibile un inconscio a cui chiedere di svelarsi?
L’analista, in questo procedere, si muove tragicamente nel viaggio tra Psß->D (il fattoscelto) grazie alla tolleranza al non immediatamente saturato dalla “teoria formale”.
Non sempre possibile.
Bion: “E’ talmente difficile sopportare d’essere ignoranti, è talmente più facile racimolare una risposta che sia una spiegazione più o meno razionale…” (idem,p.67).
Sandler ci avverte di questo introducendo la funzione anti-Alfa (p.55), ovvero la funzione di trasformare in dati sensoriali gli elementi mentali, elementi Beta, che non risultano intelligibili (p.47).
Ciò che prima era avvenimento mentale ineffabile, intollerabile, inesistente, si capovolge in concretezza teorica, “definibile con precisione apparente”. Ovvero l’intolleranza a Ps immette l’analista in “una sorta di meno-D”, fatto di erudizione, spiegazioni, mortificazione del comprendere.
Infine un’esperienza clinica che nuovamente mi ha avvicinato a Sandler, alla sua
nota su Elementi Beta “inintelligibili” (p.41) nella quale osserva che “la sua presentazione fenomenica è relativamente frequente; si tratta del silenzio verbale. O quel ‘silenzio’ che è solamente silenzio nel caso la persona che cosi lo qualifica sia totalmente inghiottita nel mondo composto da stimoli sensorialmente apprensibili”.
Sandler, narrando l’esperienza analitica con Maria, paziente che non parla, che trasporta i suoi sentimenti nell’analista non con le parole, riesce a dare senso a ciò che Maria chiede e che la terrorizza nel non accadere: ”Le dissi che ella desiderava una madre che potesse discriminare per lei tutti i sentimenti e le necessità che ella avesse. Nell’istante in cui terminai la frase ella incominciò a piangere” (p.46).
Silvana è una ragazza di 16 anni. Il padre mi ha chiesto di vederla perché Silvana soffre, non parla, non va a scuola, non esce di casa, che fare? La mamma arriva in studio con la figlia, di piccola statura, robusta, sguardo verso terra. Siedono sul divano, di fronte a me. La mamma mi ripete che Silvana sta male, come già era stata tempo prima, ma ora quasi non parla, sta in camera sua, sono due settimane che non va a scuola. Parla poi della nonna che era stata male qualche tempo fa, agitata, poi curata con faramaci. Silvana è quasi rannicchiata sul divano, si volta verso la madre, una smorfia. Le dico che penso sia spaventata, forse molto. Mi guarda, sopra gli occhiali, nuovamente si volta verso la madre, atto che farà più volte, quando le dico delle cose. Osservo che deve avere una gran paura di allontanarsi da casa, penso che qualcosa, qualcuno che sta dentro di lei le ha fatto capire che il pericolo, la minaccia è fuori e l’aspetta…cosa la spinge a credere? Parlo, Silvana mi ascolta e poi guarda la madre. Intervalli di silenzio tra noi, provo una sorta di tenerezza, ho l’impressione che le mie parole entrino in lei. Mi guarda per più tempo. Non mi sento obbligato a parlare, mi pare la cosa più naturale. Le chiedo se il cibo la tranquillizza e qui mi guarda assentendo, poi un breve si. Prosegue nel fine seduta il suo assentire verbalmente. Le dico infine che la vorrei vedere la settimana seguente, guarda la madre, annuisce. Escono e la sento piangere.
La mattina seguente mi chiama la mamma, mi dice che Silvana si è vestita per bene e le ha detto stupendola:
<< Oggi vado a scuola>>.
Mi sono dedicato, nell’après-coup, a “valutare le impressioni”, ovvero la possibilità d’aver accolto nella mia mente gli elementi Beta che l’identificazione proiettiva di Silvana immetteva in me, traducendoli, come accadde a Sandler, in elementi della categoria C della Griglia, Pensiero del sogno, mito, sogno, modello (Bion[8],p.20) per poi restituirli a Silvana come embrionali Elementi Alfa.
Forse.
Ho rivisto Silvana: ci siamo incontrati senza la madre, mi ha detto che ha continuato ad andare a scuola, meno ansia …Mi guarda e mi dice:<< Faticosa la scuola…>>.
<< Perché vai a scuola?>>.
Apre di più gli occhi, il tono è emozionato: << Voglio fare la maestra d’asilo- Quando li guardo, quei piccoli bambini, voglio aiutarli, stare con loro..>>.
Alcune domande a me stesso e ora a chi ascolta, Paulo allora…
E’ questo uno dei modi d’essere con il paziente di cui parliamo, parla Ogden, condizione di cui l’esperienza emotiva ci informa nel modo del riconoscibile?
A cui il pz. risponde con un particolare tipo di apprendimento trasformativo, ontologico, in cui ho colto la sensazione d’essere stato ben usato?
Intervento di Paulo Cesar Sandler
Il mio rapporto con l’Italia è nato parecchi anni fa, e soprattutto grazie a mia moglie che è molto interessata ad apprendere la lingua italiana.
Sono molto impressionato dal fatto che voi italiani siate così capaci di cogliere quello che cerco di comunicare e lo scrivete meglio di me.
È un po’ di tempo che ho scritto queste cose e alcune di esse le vorrei implementare. Un’area di interesse che ho è quella degli studi transdisciplinari, in cui anche Luca [Trabucco] è coinvolto, che è poi quello che Bion ha cercato di fare in Memoria del futuro. Transdisciplinare, e non interdisciplinare, perché è qualcosa che va e viene, una dinamica, che poi è quello che avviene nel tempo della seduta analitica. Quando un paziente dice qualcosa, interrompe il movimento, e noi dobbiamo chiederci cosa non ci dice e fare un lavoro su una materia prima, che non è ciò che sembra essere, ma quello che Bion ha definito un pensiero senza pensatore. Pensieri che fluttuano nell’aria come ossigeno, e le persone che hanno i polmoni possono respirare. Una analogia che oggi è particolarmente attuale in quanto alcune persone sono state private, col COVID, della possibilità di respirare, a causa di una coagulazione intravascolare disseminata, che è il modo attraverso cui il Covid colpisce, con piccoli emboli che intasano a livello polmonare, cerebrale, organi interni. Quello che avviene è che noi psicoanalisti, membri del movimento psicoanalitico, lo facciamo con le parole che i pazienti ci dicono. Le perdiamo, molte volte – e parlo per esperienza personale, l’esperienza dell’errore, ma è attraverso l’esperienza dell’errore che noi possiamo apprendere dall’esperienza; non si apprende indovinando, o attraverso i test scolastici. Entrambi i relatori, Gregorio e Carmelo, hanno spiegato molto bene questa questione della “scolastica”, che interviene nel momento della seduta.
Tornando alla questione transdisciplinare e a quello dell’errore, oggi non scriverei più “Apprensione della realtà psichica”, ma “Apprensione della realtà materiale e psichica”. In quell’epoca, per esempio, i fisici hanno comprovato l’esistenza di una microparticella più piccola dell’atomo, talmente veloce che è solo energia, ed è un’altra particella che deve donare la materia all’altra particella: è il bosone di Higgs. Higgs faceva parte di una equipe, ma dato che gli altri membri dell’equipe erano morti, solo lui ha dato il nome alla scoperta; nel 1961 hanno fatto una dimostrazione matematica dell’esistenza di questa microparticella, che resta a girare su se stessa e nello stesso tempo si muove, che è un paradosso, come fa la terra. Ho l’impressione che tutti noi facciamo la stessa cosa ma non ce ne rendiamo conto. Io ho una nipotina che gira su se stessa e poi cade. Credo che Freud e gli psicoanalisti abbiano tentato di fare una cosa simile, qualcosa che hanno percepito che è avvenuta, qualcosa che noi facciamo continuamente ma che poi, a un certo punto, ci sia un salto quantico: noi pensiamo di andare dritti, e che sappiamo quello che stiamo facendo, o il mondo ci dice che stiamo andando in un certo senso, uno stock di persone come Berlusconi, e poi ci sono guerre fratricide, guerre civili, e ho l’impressione che la cosa peggiori sempre, come per gli psicoanalisti che stanno sempre a trattare con aspetti di scuola, e questo avviene proprio quando abbiamo la certezza assoluta di ciò che sta accadendo. Tornando al bosone di Higgs, nel 2015 hanno costruito un collisore di particelle di 5 km a Ginevra, dove si accelera una particella che viene bombardata da altre particelle, più o meno come accade a noi, che non abbiamo 5 km, ma abbiamo la seduta analitica e siamo bombardati da ciò di cui parla il paziente, e noi bombardiamo il paziente, e non abbiamo un acceleratore, né le formule della meccanica quantica, non abbiamo uno stetoscopio né lo sfigmomanometro per misurare la pressione: abbiamo uno strumento molto primitivo, che sono le formulazioni verbali. E il paziente ci bombarda e noi altrettanto lo bombardiamo. È con questo materiale molto primitivo che noi tentiamo di lavorare. Quello di cui sto parlando è un modello, ma di nuovo è una cosa che si realizza in molti livelli di osservazione, e che ho tentato di individuare con questa teoria della funzione anti-α. Questa possibilità einsteiniana inversa, come Gregorio ha osservato, che realmente è possibile e che i pazienti mettono in atto, e non possiamo dire che questa sia patologia, è un nostro strumento di lavoro nel caso che noi abbiamo avuto una analisi minimamente sufficiente. Desidererei adesso ascoltare … ho trovato molto opportuno che Conforto abbia portato un caso clinico, perché il mio tentativo con questo libro era di portare un contributo alla clinica, che è un compito quasi impossibile. Per terminare il mio discorso voglio citare un poeta: “Il bello è negli occhi di chi lo vede”. Vorrei fare una formulazione psicoanalitica: un insight è il lavoro del paziente, non nostro, del paziente in relazione con l’analista, in una relazione che ricorda molto il bosone di Higgs, dove una microparticella, dato che penso che noi siamo microparticelle nell’Universo, che è di energia, segue una massa che non ha. È il paziente che fa questo, e ho l’impressione che Freud abbia chiamato questo tipo di relazione rapporto fra contenuto manifesto e contenuto latente, nella definizione data nell’“Interpretazione dei sogni”. Tutto ciò non è una scoperta dell’analista, è un atto identico a un atto sessuale, dove uno spermatozoo entra nella vagina, nell’utero, incontra un ovulo e si genera un bambino. Ho l’impressione che questo avvenga in una seduta di analisi che meriti questo nome. Può essere come una relazione sessuale, ma non è una relazione sessuale che si ha in analisi, perché questa situazione che si vede come sessuale, non è altro che una materializzazione (di una funzione) più o meno importante; è molto importante per la sopravvivenza della specie. È anche un problema dell’essere umano il fatto che questo sia un mezzo per ottenere il piacere. È anche una questione di realtà: tutti sappiamo, quando abbiamo dei figli, o attraverso chi ha figli, che questa situazione di piacere è fonte di problemi posteriori. Uno scienziato è felice se apre con la sua scoperta un campo di nuovi problemi posteriori, conseguenti alla sua scoperta.
Quello che avviene nel movimento psicoanalitico è che si cercano spiegazioni, cause ed effetti, e poi si è contenti e si va a casa. E anche durante le sedute, se succede qualcosa per cui il paziente può essere alleviato, o restare arrabbiato, o può dire “ho bisogno di andare in bagno”, o altro, questo non è il fine; il fine è sempre l’inizio.
Succede che un giorno dovremo morire, e la vita deve continuare. Io vorrei che voi faceste questo con quello che ho scritto, e sono veramente molto grato a tutti voi che comincio a conoscere ora, e spero un giorno di conoscervi personalmente. Perché voi mi avete dato l’unico bene non rinnovabile, perché oggi siamo in un’epoca in cui le persone sono molto preoccupate con le energie rinnovabili e cose di questo tipo, e l’unico bene non rinnovabile che sono riuscito a concepire che esista è il tempo; il tempo non torna, e qui in Brasile si dice “Il tempo è denaro”, non si può dare un prezzo al tempo, e voi mi avete donato molto tempo, avete letto con attenzione quello che ho scritto, e ora voglio sinceramente mostrare le mie emozioni. Grazie tante.
Intervento di Marcello Turno, dove sottolinea l’importanza che Sandler da al concetto di tolleranza del paradosso.
Sandler: Quello che avviene all’interno di una seduta d’analisi, è che è la vita del paziente e la nostra vita che sono in gioco, anche se non sembra, è un nuovo paradosso. Come avete osservato questa enfasi che io do al tollerare il paradosso senza tentare di risolverlo, è in relazione alla falsa impressione di risolverlo con spiegazioni, giustificazioni, cause ed effetti che vanno bene per avvocati e politici, ma non per gli psicoanalisti e i medici, che devono vivere la vita. Ho la pretesa, dato che sto parlando con persone che penso abbiano un’esperienza maggiore della mia, come Gregorio, Carmelo e Marcello, che il tollerare il paradosso sia un altro principio di base per lo psicoanalista, come la possibilità di trovare libere associazioni, e avere considerazione per il sistema inconscio. È una mia pretesa pensare che tutto questo sia direttamente espresso nell’opera di Freud, Klein, Winnicott e Bion.
BIBLIOGRAFIA
BION W.R. (1962) Apprendere dall’esperienza – Armando Editore, Roma, 1972
BION W.R. (1965) Trasformazioni – Armando Editore, Roma, 1973
BION W.R. (1983) Seminari Italiani – Borla Editore, Roma, 2011
GROTSTEIN J.S. (2007) Un raggio di intensa oscurità – Raffaello Cortina Editore, Milano, 2010
MELTZER D. (1978) Lo sviluppo kleiniano – Borla Editore, Roma, 1982
note:
[1] Sandler, P., C., (1989), Fatti. La psicoanalisi e la tragedia della conoscenza, Roma, Alpes, 2022.
[2] Bion, W. (1992) Cogitations., pensieri, Roma, Armando, 1996.
[3] Conforto, C. Tra intenzionalità e assenza, in Granieri, A. (a cura) Il fattore T in psicoanalisi, Roma, Borla, 2015.
[4] Nella mia funzione di Supervisore di Comunità
[5] Levine, H. (2913) La tela incolore: rappresentazione, azione terapeutica e creazione della mente, In: Levine, H. e altri, Stati non rappresentatie costruzione del significato, Milano, Franco Angeli, 2015.
[6] Chuster, A. (2010) Le origini dell’inconscio, In: Van Buren, j., Alhnati, S.,A.( a cura) Stati primitivi della mente, Roma, Armando, 2013.
[7] BIon, W. (1980) Discussioni con W. Bion, Roma, Armando, 1984.
[8] Bion, W.(1997) Addomesticare i pensieri selvaggi, Milano, Franco Angeli, 1998.
