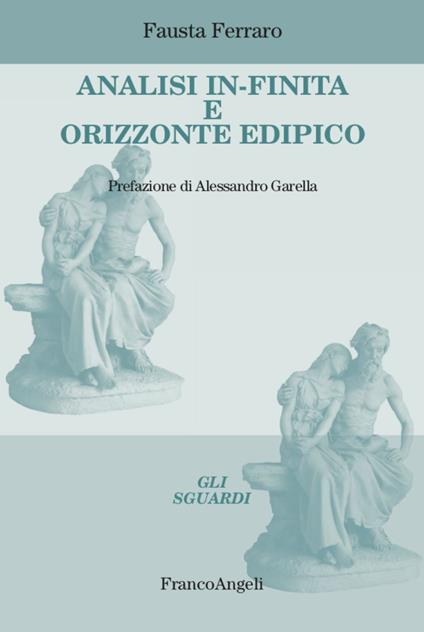
Parole chiave: Psicoanalisi; Complesso edipico; Gaddini; Green
Analisi In-finita e Orizzonte Edipico
di Fausta Ferraro
(Franco Angeli ed., 2022)
Recensione a cura di Rossana Gentile
Fausta Ferraro ci offre in questo volume di recente pubblicazione una pregevole raccolta di saggi che riflette la ricca esperienza clinica maturata nel corso degli anni e la sua profonda conoscenza della teoria psicoanalitica. Il libro è dedicato ai pazienti, considerati con gratitudine coautori del testo.
Analista di radicata estrazione freudiana, F. Ferraro non ha mai rinunciato alla passione del metodo e all’esercizio del dubbio, ponendo in tensione continua e costante teoria e clinica: come ci fa notare S. Garella nella prefazione al volume, in questi scritti l’A. intraprende una vera e propria “traversata” nel campo analitico, con lo stile di una navigazione a tutto tondo, aggiungerei, tra interrogativi, confronti, affondi, anticipazioni e ritorni tipici della mente psicoanalitica al lavoro.
Il volume si articola in tre parti: nella prima, intitolata “Ricalchi”, ovvero tracce, solchi, qualcosa che necessita di uno scavo per ottenere un ri-calco, si pone l’intreccio tra il tema del trauma e quello della ripetizione, già caro all’Autrice (Ferraro, 1990, 1995; Ferraro, Garella 2002).
Fa da incipit una domanda: ciò che si ripete è da intendersi come un ritorno al passato, nodo insolubile, o non, piuttosto, un tentativo di dare forma psichica a qualcosa di informe, un’esperienza traumatica, lutti familiari non elaborati, frammenti di dramma edipico, resti congelati della vita psichica che attendono di essere dispiegati, riaperti a una possibile significazione? Nel movimento psichico creato da questi ritorni, si sottolinea, si inscrive la questione della temporalità inconscia che rende possibile la persistenza del transfert, regola le interruzioni e, nel caso delle seconde analisi, orienta il riaggancio a un nuovo percorso analitico.
Si colloca in questa prima parte del volume anche la riflessione sul corpo inteso come strato roccioso, espressione che l’Autrice accoglie in una duplice accezione, ovvero come fondamento della psiche, ciò che vincola la psiche all’origine, ma anche come resto intrasformabile, limite al lavoro analitico.
Attraverso l’effetto plasmante del fantasma, declinabile in tante e differenti variazioni che caratterizzano i percorsi identitari, la rocciosità del corpo si connette con l’assunzione dell’identità sessuata a partire dalla nozione complessa e controversa di bisessualità psichica.
In sintonia con gli apporti di Mc Dougall (1989) e Dejours (2002) Ferraro focalizza l’attenzione sulla clinica del corpo allo scopo di evidenziare i processi trasformativi che hanno luogo durante l’analisi.
Segnala, quindi, la funzione che ricopre l’affetto nel costituire o ripristinare un corpo erogeno e la modifica nell’economia pulsionale, nel rapporto tra (pulsioni di) vita e ( pulsioni di) morte.
Esemplificativo a tale riguardo il caso di S., una paziente che nell’intake si era presentata all’analista con una storia segnata da lutti, crolli, malattie di persone care, vicende cui sembrava aver reagito con l’insorgere crescente e violento di manifestazioni somatiche. A distanza di anni, un sogno sollecita connessioni significative con eventi passati, in particolare con un trasloco avvenuto in circostanze di vita emotivamente molto drammatiche per la paziente. Nella mente dell’analista si rivelano ipotesi circa l’emergere nella paziente di scenari di figurazione simbolica che fanno pensare a un transito da “ fantasie nel corpo” a “fantasie sul corpo”(Gaddini, (1981). Nella condensazione operata dal sogno era stato possibile istituire una relazione dinamica tra difficoltà, inibizioni, impossibilità che fino ad allora non avevano trovato altro modo di esprimersi.
La seconda sezione del libro è dedicata al primato della non tramontabilità dell’Edipo e alla funzione del padre. L’Autrice si colloca in dialogo immaginario con due grandi maestri, E.Gaddini e A.Green, avanzando l’ipotesi che entrambi sviluppino una beanza del pensiero freudiano, da lei stessa rintracciata nell’ enigmatico concetto di “ identificazione con il padre della propria personale preistoria” (Freud, 1922, p. 493).
Ferraro pone in luce aspetti di convergenza e divergenza nella ricerca di questi due Autori: per entrambi il padre compare sulla scena della relazione madre bambino incardinandosi in una scena primaria che è pregenitale. Nella visione di E. Gaddini il padre rappresenta in realtà il primo oggetto d’amore da acquisire. A differenza della madre, che il bambino vive inizialmente come Sé, il padre è vissuto fin da principio come oggetto estraneo e, successivamente, come esterno al Sé (Gaddini 1974, p. 326).
Secondo Green, il padre si inscrive sin dall’inizio in una configurazione triangolare che lo vede nella relazione tra madre e bambino come la figura dell’assenza, il cui posto nella mente della madre incide sensibilmente nella relazione tra madre e bambino. Il padre, secondo oggetto che si impone al bambino, favorisce lo sviluppo dei processi terziari: la triangolazione inaugurata dalla esistenza del padre tra madre e bambino fa sorgere l’altro dall’oggetto e apre infinite prospettive della terzietà, da Green rivisitate nel corso degli anni fino all’ elaborazione della sua ”teoria della triangolazione generalizzata con terzo sostituibile” che può comprendere il soggetto, l’oggetto e l’altro dell’oggetto che tuttavia non è il soggetto ( Green, 2002 p.231).
Sia Gaddini che Green convergono, scrive Ferraro, su una ipotesi, ovvero che vi sarebbe una istintualità (auto)distruttiva mantenuta in quiescenza, piuttosto che soggetta a rimozione. In questo contesto, il ruolo di differenziazione del padre, sottolinea Ferraro, è coestensivo ad una dinamica più articolata dell’aggressività e viene individuato sia come tragitto evolutivo complesso che come compito fondamentale dell’ analisi ( p.80).
Da prospettive teoriche diverse, dunque, sia Gaddini che Green, rileva la nostra Autrice, hanno avuto il merito di evidenziare quanto la figura paterna, in anticipo sulle vicende edipiche vere e proprie, svolga una funzione determinante nei processi di differenziazione del bambino dalla madre. Per entrambi la comparsa del padre ha in sé un carattere drammatico-traumatico che coincide con la perdita definitiva del rapporto originario.
F .Ferraro ricostruisce nel percorso di Green la funzione del padre come modello propulsivo nell’orizzonte dell’avvenire del soggetto. L’Autrice .qualifica questa funzione della relazione con il padre come “amore identificatorio” dichiarandosi incline a seguirne le ricadute sulla creatività.
Il padre può costituire per il bambino un primo barlume di integrazione e completezza personale, afferma Ferraro, citando un prezioso commento di Winnicott a proposito del Mosè e del ruolo del padre nell’ emergenza dell’individualità e della nascita del soggetto
( p.90).
In questa prospettiva si colloca secondo la nostra A. il movente profondo di alcune seconde analisi, che originerebbero da percorsi precedenti non conclusi in quanto immobilizzati nell’impasse di una logica duale (o più precisamente tri-bi-angolare).
La sfida dell’analisi, in queste situazioni, sarebbe quella di rimuovere gli ostacoli che hanno prodotto l’impasse, favorendo la mobilità dei processi integrativi e la ripresa della temporalità psichica, operazione necessaria per portare a compimento l’Edipo.
Ferrraro segnala a tale scopo l’importanza che ricopre il ruolo e la funzione dell’analista in posizione paterna.
E qui veniamo alla centralità del tema dell’Edipo su cui si fonda l’impianto del volume. L’ A intende ribadire le potenzialità ordinatrici dell’Edipo nella complessità dell’esperienza clinica, preoccupata di ovviare a una crescente desessualizzazione del discorso analitico e di incalzare le teorizzazioni attuali a riconfrontarsi con l’Edipo che, ribadisce, è da considerarsi fonte originaria della psicoanalisi.
Le sue argomentazioni fanno riferimento a tre costrutti principali. Il primo riguarda la scena primaria e il suo ruolo nello sviluppo della mente inconscia nel differenziare il rapporto oggettuale con il padre da quello con l’oggetto materno. Il secondo costrutto riguarda la triade corpo concetto-parola in cui, come sostiene McDougall, il somatico rappresenta il protolinguaggio dell’affetto forcluso che in analisi è possibile trasformare-tradurre da corpo anarchico che si esprime solo psicosomaticamente in corpo simbolico. Il terzo costrutto investe il rapporto tra setting e linguaggio: in una visione più ampia dell’Edipo inquadra la tematica della creatività e la possibilità di nascere come soggetto.
Chiude questa parte del volume la riflessione su una lunga esperienza effettuata dall’A. in un servizio clinico di consultazione per studenti universitari. Da questo osservatorio privilegiato che l’A. definisce un “sismografo delle tensioni della modernità”, si individua una particolare dialettica intergenerazionale che può essere vista da due vertici: come un oscuramento della configurazione edipica sostituita dal complesso fraterno e come una difficoltà a far prevalere l’impianto genitale del pensiero.
L’ultima sezione del volume, dal titolo “Analisi finita e in-finita: uno sguardo sull’abisso”, si apre con un saggio dedicato a Celestino Genovese, discussant presso il Centro Napoletano di Psicoanalisi durante una serata scientifica in cui l’A. presentava una rilettura del testo freudiano Analisi terminabile e interminabile( Freud, 1937). L’A. torna a riflettere sul setting e sul suo paradigma triangolare (Green 1984), nonché sull’uso dell’ascolto e della parola come strumento terapeutico per eccellenza a disposizione dell’analista e come ricerca della verità del soggetto, ricerca che Bion ha evidenziato nei suoi aspetti fortemente drammatici.
Soprattutto nei giovani adulti, sottolinea Ferraro, la ricerca della verità può presentificare il “lavoro della morte” che si estrinseca come spinta regressiva, ma anche come angoscia catastrofica di fronte alla ineludibile “uccisione” del padre che accompagna il processo di soggettivazione, ovvero la nascita di sé come individui separati, adulti.
La morte rappresenta la figura centrale della terminabilità dell’analisi, del limite e della rinuncia all’invulnerabilità narcisistica che poggia sulla concezione freudiana della bisessualità come roccia basilare della psiche.
Si apre da queste premesse una ricca e articolata riflessione dell’A. sul tema delle ri-analisi, che con maggiore vigore convocano l’analista nella complessità della sua posizione edipica, in un ruolo di “controfigura” o “predecessore” destinato a uscire di scena per favorire l’esprimersi delle spinte differenzianti.
Il termine “ri-analisi”, precisa Ferraro, è complesso e carico di ambiguità semantiche proprio a causa del prefisso ri, che sembra evocare contemporaneamente la ripetizione, la ripresa, il rifacimento. La sfida, scrive l’A., è nel riuscire a mantenere la neutralità dell’analista, insieme con la convinzione che ciascuna esperienza è diversa dall’altra, è una nuova esperienza. Nelle rianalisi, scrive Ferraro, prende corpo la figura del doppio e del suo rapporto con la triangolazione. Lo scenario del doppio rimanda alla difficoltà di separazione dalla prima analisi, mentre l’immagine di sé sdoppiata farebbe pensare a tendenze evolutive e spinte regressive in conflitto tra loro.
L’A. torna su una ipotesi già ventilata nella prima parte del volume: ossia che nell’occorrenza di un secondo percorso possa esservi la riproposizione di scenari traumatici e il tentativo di disincagliarsi da una configurazione tri-bi-angolare, in cui domina la difficoltà a percepire la dualità come differenziazione. Esemplificativo a tale riguardo il caso di Fulvio che, nel riprendere a distanza di molti anni l’analisi, comunica che in questa seconda tranche l’analista sarebbe stata ”completamente” diversa dalla prima, con allusione inconscia, forse, al paradosso del transfert, al suo declinarsi tra persistenze, ripetizioni, ma anche speranze in nuove opportunità trasformative. Alla luce di quanto il paziente dice al termine del percorso circa l’ultima seduta che paragona al finale di una sinfonia, aggiungerei che, inconsciamente, forse, con queste parole aveva intuito già che l’analisi avrebbe potuto “risuonare” dentro di lui come lo spartito di un tema musicale dalle infinite variazioni.
La lettura di questo libro, come si può vedere, aiuta a riflettere sul modo in cui lavora un analista maturo, tra aperture, attraversamenti, libertà di pensiero e di amore per la psicoanalisi. Il tema delle rianalisi, nel suo intrecciarsi con gli scenari ancora “in allestimento” di un Edipo rimasto incompiuto, risulta molto interessante e a mio avviso rappresenta anche un utile contributo per la comprensione di tanti pazienti cosiddetti “al limite”. Molte esperienze di seconde analisi, se lette da questa visione prospettica, possono costituire un terreno su cui coltivare nuove e fertili opportunità di ripresa trasformativa, oltre che di ricerca in campo psicoanalitico.
Un fattore importante, ricorda Ferraro, è la ferma costituzione del dispositivo analitico garantito dal setting in quanto vettore di triangolazione tra analista e paziente: è il setting che garantisce la costruzione di un apparato per simbolizzare il transfert e sostenere la capacità dell’analista di lavorare sul suo controtransfert. Per non ostacolare la percezione di aspetti dolenti della storia dell’altro (Little 1951), ci segnala l’A., occorre mantenere la funzione edipica della mente (Di Chiara 1985) imperniata sulla triangolazione.
Tornando all’immagine della navigazione, mi sembra di poter dire che con questo libro si ha idea di trovarsi in mare aperto con saldo possesso del timone e della rotta da parte del capitano della nave con qualche incursione di tanto in tanto sottocosta!
L’impianto del volume segue un’articolazione complessa e la lettura rimanda a una condensazione di piani paralleli che deriva, appunto, dalla presenza dei numerosi rimandi alla letteratura analitica nonché all’esperienza clinica dell’Autrice. A quest’ultima sento di rivolgere il mio ringraziamento per questa generosa scrittura, testimonianza di una piena vitalità che torna a vantaggio di tutti noi.
Bibliografia
Dejours C. (2002), “Il corpo come esigenza di lavoro per il pensiero”, in Psicopatologia dell’esperienza del corpo, Borla, Roma 2004.
Di Chiara G. et al (1985) “ Preconcezione edipica e funzione psicoanalitica della mente”, Riv. Psicoanal., 31, pp. 327-341.
Ferraro F., Garella A.(2002), In-fine, Franco Angeli, Milano.
Ferraro F.(1990), “Transfert resistenza e interpretazione”, Riv. Psicoanal., 36 pp.1053-1081.
Ferraro F., Garella A. (2002), Nachtraglichkeit, Riv.Psicoanal., 47,pp. 79-106.
Freud S. (1937), Analisi terminabile e interminabile, OSF, 11.
Freud S. (1922), L’Io e l’Es, OSF, 9.
Gaddini E. (1973) “Discussione del lavoro di Henry Edelheit “Crucifixion Fantasies and their Relation to the Primal Scene ” in Scritti, Raffaello Cortina, Milano 1989.
Gaddini E. (1974) “Formazione del padre e scena primaria ” in Scritti, Raffaello Cortina, Milano 1989.
Gaddini E. ( 1975) “LA Formazione del padre nello sviluppo infantile” in Scritti, Raffaello Cortina, Milano 1989.
Gaddini E. (1981), “Aggressività e principio del piacere. Verso una teoria psicoanalitica dell’aggressività” in Scritti, Raffaello Cortina, Milano 1989.
Gaddini E. (1981), “Fantasie difensive precoci e processo psicoanalitico”, in Scritti, Raffaello Cortina, Milano 1989.
Green A., (1984) Il linguaggio nella psicoanalisi, Borla, Roma, 1991.
Green A., (1992) “Freud Edipo e noi” in Slegare, Borla, Roma, 2001.
Green A. (1993), “L’analità primaria”, in Il lavoro del negativo, Borla, Roma,1996
Green A. (2002), Configurazioni della terzietà, in Idee per una psicoanalisi contemporanea, Raffaello Cortina, Milano 2004.
Little M. (1951), “il Controtransfert e la risposta del paziente a esso”, in Cecilia Albarella, M. Donadio (a cura di) Il Controtransfert ,Liguori, Napoli, 1986.
Mc Dougall J. (1989), Teatri del corpo, Raffaello Cortina, Milano 1990.
