
Chaos + Repair = Universe. Kader Attia, 2014
Parole chiave: Inquietante estraneità, Psicoanalisi, Colonizzazione, AfrichE, Apres coup
AfrichE Tra(n)s-formazioni postcoloniali. Daniela Scotto di Fasano, Cristiano Rocchi, Livio Boni. Armando Editore, 2025
Franco D’Alberton
Ecco perché non credo nelle tutele civilizzatrici.
Gli uomini vanno sottomessi con la forza oppure lasciati in pace.
Miguel Angel Asturie
Se un lettore cercasse una tesi, un pensiero compiuto e definitorio in questo libro rimarrebbe deluso; la ricchezza del volume risiede nel contrappunto di idee, posizioni culturali, spesso in contrasto, che promuovono l’emergere di sintesi personali.
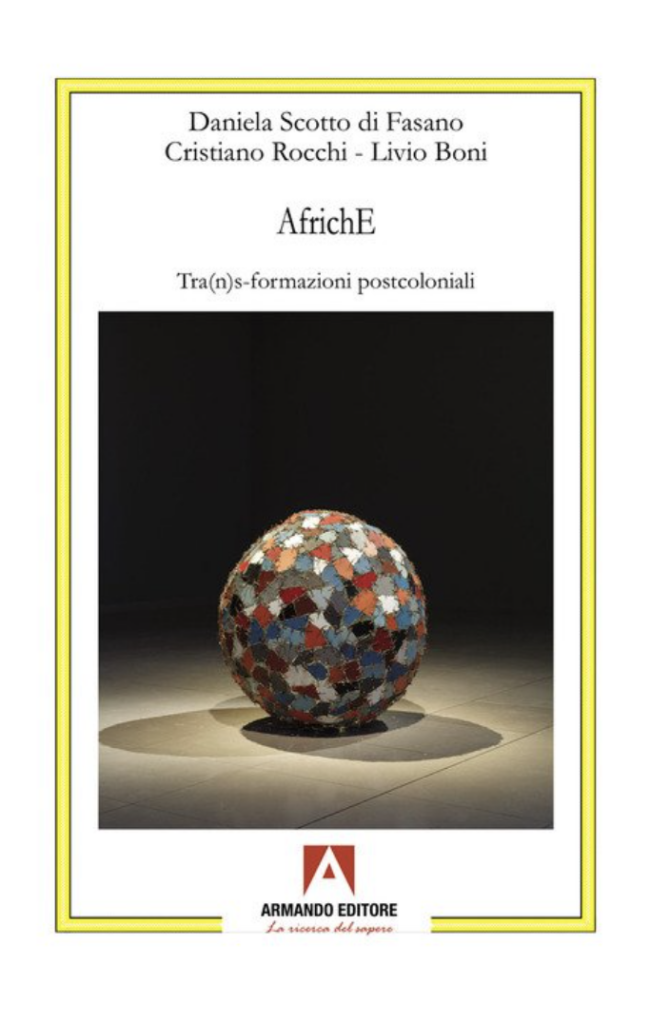
Il libro non fa sconti alla fatica di pensare. Attraverso una serie di interviste e di conversazioni, fornisce uno spaccato “a vivo” della realtà etnica, sociale culturale e politica di alcune nazioni del Magreb e del Corno d’Africa, capace di portare direttamente in “medias res” anche il lettore meno informato con una forza espressiva che lo avvicina al testo poetico.
Già la frase del premio Nobel della letteratura Mighel Angel Asturie citata in esergo illustra la complessità di un pensiero, che rifugge la non conflittualità. Quella citazione che Rita El-Khayat, medico, psichiatra, psicoanalista marocchina colloca al termine della sua prefazione racchiudere il tema di fondo di questo testo di Daniela Scotto di Fasano, Cristiano Rocchi e Livio Boni.
Un libro che mi è capitato di apprezzare come si assaggia un cibo che si conosce poco e che, dopo una iniziale dubbiosa incertezza, si fa gustare come particolarmente saporito.
È successo anche a me però di provare i “sentimenti molto complessi” che Alfredo Lombardozzi descrive nella postfazione di fronte al compito di commentare il libro AfrichE Tra(n)s-formazioni postcoloniali.
Primo tra tutti una sorta di “unheimlich”, una inquietante estraneità, «… quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da lungo tempo, a ciò che ci è familiare (Freud 1919)» a fronte del passato coloniale italiano, le sue gesta, le sue atrocità, le sue architetture, di qualcosa che si sapeva, faceva parte della nostra vita ma del quale non eravamo del tutto consapevoli.
L’amicizia e la simpatia per gli autori-curatori mi aveva portato ad accettare la richiesta di scrivere un commento; il pensiero di declinare l’invito si è fatto subito presente quando ho ricevuto il volume: – Ma cosa c’entro con gli argomenti di cui il libro parla, cosa posso aver da dire su quei temi?
Temi a cui mi capitava di passare accanto come passiamo accanto ai resti dell’architettura coloniale che disseminano Roma, come ci racconta il capitolo sull’oblio monumentale che tende a negare la realtà coloniale, mescolandola ai tanti residui di altre epoche, che viene raccontato da Dana Scotto di Fasano nei suoi commenti e interviste nei capitoli dedicati a “Roma negata” di Igiaba Scego con le fotografie di Rino Bianchi.
La curiosità ha presto preso il posto all’estraneità nei confronti dei temi proposti e mi ha portato anche a superare presto una mia personale idiosincrasia per le maiuscole o le parentesi introdotte all’interno di una parola.
La stessa che mi aveva portato ad aderire al gruppo di studio “psicoanalisi nel mediterraneo” che raccoglieva colleghi dei vari paesi che su quel mare si affacciano: francesi, spagnoli, portoghesi, libanesi, tunisini, marocchini, israeliani, oltre a me per l’Italia. Il gruppo di ricerca che si era formato qualche anno fa alla casa della Fep di Bruxelles aveva l’obiettivo di condurre una riflessione intorno a questioni specifiche delle culture del bacino mediterraneo nelle loro differenze e nei loro aspetti comuni. Ci si chiedeva se esistesse una particolarità nel funzionamento di uno psicoanalista che vive in luoghi bagnati dal mare mediterraneo rispetto a una psicoanalisi tradizionalmente più collegata al nord Europa e al mondo anglosassone.
Dopo due incontri teorico-clinici molto ricchi, uno a Kelibia, in Tunisia, nel marzo 2020 sul tema “I sogni nel mediterraneo”, e uno a Palermo, nell’aprile 2023, su “Invidia e gelosia, fonti di psico ed etnopatie nel mediterraneo”, il gruppo si è sciolto rimanendo invischiato nei conflitti sociopolitici del nord Africa e del Medio Oriente che hanno reso impraticabile il confronto tra professionisti appartenenti a Stati, culture, religioni coinvolte in ostilità più o meno aperti.
Il confronto che percorre in lungo e in largo il libro, il filo rosso di tutto il testo, è il difficile incontro tra l’Occidente e le AfrichE, come le chiamano gli autori, nella loro costante trasformazione, sia dei confini geografici, che degli orizzonti culturali.
La stessa curiosità che mi aveva fatto apprezzare La più recondita memoria degli uomini, di Mohamed Mbougar Sarr, vincitore del premio Goncourt 2021 (cfr. Daniela Federici su Spiweb, 2023). Un bel libro su un giovane scrittore africano che decide di lasciare la Francia e tornare a vivere in Africa. Nel libro, l’idea di assimilarsi alla cultura occidentale, di mostrarne la padronanza, appare una illusione; il successo più diabolico della colonizzazione è che semina nei colonizzati “il desiderio di diventare ciò che li distrugge”. Accedere alla lingua del paese colonizzatore implica riconoscerne il valore e l’eccellenza ma anche utilizzare, con le parole di Deridda «l’irrappresentabile lingua dell’altro» di quell’altro colonizzatore considerato un «nemico interno».
Rita El-Khayat parla in questo libro della “lingua del Latte”, “quella che la madre parla al bambino alla nascita, quella che quest’ultimo interiorizza come la prima, la più significativa, “è la lingua materna”. Nell’involucro del corpo del bambino e all’interno del latte bevuto al seno della madre, ci sono le parole che essa dice quando parla al bambino, queste parole sono quasi istintive e nutrono l’inconscio del bambino tanto quanto il latte, inoltre, esprimono amore e preoccupazione per il suo benessere, costituiscono la sua costituzione istintivo affettiva…” (p.10).
Un mito che il libro spazza subito via è quello di un occidente bendisposto e curioso -politicamente corretto- verso i fenomeni politici e culturali che caratterizzano la grande complessa realtà dell’Africa e delle sue trasformazioni, l’occidente e gli occidentali devono fare i conti con la loro storia, le loro amnesie e le loro rimozioni, con i problemi ancora aperti della dominazione coloniale e della cultura che da essa è emanata.
Ancora Rita El-Khayat, infatti, sottolinea “la misconoscenza da parte degli Occidentali circa i paesi africani (o arabi, o mussulmani, o tutti gli altri non occidentali)”. A suo parere ciò, implica che per le persone che vivono “sul posto”, e che subiscono tutto quello che, in modo esogeno, le descrive e parla al posto loro, “non sia data la possibilità di muovere osservazioni e portare contributi e analisi più endogene.” (p.12).
Nelle intenzioni degli autori, si tratta di un tentativo di utilizzare concetti psicoanalitici per leggere la realtà attuale: “né studio analitico, né saggio universitario, né reportage culturale, questo agile volumetto si vuole essenzialmente come un invito a proseguire con altri mezzi e in altri luoghi l’impresa qui appena abbozzata: coinvolgere la psicoanalisi nell’allargamento del nostro orizzonte di ricezione delle AfrichE. La posta in gioco è triplice: espandere le frontiere della cultura analitica (senza facili riduzionismi); scommettere sul fatto che l’inclusione delle AfrichE comporta, necessariamente, una parallasse (cambiamento di angolo e di visuale); contribuire all’apertura di uno spazio transizionale e di mutua contaminazione” (p.31).
Alcuni concetti psicoanalitici vengono proposti come possibili chiavi di lettura dei fenomeni storici e sociali dell’attualità, suscitando curiosità e iniziali rifiuti negli, a volte, stupefatti interlocutori che però hanno cercato di comprendere le ragioni dei quesiti che venivano posti.
Uno riguarda l’aprés coup come possibile chiave di lettura per le tematiche odierne della migrazione alla luce delle tragedie della colonizzazione, del mercato degli schiavi.
Gli autori ne propongono una definizione di Jacques André “l’après coup è un trauma e se non è semplice ripetizione, è perché contiene elementi di significazione che aprono, a condizione di trovare un ascolto e una interpretazione, su una trasformazione del passato. Aprono a una trasformazione del passato” (p. 46).
Una sorta di colpo di teatro avviene quando Daniela Scotto di Fasano interloquisce con l’artista italo etiope Gabriella Ghermandi, chiedendole cosa ne pensi delle “amnesie e rimozioni” dei governi e degli stati che hanno occupato il Corno D’Africa, tra cui il nostro paese, confessa di “essere presa alla sprovvista” dalla reazione dell’intervistata. La Ghermandi, infatti, le fa notare che anche quando l’Occidente si interroga sulle sue amnesie e sulle sue rimozioni lo fa in un modo “europacentrico” cioè con una modalità che mette al centro del modo di pensare l’Occidente: l’Occidente fa,” l’Occidente invade, l’occidente dimentica”.
Affermazioni che ricordano per via associativa una inconsapevole “ipocrisia professionale” di cui parla Ferenczi che porta una paziente, a fronte di un riconoscimento di un errore da parte del suo analista, a dire “sarebbe meglio che non avesse sbagliato…Lei è così presuntuoso, dottore, da voler trarre vantaggio anche dagli errori…” (Ferenczi s: 1932, 94).
Interessante anche l’approfondimento delle differenze tra produzioni letterarie proprie della cultura africana autoctona rispetto a quelle che fanno riferimento alle tradizioni dei paesi colonizzatori proposto dagli autori attraverso l’analisi di alcune opere letterarie.
Il libro offre un sorprendente invito a riflettere; gli autori non ci propongono letture sature, si sono confrontati e ci vogliono mettere a confronto “con l’idea di una confusione quando non una divisione intima del soggetto africano, che, come ogni soggetto impattato dalla modernità, si trova combattuto tra istanze contraddittorie (Tradizione versus modernità; secolarizzazione versus integralismo religioso; passato coloniale versus globalizzazione post-coloniale, cosmopolitismo versus ripiegamento etnico-identitario..) (p.27).
Insomma, un libro che ripaga della fatica del superamento della “inquietante estraneità” che ho descritto all’inizio e che offre, a chi si inoltra nella lettura, una nuova consapevolezza di cose che forse già intimamente si sapevano ma delle quali in gran parte non eravamo consapevoli.
Derida J (1996) Il monolinguismo dell’altro o la protesi d’origine. Raffaello Cortina Editore, Milano, 2004.
Ferenczi, S. (1932) Confusione di lingue tra adulto e bambino In Sandor Ferenczi, Opere, Vol. 4, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2002.
Federici D. (2023) “La più recondita memoria degli uomini” di M. M. Sarr. Recensione di D.Federici | SPI
