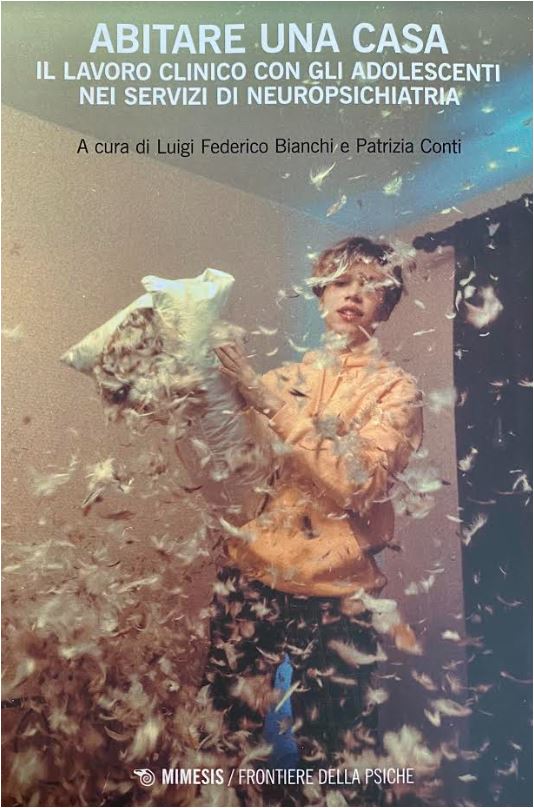
Parole chiave: Psicoanalisi, Adolescenza, Ascolto, Cura.
“Abitare una casa. Il lavoro clinico con gli adolescenti nei servizi di neuropsichiatria”
A cura di Luigi Federico Bianchi e Patrizia Conti
(Mimesis ed., 2022)
Recensione a cura di Maria Flora Piccinini.
Il titolo di questo volume dedicato al lavoro clinico con gli adolescenti nei servizi pubblici, rimanda ad un luogo da abitare, la casa delle relazioni originarie ma anche un edificio che protegge, un contenitore familiare in cui si possono intrecciare legami, un ambiente che accoglie e dove si tesse una cura possibile. La casa come oggetto dell’abitare in senso attivo rimanda al concetto di uso dell’Oggetto, winnicottiano, punto d’arrivo e di partenza possibile per un percorso terapeutico in cui è fondamentale, oltre alla capacità di fare un uso personale dell’oggetto, che l’oggetto stesso si offra e si renda disponibile per essere usato, che ci sia un ambiente facilitante.
Sembra questa la visione che tiene insieme le differenti tipologie di interventi clinici offerti nelle varie esperienze di cura descritte dagli autori, una casa offerta alle adolescenze terremotate, in uno sforzo collettivo volto alla ricostruzione.
Se, come scrivono i curatori del volume, Lugi Federico Bianchi e Patrizia Conti, “il filo rosso che unisce i contributi è l’attenzione e l’ascolto rispettoso della mente in crescita dei nostri ragazzi…” e “il servizio pubblico, nelle sue diverse articolazioni diviene il luogo preso d’assalto da malessere e agiti” l’estensione del metodo psicoanalitico in tali contesti costituisce una trincea contro l’agire offrendo una nuova opportunità affinché la sofferenza trovi un senso e una pensabilità.
L’immagine di un lavoro in trincea rimanda non solo alla necessità di reagire ai ripetuti attacchi (al setting, al legame, al pensiero) ma anche ad una posizione scomoda e complessa dove si lavora certamente “senza divano”, ma supportati dai compagni di avventura, con cui è di vitale importanza fare squadra e fare rete. La risorsa principale a cui attingere è proprio l’approccio alla cura da parte dei diversi operatori testimoniata dagli autori, a fronte del grave deficit di risorse messe a disposizione dell’Ente pubblico, in servizi decisamente sottodimensionati e spesso in difficoltà nel rispondere ai bisogni emergenti.
Il pregio del volume è di illustrare una polifonia di interventi e di mettere in luce l’importanza della malleabilità del contenitore di matrice psicoanalitica, che offre un ascolto alla sofferenza consentendo le differenti declinazioni della cura.
Il libro testimonia la possibilità di coniugare interventi multidisciplinari e dialoganti con altri modelli pur mantenendo un assetto mentale di stampo psicoanalitico.
Delinea un quadro vivo e reale di come si fa e cosa si fa dentro al variegato mondo del servizio pubblico, riconferma lo stato di buona salute della psicoanalisi che sa farsi ambiente e farsi cura con gli adolescenti difficili da incontrare in questi contesti. Una psicoanalisi “ontologica” come la intende Ogden (2022) che aiuta a “prendere vita” e che, senza rinunciare all’approccio epistemologico relativo al conoscere e al comprendere, si manifesta nel costruire nuove esperienze con i pazienti.
Gli autori sottolineano la centralità dell’attenzione “a mantenere un lavoro coordinato e condiviso a più livelli: fra la cura del contesto familiare, l’approccio farmacologico, quello psicoterapeutico e gli interventi educazionali e di sostegno…Soprattutto per i casi difficili… si tratta di rimettere insieme i momenti della frammentazione” attraverso una cura che riaccenda la speranza e accompagni nel percorso di ritrovamento di una personale creatività e soggettività. Affrontando le sfide che questi adolescenti pongono ai curanti, gli autori raccomandano di evitare conformismi nella diagnosi e nel trattamento e ancora una volta ribadiscono l’importanza di un ascolto che porti alla risignificazione, fin dove è possibile, dell’esperienza traumatica. Il cuore dell’ascolto analitico è anche il poter sostare, e tollerare il non sapere , il non capire subito ‘che cosa succede’ e non riempire l’agito e la crisi adolescenziale con spiegazioni a volte difensive da parte degli operatori; un non capire che può diventare trasformativo.
Non sembra un caso che il capitolo che apre la raccolta di contributi parli dell’incontro con i genitori (L. Bianchi, P. Conti), valorizzando l’ascolto analitico delle diverse sofferenze dei componenti familiari, che vanno accolte. Nella prima parte del libro si tratta anche della valutazione diagnostica del disturbo borderline in adolescenza e di come orientarsi nella definizione di un trattamento (G. Rossi) e della ricchezza delle esperienze cliniche di ricovero degli adolescenti nella NPIA di Monza (R. Nacinovich).
La seconda parte, dedicata al lavoro nelle strutture residenziali e semiresidenziali descrive il lavoro nelle comunità a partire dal “quando e perché” della presa in carico e del come orientarsi all’interno di un ventaglio di proposte e percorsi possibili (S. Molteni, M. Sardo) per poi passare a descrivere le esperienze nella Comunità residenziale educativa con l’Estensione della Consultazione Partecipata (B. Friia), a trattare del ruolo cruciale plurifunzionale dell’educatore nella cura con l’adolescente, impegnato in una relazione “educativa” o “terapeutica”, poco importa (I. Ciprian Farcas, G. Marchesini) e infine a riflettere su come “i contesti educativi e di cura sono chiamati a realizzare un nuovo patto di lavoro per funzionare efficacemente con questo tipo di patologie al limite degli adolescenti”, prestando particolare attenzione ai funzionamenti gruppali “fra gruppo evolutivo e branco” (D: Biondo).
La terza parte del volume descrive alcuni modelli di intervento sottesi a interessanti progetti attivati nel contesto dei servizi pubblici, un progetto (PERCIVAL) volto alla costruzione di interventi multidisciplinari per affrontare le acuzie in adolescenza (A. Costantino, G. Frasson) ed il progetto SAGA (A. Albizzati, E: Ierardi, M: Moioli, C: Riva Crugnola) rivolto ai genitori di adolescenti in supporto alla loro complessa esperienza di genitorialità.
Infine nella parte quarta il testo offre un panorama di esperienze cliniche con gli adolescenti spaziando tra i disturbi alimentari in NPIA, dove è fondamentale il lavoro con i genitori (R. Nacinovich), illustrando la qualità dell’ascolto rivolta all’adolescenza all’interno del Consultorio e la complessità di un intervento socio-sanitario integrato e multidisciplinare in una presa in carico globale (M. Gallo), riportando le difficoltà di lavoro nelle “équipe di frontiera” (S. Quercioli), che operano in territori di profondo disagio sociale e ambientale; e non ultimo il lavoro clinico con gli adolescenti stranieri, che impegnano la psicoanalisi ad occuparsi di adolescenze sul confine. (V. De Micco), la faticosa costruzione di una identità personale quando il processo migratorio ha messo in crisi i legami familiari.
