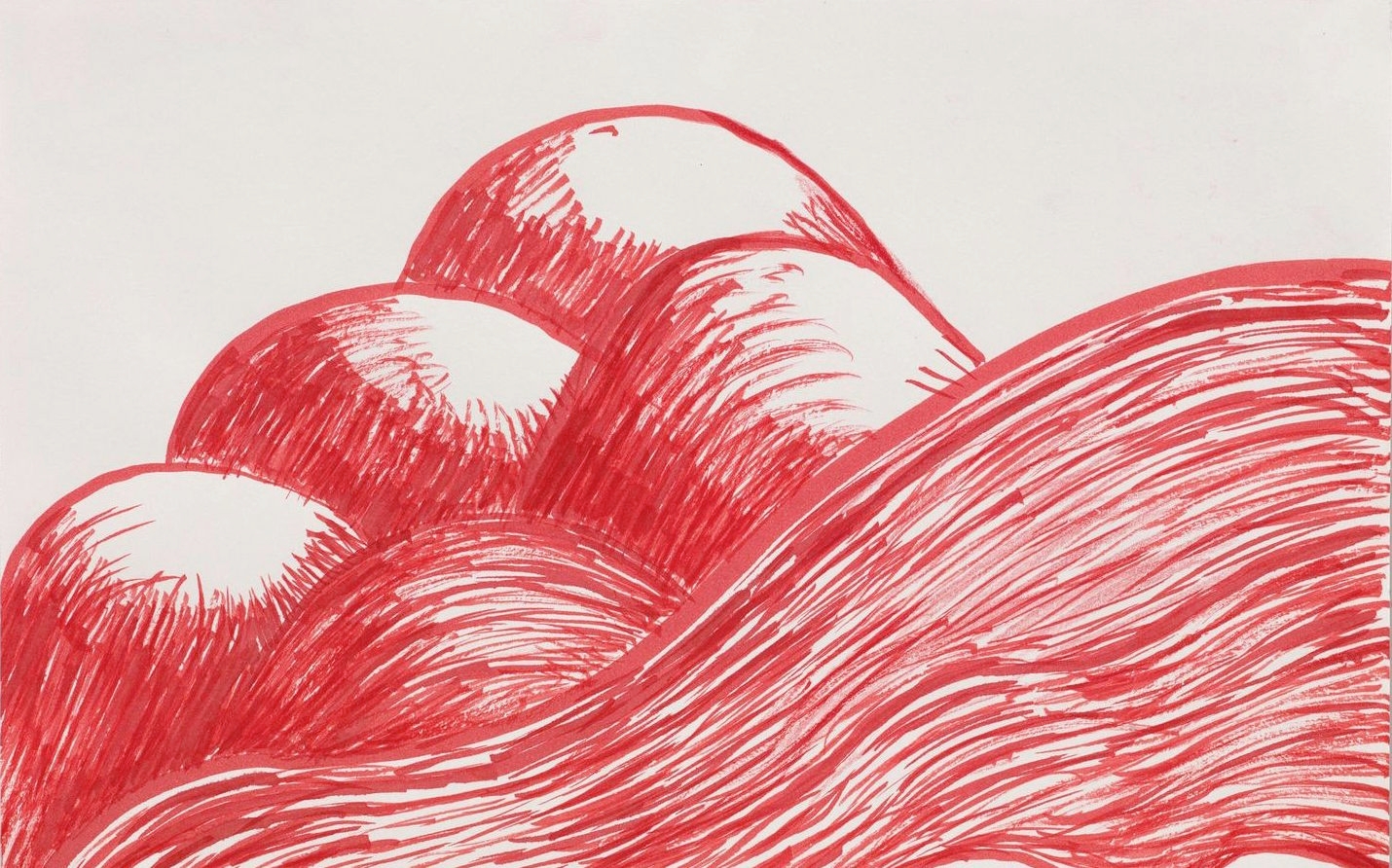
LOUISE BOURGEOIS, 2003
parole chiave: godimento, pulsione di morte, sadismo, masochismo
Masochismo
A cura di Andrea Baldassarro
Abstract Il masochismo presenta il paradosso di un godimento apparentemente sganciato dal piacere e intrecciato invece con il dolore e l’angoscia, questione che già nell’opera di Freud assume un rilievo sempre più centrale: da inflessione del sadismo sullo stesso soggetto diventa sempre più punto nodale del comportamento umano, attrattore fondamentale delle spinte pulsionali inconsce più profonde e più misteriose, come il fondo distruttivo dell’umano rivolto all’interno del soggetto, che la pulsione di morte, silenziosamente, porta con sé. Non un desiderio di morte, ma la necessità di “tornare allo stato di cose iniziale” che è la meta di ogni pulsione, ovvero quella di ripristinare uno stato di cose precedente.
Masochismo
A cura di Andrea Baldassarro
Quando Freud inizia ad utilizzare il termine “masochismo” per designare una delle perversioni su cui appuntare il proprio interesse e la propria riflessione, la parola era di conio recente. Era stato infatti Krafft-Ebing ad inserirla nella sua Psychopatia Sexualis nel 1886, prendendo il posto della “algolagnia” che era stata proposta invece da Schrenck-Hotzing e che significa “voluttà nella sofferenza”. Il termine, poi entrato nell’uso corrente, era derivato dal nome di Leopold von Sacher Masoch, l’autore del romanzo Venus in Pelz (Venere in pelliccia), e che a quell’epoca era ancora vivente. Egli aveva descritto, come Krafft-Ebing stesso aveva sottolineato nel nono capitolo della sua Psychopatia, il legame della voluttà con la sottomissione alla crudeltà, e la “direzione dell’istinto sessuale verso la sottomissione a un’altra persona e il duro trattamento inflitto da questa stessa persona”. Il masochismo non sarebbe altro, dunque, che la ricerca del più grande godimento attraverso la sottomissione e il maltrattamento, sebbene alcune forme più “sublimate” di questa inclinazione – tipicamente maschile – possano essere rintracciate già nell’amor cortese, quando il “cavalier servente” trovava la sua piena realizzazione nell’esser del tutto soggiogato e nel sottomettersi del tutto volentieri, anima e corpo, alla dominazione della propria Dama, investita di un’adorazione assoluta.
Il masochismo, dunque, deriva il suo nome – a differenza delle altre perversioni sessuali, che fanno riferimento a un comportamento “deviato” dalla norma – da un autore, un letterato, così come il suo tradizionale complemento, il sadismo, il cui nome proviene dall’opera del marchese de Sade. Ma se in quest’ultimo caso sappiamo per certo che la pratica “perversa” apparteneva “per antonomasia” al suo autore, non sappiamo se le cose stessero così anche per Sacher-Masoch. Certamente il masochismo non poteva non incontrare il suo opposto, il sadismo; resta il dato, comunque interessante, che queste due “perversioni” si riferiscono entrambe a un “conio” personalizzato, ovvero al nome del loro “inventore”. Mentre tutte le altre descrivono le deviazioni dal comportamento “normale” non a partire da un autore, ma dalla “cosa” stessa.
D’altra parte, la congiunzione sadismo-masochismo non va da sé, sebbene sia ormai entrata nell’uso comune come due facce di una stessa medaglia. In ogni caso, se il soddisfacimento è sempre problematico nella nevrosi, sebbene presente come “godimento del sintomo” (Lacan), raggiunge invece il suo scopo nelle perversioni. Ed è questo il motivo per il quale difficilmente i perversi si sottopongono a un’analisi: se va bene così, perché fare problema di qualcosa che, tutt’al più, attenterebbe solo all’ordine sociale? Al massimo, quello che si può rimproverare alle perversioni è quella necessità che costringe a ricercare – e forse, a trovare – il piacere secondo delle vie obbligate: ma, al limite, non è forse così per tutti gli esseri umani, se la perversione non è altro che un rappresentante della vestigia, potremmo dire, della sessualità polimorfa – perversa, appunto, come aveva sostenuto Freud – dell’infanzia? Quando Freud, infatti, aveva posto il problema di una perversione originariamente “naturale” nel bambino, si era domandato anche se e come si potesse realizzare l’abbandono di questa posizione infantile iniziale. Il passaggio dalla perversione infantile polimorfa alle necessità della civilizzazione si realizzerebbe attraverso il passaggio dal diniego – meccanismo all’opera appunto nella perversione, che non riconosce la castrazione e la differenza tra i sessi – alla rimozione, propria della nevrosi, che in questo senso diviene appunto la “negativa” della perversione.In ogni caso, nella tradizione psicoanalitica secondo la “logica” freudiana, essa non è soggetta a rimozione, dunque al ritorno del rimosso e al conflitto, in quanto il perverso aderisce del tutto al piacere che sperimenta; per questo motivo la perversione, in quanto positiva della nevrosi – se la nevrosi è la sua “negativa” – non sarebbe trattabile psicoanaliticamente. E dunque se il bambino è un perverso polimorfo, anche le perversioni non sarebbero altro che delle fissazioni ad uno stadio dello sviluppo anteriore: l’unico appunto che si potrebbe far loro sarebbe dunque quello di perseguire delle “vie obbligate” per il raggiungimento della soddisfazione; di porre insomma dei limiti stringenti alla libertà individuale. Le conseguenze di questo discorso, indubbiamente già molto audace all’epoca di Freud, è che non ci sarebbe più nessun male nell’essere perversi, divenendo così la perversione stessa più una questione di posizione psichica che di attitudine morale: in quanto, se la fissazione non è una scelta, ma un effetto delle vicende pulsionali del soggetto, quello che un tempo era assegnato alla censura della morale può anche divenire pratica comune, che è appunto quanto si assiste oggi, ad una sorta di “normalizzazione” di alcuni comportamenti o scelte d’oggetto un tempo ascritte a pratiche perverse.
Ma per tornare al masochismo, esso rappresenta non solo il lato opposto del sadismo ma è anche ad esso complementare: è infatti un luogo comune dire che un masochista ha sempre bisogno di incontrare un sadico per dare soddisfacimento alla propria perversione. D’altra parte, già Freud non aveva mancato di notare come i due ruoli (sadico-masochista, attivo-passivo) possono facilmente ribaltarsi, anzi di frequente si può passare da una posizione a un’altra, anche nello stesso individuo. Si può allora affermare con certezza che il masochista “subisce” l’azione del sadico? O in realtà è colui che dirige le operazioni? In fondo, già nella “contrattualità” concordata tra il protagonista della Venere in pelliccia e Wanda, ovvero la Venere stessa del romanzo, è il primo a spingere l’altra alla pratica perversa, pressandola con una domanda esorbitante, eccedente, e dunque rendendo di fatto indistinguibili i due ruoli[1]. Lo stesso masochista perverso – aveva notato Piera Aulagnier – conferendosi l’autorità di farsi castrare dal proprio partner, esercita una padronanza assoluta, addirittura maggiore dello stesso sadico: “quel potere assoluto che (…) fa di lui colui che, per proprio desiderio, propone il proprio corpo alla mutilazione e prova, attraverso il proprio godimento, che il dolore è piacere, che l’orrore è fascinazione, che la castrazione è una forma pura di godimento”[2]. Si pone allora la questione: chi assoggetta davvero l’altro? Non è forse il masochista una sorta di “principe assoluto” che sfida la realtà codificata, e la modella secondo il proprio stesso desiderio?
E per venire alle questioni teoriche: nella prima teoria freudiana delle pulsioni il sadismo appare come primario, in particolare nel senso di una spinta aggressiva che non corrisponde ad alcun piacere sessuale: piuttosto, sembra avere a che fare con una volontà di dominare l’altro, di assoggettarlo alla propria pulsione di impossessamento. Mentre il masochismo, inizialmente, non corrisponderebbe ad altro se non alla riflessione su di sé di questa stessa pulsione e alla trasformazione dell’attività in passività. È qui che il piacere sessuale si manifesta, quando il dolore si mette in relazione con l’eccitazione. Il piacere di soffrire – dice Freud – si mostra nella nevrosi ossessiva, quando si mira a far soffrire sé stessi ostinatamente, e nel masochismo vero e proprio, quando è però necessario l’intervento di un altro come agente delle proprie sofferenze. Ma in ogni caso un ruolo decisivo è giocato da un fantasma soggettivo, in quanto nel masochismo l‘Io cede la propria posizione precedentemente occupata (nel sadismo) a un altro, mentre nel sadismo avviene un’identificazione con le sofferenze inflitte a un altro. All’inizio dunque, vi sarebbe un sadismo primario attivo che investe un soggetto esterno e che in un secondo tempo può rivolgersi verso il soggetto stesso.
Successivamente, con la seconda teoria pulsionale, Freud capovolge la sequenza, e considera invece il masochismo come primario, in quanto il sadismo rappresenterebbe solo l’estroflessione all’esterno della pulsione di morte, originariamente rivolta verso il soggetto stesso. Il masochismo primario risulta così da un impasto delle pulsioni erotiche e di quelle distruttive. Solo in un secondo tempo, comunque, il sadismo può rivolgersi ancora verso il soggetto, andando a costituire il cosiddetto masochismo secondario. Ma queste insidie terminologiche e concettuali rendono ragione evidentemente di una difficoltà a collocare in una teoria definitiva la questione dell’associazione – davvero inevitabile? – di sadismo e masochismo.
Le cose non sono appunto affatto semplici, ma estremamente intricate e di difficile decifrazione. Già una nota freddura lo fa notare, in una sorta di vertigine ambigua che recita così: un masochista incontra un sadico, e gli dice: “Fammi male…”. E il sadico ribatte: “No!”, facendo paradossalmente godere l’altro di una sofferenza che sconcerta e lascia interdetti. C’è infatti qualcosa di inquietante e di equivoco in questo scambio di battute, perché mostra forse un fantasmatico accenno al perturbante.
In effetti, la congiunzione sadismo-masochismo non va da sé: non solo perché, come dicevamo, i ruoli possono essere interscambiabili, e il godimento del sadico – Freud l’aveva ben compreso – consiste fondamentalmente in un’identificazione con la sofferenza del masochista, ma soprattutto perché nel masochismo si manifesta qualcosa che è più di un enigma[3]: com’è possibile trarre soddisfazione dal dolore? Ma sadismo e masochismo si differenziano anche per un dato fondamentale: nel secondo è previsto una sorta di “contratto” stipulato tra il masochista e il soggetto cui si sottomette – come mostra con tanto di “stipula ufficiale” l’addendum al romanzo Venere in pelliccia – che prevede delle rigide regole e dei principi di comportamento, mentre nel sadismo, viceversa, nessuna regola è prevista; anzi, il godimento del sadico sta proprio nell’oltrepassare e trasgredire i codici comuni di comportamento, ovvero la Legge. È proprio il rapporto con la Legge che costituisce il problema maggiore per il perverso – fa notare Lacan – che non riconosce la legge del padre e la sfida per poter continuare a preservare il proprio diniego a proposito della castrazione e della differenza tra i sessi. E così l’interdetto, invece che provocare la rimozione, come nella nevrosi, è indice di un godimento per il soggetto: che trasgredisce la legge per rispondervi, la rifiuta ma si appoggia ad essa[4].
Ma soprattutto il masochismo costituisce una sorta di rebus irrisolvibile, che nell’opera di Freud assume un rilievo sempre più centrale: da inflessione sullo stesso soggetto del sadismo rivolto inizialmente all’esterno, diventa sempre più punto nodale del comportamento umano, attrattore fondamentale delle spinte pulsionali inconsce più profonde e più misteriose.
Il masochismo è così a fondamento dell’umano. È non lo è solo in ciò che fa problema – il senso di colpa inconscio, la crudeltà del Super-io, la reazione terapeutica negativa – ma nel suo dispiegamento assoluto in relazione alla (auto)distruttività umana e al primato della pulsione di morte.
Ma procediamo con ordine.
Nei Tre saggi sulla teoria sessuale, Freud abborda in questo modo la questione del masochismo: “… la designazione di masochismo abbraccia tutti gli atteggiamenti passivi verso la vita sessuale e l’oggetto sessuale, e di questi l’estremo appare essere la congiunzione del soddisfacimento col patimento di dolore fisico o psichico cagionato dall’oggetto sessuale. Il masochismo come perversione sembra allontanarsi dalla meta sessuale normale più del sadismo; ed è lecito innanzitutto dubitare se esso si presenti in modo primario o piuttosto non sorga regolarmente per una trasformazione dal sadismo”[5].
In questa prima versione del masochismo, dunque, Freud considera il masochismo come “una prosecuzione del sadismo rivolto contro la propria persona, la quale fin dall’inizio tiene luogo dell’oggetto sessuale”[6]. È dunque il sadismo il “centro” delle aberrazioni sessuali, mentre il masochismo raggruppa tutte quelle attitudini sessuali “passive” che rinviano ad un fantasma di punizione dolorosa, di maltrattamento, di umiliazione e di abbassamento della propria condizione umana, fino al soggiogamento incondizionato e all’adorazione di un oggetto sessuale. In questo modo, il soggetto si pone come oggetto di un godimento paradossale che passa attraverso la dominazione e il soggiogamento da parte dell’altro. E’ proprio questo aspetto estremo e paradossale del masochismo che ne individua il suo carattere enigmatico, in quanto la perversione masochistica non solo sembra sfuggire alla meta sessuale “normale” per il suo carattere particolarmente bizzarro, ma soprattutto mostra qualcosa che oltrepassa la perversione in senso stretto, che si colloca “al di là” della logica pulsionale, anzi addirittura ne indica un sovvertimento, che costringerà Freud ad una revisione fondamentale della teoria pulsionale stessa: il masochismo risulta infatti incomprensibile se è il principio di piacere a dominare i processi psichici. Attraverso una progressiva esplorazione delle modalità con cui il masochismo si presenta, dalle fantasie di percosse infantili in Un bambino viene picchiato (1919) fino al Problema economico del masochismo (1924), sembra prevalere nel carattere “perverso” del masochismo – che pure era sempre stato mantenuto – una qualità “strutturale”, secondo una traiettoria che ricopre in parte l’evoluzione delle considerazioni sul narcisismo, del quale sembra quasi prendere il posto. Il masochismo – inizialmente declinato nelle sue diverse varianti: erogeno, femminile, morale – pone infatti sempre più la questione di un godimento sganciato dal piacere e intrecciato invece con l’angoscia. Questione che in qualche modo rinvia alla condizione originaria di Hilflosigkeit del soggetto umano all’inizio della vita, alla sua inermità dovuta alla sua necessaria dipendenza dall’altro per sopravvivere. Si tratterebbe allora di una forma originaria in cui piacere e dispiacere non sono ancora separati: un insieme che non è né piacere né dispiacere, ma una “coeccitazione che si potrebbe forse definire come intensità tensionale”[7], intensità tensionale che rappresenta – si noti bene – il principio di piacere come tentativo costante di “fare presa” sul piacere e sull’oggetto, e di preparare così il terreno al piacere stesso. Sin dall’inizio, infatti, Freud aveva parlato della “coeccitazione libidica” per spiegare non solo la compresenza di piacere e dolore ma l’impossibilità iniziale di una loro sostanziale distinzione: non era il dolore a provocare il piacere, ma piuttosto l’eccitazione ad esso collegato. Ma in effetti, la distinzione che Freud opera tra i diversi tipi di masochismo non sembra tenere del tutto: se il masochismo “erogeno” appare infatti come la forma “classica”, in cui il piacere segue le vie del dolore, e quello “femminile” non concerne tanto le donne, quanto piuttosto il fantasma – tipicamente maschile – di assumere una posizione passiva e di essere maltrattati, è il masochismo “morale” a costituire il problema maggiore: si tratta di una spinta alla punizione – dettata da un senso di colpa inconscio – nella quale la relazione con la sessualità sembra del tutto abbandonata. Il soggetto si trova alle prese con un “al di qua” dell’Edipo in cui la pulsione di morte, attraverso un Super-Io particolarmente crudele, aggredisce l’Io[8], che gode della sua stessa distruzione, fine ultimo della stessa pulsione di morte, che mira appunto all’azzeramento e all’annullamento delle differenze. È evidentemente in gioco – proprio attraverso la posizione di vittima che il masochista morale tende ad acquisire, e che indica una sorta di perfezione cui altri non possono aspirare – una valenza narcisistica che si ritroverà come determinante nella reazione terapeutica negativa.
Già leggendo le pagine della Venere in pelliccia si è in effetti catturati dalla viva impressione che dietro la messa in scena delle pratiche umilianti e “adoranti” nei confronti dell’oggetto, si agiti un fantasma soggettivo, e che dietro questo fantasma si muova una logica pulsionale generale: quella che va dalla perversione al piacere/dispiacere e dalla passività alla colpa. Il sadico, lo diceva Freud – e non si può non essere d’accordo – non trae forse il suo godimento dall’identificazione con il dolore provato dal masochista? E in fondo, come Lacan non ha mancato di notare, il masochista non intende suscitare l’angoscia quando si fa oggetto dell’Altro, riuscendo in questo modo a esistere – illusoriamente – ai suoi occhi? Se pensiamo all’esempio biblico di Giobbe troviamo appunto – come fa notare Assoun – il suo appellarsi a Dio come sua vittima, come il giusto, l’eletto che diviene rifiuto, scarto divino. E che fa appello a lui per angosciarlo con il suo dolore[9].
In ultima analisi, il masochismo appare come una forza costante che alla fine estroflette fuori di sé la spinta interna all’autoannullamento, all’autodistruzione che la pulsione di morte, silenziosamente, porta con sé: si intenda bene, non un desiderio di morte, ma la necessità di “tornare allo stato di cose iniziale” (al limite, filogeneticamente, di risalire al “prima” della vita stessa) che è la meta di ogni pulsione, ovvero quella di ripristinare uno stato di cose precedente. Freud ha proposto una spiegazione della spinta umana alla distruttività, propria e altrui, “che anche agli psicoanalisti appare spesso insostenibile, ma che è tanto significativa quanto terribilmente semplice: l’uomo estroflette all’esterno il male per non essere ucciso da esso, ed arriva ad uccidere, potremmo dire, per non uccidersi; per il desiderio, in ultima analisi, di non morire. Infatti, anche quelli che si uccidono per uccidere, in nome di un dio o di una dottrina, lo fanno nella convinzione di una vita ulteriore fatta di soli piaceri, di soli godimenti, per sempre”[10]-
Il masochismo primario appare allora come una modalità del funzionamento psichico di base. La sua declinazione nella forma “morale” lo disloca definitivamente dalla perversione in senso stretto: infatti “può essere interpretato come segno di una ‘volontà di potere’ rovesciata” che “non conosce disfatta, perché ciò che per gli altri è causa di abbattimento, speranza delusa, segno del destino avverso, in questo caso invece è apoteosi suprema. Più dura sarà la caduta, più alta la vittoria[11]. Il masochismo appare allora come quel fondo distruttivo – forse ineliminabile – dell’umano, rivolto all’interno del soggetto, che dà oltretutto l’illusione di un’assoluta indipendenza dal comportamento dell’oggetto, evitando così anche di manifestare qualsiasi spinta distruttiva nei suoi confronti. E qui ne emerge la sua natura narcisistica, o almeno legata a quello che Green chiama “narcisismo negativo” che, “anziché far tendere gli investimenti dell’Io verso l’unità, li orienta alla ricerca dello zero al fine di trovare una soluzione ai problemi della distruttività dissociandoli dall’aggressività, che può essere raccordata alle espressioni del narcisismo positivo”[12]. Se il narcisismo positivo mira all’autosufficienza e comporta la rinuncia alle relazioni oggettuali, il narcisismo negativo aspira invece al nulla oggettuale e al grado zero della soggettività.
In definitiva, intorno alla questione di un masochismo originario si giocano vicende ed esperienze che vanno ben al di là della semplice perversione. Appunto, proprio quell’“al di là” che è il grande problema che era stato sollevato da Freud a proposito dei modi perturbanti con cui il soggetto umano cerca il soddisfacimento e il piacere.
Bibliografia
Aulagnier P. (1967), La perversion comme structure, in L’inconscient, 2
Assoun P.-L. (2007) Le Masochisme. Antropos, Paris
Baldassarro A. (2017) Perché il male. Mimesis, Milano
Deleuze G. (1967) Il freddo e il crudele. SE, Milano, 1996
Freud S. (1905) Tre saggi sulla teoria sessuale. OSF vol. 4, Boringhieri, Torino
Freud S. (1919) Un bambino viene picchiato. OSF vol. 9, Boringhieri, Torino
Freud S. (1920) Al di là del principio di piacere, OSF, vol. 9, Boringhieri, Torino
Freud S. (1924) Il problema economico del masochismo. OSF, vol. 10, Boringhieri, Torino
Green A. (1991) Psicoanalisi degli stati limite. Cortina, Milano
Green A. (1992) Narcisismo di vita, narcisismo di morte. Borla, Roma
Ives D. (2011) Venere in pelliccia. Bur, Milano, 2013
Lacan J. (1975) Il seminario XX. Ancora. Einaudi, Torino, 2011
Sacher-Masoch L. (2004) Venere in pelliccia. ES, Milano
Valdré R. (2020) Sul masochismo. Celid, Torino
[1] La possibilità di uno scambio, di un’inversione dei ruoli tra sadico e masochista è rappresentato in maniera esemplare nel film di Roman Polanski Venere in pelliccia, tratto dall’omonimo romanzo di David Ives, che a sua volta mette in scena il testo di Sacher-Masoch. Nel vertiginoso finale, in particolare, i due protagonisti si scambiano i propri ruoli e personaggi con un effetto di sorpresa e di confusione per lo spettatore. Fino al trionfo conclusivo della Venere, apparentata a una Baccante del teatro classico greco.
[2] P. Aulagnier (1967), La perversion comme structure, in L’inconscient, 2.
[3] Cfr. a questo proposito l’esemplare disamina storica e concettuale che ne fa Rossella Valdré nel suo Sul masochismo. L’enigma della psicoanalisi, Celid, Torino, 2020.
[4] Deleuze sostiene che il sadico cerca un principio superiore alla legge che, essendo destituito il bene, non può che essere il male. Contro la legge, Sade difende l’istituzione, rappresentata dalla società dei libertini, che ha il compito di affermare l’eguaglianza di tutti nel godimento senza remore per gli altri, la cui unica libertà è di sottomettersi alla loro volontà di godimento. Al contrario, il masochista, a partire dalla scoperta che la legge alimenta la colpa di chi vi si sottomette, “aggira la colpevolezza, facendo del castigo una condizione che rende possibile il piacere proibito” (Deleuze, 1996, pp. 98-99). Egli applica la legge fino al suo estremo mostrandone la sua assurdità e provocando il disordine che essa doveva scongiurare, cercando nella punizione il proprio godimento: è il trionfo dell’Io contro il Super-Io, laddove nel sadismo è la crudeltà del Super-Io ad attentare all’Io. Entrambe le strutture perverse hanno in comune comunque la freddezza, risultato di quella “desessualizzazione di Eros” che poi conduce alla “risessualizzazione di Thanatos”.
[5] Freud, 1905, p. 471.
[6] ibid.
[7] Green, 1992, p. 127.
[8] È da notare che questa prospettiva viene del tutto rovesciata dalle riflessioni di Deleuze (cfr. Il freddo e il crudele, op. cit.): è l’Io a trionfare nel masochismo sul Super-Io, e il contrario avverrebbe nel sadismo.
[9] “Nella fattispecie, non si tratta di trarre piacere dalla sventura, ma di identificarsi come soggetto (senza sciogliersi nell’infelicità generale), all’oggetto-scarto della Creazione. Si produce innegabilmente una conversione del dolore realmente vissuto in godimento inconscio. In fondo, Giobbe arriva a presentarsi e a confermarsi come l’eletto di Dio, non più come giusto, ma come vittima” (Assoun, 2007, p. 91, trad. nostra). E laddove Giobbe chiede spiegazione al divino della sua sofferenza, la risposta è una domanda: una domanda sul non sapere dell’uomo – e non poter domandare – dell’origine del vivente.
[10] Baldassarro, 2017, p.19.
[11] Green, 1991, p. 327.
[12] Green, 1992, p. 151.
