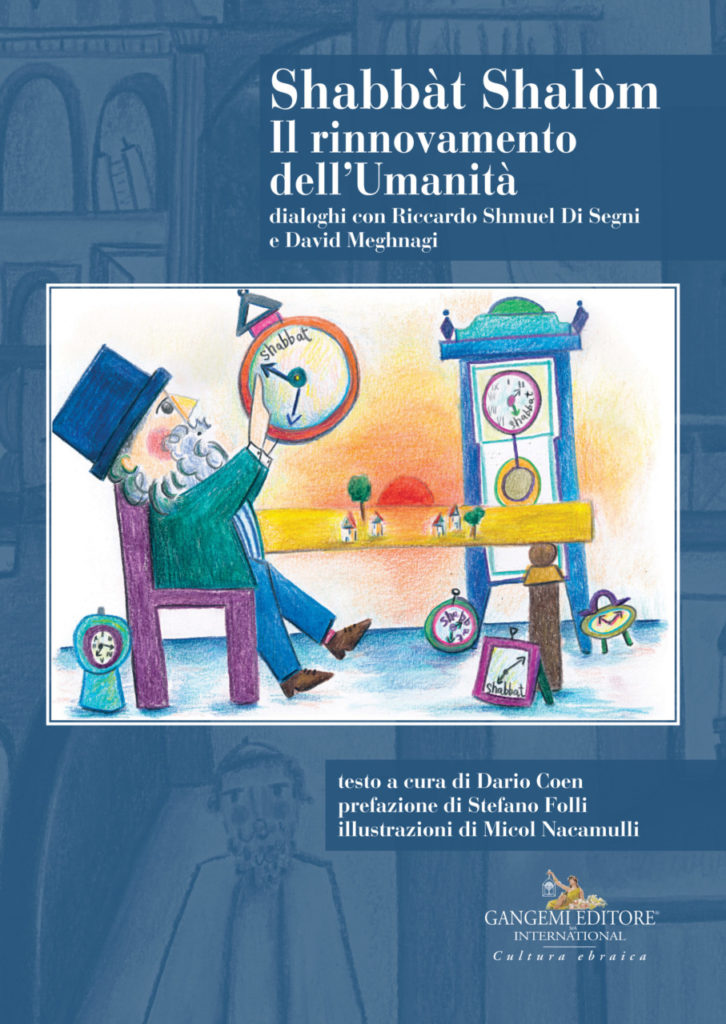
Shabbàt Shalòm. Il rinnovamento dell’umanità – Dialoghi con Riccardo Shmuel Di Segni e David Meghnagi
a cura di Dario COEN (Gangemi Editore, 2022)
Recensione a cura di Rita CORSA
Parole chiave: #psicoanalisi e fede, #ebraismo, # Shabbàt
Da diversi anni sono parte attiva del gruppo nazionale S.P.I. Psicoanalisi e Fede, un’affiatata squadra di soci di matrice laica, che si propone di indagare dal versante psicoanalitico la ramificata e complessa tematica dei rapporti tra i diversi orientamenti psicoanalitici e la fede. Lucia Fattori e Gabriella Vandi, due tra le fondatrici dell’iniziativa, hanno inoltre avviato per la casa editrice romana Alpes una collana di testi psicoanalitici che porta lo stesso nome del gruppo, Psicoanalisi e Fede, destinata ai nostri studi sul delicato argomento. Visti i miei interessi, non poteva passarmi inosservato il recentissimo volume Shabbàt Shalòm. Il rinnovamento dell’umanità (2022), dedicato ad uno dei precetti fondanti dell’ebraismo, lo Shabbàt. Dario Coen, curatore del testo, utilizza l’espediente narrativo dell’intervista per introdurre e favorire la conversazione sul Settimo Giorno, il tempo del riposo, tra Riccardo Shmuel Di Segni, Rabbino Capo di Roma, e David Meghnagi, psicoanalista e già didatta dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (IIPG), grande esperto di cultura ebraica che ha contribuito a innovare a livello internazionale quest’area di studi freudiani. Il libro che vado a esaminare fa parte di un ampio progetto, collocato nella collana Roma ebraica, realizzato dal Dipartimento Beni e Attività Culturali e dalla Comunità Ebraica capitolina con la partecipazione dell’Archivio Storico, ed ha occupato un posto di primo piano nelle cerimonie della Giornata della Cultura Ebraica di quest’anno, volta ad approfondire storia, cultura e tradizioni proprio nel segno del rinnovamento dell’umanità.
Il libro offre un intreccio di riflessioni, ricche e composite, sullo Shabbàt ricevibile non solo per i soggetti e le comunità che lo osservano, ma pure per coloro che non conoscono a fondo questo assunto cardine della religione ebraica. Come spiega Stefano Folli nella Prefazione, si tratta di «un viaggio attraverso il significato antichissimo e attuale dello Shabbàt, il sabato ebraico dedicato al riposo e codificato da regole precise, un tempo rigidissime e oggi scese in qualche misura a parziali compromessi con la modernità» (2022, 7). E aggiungo che, pur sviluppandosi principalmente lungo la linea della tradizione ebraica, non manca il confronto con le altre fedi, con la domenica, il giorno del riposo dei cristiani, e con il rispetto del venerdì da parte dei mussulmani. Il discorso rimane inoltre aperto a interpretazioni culturali, psicologiche e psicoanalitiche di cifra nettamente laica. Alcune pagine, invero, sono riservate a Umberto Eco, uno dei pochi intellettuali italiani non giudaici che hanno scritto del Sabato ebraico e della sua saggezza (L’Espresso, 28 luglio 1991; in Di Segni, 2022, 61-62).
È un libro erudito, ma grazie ad alcune schede tematiche (box),risulta di agile fruizione anche per un lettore sprovveduto. Le bellissime illustrazioni di Micol Nacamulli illuminano il testo nei passaggi chiave e aiutano a rappresentare anche sul piano visivo la grandiosità e universalità del valore dello Shabbàt, la “sposa” senza tempo del popolo ebraico. Lo Shabbàt è la festa settimanale che riunisce un popolo ovunque si trovino i suoi membri: serve a «ricomporre in perfetto equilibrio materia e spirito (…)» – scrive Coen nell’Introduzione. La luce delle candele, accese per onorare questo giorno santo, fa risplendere la dimora della «famiglia unita per accogliere “la delizia, “la regina”, “la sposa”, come viene chiamato il Sabato, insieme a una tavola apparecchiata a festa, con pane fatto in casa e la consacrazione del vino. Un’atmosfera di gioia che si ripetete settimanalmente, da sempre e per sempre, ovunque ci sia un Ebreo, radunando genitori, figli e nipoti per prendere la benedizione del capofamiglia» (2022, 9).
L’elaborazione dello Shabbàt nel suo millenario senso e con i suoi innumerevoli simboli e rituali, è un momento di assoluta centralità nella vita ebraica. Il rav Di Segni riferisce che, sul versante teorico, «già da quando finisce il Sabato, tutta la settimana deve essere proiettata verso la sua fine, dedicando alla sua preparazione i pensieri migliori, la scelta dei cibi, i tempi lavorativi e l’organizzazione domestica, in un crescendo che culmina il giovedì e il venerdì». Un rito dalle origini lontanissime: «Lo Shabbàt è nato con la creazione del mondo, alla fine della creazione. Dopo sei giorni di creazione, racconta la Torà al suo inizio, il Signore si fermò. Quindi Shabbàt e creazione sono due termini indissociabili» (Di Segni, 2022, 13). Un culto le cui radici si perdono nella notte dei tempi, ma che ha saputo adattarsi ai più diversi contesti e scenari. E che dal punto di vista psicoanalitico mette a confronto le generazioni, attraverso lo snodarsi transgenerazionale dell’eredità familiare. Un argomento sfiorato nel libro da Meghnagi, nei passi in cui accenna allo sviluppo del movimento di emancipazione ebraica e alla nascita del sionismo e al sogno dell’Ebreo nuovo, libero dalle catene dell’esilio. «Un processo complesso – egli afferma – in cui le immagini del riscatto futuro si saldavano all’idealizzazione di un’epoca più antica». Questa dinamica richiama alla pratica analitica, quando il conflitto aspro con i padri e con i genitori riesce a trovare una via di ricomposizione attraverso un positivo lavoro associativo sui nonni. Meghnagi ci fa così ben capire che «ciò che nelle dinamiche interne ad una famiglia potrebbe apparire una frattura irreversibile, è in realtà un processo di riconquista di legami che si estendono alle generazioni passate e le salda tra loro» (2022, 35-36).
A proposito di generazioni che si avvicendano, è toccante il passaggio di Meghnagi, che ben conserva la memoria degli ebrei di Libia, quando rammenta che se per caso non c’erano orologi nelle abitazioni «per stabilire l’arrivo dello Shabbàt si guardava in cielo per vedere se erano apparse tre stelle, a richiamare le persone che era l’ora di accendere i lumi». Tre stelle, che splendono nel firmamento a rivelare sia l’inizio che il termine del santo giorno del riposo. E da bambino faceva a gara con suo fratello e sua sorella a chi le scorgeva per primo, per correre ad annunziare ai genitori la fine della festività sabbatica (Meghnagi, 2022, 43). Una celebrazione, quella dello Shabbàt, che resiste nel tempo e al tempo e che rimane un inscalfibile baluardo di passato, di identità presente e di vita futura.
Ma nel dipanarsi della conversazione, sostenuta dai puntuali richiami del rav Di Segni agli scritti sacri, l’orizzonte si estende oltre i basilari aspetti religiosi dello Shabbàt, per declinarsi su problematiche che si presentano quotidianamente. Mi piace ricordare che un rilievo speciale viene dato alla centralità dell’immagine della donna, descritta da Meghnagi attraverso le vicende personali, religiose e scientifiche di alcune straordinarie esponenti della tradizione ebraica. Storie al femminile «in aperta tensione con alcuni degli stereotipi più consolidati sul ruolo della donna» (Meghnagi, 2022, 22). Modelli di un femminile che, gradualmente, ha modificato le sue coordinate, portando a «cambiamenti epocali nel rapporto tra uomo e donna» e che sono «il riflesso psicologico di un’attitudine nuova volta a superare barriere sociali e famigliari che si sono sedimentate nei secoli» (Meghnagi, 2022, 78).
Il lettore che avvicina questo libro si trova a percorrere un itinerario emozionante, di natura etica, filosofica e culturale, dove nessuna tappa è lasciata priva di spiegazione: dalla minuziosa preparazione dello Shabbàt, alle norme che regolamentano le azioni degli uomini durante la giornata, alla sua conclusione, fatta a sua volta di gesti eterni che proiettano al sabato seguente. Una fine che, nelle comunità ebraiche del mondo arabo del Nord Africa, si associa al riso, perché, come chiarisce Meghnagi «allo stesso modo in cui lo Shabbàt è stato accolto con gioia, lo si accompagna alla sua uscita». Ma anche perché «il riso ci ricorda che gli esseri umani non sono angeli e non vivono in cielo» e devono tornare alla vita di ogni giorno (2022, 106).
Molto ancora potrei dire di questo curioso e dotto libro, ma lascio al lettore il piacere di scoprirne il particolarissimo contenuto. Riservo a me, invece, il piacere di chiosare con le parole di Nathan Englander, il romanziere statunitense oggi considerato come uno dei più luminosi eredi della tradizione yiddish, dalla vita divisa tra New York e Israele: «Il giorno ebraico comincia nella calma della sera, quando non sconvolge l’organismo con il suo arrivo. Fu allora, al calare del giorno, tre stelle visibili nel cielo di Manhattan, che Charles Morton Luger capì di essere in possesso di un’anima ebraica» (1999, 121).
Note bibliografiche
COEN D. (2022). Introduzione. In: Coen D. (a cura di), Shabbàt Shalòm. Il rinnovamento dell’umanità – Dialoghi con Riccardo Shmuel Di Segni e David Meghnagi. Roma, Gangemi Editore.
ECO U. (1991). La Bustina di Minerva – Sacrilegio! Si lavora nel week end. L’Espresso, 28 luglio 1991.
ENGLANDER N. (1999). The gilgul of Park Avenue. In: For the relief of unbearable urges. New York, Alfred A. Knopf [Il gilgul di Park Avenue. In: Per alleviare insopportabili impulsi. Milano, Arnoldo Mondadori, 2007].
FOLLI S. (2022). Prefazione. In: Coen D. (a cura di), Shabbàt Shalòm. Il rinnovamento dell’umanità – Dialoghi con Riccardo Shmuel Di Segni e David Meghnagi. Roma, Gangemi Editore.
