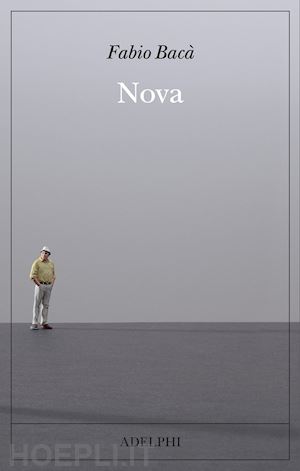
Parole chiave: #violenza, #perturbante, #male, #integrazione
Nova
di Fabio Bacà (Adelphi, 2021)
a cura di Daniela Federici
E qualunque cosa io faccia,
si muterà per sempre in ciò che ho fatto.
Szymborska, Una vita all’istante
La violenza come male che ci riguarda, per l’affronto di una brutalità che ci inchioda vittime, per la smarrente consapevolezza dell’intima e oscura natura del nostro dentro.
In astronomia, una nova è un’esplosione nucleare sulla superficie di un corpo celeste, che designa a un tempo sia la causa del fenomeno che la stella al momento della sua eccezionale luminosità.
Gli accidentali cortocircuiti della ragione che brillano nel romanzo, ben oltre la portata delle intermittenze del cuore proustiane, aprono rivelazioni sfuggenti e prospettive impreviste per il suo protagonista, avviluppando il lettore in un’atmosfera densa e suggestiva.
A cosa pensa un uomo appena si sveglia? Cosa gli recapita la connivenza d’inconscio e realtà? Qual è l’oggetto delle sue prime, confuse meditazioni mentre tenta di recuperare la potestà sul vero? (…) Davide pensa alla morte.
Davide è un neurochirurgo che vive al riparo nella fiducia di maneggiare le sofisticate leggi di funzionamento del cervello e di un quieto sfondo di vita borghese, che l’elegante scrittura di Bacà dipinge a tinte patinate per poi sbrecciarlo con un crescendo sinistro di soprusi, angherie, violenze che destabilizzeranno quel pacifico equilibrio. Le alte siepi dietro cui custodisce la sicurezza della sua famiglia vengono violate da qualcosa di primitivo, da un rumoreggiare intrusivo e disturbante che spande un senso di pericolo e l’ansimo di come proteggersi.
Lo scenario costruito dall’Autore è quello di un quotidiano in cui non ci si può che identificare: un gradasso molesto, un vicino prepotente, un automobilista minaccioso, l’impatto con la propria paralisi impotente.
Davide rimase lì, confuso, percependo la velata minaccia effusa dalle circostanze, ma allo stesso tempo perplesso di fronte a una situazione suscettibile di una mezza dozzina d’interpretazioni, non tutte necessariamente incongrue o spiacevoli. Almeno fino a quando il senso di latente sopraffazione si reificò nel lembo della camicetta di sua moglie afferrato dalla mano di un estraneo, con tutta la sua messe di urticanti simbolismi. A quel punto si pietrificò. Per lunghi attimi si scoprì incapace di muovere un muscolo. Pur di non agire, pur di crogiolarsi in quel subbuglio inerte e penoso, tentò di convincersi di aver sbagliato ristorante, e che quella donna e quel ragazzo non fossero la sua famiglia…
Il rigurgito tormentoso e acidulo della vigliaccheria, la crescente spinta degli istinti contro le convinzioni miti di una vita. Ciò che Bacà raffigura è l’irruzione del perturbante, qualcosa che abita nell’intimo e che sfugge, che spesso terrorizza e che nel protagonista sovverte pian piano l’idea di sé e di ciò che si è disposti a fare per difendere i propri cari e per non soccombere alla paura.
L’enigmatico personaggio che prende le difese della moglie di Davide, si rivelerà un monaco che gli insegnerà come ciò che può esplodere sta in quello che di sé non si conosce e che occorre addomesticare per non venirne dominati. Un incontro che lo avvierà a un percorso riflessivo sulla propria indole profonda al di là dell’inabilità e della ripugnanza per la violenza. Uno sviluppo narrativo in cui questo maestro zen, la moglie logopedista (colei che ha cura delle parole) e convinta pacifista, il figlio che sboccia al turmoil adolescenziale e gli altri personaggi, sembrano diffrazioni di vari punti di vista attraverso cui l’Autore sonda le cosmologie violente.
L’apertura del romanzo su un fatto di cronaca del milanese del 2013 in cui un uomo uccise a picconate tre persone dicendo di sentire delle voci nella testa, è l’occasione per riflettere sull’impatto dell’efferatezza, perché quell’epilogo drammatico fu preceduto da altre 2 aggressioni a mani nude in cui i malcapitati erano scampati senza fare poi nessuna segnalazione alle autorità.
Io credo che la maggior parte delle persone non sia preparata a un evento psichicamente traumatico come un’aggressione brutale. (…) Non è che il cittadino medio sia diventato immune ai contraccolpi psichici di un agguato: è che non riesce a stabilire un collegamento produttivo tra l’impatto razionale e le inferenze emotive che tale impatto innesca. La parola fondamentale, qui, è “produttivo”. Il problema è che abbiamo perso contatto con qualcosa di essenziale dentro di noi.
Amati Sas (“L’Ovvio, l’Abitudine e il Pensiero”, Setting 1996, 1, p. 101-107) sottolinea come l’ovvio sia pertinente a quello sfondo psichico di sicurezza che viene attribuito al contesto esterno e concreto della realtà psichica. Viviamo la nostra esistenza dando per scontato di condividere con gli altri regole e convenzioni, in una sufficiente attendibilità e prevedibilità del mondo che ci circonda; così la famiglia, le leggi, lo Stato o altri garanti della cornice entro cui ci sentiamo contenuti, si danno come depositari inconsci delle nostre angosce primitive. Per Bleger, eventi traumatici che comportano una rottura di questo patto inconscio, possono avere un effetto psicotizzante e produrre una difesa regressiva, il ritorno a una posizione ambigua pre-conflittuale e conformistica, dove l’individuo perde le capacità critiche e le funzioni di segnale sulla realtà. Nel tentativo di adattarsi a condizioni di minaccia e disaiuto, l’individuo punterà a banalizzare e rendere familiare un inaccettabile non più pensabile come tale nella sua reale portata emotiva: una sorta di ‘le cose stanno così’ rassegnato e inerme.
La nostra abituazione alla crescente violenza che ci circonda, è in rapporto con questo adeguamento regressivo. Come nel principio della rana che finisce bollita.
L’isolamento dell’individuo contemporaneo in una generale perdita di certezze e di coesione comunitaria, fra i toni da allarme sociale di una politica che esacerba la paura, ci fanno vivere in un’inquietudine diffusa nell’angoscia di franare in uno stato di inciviltà.
La paura dei barbari è ciò che rischia di renderci barbari, scrive Todorov (Garzanti, 2009), nella secolare lotta fra risentiti e terrorizzati che proietta sull’altro gli aspetti sgradevoli dell’umana cattiveria o di labilità psichica, rivendicando la propria innocenza.
Dice Davide alla moglie (Barbara, appunto): Puoi immaginare qualcosa di più stupido che credere che il mondo non ti tocchi solo perché ti rifiuti di ammettere che possa? Solo perché fai ogni sforzo per essere un bravo padre e un bravo marito? Solo perché ti impegni a essere dolce e comprensivo con tutti? Sai bene che ho sempre considerato indecente il paragone tra il cervello, l’incantevole strumento che fa di noi quello che siamo, e la sbrigatività volgare della violenza. Ma ora ho capito che non esiste tempo più sprecato di quello passato a stupirsi dell’aggressività altrui. L’unico modo di inceppare il meccanismo banale e ripetitivo della follia umana è accettare quello che siamo… e io avevo semplicemente paura di essere ciò che sono.
‘La violenza ci riguarda’, faceva dire Yasmina Reza a una protagonista della sua pièce teatrale “Il dio del massacro” (Adelphi, 2011), trasposta poi nel film Carnage diretto da Polanski, una delle più spietate e riuscite rappresentazioni di ciò che può albergare sotto le maschere della buona creanza e delle benevole virtù morali di due ‘buone famiglie’, che squarcia con soave crudeltà i veli destinati a ricoprire la costitutiva barbarie della creatura umana.
Freud fa della “componente egoistica e malvagia della natura umana” (1915-17, p. 318) un dato strutturale e riconosce all’odio un movimento di costituzione della realtà; la possibilità civilizzatrice sta nel legame, nell’impasto delle pulsioni: “i buoni si accontentano di sognare ciò che gli altri, i cattivi, fanno realmente”.
La scaturigine del male è nel distruggere, nella violenza che liquida velocemente il conflitto nel puro scarico delle tensioni, nel non riconoscere e rendere disanimata la soggettualità dell’altro, così che la proiezione sul nemico o la sua alterità radicale vengono impiegate come ragioni per giustificare la crudeltà.
Il diavolo (diàbolos), che dal punto di vista etimologico rimanda al disunire, è ciò che impedisce il simbolo (symballo), ciò che unisce.
Solo l’assunzione del conflitto e il riconoscimento della propria parte consente di uscire dal registro del dominio e distinguere senza polarizzare, così che una lenta elaborazione possa sanare i torti fuori dalle logiche falsificanti delle difese scissionali.
Hannah Arendt parlava della necessità di un pensiero senza balaustra, che non si acquieta sul già conosciuto ma apre ai dubbi, che impara e com-prende per poter superare.
La frase che Davide impiega nel confronto con chi gli ha fatto misurare i limiti del proprio coraggio (Uomini che hanno un rapporto talmente disinvolto con la parte peggiore di se stessi da lasciare a bocca aperta…), è la stessa con cui il vicino dai modi mafiosi aveva ventilato la sua minaccia.
L’apprendimento passa sempre dall’imitazione prima di far propria un’eredità, salto quantico di lutti e trasformazioni.
Il finale del romanzo rimane in bilico su come Davide risolverà il suo koan, cosa sceglierà di essere una volta tolto l’epitelio della civiltà fino a esporre il sembiante scorticato del suo vero io.
Certo ha appreso che le cose non sono sempre come appaiono e che il crinale fra innocenti e colpevoli, fra vittime e carnefici, può essere molto sottile e rovesciarsi facilmente.
Non a caso pharmakon è a un tempo veleno e antidoto, male e rimedio.
L’elaborazione immaginifica che contiene le angosce dando forma e significato rappresentativo è ancora più fondamentale su temi tendenzialmente evacuativi come quello della violenza, e questo romanzo di Bacà è pieno di godibili suggestioni per il pensiero.
