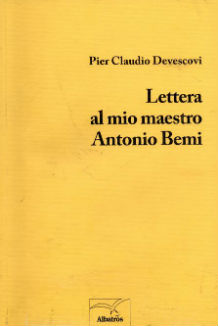
Pier Claudio Devescovi (2016)
Lettera al mio maestro Antonio Bemi
Edizioni Albatros, Roma, pp. 85
Da bambina il venerdì era per me un giorno di festa. Al suono del campanello che sanciva la fine della mattinata scolastica mi precipitavo fuori dall’aula, dove trovavo ad attendermi il nonno. «Ciao picia» – mi chiamava “la mia picia” (“la mia piccola”). Accoglieva la mia manina nel suo sconfinato palmo (era un pezzo d’uomo, il mio nonno) e così, con passo lesto, ci avviavamo da nonna, che stava preparando il pranzo. Il venerdì nonna cucinava il pesce e per me era una pacchia. Da sola con i nonni. Senza il mio fratellino tra i piedi, che se ne restava a casa con mamma. Il pesce era cibo per “grandi” e non per mocciosetti capricciosi. Il piatto che preferivo era saporitissimo, ma assolutamente invernale: polenta con il baccalà. All’istriana. Ho poi scoperto che era assai complesso ed elaborato da preparare. Mia nonna era una maestra nel realizzarlo e – qui lo confesso – mia madre non è mai stata all’altezza nel riproporlo e io… non c’ho neanche provato. Sarebbe stato come profanare una sacra memoria! All’istriana – dicevo – perché i miei nonni materni provenivano da quella meravigliosa e tanto tribolata terra che è la penisola istriana. Dopo l’occupazione jugoslava da parte delle truppe di Tito (maggio 1945), avevano scelto l’esilio, sentendosi “italiani” (in realtà il loro era un sangue meticcio, il tipico sangue di quelle genti che per secoli avevano miscelato pacificamente razze e religioni). L’esilio piuttosto che rinnegare le loro radici. Oggigiorno questo è un discorso assai sdrucciolevole. Lo è sempre stato, a dire il vero. Ma, come spiega Devescovi, «(…) in quegli anni le persone ragionavano spesso per schemi: se vieni via da un paese comunista, sei fascista! Non veniva presa in considerazione la possibilità che una persona potesse sentirsi italiana e desiderare di vivere in Italia senza per questo essere fascista» (2016, p. 37).
Il libro di Devescovi, noto collega junghiano con una storia familiare affine a quella della mia linea materna, non è affatto un libro politico. Ne sono usciti a bizzeffe da quando è cominciato lo sdoganamento della “questione istriana”. Negli ultimi anni si sono susseguite iniziative non solo editoriali, ma anche cinematografiche, teatrali e musicali, che hanno rievocato quel momento storico tormentato, offrendone diverse chiavi di lettura, spesso pesantemente ideologiche.
Il racconto di Devescovi, invece, è un tenero percorso della memoria. Per me è stato uno struggente ritorno nella cucina dei miei nonni. Il risentirmi avvolta dal profumo intenso del cibo della mia infanzia. L’avvertire ancora una volta le voci amatissime di quand’ero bambina. «Picia mia»…
Un mondo antico, come appare lontanissima l’epoca dipinta con poetica sapienza da Pier Claudio Devescovi. Immaginando di scrivere una lettera al proprio maestro delle elementari, l’autore ripercorre le tappe più significative della sua crescita, del suo divenire uomo in una società dapprima sconvolta dalla fine della guerra e successivamente distante dalle tradizioni dei suoi avi. Dopo la guerra, l’esodo. Il dover ridisegnare una mappa identitaria, il cercare nuove coordinate relazionali e affettive entro cui collocarsi. Viene qui riproposto l’antico e sempre attualissimo tema del migrare. Del riscrivere la propria storia, abbandonando le origini per approdare su nuovi lidi. Perdere↔modificare↔integrare: la dialettica ineludibile del migrare e, forse, dello stesso vivere sociale.
La generazione che porta il carico traumatico del radicale cambiamento non ha voce per parlare. Il racconto spetterà alle generazioni successive – come ci insegna la Faimberg – che si troveranno a rinnovare la “condensazione” di una storia che, almeno in parte, non appartiene alla generazione del narratore.
In quest’opera di rimembranza, Devescovi si fa accompagnare dal suo vate dell’infanzia, il maestro Bemi, una figura concretissima ed insieme leggendaria. Un faro, un modello, un generoso maieuta per lo spaesato fanciullo nato a Lucca, ma figlio di profughi.
La rievocazione si muove su un doppio registro, i cui piani s’intrecciano costantemente: quello dei ricordi personali della scuola e della lucchesia degli anni Cinquanta e quello di una memoria collettiva difficile, spesso storicamente negata o accantonata per il suo carattere scomodo. Nel 1946 i genitori di Devescovi erano giunti in Toscana dopo un viaggio duro: erano stati costretti a lasciare il paese natale, Rovigno, ormai divenuto irrimediabilmente territorio jugoslavo, insieme al resto dell’Istria. Sotto il peso della sconfitta, la posizione degli italiani non disposti a rinunciare alla propria identità era divenuta insostenibile. Di questo dramma l’autore ha tratto una velata consapevolezza attraverso le narrazioni e le abitudini del lessico familiare, e anche grazie alle consuetudini alimentari – la jota, le pinse, le titole, i mussoli – tanto insolite da quelle della provincia toscana. E grazie al dialetto istriano, l’unica lingua parlata dalla nonna Lucia, che faceva parte del nucleo familiare. Sono pagine spassose ed ironiche quelle dedicate all’anziana donna. E colme d’amore per l’ultima, pura “portavoce” delle tradizioni natali. Agli altri, invece, è toccata la fatica, ma anche la ricchezza della «doppia appartenenza», emblematicamente rappresentata dall’autore in un sogno sognato durante la sua analisi personale (p. 25).
Queste differenze talvolta sono state motivo d’imbarazzo e di vergogna per il bambino Pier Claudio che, nel suo intimo, si sentiva comunque ben inserito nella realtà d’adozione: «abitavo a [Lucca, nel quartiere di ] S. Vito, nelle case popolari di viale Sardegna, dove ero nato al n. 14» (p. 22). A S. Vito vivevano molte altre famiglie di profughi istriani, fiumani e delle isole di Cherso, Lussino e Veglia: «con alcune di queste famiglie eravamo diventati amici, come se fossero diventati degli zii». Ma anche i lucchesi di S. Vito li avevano ben accolti, «normalmente», come se fossero sempre stati lì: «a volte, incuriositi dalle abitudini alimentari, chiedevano le ricette» (p. 34).
A scuola, poi, i fanciulli «facevano gruppo», guidati dall’epica figura del maestro Bemi, che con la sua rettitudine leale, la sua paterna ed empatica autorevolezza quasi incarnava l’onore e il riscatto di un’Italia ideale, non compromessa dagli orrori del passato conflitto e pronta alla rinascita.
La scrittura di Devescovi è leggera e toccante. Ne scaturisce un racconto di formazione tenero, lucido e non privo d’ironia. È un libro raro, originale e gustoso (come i piatti della mia nonna), che si legge tutto d’un fiato. Raro specialmente perché uscito dalla penna di uno psicoanalista, che ci offre un’esemplare istantanea della propria vicenda personale avviluppata a momenti dolorosi della Storia del nostro Paese. Ma è pure la storia di un fanciullo che è diventato un uomo tenero, lucido e capace di fine ironia. Grazie anche al suo maestro, Antonio Bemi.
Recensione di Rita Corsa
Agosto 2016
CdPR – Una buona scuola per una buona crescita Ciclo di seminari 2020-2021
