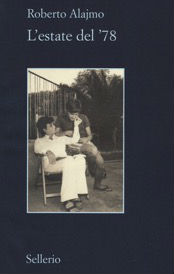
L’estate del ‘78
Di Roberto Alajmo, Sellerio, 2018
Recensione di Daniela Federici
“Tentare di ricostruire quello che,
al di qua del linguaggio,
nel rimaneggiare interno,
può ancora essere comunicato ad altri.”
G.-A.Goldschmidt
Ogni scrittore fa della propria vita una materia letteraria, ma l’impianto narrativo di questo libro è particolare.
Nell’estate del ’78 Roberto Alajmo sta preparando l’esame di maturità con alcuni compagni; nel tardo pomeriggio escono a prendersi un gelato e poco fuori dalla loro casa di Mondello, trova la madre seduta sul marciapiede. Il gesto della sua mano che si ripara dal sole, le poche parole scambiate nell’imbarazzo di una situazione insolita fino alla sconvenienza, un tempo che vuole solo spensierarsi dei tormenti e dei guasti degli adulti. Sarà il loro ultimo incontro.
“Roberto capirà.”
Come si porta questo lascito? Come si diventa scrittori sullo sfondo di un disagio domestico che ha segnato gli anni del crescere fendendoli di quell’ultimo atto con le sue domande inevase?
Un memoir non ha gli oneri dell’esattezza storica, è un viaggio in cui si è trasportati dalle onde della memoria emotiva, un andirivieni nel tempo interiore che intreccia l’indagine con i ricordi, passato e presente guardati alla luce dei significati del proprio sentire.
Matrem nudam.
Quanta distanza occorre per avvicinare l’incandescenza dell’innominabile? Per far entrare i lettori fra le foto di famiglia, nell’intimo racconto di sé e di Elena, sua madre: “il ritratto di una donna che voleva afferrare il mondo, e il mondo le scappava dalle dita.”
Raccoglie le lettere fra i giovani innamorati nel periodo di leva del padre: “viene fuori il ritratto di un amore dal quale fa un bell’effetto essere stati concepiti.”
“I sintomi dei problemi devo andarli a smorfiare nella memoria infantile. Sono porte chiuse di giorno e sbattute in piena notte, voci alterate che provengono dalla camera. A noi ragazzi conviene rimanere a letto, però fino a un certo punto si può far finta di niente, poi no. Poi no: è una mattina in cui Elena ha i polsi fasciati, e anche per il bambino che sono, disperatamente in cerca di non sapere nulla, è un segnale troppo chiaro.”
Per sedare i mal di testa molte donne negli anni ’70 fanno largo uso dello Spasmo Oberon, un barbiturico che induce una forte dipendenza e che spesso si riscontra nei suicidi. Sarà ritirato dal mercato con un decreto ministeriale del luglio 1986.
“I disturbi psichici vengono mantenuti spesso sottotraccia… una di quelle malattie di cui vergognarsi… socialmente impresentabile.” Disagio psichico e dipendenza si imbricano; nelle cartelle cliniche si parla di grave farmaco-dipendenza, psiconevrosi, depressione ansiosa. Nei ripetuti ricoveri la terapia di disintossicazione comprende sedute di elettroshock: “lasciare che l’elettricità attraversi il corpo del paziente è una specie di lancio di dadi, l’equivalente del calcio alla lavastoviglie che ha smesso di funzionare. Può andare bene ma esiste anche la possibilità che finisca di sfasciarsi del tutto.”
Nei giorni del ritorno a casa scruta il suo claudicare, la luce spenta negli occhi, la transitoria ripresa che presto lascia spazio alla “ritrovata sciatteria” e al blister che galleggia tenace nel water.
“Privato dolore, pubblico silenzio.”
Il clima di quegli anni è raccontato dall’Autore con un affresco miniato di paure, vergogna, fastidio, ostilità, un lento piano inclinato verso il distacco.
“È difficile stabilire il momento in cui si prende commiato da una persona…”.
Il divorzio arriva dopo qualche anno, a far vita ciascuno per sé, una facciata per il mondo che guarda e per i figli, che vengono affidati al padre: “contro ogni consuetudine giurisprudenziale. Dolore e sollievo si mescolano. … A venire sottratto è l’elemento perturbante, che accetta di levarsi di torno. In fondo da parte di Elena è un’ammissione di colpa.”
L’insegnante amata e talentuosa che aveva portato l’anticonformismo della dottrina di Don Milani nella scuola dei quartieri popolari di Palermo, è ormai un’anima sabotata dal farmaco, che si assenta all’improvviso dalla classe in cerca di pace chimica. E lontana da casa, viene a mancare anche la spinta alla disintossicazione: “non vuole essere salvata dall’annegamento”.
Aulagnier scriveva che pur credendo di trarre ispirazione dalle lezioni della clinica “non facciamo altro che riprendere, sotto altre forme, le questioni fondamentali proprie di ogni analista”.
E uno scrittore come elabora le sue questioni profonde? Trame e personaggi svolgono una funzione traumatolitica che trasforma gli scenari o si incidono come la conta dei giorni sui muri delle nostre prigioni interiori, nell’ostinato anelare a dar forma a ciò che si ripete o a ciò che non è stato?
Quando l’Autore raggiunge l’età in cui è morta la madre, consulta le carte dell’indagine in cerca di qualcosa “che getti una luce diversa sulla ricostruzione dei fatti… qualche elemento che consenta un’archiviazione personale.”
Lo sguardo sulle foto del corpo della madre nella stanza invasa dal disordine, la sua associazione con I miei luoghi oscuri: “la sua morte aveva corrotto la mia immaginazione”, scriveva Ellroy. Ma il racconto di Alajmo non ha la morbosità torbida dello scrittore americano, casomai risuona dell’ossessione di sondare i moventi, di comprendere come fosse arrivata a quella distruzione. Gli è insopportabile il pensiero di un’overdose accidentale rispetto all’orgoglio di essere protagonista: “alla convinzione che di suicidio si sia trattato mi aggrappo come all’unico oggetto galleggiante nel naufragio generale, trasformando il dolore in fierezza.” Pavese era la loro comune passione letteraria, e Alajmo narra che per diversi anni dell’ardore giovanile proclamava l’intenzione di porre fine alla sua vita in una data precisa, un modo per scandalizzare e rivendicare il diritto di decidere, un’ostentazione che suppura come una piaga. Ma allo scadere di quei giorni gli nasce il figlio e la morte con cui flirtava diventa una prospettiva terrificante, da non considerare più, almeno “fino a quando la morte di un genitore non costituirà per lui il trauma che è stato per me.”
Un libro che mette in parole la catena che ci costituisce tutti. “A proposito di consapevolezza. A proposito di genitori e figli. A proposito di almeno voglio sapere cosa gli è successo. A proposito del desiderio di protrarre la memoria di sé” lo scrittore ricorda che nel resoconto del grande naufragio del 3 ottobre 2013 al largo di Lampedusa, fra i molti sul punto di annegare, le urla ripetevano nome e paese di provenienza. Nel momento estremo il loro pensiero andava alla famiglia e al doloroso travaglio di chi non sa se piangere un figlio morto. Riconoscimento e testimonianza che si inanellano: “ricordatevi che sono esistito, raccontate la mia storia a chi rimane.”
Un libro sull’essere figli e padri, che riapre un dolore incistato e si prende cura del guado.
“Esiste una cosa chiamata mai più.” Un libro onesto sul passaggio di testimone.
“Alla fine di questo raccontare non so se in me è avvenuta la catarsi su cui confidavo. Magari no. Magari prevarrà in me la disposizione all’inquietudine, e sputare il rospo sarà servito solo a mettere ogni cosa nero su bianco. Nel qual caso si vede che certi caratteri identitari non si cambiano a forza di scrivere libri.”
Scardinare zone addensate e lavorarle, fatiche che ci riconsegnano un’esperienza più complessa, perché dove c’è troppo dolore il pensiero fa naufragio. Se ogni scrittura è un tentativo di dar forma all’impensabile e avvicinarsi a se stessi, questa di Alajmo sembra la sua opera più necessaria e personale, “la ricerca di un senso per il commiato”. E forse non solo.
“Era necessario che mia madre diventasse storia perché io mi sentissi meno sola.” (A. Ernaux, Una donna)
