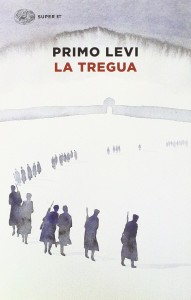
Primo Levi (1963)
La tregua
Einaudi
La Tregua. Uno sguardo sui bambini di Auschwitz.
“Dopo Auschwitz, nessuna poesia, nessuna forma d’arte, nessuna affermazione creatrice è più possibile” – così nel 1966 Theodor Adorno esprimeva la sua posizione radicale, ponendo la questione del significato metafisico e teologico dell’esperienza concentrazionaria. Scrivere poesie diventa un atto di barbarie (Adorno, 1949), l’arte che prima non è bastata a prevenire il male non ha, dopo Auschwitz, il diritto di rappresentarlo. L’indicibilità del male, e l’impossibilità della ricerca di senso, costituiscono tematiche filosofiche di grande portata che tuttavia hanno contribuito ad allontanare dalla coscienza l’esperienza concreta di Auschwitz e con essa la possibilità di osservare più da vicino quanto era accaduto.
Primo Levi ha impiegato la sua intera esistenza a descrivere il luogo al quale era sopravvissuto, e lo ha fatto partendo da una narrazione minuta di quali erano le regole, le eccezioni, le gerarchie, i rapporti di forza, le comunicazioni, i legami sociali che si attivavano nel Lager. Ma soprattutto ha osservato e descritto le persone al suo interno e lo ha fatto con l’assetto di chi aveva lavorato nei laboratori di chimica, vale a dire non con freddezza e distacco, ma con il metodo e la curiosità del ricercatore pronto a smontare e rimontare ipotesi, di chi ha la consuetudine all’esercizio del dubbio. Era un osservatore acuto e aveva conservato la capacità di stupirsi e di riconoscere quando gli elementi si combinavano in modi sorprendenti e i reagenti generavano prodotti inaspettati.
Nell’opera di Levi sono presenti temi che sono al centro della elaborazione psicoanalitica: il trauma e il rapporto che il soggetto intrattiene con gli eventi traumatici nel corso della sua esistenza, le risorse che taluni mobilitano in situazioni estreme, i segni indelebili dell’umiliazione, il sentimento incancellabile della vergogna, la funzione svolta dall’altro, testimone e depositario di elementi non elaborabili. Questi sono solo alcuni dei temi psicoanalitici che ricorrono nella poetica di Primo Levi e che prendono forma in un racconto che si mantiene aderente all’aspetto materiale, concreto, tangibile dei campi di concentramento.
Anche il suo destino di scrittore è stato segnato dall’esperienza concentrazionaria, la portata degli eventi di cui è stato vittima e testimone ha spesso oscurato i suoi meriti letterari. Credo che riproporre, in occasione della Giornata della Memoria, la lettura di un brano de La Tregua, sia importante non solo per riuscire a continuare a indagare e tentare di comprendere la Shoah come prodotto dell’uomo, ma anche per sottolineare la portata letteraria e psicoanalitica di uno dei più grandi autori del Novecento.
Nel Lager la lotta per rimanere vivi si dispiega incessantemente nel tentare di essere assegnato a un lavoro meno pesante, nello scegliere nella fila un posto dove poter ricevere una razione più densa di minestra, nel cercare di restare vigili giorno e notte per conservare oggetti indispensabili come il cucchiaio o le scarpe. Una dura lezione che Levi apprende da Mordo Nahum “il greco”, nel corso del lungo viaggio raccontato ne La Tregua, è che le scarpe sono più importanti persino del cibo “perché chi ha le scarpe può andare in giro a trovar da mangiare, mentre non vale l’inverso”. E subito dopo, quando Primo obietta “ma la guerra è finita”, Mordo gli risponde: “guerra è sempre”. In questa breve proposizione c’è tutta la profondità di questo autore, per il quale l’elaborazione di temi universali avviene a partire dal concreto, dal corpo.
Fra le tante storie che Levi ha raccontato in questo libro ci sono quelle dei bambini, il più piccolo dei quali è Hurbinek, la cui morte avvenne i primi di marzo del ‘45, a circa due mesi dall’arrivo delle prime truppe dell’Armata Rossa:
Hurbinek era un nulla, un figlio della morte, un figlio di Auschwitz. Dimostrava tre anni circa… non sapeva parlare… Era paralizzato dalle reni in giù, ed aveva le gambe atrofiche, sottili come stecchi; ma i suoi occhi, persi nel viso triangolare e smunto saettavano terribilmente vivi, pieni di richiesta, di asserzione, della volontà di rompere la tomba del mutismo. …era uno sguardo selvaggio e umano ad un tempo, anzi maturo e giudice, che nessuno fra noi sapeva sostenere, tanto era carico di forza e di pena.
Nessuno, salvo Henek, un robusto e florido ragazzo ungherese di quindici anni. Henek passava accanto alla cuccia di Hurbinek metà delle sue giornate. …sedeva accanto alla piccola sfinge, immune alla potenza triste che ne emanava; gli portava da mangiare, gli rassettava le coperte, lo ripuliva con mani abili, prive di ripugnanza; e gli parlava, naturalmente in ungherese, con voce lenta e paziente. Dopo una settimana, Henek annunciò con serietà, ma senza ombra di presunzione, che Hurbinek “diceva una parola”.
(Primo Levi, La Tregua, in Opere I, Torino, Einaudi, 1997, NUE, vol 225*, pp. 215-6)
Pensare all’esistenza di Hurbinek significa evocare il fantasma della madre, la gravidanza e il parto nel Lager e il Lager come madre-ambiente che non permette la vita psichica né corporea. Ma significa anche vedere la straordinaria vitalità di questo “figlio della morte”, che ha lottato per entrare in comunicazione con il mondo e che ha tenacemente atteso per tre anni di incontrare un essere umano che potesse sostenere la sofferenza del suo sguardo. Hurbinek è il trauma primario, ma anche la lotta per la vita. Non solo il depositario dell’immaturità e della debolezza psico-fisica, ma altresì delle potenzialità sane di sviluppo; tenterà fino all’ultimo di aprirsi una strada per uscire dal sistema chiuso nel quale la mostruosità dell’uomo lo ha costretto.
Le poche pagine dedicate da Levi alla relazione fra questi due bambini aprono a mio avviso molte finestre alla comprensione sia di cosa renda possibile la sopravvivenza in un ambiente originariamente e ripetutamente traumatico, sia dell’assetto interno di chi si prende cura. Henek viene descritto da Levi come un buon compagno, pieno di risorse, capace di sorprenderlo. Ad Auschwitz viene uccisa la sua famiglia. Mente alle S.S. dicendo di avere 18 anni per essere spostato come muratore a Birkenau, una volta arrivato insiste sulla sua vera età, riesce quindi a diventare Kapo del Block dei bambini, è lui a fare le selezioni (“Non provava rimorso? No: perché avrebbe dovuto? Esisteva forse un altro modo per sopravvivere?”). La sua lotta non si arresta neppure davanti all’uccisione della famiglia o alle innumerevoli morti che avvengono accanto a lui; se necessario, è lui a selezionare chi dovrà morire, cerca una collocazione che gli consenta di sopravvivere, è tutto teso verso questo obiettivo, governato da una feroce determinazione biologica che travalica il soggetto per radicarsi nella specie. In questo percorso straordinariamente non si disumanizza (o forse sarebbe più corretto dire che conserva una disponibilità emotiva verso l’altro), è capace di stare accanto a Hurbinek (forse intuendo la propria stessa tenacia nello sguardo mobile e vivo di quel bambino in lotta?) con ostinazione e pazienza; e dopo una settimana di accudimento “materno” Hurbinek dice una parola. Henek comunica questo dato “senza ombra di presunzione”, è semplicemente quello che è avvenuto e che sarebbe potuto non avvenire.
Secondo Richard Glazar, superstite di Treblinka, ciò che permetteva la sopravvivenza nel Lager non era la spietatezza, ma una qualità indefinibile, “una specie di inestinguibile sete di vita, una sorta di talento per la vita…” (Gitta Sereny, In quelle tenebre, Milano, Adelphi, 1974, pp. 246-7).
Henek è un bambino che nel Lager mantiene in vita il legame con l’altro e per questo riesce a sopravvivere, anche psichicamente. E’ evidente che, in condizioni estreme, la disponibilità emotiva è una risorsa da amministrare con economia, non si declina a tutto tondo verso l’umanità: ha oggetti e volti specifici. Nel Lager esiste l’altro ignoto e l’altro prossimo, l’estraneo che si guarda, o si seleziona per andare alla camera a gas, e l’altro per il quale si è disposti a correre dei rischi.
Poche pagine dopo Levi ci parla di un altro bambino.
La sua sagoma era patetica e sgradevole… non aveva che dodici anni. Tutto era irregolare in lui. Era cresciuto troppo e male: dal busto tozzo e corto sporgevano braccia e gambe lunghissime, da ragno (…) Nessuno lo amava, salvo il suo protettore. All’ombra dell’autorità, ben nutrito e vestito, esente dal lavoro, aveva condotto fino all’ultimo giorno un’esistenza ambigua e frivola di favorito, intessuta di pettegolezzi, di delazioni e di affetti distorti (…) provavamo verso di lui diffidenza e una pietà ostile (…) Tacque per due giorni: se ne stava in cuccetta tutto raggomitolato, con lo sguardo fisso nel vuoto e i pugni serrati sul petto. Poi prese ad un tratto a parlare, e rimpiangemmo il suo silenzio. Il Kleine Kiepura parlava da solo, come in sogno: e il suo sogno era di avere fatto carriera, di essere diventato un Kapo. Non si capiva se fosse follia o un gioco puerile e sinistro: senza tregua, dall’alto della sua cuccetta vicino al soffitto, il ragazzo cantava e fischiava le marce di Buna, i ritmi brutali che scandivano i nostri passi stanchi ogni mattina e ogni sera, e vociferava in tedesco imperiosi comandi ad uno stuolo di schiavi inesistenti.
– Alzarsi, porci avete capito? Rifare i letti, ma presto: pulirsi le scarpe. Tutti adunata, controllo dei pidocchi, controllo dei piedi. Mostrare i piedi, carogne! Di nuovo sporco, tu sacco di m…: fai attenzione, io non scherzo. Ancora una volta che ti pesco, e te ne vai in crematorio – . Poi, urlando alla maniera dei militari tedeschi: – In fila, coperti, allineati. Giù il colletto: al passo, seguire la musica. Le mani sulla cucitura dei pantaloni –. E poi ancora, dopo una pausa, con voce arrogante e stridula: – Questo non è un sanatorio. Questo è un Lager tedesco, si chiama Auschwitz, e non se ne esce che per il Camino. Se ti piace è così: se non ti piace, non hai che da andare a toccare il filo elettrico.
Il Kleine Kiepura sparì dopo pochi giorni, con sollievo di tutti. In mezzo a noi, deboli e malati, ma pieni della letizia timida e trepida della libertà ritrovata, la sua presenza offendeva come quella di un cadavere, e la compassione che egli suscitava in noi era commista ad orrore. Tentammo invano di strapparlo al suo delirio: l’infezione del Lager aveva fatto in lui troppa strada. (Primo Levi, La Tregua, Opere I, Torino, Einaudi, 1997, NUE, vol 225* pp.119-120)
Sappiamo che la depersonalizzazione, la metamorfosi operata nel Lager era necessaria per allontanare dai carnefici la consapevolezza di trovarsi di fronte ad esseri umani: via il nome, via gli abiti, via i capelli, via la dignità, via ogni traccia di ciò che l’individuo era stato prima di entrare nel campo. Le sistematiche umiliazioni e la crudeltà cui erano sottoposti i detenuti erano ingredienti indispensabili agli esecutori per fare il loro lavoro, come diceva Eicke: “Nei ranghi delle S.S. non c’è posto per le ‘pappe molli’, sarebbe un imperdonabile errore di cui i nemici dello Stato si approfitterebbero immediatamente”.
Dell’umiliazione il bambino Kiepura, dall’aspetto tanto sgraziato e irregolare, doveva aver fatto ripetuta esperienza molto prima di fare ingresso al Lager. Era cresciuto in un’epoca in cui autobus di pazienti venivano portati nottetempo agli ospedali e ai manicomi, un’epoca in cui la Germania, inseguendo l’ideale della purezza razziale, metteva in atto sistematiche campagne propagandistiche contro i malati, dove non c’era spazio per le cosiddette persone inferiori o i minorati.
Anche lui aveva fatto di tutto per sopravvivere, ma, a differenza di Henek, per farlo aveva venduto la sua anima al diavolo. Kiepura prende a calci i porci, le carogne che rappresentano la sua parte deforme, ebrea; si identifica con chi porta l’uniforme pulita, al prezzo di non guardarsi mai allo specchio, di perdere la propria identità. In fondo se i suoi capi lo proteggevano e lo trattavano con tanto riguardo forse non era davvero mostruoso, forse avrebbe potuto un giorno essere come loro. Il crollo del sistema di potere lo conduce al mutismo e al delirio. La sua vita è legata a un oggetto che lo ha reso prigioniero, al quale è totalmente asservito, che lo manipola spietatamente per i propri fini, ma senza il quale non può sopravvivere.
Alessandra Balloni
Febbraio 2016
