
Parole chiave: #madri, #figlie, #comunicazione
La casa delle orfane bianche
di Fiammetta Palpati (Laurana Ed. 2024)
Recensione di Daniela Federici
Poi, d’improvviso, il mio mondo fu grigio
e la tenebra cancellò la gioia.
Solo un vuoto opaco e accorato rimase
dove mani sbadate avevano toccato
distrutto
il mio nido argentato di felicità.
Smarrite si fermarono le mani,
poiché mi amavano, piansero nel vedere
le rovine del mio firmamento.
S. Plath, Lettere
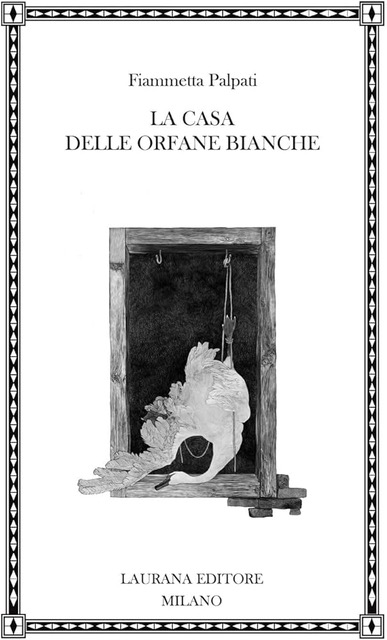
Un romanzo d’esordio acuto e intrigante, una prosa raffinata e una strutturazione visiva come una pièce teatrale. È la storia di tre amiche attempate che si riuniscono a casa di una di loro con le rispettive madri; l’idea è di spartirsi la gestione delle anziane, confidando che questo permetterà migliori opportunità di aiuto e più libertà a ciascuna. Un sodalizio. Un gioco.
Elettriche. Trillavano come cince. Quell’euforia che può scambiarsi per felicità.
Il desiderio è solo uno, e di tutte: un nido caldo, pulito, dove l’ordine tenga lontano il male. Il desiderio di una casa felice.
Bramano quel che non hanno mai avuto. Perché dietro quell’atmosfera di attese e promesse, si svela tagliente la realtà dell’incontro infelice con madri mancanti e disturbate.
… ancora cerco l’amore incondizionato.
Quelle figlie che accudiscono e si divincolano, fra rancori e sensi di colpa, sono un’efficace rappresentazione di ciò che può albergare dietro il rassicurante stereotipo delle madri buone e dell’amore filiale: il tumulto di sofferenze patite e inflitte, di rabbia, impotenza, disperazione, delle cicatrici che lascia, degli inevasi cui condanna.
Anche il male è una relazione, come il bene; e nella relazione che lo riconosce, lo nomina, lo ricorda, può esserci la sua cancellazione. Chiedere perdono è, dunque, volersi incontrare per riconoscere il male – riconoscimento, non pentimento. Ma questo male qui, senza colpa, chi lo riconosce? Chi se lo prende sulle spalle? Chi gli dà un nome? Si può dimenticare ciò che non ha un nome?
In quell’abitazione paesana nella campagna umbra, in cui si dispensano cure che si sarebbero volute ricevere e si cerca di riparare i danni, va in scena la ripetizione del familiare profondo delle protagoniste, fra negazioni e nascondimenti. Un racconto intessuto con grazia e intelligenza sul mestiere più difficile del mondo, sulle tristi pene della vecchiezza, sulle angosce e sulle difese amputanti erette a partire da relazioni disfunzionali.
Inibire il desiderio. Soffocare le urgenze. Bloccare le reazioni. Dimenticare lo ieri. Misconoscere il domani – ne va della sopravvivenza. Mantenersi ebbri e inspessire la scorza. Occorre pratica, disciplina. Il corpo è l’unico possedimento. Deve trasformarsi in casa. Cementare.
La sofferenza porta a predisporsi al negativo e insegna il far da sé senza aspettarsi nulla, bloccando la possibilità di ricevere altro, perché l’esperienza positiva può essere respinta per non cedere a un’illusione dolorosa, o lasciare, come scrive l’Autrice, in uno stato di prostrazione rancorosa – rabbia mite, piacere sospettoso. Comunque addomesticata. Regredita, larvale.
Dai paesaggi descritti con finezza a specchio dei climi emotivi, ai personaggi che intrecciano la quotidianità delle protagoniste, tutto nel romanzo risuona della messa a confronto fra madri e figlie. Dalla cagnetta Laica, creatura storta e nevroticamente in cerca d’amore, alla damigiana – otre feticcio con un fondo melmoso di aceto madre -, dai pulcini a una piantina di dittamo, tutto è affidato in equilibrio precario alla capacità maldestra delle donne di accudire e far crescere.
Magari si potesse essere tristi, insieme, della nostra miseria. Magari un giorno mi potesse dire: sono triste della mia, della tua vita. Piangere davvero. Perdonarsi.
«Ma tu cosa vorresti da tua madre?»
Germana posa il bicchiere. Il palmo, il dorso – sulle labbra bagnate. Sulle guance. È accaldata.
«Essere sua figlia, per una volta. Prima che muoia.» Rimane assorta. Sorride.
«E tu dalla tua?»
«Vorrei che fosse madre, per una volta. Prima che muoio.»
Anche il vicinato, che schiude le persiane sulla piazzetta, risponde agli olezzi e all’isteria che emana dalla casa.
Qualcuno avrà pure scosso la testa, trattenuto il compiacimento – che tale è la reazione all’anomalia quando essa è ben al sicuro, fuori di noi. Se sapessero quello che la donna ha passato – e non dubitiamo che le voci si siano già sparse – penserebbero che l’uscire fuori di senno sia il minimo.
Tristi e manchevoli queste figlie? Crudeli e sofferenti queste madri?
Le orfane sono eroine di una tragedia. Desiderare vendetta nei confronti di chi ci ha generati è un abominio. Uno stigma. Esse devono perdonare il loro aguzzino. Tenerlo in vita. Non meritano il nostro scherno.
Ci si può offrire per chi ti ha amato, cresciuto – ha detto si per te: è una restituzione. Sacrificarsi per chi ti è stato nemico si chiama santità. Tutto il resto è una prigione.
Quel nido in cui volevano ripararsi diventa pian piano un covo di tensioni, e mentre si vuota la cantina dei resti del passato per far spazio a una badante, sembra naufragare la speranza.
Ma si presenta alla porta una strana suora: È questa la casa delle orfane bianche?
Le tre donne la pensano un aiuto mandato dal parroco e non intendono quel palesarsi di un filo sotteso al loro legame: «Noi di madri, di genitrici, ne abbiamo in abbondanza. Vive e vegete. Questo è il nostro problema.»
«Quindi siete certe di non cercare una madre. Giusto?»
«Dio ce ne guardi. Con rispetto parlando. (…) Badiamo alle madri. Diciamo pure che cerchiamo di sopravvivergli.»
«Siete voi le madri.»
Disorientamento. Si scambiano sguardi, le si radunano intorno.
«Si spieghi meglio, per favore.»
«… Voi cosa siete? Madri o figlie?»
Un’esitazione. Poi tutte: «… Figlie.»
«E allora perché comandate?»
«Non comandiamo, suor Modestina. Noi guidiamo. Le nostre sono madri bambine.»
«Madri bambine, bene. Da quando?»
Si guardano. Illuminazione! In coro: «Da quando siamo nate noi!»
«Allora voi siete come orfane, giusto?»
Benedette figliole. Benedette fanciulle con le lenti da vicino e le vene varicose, possibile che non capite? Le orfane bianche siete voi.
Il velo crolla.
Gli orfani bianchi sono i figli dei genitori lontani. E quale lontananza è il non sentirsi amati o la follia?
Straziante è sentirsi abbandonare da chi ci ha amati. Ogni giorno un pezzetto: dapprincipio è sbadataggine – non afferra la mano – assenza – sarà malinconia? – il nome – confusione – una parentela scambiata, negata. (…) Ma se quella distanza che aumenta non è mai stata una prossimità, allora non è lacerazione, strappo. Ma tragedia. Coesistenza di opposti. Ambivalenza. Poiché non c’è separazione dalla fonte d’amore, ma dalla speranza di essere amati. Dalla possibilità di correggere, di riparare. Pazzia.
Mia madre sta male per me, da me…
Viene in mente il piccolo paziente di Winnicott che aveva colto con grande intuito l’intreccio maligno: “Dottore, la mamma ha male al mio stomaco”.
Perché un bambino lo si può far crescere per renderlo ciò che serve: una conferma al proprio valore, un prolungamento per realizzare i propri desideri inespressi, la fonte di amore incondizionato che la propria madre non è stata.
Il suo desiderio di me, di avermi, era morboso. Di avermi non come figlia, ma come madre. Di entrare nel mio grembo maturo. Un desiderio incestuoso. Io crebbi contro questo desiderio. Su questo desiderio. Lei regredì. Sempre più piccola. Capricciosa. Potente nel bisogno. Mi sentivo cannibalizzata, vampirizzata. Volevi essere figlia: io ero la tua candidata perfetta. Mamma.
Diventano strapiombi l’identificarsi, il differenziarsi. Il percorso dello sviluppo viene slogato, si carica di costrizioni, interdetti, cecità, vincoli sgorbiati e confondenti.
Le ferite dei legami primari non riguardano solo l’eccezionalità della sofferenza ma le conseguenze dell’impossibilità di comunicarla. La repressione dei propri sentimenti – per il timore di minacciare l’equilibrio dell’altro o di perderne l’amore -, costruisce un’opposizione verso il proprio mondo interno che lo condanna al buio, ai circuiti proiettivi, al veleno di sensi di colpa irredimibili.
Lungo l’arco temporale di quaresima in cui si svolge la vicenda, ognuna delle protagoniste confida la propria storia in un doloroso “tra sé” rassegnato di non poter raggiungere quelle madri barricate.
Quell’idea strampalata di voler tenere in piedi tutto: capire il passato e cambiare il futuro.
Credere che a tutto c’è riparazione…
Un travaglio, quello delle protagoniste, che pare ritrovare la speranza quando la cucina si riempie di un tepore da grossa incubatrice in cui si respira il profumo acidulo dei lieviti, e il dedicarsi a far crescere impasti si prende il lento tempo che occorre alle trasformazioni.
Premiato con il Campiello Opera prima, questo romanzo sa risuonare e mostra molto bene come la possibilità di comprendere e bonificare la distruttività si dia nel riattivarsi di sentimenti paralizzati e nel lavorio del senso, riconoscendo ciò che si può e non si può riparare. Per fare virtù di quel che si può.
Donne / Madri / Cattivi Pensieri – Marzo 2012 | SPI
