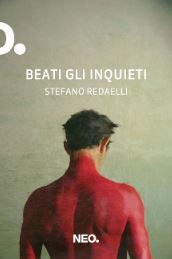
Intervista a STEFANO REDAELLI
A cura di Daniela Federici
Stefano Redaelli, fisico e docente di letteratura nell’Università di Varsavia, da anni interessato al rapporto fra scienza, follia, spiritualità e letteratura, è autore del libro Beati gli inquieti (Neo Ed. 2021), un’efficace spaccato di vita in una struttura psichiatrica. Una materia delicata, trattata con garbo e un ascolto capace di rendere climi e tratti dell’universo fuggevole e più fragile dell’umano. Come sei arrivato a interessarti della follia e farne uno snodo dei tuoi interessi?
È “colpa” di un’amica. Quattordici anni fa (è un libro che viene da lontano) mi chiese di trasformare in un romanzo i diari di una loro (della comunità di Sant’Egidio) esperienza di amicizia con i pazienti di una struttura psichiatrica. Non avevo avuto fino ad allora alcun rapporto con la malattia mentale. Lessi i diari, mi colpirono molto. C’erano frasi sorprendenti, tipo: “solo quando sono con loro mi sento libero di essere me stesso…”. C’erano persone la cui storia, malattia, sensibilità, il cui linguaggio mi attrassero. Volevo aiutare la mia amica, ma non avrei potuto scrivere niente che non avessi sperimentato anche io di persona. Cercai un Centro Psicoriabilitativo nella mia città natale ed iniziai a frequentarlo. Non ho ancora smesso. Sono diventato amico dei pazienti. Per anni ho raccolto le voci, storie, confidenze, lettere mai spedite, poesie, invenzioni. Le ho custodite. Nel frattempo mi sono messo a studiare le rappresentazioni letterarie della follia. Volevo capire come gli scrittori le avessero dato un volto e una voce, come questi volti e voci nel tempo fossero cambiati, cosa avessero da dire oggi, a quarantuno anni dalla legge Basaglia. Chiusi i manicomi, dov’è finita la follia?
Nel tuo libro Circoscrivere la follia: Mario Tobino, Alda Merini, Carmelo Samonà, attraverso i punti di vista di questi tre autori esplori quale significato e funzione ha la scrittura dell’esperienza della follia, fra atto di studio, funzione terapeutica e di sensibilizzazione. Cos’ha significato per te la scrittura di Beati gli inquieti e cosa ti riprometti che possa rappresentare per il lettore? Nella scelta di romanzare la tua esperienza al centro di riabilitazione psichiatrica, come hai rielaborato i tuoi vissuti e i tuoi studi con la realtà e le relazioni che hai sperimentato?
Trasformare l’esperienza fatta, il materiale raccolto in un romanzo è stato un processo lungo e difficile. Mi sembrava di tradire la fiducia dei pazienti: non sarebbe stato corretto utilizzare a fini letterari un vissuto così intimo, dolente, delicato. Eppure, ero mosso da un imperativo interiore: dare voce a chi voce non ha, visibilità a chi ancora vive nell’ombra nonostante la chiusura dei manicomi e la riforma Basaglia. Allora ho immaginato di vivere con loro, di condividere e scandire giornate, settimane, anni. Ho iniziato a immaginare cosa sarebbe potuto accadere se anche io fossi diventato un paziente. La scrittura narrativa, in questo modo, si è sviluppata in modo autonomo, staccato dalla realtà. L’invenzione ha preso il posto della testimonianza, amplificandola. Spero che il romanzo rappresenti per il lettore questo: una cassa di risonanza, un amplificatore delle voci della follia, del disagio mentale, ma anche di una sensibilità umana così autentica, spiccata, da farci provare nostalgia per quella parte di noi a cui non diamo sufficientemente ascolto, che temiamo e invece…
Per Freud i poeti e gli scrittori sono alleati preziosi, spesso più avanti nella conoscenza dell’anima, perché attingendo a fonti profonde, scoprono e danno forma a quel che lo scienziato impiega un lavoro faticoso per portare alla luce. Scrive a Schnitzler che vede nella letteratura una sorta di doppio della psicoanalisi: condividendone fonti e oggetto, autore e psicoanalista utilizzano entrambi l’interpretazione, l’uno per creare, l’altro per penetrare le intenzioni e la tramatura sotterranea dell’opera, disfacendo (analein) l’elaborazione secondarizzante. La psicoanalisi deve molto al rapporto con l’intelligenza letteraria; secondo te quanto quest’ultima è influenzata dalle scoperte della psicoanalisi sulle dinamiche del profondo?
Letteratura e psicanalisi condividono la fede nelle possibilità esplorative e nel potere curativo della parola. Si sono ispirate e influenzate reciprocamente fin dalla nascita della psicanalisi. Un esempio tra i numerosi: nella novella L’Ave Maria di Bobbio, Pirandello dà una straordinaria descrizione letteraria dell’inconscio freudiano: “Bobbio anzi diceva che ciò che chiamiamo coscienza è paragonabile alla poca acqua che si vede nel collo di un pozzo senza fondo. E intendeva significare con quello che, oltre i limiti della nostra memoria, vi sono percezioni e azioni che ci rimangono ignote, perché veramente non sono più nostre, ma di noi quali fummo in altro tempo, con pensieri e affetti già da un lungo oblio oscurati in noi, cancellati, spenti; ma che al richiamo improvviso d’una sensazione sia sapore, sia colore o suono, possono ancora dar prova di vita, mostrando ancor vivo in noi un altro essere insospettato”. Aveva letto Freud? In tutta l’opera di Pirandello – da Sei personaggi in cerca d’autore a Uno, nessuno e centomila – emerge il tema dell’io diviso, che David Laing tratterà approfonditamente nel suo saggio del 1955 e nei successivi. Pirandello muore nel 1936: è stato un anticipatore dell’antipsichiatria? Quando letteratura e scienza indagano le medesime fonti con strumenti simili (la parola), sebbene con finalità diverse, capita che l’una anticipi l’altra o ne sia illuminata. È sempre stato fertile questo scambio, questo intreccio.
Proust diceva che ogni lettore legge se stesso, che un libro è uno strumento ottico che ci permette di comprendere quel che forse, senza di esso, non avremmo mai conosciuto di ciò che siamo. Incontrare una storia è sempre l’occasione di un viaggio per farci carico dell’alterità di noi a noi stessi – come accade nei sogni – e della possibilità di farci trasformare dall’incontro. Anche per chi scrive, ogni personaggio offre l’opportunità di rappresentare degli aspetti della vita psichica, così nel farsi della storia, l’Autore oscilla fra uno scrivere per la trama, per ciò che “già conosce” e vuole raffigurare, e l’opportunità esplorativa che il punto di vista di un altro gli permette, scavandolo da dentro e traendone traiettorie impreviste. Come hai scelto e costruito i tuoi personaggi? In particolare il rispecchiamento fra Antonio e Angelo, cui affidi di trovare una risposta alla ricerca su cui il protagonista era incagliato, mi sembra uno scenario denso di esiti sorprendenti e intenti comunicativi. Ci dici qualcosa di più?
I personaggi del romanzo recano i tratti delle persone (i pazienti) che ho conosciuto e frequentato. Le loro voci ne portano l’eco. Ma i personaggi letterari sono una sintesi di caratteri diversi, una condensazione che assurge a simbolo, a carattere specifico e universale al contempo. Carlo, ad esempio, è l’archetipo di Adamo, il primo uomo, cacciato dall’Eden, che da allora non ha mai smesso di lavorare duramente per guadagnarsi da vivere. Per questo adesso è stanco, patologicamente, e ferito, perché nessuno l’ho mai pagato per i suoi lavori (“centomila miliardi di mesteri”). Simone è il mistico: combatte senza tregua con i “satanini”, che bisogna assassinare per guarire la schizofrenia. Marta è una creatura eterea, immacolata, dal passato violato. Angelo è il genio. Lui inventa, scopre, dipinge, crea. Tra lui e Antonio – il protagonista del romanzo, un ricercatore che decide di passare un periodo nella Casa delle Farfalle per studiare la follia da vicino – si crea un rapporto strettissimo, speculare. Diventano un po’ alla volta un unico personaggio: Angelo-Antonio. Non si sa chi sia il sano e chi il malato, chi stia studiando chi, chi sia lo scienziato e chi il folle. Quale sia la verità della ragione e quella della follia. La frontiera sfuma. La parabola di Angelo-Antonio rappresenta il percorso che il lettore dovrebbe fare leggendo il romanzo: un progressivo spostamento di punto di vista, ottenuto per empatia con i personaggi.
Nelle Lezioni americane Calvino richiamava il pericolo di perdere la funzione fondamentale dell’immaginazione, che la capacità di evocare immagini in assenza si atrofizzi in un’umanità sempre più inondata dal diluvio delle immagini prefabbricate. Invocava una pedagogia dell’immaginazione, per apprendere a elaborare le proprie visioni interiori, perché quelle epifanie cariche di significati che spesso fondano l’immaginazione letteraria animino una scrittura creativa che dia ordine e intenzione a quelle invenzioni. Quale pensi sia il ruolo della letteratura in questo nostro tempo in cui languono le capacità simboliche e la nebulizzazione del senso del limite rende sempre più inagibile fare i conti con le perdite, coltivare i dubbi e un senso di responsabilità?
Le sfide che Calvino raccoglieva nelle Lezione americane sono ancora urgenti. Nella complessità crescente in cui viviamo, nella ridondanza di immagini e parole (spesso contraffatte e manipolate), nella tendenza a omologare desideri e idee, proiettandoli su una dimensione di puro consumo, nell’anestesia del pensiero critico, del dubbio, la letteratura continua a compiere tre azioni salvifiche: 1) tessere insieme le diversità non per annullarle, ma perché rimangano tali, componendosi in una forma, 2) restituire alle parole e alle immagini la loro carica simbolica, la capacità di interrogarci e generare senso, 3) non limitarsi a rappresentare la realtà (la sua complessità, le sue contraddizioni) ma cercare di ri-crearla. È una sfida (molteplice) che assomiglia a una fede, se non altro per il suo anelito a guardare oltre, a precorrere, a immaginare con tale forza da rendere quelle immagini realtà.
