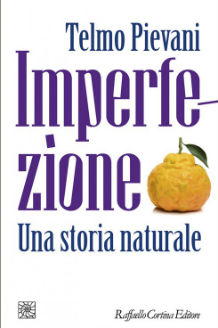
IMPERFEZIONE. Una storia naturale
di Telmo Pievani
(Cortina, 2019)
Recensione a cura di Daniela Federici
“Intenta ad accumulare i suoi carati di perfezione,
Bersabea crede virtù ciò che è ormai
un cupo invasamento a riempire il vaso vuoto di se stessa;
non sa che i suoi momenti d’abbandono generoso
sono quelli dello staccare da sé,
lasciar cadere, spandere.”
Calvino, Le città invisibili
Nel nostro tempo assillato dal mito della perfezione e dalla pretesa antropocentrica che l’ordine universale assecondi il progresso di conquista della sua specie eletta, Telmo Pievani, filosofo della biologia, evoluzionista, bella penna della divulgazione scientifica, propone un libro avvincente che smonta queste visioni teleologiche e offre spunti di intelligente ironia sulla nostra condizione esistenziale.
Dall’esplosione della perfetta ma instabile armonia gravitazionale, deviazione fortuita nel vuoto quantistico primordiale, attraverso la sintesi – nel cuore di stelle collassate – degli elementi che hanno principiato la struttura dell’universo per come la conosciamo, fino al clamoroso successo biologico della nostra specie. Meccanismo di fondo dell’evoluzione cosmica e biologica, il clinamen lucreziano, turning points imprevedibili quanto decisivi per il corso degli eventi successivi, rotture di simmetria che si approfondiscono lungo sequenze inarrestabili, nell’incessante tiro alla fune fra leggi e caso. Non siamo l’esito necessario e atteso di un disegno prestabilito, ma solo un presente fra i molti irrealizzati di cui erano gravide le divaricazioni delle contingenze.
Il sapore di fondo è quello dell’improvvisazione. La natura non fa progetti, trova espedienti.
L’evoluzione è un artigiano che riutilizza in modo più o meno ingegnoso vecchie strutture per nuove funzioni in relazione al mutare dei contesti, l’adattamento un flusso di trasformazioni fra disastri ingegneristici e malfunzionamenti. La natura ci insegna che la perfezione è per definizione compiutezza atemporale, dove c’è perfezione è già successo tutto, l’ingranaggio non fa più gioco. È l’imperfezione – connaturata all’evoluzione stessa e non un suo effetto collaterale – che permette lo sviluppo, perché è in essa lo spazio di mancanza e l’area di manovra della creatività del bricoleur, la sorgente e la promessa di evolvibilità.
Due tra i più complessi e creativi sistemi mai inventati dall’evoluzione – il genoma e il cervello – sono reticolari, palesemente imperfetti, inutilmente complicati, figli di rabberci, aggiustamenti, accrocchi e compensazioni.
Non solo geni atavici ma una massa debordante di genoma che sembra non servire a nulla, che la selezione naturale conserva come il ciarpame che si stipa nei garage con l’idea che ‘non si mai…’; così il premio Nobel Sydney Brenner coniò l’espressione junk per il DNA “spazzatura”. Ma quell’esuberanza di materiale di risulta è un magazzino di riutilizzi creativi per l’evoluzione adattiva e in quelle infinite copie di backup – senza nessuna preveggenza – si possono sviluppare mutazioni intelligenti che imprimono nuove direzioni di possibilità. Perché la duplicazione è stabile – altrimenti non ci sarebbe trasmissione – ma al contempo variabile, perché senza quelle leggere imperfezioni innovative, gli scarti dalla media, le disobbedienze generazionali che ogni individuo reca con sé dalla nascita, non ci sarebbe evoluzione. Anche il genoma è un sistema che evolve obbedendo alle leggi dell’imperfezione.
Evoluzione come aggiustamento dell’esistente… come trasformazione del possibile…
Bipedismo, neotenia e linguaggio: tre portentose imperfezioni che hanno fatto la nostra fortuna, sono sublimi rimaneggiamenti che hanno dovuto fare i conti con i vincoli di architetture e sistemi complessi, negoziando vantaggi e costi collaterali delle mutanti soluzioni anatomiche e funzionali. Così, acquisita la posizione eretta per diminuire la superficie di esposizione termica, non potendo ampliare più di tanto il canale del parto per non andare a discapito della locomozione, la soluzione è stata una neotenia prolungata, con un cervello che si sviluppa per due terzi dopo la nascita. Adattamento costoso in tempi di predazione, nelle ere questo ha dilatato gli spazi per i processi di apprendimento, favorendo plasticità, imitazione e innovazione creativa nello sviluppo di capacità e sperimentazione linguistica. Intanto nell’encefalo, cresciuto in parallelo con la complessità delle relazioni sociali, le nuove parti della corteccia non hanno ristrutturato quelle arcaiche, che continuano a svolgere funzioni biologiche basilari, ampliando una discrasia evolutiva potenzialmente lacerante che si annida nel nostro cervello.
Il sistema limbico che dirige il nostro universo emozionale è ancora quello dei primati. Lo sanno bene i pubblicitari e i capipopolo.
La selezione naturale non raffina dall’imperfetto al perfetto, non determina necessariamente un accumulo di esperienza adattiva positiva: gli ambienti cambiano velocemente senza una direzione prevedibile, cambiamenti cui noi stessi contribuiamo con il nostro impatto invasivo: la nostra rincorsa adattiva potenzialmente infinita, come nel regno della Regina Rossa di Carroll, è ormai sub-ottimale. Certo la prorompente evoluzione culturale che si è innestata su quella biologica, con le sue invenzioni tecnologiche, protesi, integrazioni e potenziamenti, ci permette di sopperire alle nostre limitazioni innate, ma rischiamo il cortocircuito dell’imperfezione nel rapporto tra i nostri poteri crescenti e i nostri limiti persistenti.
Non siamo predisposti per la lungimiranza, rimarca Pievani, la mente umana predilige il tutto-subito, le tentazioni del presente alimentano la nostra radicata avidità e i nostri bisogni indotti: l’economia predatoria, il consumismo sconsiderato, le miopie politiche. Siamo portatori di bias cognitivi ed emotivi, attori di rapporti sociali sempre in bilico fra collaborazione e belligeranza. Tutte le transizioni evolutive sono esplorazioni di nuove possibilità organizzative, capolavori di simbiosi e di cooperazione, scrive Pievani nella prefazione a Le origini profonde delle società umane, di Edward O. Wilson (Cortina, 2020), cantore dell’eusocialità, delle società complesse come culmine delle tendenze aggregative. Ma perfino l’altruismo ha le sue radici ambivalenti nella conflittualità fra i gruppi, che ha avuto precise ragioni evolutive: è la minaccia di un nemico che ha portato all’aggregazione di un “noi contro loro”, da cui derivano sia i più fecondi risvolti solidali sia il pretesto per le più infime scelleratezze.
Ereditiamo una natura ambivalente e duale, quindi la cultura e le esperienze ci possono condurre per il meglio o per il peggio. Ne discende la necessità di una continua vigilanza etica e civile.
Il nostro successo evolutivo ha espanso enormemente il dominio di ciò che possiamo influenzare, aumentando così anche la nostra responsabilità morale per questo potere d’azione e la gestione dei suoi possibili rischi. Ma nonostante la nostra straordinaria predisposizione genetica e biologica a imparare dall’esperienza e l’indubbio potenziamento delle capacità della ragione, sembriamo incapaci di far fronte alle sfide del nostro tempo con politiche sostenibili, privi di interesse e volontà verso l’altro dell’iniquo presente e delle generazioni future.
Nel libro c’è un intercalare di passi del Candide di Voltaire, un richiamo alla pretesa di Pangloss di vivere nel migliore dei mondi possibili. Una spinta a elevarsi che fa venire alla mente la neuroetica, che si interroga su come realizzare un biopotenziamento morale attraverso trattamenti farmacologici e interventi di ingegneria genetica (Inadatti al futuro. L’esigenza di un potenziamento morale, di I. Persson e J. Savulescu, Rosenberg & Sellier, 2019). Se le evoluzioni, più che buone o cattive in sé, stanno nell’uso che se ne fa, occorre cautela per non rischiare di far rientrare dalla finestra le aberrazioni dei modelli di purezza che vorremmo aver messo fuori della porta.
Pievani rimarca il pericolo di guardare al mondo dalla prospettiva della perfezione, perché ci fa considerare le diversità come scarti dall’ideale, scadendo in una visione gerarchica, mentre la natura non è fatta di norme ma dell’irriducibile unicità degli esseri, ognuno portatore di differenze inalienabili che sono motore e combustibile di ogni cambiamento.
La plasticità cerebrale è un Giano bifronte. Da un lato la malleabilità della nostra mente la rende facilmente indottrinabile e i fattori culturali possono letteralmente plasmare le condotte dei singoli e delle folle, anche verso gli esiti più turpi. Dall’altro lato, un’educazione precoce ai valori di civiltà può disattivare o reprimere gli istinti più bassi, che non sono per noi cogenti e invincibili come lo sono per gli animali.
La natura umana è ambivalente quindi aperta, questa è la possibilità.
Da psicoanalisti lavoriamo con le primigenie tendenze a espellere da sé ciò che si disprezza – le nostre componenti “vestigiali”, storture e imperfezioni dell’umanità che siamo, con i meccanismi di elusione anche verso una sensibilità collettiva. In un tempo di frammentazione del rapporto individuo-società, fra frenesia del presente e rischio di un collasso della prospettiva, continua a spettarci di sostenere il pensiero, mantenendo pervio uno spazio per il conflitto e la comprensione emozionale, necessari a un’etica di responsabilità.
Nessun ritorno all’Arcadia è possibile, l’uomo dovrà continuare a essere fabbro di se stesso. Il richiamo di Pievani è a Levi: l’antidoto contro il disumanesimo non è una razionalità perfetta ma un razionalismo critico e autocritico, scettico e di metodo.
Il pensiero sul “come” è strumento di cura.
