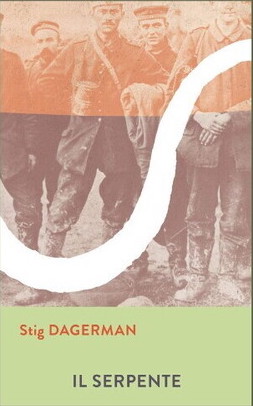
IL SERPENTE
di Stig Dagerman (Iperborea, 2021)
Recensione a cura di Daniela Federici
La tragedia dell’uomo contemporaneo
è che non ha più il coraggio di avere paura.
È una sciagura, perché ne consegue
che deve poi anche smettere di pensare.
Dagerman Il serpente
Faceva così caldo che quasi si sarebbe potuto tostare il caffè sulle rotaie. La ghiaia tra le traversine luccicava tanto da ferire gli occhi e dall’altra parte della ferrovia penzolavano le spighe dell’avena, ormai quasi mature. Al di là del campo erano addossate l’una all’altra alcune case del paese, dipinte di rosso, e dal gruppetto si innalzava aguzzo lo stuzzicadenti di un’asta di bandiera. Sulla pianura gravava il colosso della stazione e dallo slargo antistante, coperto di ghiaia, si levavano strette colonne di polvere. In lontananza, dal verde infinito si avvicinava un treno. Il fumo fluiva dal camino della locomotiva formando nuvole che si adagiavano poi sui binari come piccoli funghi. Era quasi l’una e il treno veniva a dare una gomitata nel fianco alla comunità sonnacchiosa.
Il caldo afoso e letargico in cui si svolge la vicenda si presta a dare forma alla sfibrata indolenza dell’indifferenza.
Niente serviva a niente. … provò l’intenso desiderio di qualcosa capace di schizzare sangue su tutto quel grigiore.
Nel succedersi delle pagine si viene immersi in un’atmosfera accecante e pastosa, quello stadio in cui nessuna fantasia è tanto folle da non essere presa sul serio dall’intelletto… Un tempo di visioni che si inalberano nei vapori della follia, di vertigini che spingono sull’orlo della tragedia.
Era così spossata, così intontita da non tenersi in piedi, e nello stordimento sentì come un getto raggelante di paura iniettarsi in tutto quel calore… Pensò, quasi esultante: «Mi sta succedendo qualcosa».
Il serpente, tradotto solo ora da Iperborea, è uscito in Svezia nel 1945, romanzo d’esordio che consacrerà Dagerman come scrittore di culto della sua generazione. Reportage e scritti politici, drammi, poesie, romanzi, una folgorante carriera letteraria stroncata da una morte tragica a soli 31 anni.
Appare sorprendente l’acutezza del suo sguardo, che fu tagliente sui guasti del dopoguerra e oggi risuona precorritore di paesaggi dell’anima che sembrano dipinti di fresco.
Perché nessuna assicurazione al mondo garantisce la libertà dalla paura?
La prosa visionaria di Dagerman pennella scenari onirici sul cui sfondo prendono vita i fantasmi che abitano i personaggi e la lotta per addomesticarne le forze selvagge.
Un rettile grigio dalla lingua sibilante si solleva dal ventre della terra – questa la figura che fa da filo rosso nell’inanellarsi delle varie scene. Il serpente si allunga come un’ombra e risucchia, ipnotico, lo sguardo di un sergente immobile a terra durante un addestramento. Un soldato che vede la paura negli occhi del suo superiore, lo cattura e ne fa moneta per estorcere qualche ora di libera uscita. Dallo zaino in cui viene gettato, la creatura attende sorniona di riemergere con il suo carico sinistro, espressione simbolica delle paure annidate nelle tenebre del mondo interno, che avviluppano sinuose come un canto di sirena, che mordono improvvise come crampi.
Così l’odore pungente di terrore sale dalle crepe del pavimento della caserma, penetra i sogni e scrolla le brande lungo veglie impietrite, a raccontarsi storie nel buio per ammansire l’angoscia, pensieri disperati che battono a martello nella testa.
Come un sommozzatore quando scende verso il fondo… apnee che attendono il ristoro dell’alba e i rumori dei vivi.
Lo zaino passa poi di mano, spargendo la tossicità di una febbre diaccia.
C’è solo il vuoto. Allora chiude gli occhi, tranquillizzata, sapendo che le basterà lasciarsi inghiottire perché non le accada nulla. Nell’intimo, però, sa anche che si tratta di una speranza ingannevole. Come il funambolo vigliacco che si crede in salvo solo perché non guarda giù. Dentro di lei rosicchia un animaletto dai denti aguzzi.
Paure della solitudine, del fallimento, dell’impotenza, della morte, che allungano i loro tentacoli e strangolano come tenaglie.
… si convince che l’azione metterà un punto al tempo, che quando l’avrà compiuta avrà inizio l’eternità, la vita si fermerà e non avanzerà più di un passo, un po’ come la puntina di un giradischi su un disco rotto.
Spire tensive che instillano veleno, perché chi è più pericoloso di colui che ha paura, intossicato di acredine e diffidenza?
… la paura è una malattia che è sempre lì, latente, che cerca di strisciare lungo i più sottili filamenti della coscienza e li punzecchia finché si scaldano e bruciano. Allora si capisce anche che non c’è scelta: quella che ci si immaginava essere la libertà dalla paura non è altro che un tentativo, più o meno spasmodico, di escluderla dall’esistenza. Nella sua situazione disperata, uno magari scopre che tutto si tiene in equilibrio su una colonna di paura e comincia a prepararsi per convivere con questa consapevolezza.
Ognuno di noi porta dentro di sé l’immagine di uno spettro, scrive in Bambino bruciato: la paura è del vivere, è inestirpabile alla condizione umana, si può solo placarla al fondo del sacco e averne cura. Perché solo chi ha un intimo rapporto con la sua paura è consapevole che non ha alcun bisogno di chiudere gli occhi.
Lo scrittore che indaga se stesso si fa simbolo di chi è andato fino in fondo alla sua paura, chi ne sa di più e la teme meno, perché è sua costante abitudine frequentarla. Negli svincoli fra incuria e responsabilità, il suo ruolo è allora quello di scuotere le coscienze cercando la parola che tocchi il cuore del mondo (Il nostro bisogno di consolazione, 1952 – Iperborea 1991).
Così dalle pagine del romanzo Dagerman lancia un’esortazione che fece di lui una bandiera in quei tempi devastati dalla guerra e corrotti: Una soluzione forse non esiste, ma l’unica eventuale possibilità è una nuova epoca di intellettualismo, che possa dare almeno a qualcuno il coraggio di guardare l’angoscia negli occhi, invece di strisciare nelle grotte e nelle alcove del misticismo infantile per cercare rifugio. Un monito che non smette di essere attuale.
Con Il serpente Dagerman si palesa un mirabile creatore di atmosfere, che articola in modo affascinante uno stile colloquiale e diretto con invenzioni liriche e una sofisticata complessità di sviluppi metaforici.
C’è maestria nel suo descrivere il frangersi delle illusioni più carezzevoli, il momento esatto in cui ci si riscuote da un’idealizzazione e si torna in contatto con la superficie della realtà e i suoi contorni miseri e prosaici. O l’istante dello schiarirsi della mente braccata dalle paure, che distingue la luce della superficie e risale nuotando a grandi bracciate per riportare i pensieri in acque poco profonde. Le immagini di un profondo che è un altro modo di dire vuoto.
Poi la colpa che stinge addosso il suo colore, o la vergogna come un gigante con sudici e rumorosi scarponi ai piedi entrato per caso nel laboratorio di un fabbricante di bambole.
Una prosa a dir poco talentuosa di un ventenne, nella quale si percepisce la sostanza umana di chi conosce il gelo dei pozzi, di chi ha affrontato i suoi serpenti a mani nude, aprendosi varchi nel buio. L’immaginifico con cui Dagerman “paesaggia” l’urgenza della sua scrittura sembra mirare a farsi ponte sui manchi esistenziali della provvisorietà delle consolazioni e di una solidarietà umana come speranza difficile da attingere.
Questa è la mia unica consolazione. So che le ricadute nella disperazione saranno molte e profonde, ma il ricordo del miracolo mi sostiene come un’ala verso una meta vertiginosa: una consolazione più bella di una consolazione e più grande di una filosofia, vale a dire una ragione di vita (Il nostro bisogno di consolazione, 1952 – Iperborea 1991).
Fulvio Ferrari, suo valente traduttore, sottolinea il rigore etico del suo pensiero politico: uno scrittore che ha tenuto vive le angosce che nascono dalla consapevolezza come espressione di salute morale, antidoto al precipitare nelle spire del potere.
Il suo è un invito alla libertà e alla ricerca di ciò che dà senso, alla possibilità di mettere le tende nel bosco dei paradossi.
Costa caro sapere davvero, costa lacrime e sangue, ma vale il suo prezzo (Bambino bruciato, 1948, Iperborea 1994).
