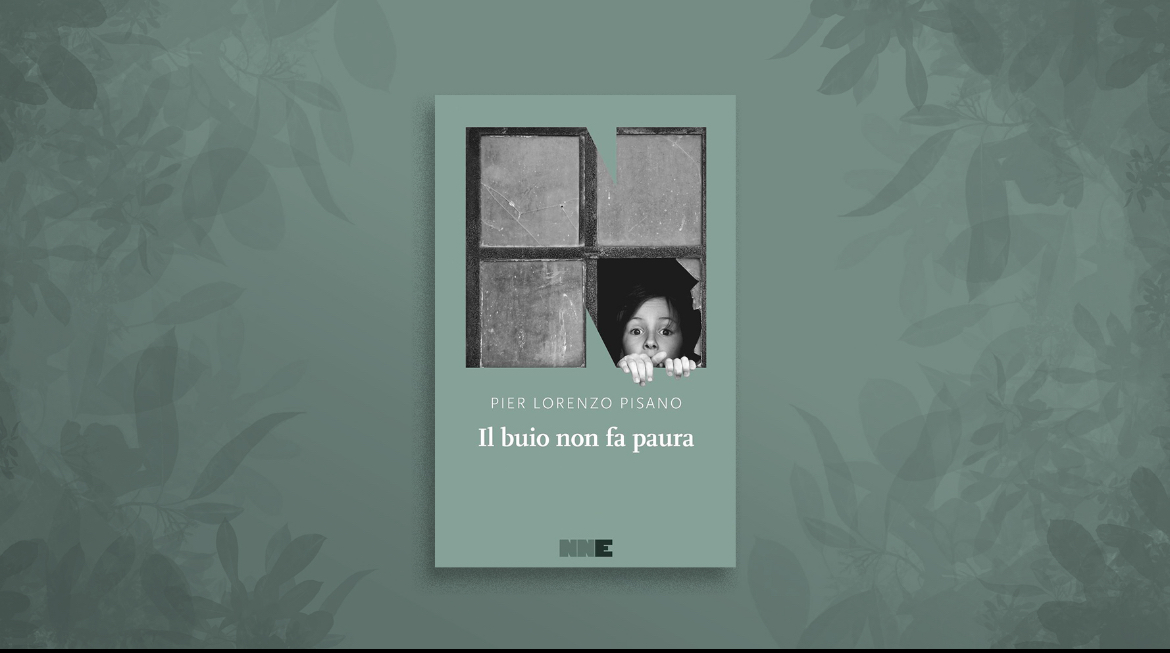
Parole chiave: Lutto, fantasia, infanzia, trasformazioni
IL BUIO NON FA PAURA
di Pier Lorenzo Pisano (NNE, 2021)
Recensione di Daniela Federici
L’arte ricompone esattamente la vita,
intorno alle verità attinte in noi stessi
spirerà sempre un’aura di poesia,
la dolcezza d’un mistero,
che non è se non il vestigio
della penombra che abbiamo dovuto attraversare.
Proust, Il tempo ritrovato
Una scrittura incantevole, metaforica, visiva, per una favola nera e sognante sul dolore della perdita e la magia dell’illusione.
Gabriele ha due fratelli e vive con mamma e papà in un piccolo paesino di montagna ancora segnato dai buchi delle bombe.
Una sera mamma va nella stalla per prendergli una tazza di latte e scompare nell’oscurità.
Il bambino prova a lanciare un sassolino nel buio, chiama ma’ ma’, non c’è nessuna risposta, nemmeno un’eco, la voce cade assorbita nel pozzo. Solleva il piede per fare un passo, sta per entrare nel nero, sta per sparire anche lui, ma all’ultimo non se la sente e il passo lo fa indietro…
… il nero resta illeggibile e freddo, com’è possibile, non c’è più nulla…
La piccola muta di fratellini si trova a dover affrontare il buio inestricabile dell’assenza di mamma, la disperazione del padre che continua a cercarla, la casa che resta buia anche quando si aprono le finestre, come se il muro di pietra, i mobili, gli intrecci delle sedie si fossero imbruniti, come se tutto il mondo stesse scendendo verso colori più scuri… un guscio vuoto, a malapena buono per proteggerli dal freddo.
Le parole sono bandite ma cose da dire ce ne sarebbero, tantissime, però restano tutte dentro, restano nelle unghie dei bambini mangiate fino a far uscire il sangue.
… e ore e ore e ore, ad aspettare che finisca almeno la notte…
Su tutto regna la paura, perché in paese sembra aggirarsi una belva feroce che uccide gli animali e tutti impugnano i forconi, babbo fa la ronda la notte e il giorno spacca la legna come volesse radere al suolo il bosco che nasconde i pericoli e il mistero della scomparsa, il nulla divorante di un muro nero incomprensibile.
Mentre il sole tramonta e le forme si impastano in un miscuglio pallido di sagome sghembe, Gabriele vede una figura aggirarsi nel buio, sembra un animale strano, sproporzionato, ma è troppo grande per essere vero… è tremendo che non si riesca a capire cos’è questa cosa gigantesca. … Sta tremando, non ci pensare non ci pensare, è troppo buio per aver visto bene, è troppo buio per stare ancora fuori, è troppo buio per non stare a letto, è troppo buio per non chiedere le storie alla mamma, quanto vorrebbe mamma adesso.
… forse è ancora qui, solo che è buio e noi non la vediamo.
È al sapere attribuito alla parola materna che l’Io comincia a domandare ciò che diventerà, la sua domanda sull’origine ma anche sul suo futuro (Aulagnier, I destini del piacere, La Biblioteca 2002).
L’incubo dà forma al divenire quando ci si trova in mancanza di un appoggio, quando si è abitati da una sofferenza assurda, che per sostenerla non bastano due mani che si aggrappano l’una all’altra.
Il piccolo protagonista è caduto fuori da un tempo di contenimento, il mondo non è più in equilibrio: la madre è scomparsa, il padre smarrito, i fratelli guardano giù dal castello dei loro letti e vedono fantasmi e ricordi che si sfocano, le persone intorno sono incattivite e spaventate.
Una sera che tutti sono fuori con le lanterne a cercare il mostro, Gabriele si addentra nel bosco.
Chi li capisce i bambini, combattono le loro battaglie invisibili.
Sembra che ogni volta col bosco sia un discorso diverso, un discorso di paura, un discorso che ti perdi, un discorso che solo mamma, se la trovi, può proteggerti, e se non avesse quella certezza non se la sentirebbe di andare avanti così, senza preoccuparsi di nulla.
Il buio del bosco rappresenta bene la dimensione primitiva, profonda e spaventosa del dentro, compito iniziatico, perché crescere richiede il coraggio di avventurarsi.
E a un tratto, nel muro di quella oscurità, si trova davanti una enorme figura nera, o forse è un’impressione, forse non esiste davvero una cosa così, è solo una visione… comincia a sentire un odore, come un profumo familiare, qualcosa di indescrivibile, che lo fa stare meglio, per la prima volta da quando mamma se n’è andata. La bestia e il bambino si avvicinano ancora, lei si abbassa piano, lui sale sulle punte dei piedi, senza pensarci, senza riuscire a resistere. Gabriele è quasi sotto le braccia nere, che gli si avvolgono attorno e lo sollevano piano, ma non ha più paura, non sente più nemmeno il freddo, e adesso che sono così vicini gli sembra di riconoscerla. Sussurra: ma’?… perché è così. Quella dev’essere sua madre, certo, il mostro è comparso dopo che se n’è andata, è la cosa più sensata, è la cosa più bella del mondo pensare che mamma è ancora viva, e ha bisogno di lui.
Perché una separazione non si limita a sottrarre l’oggetto d’amore, ma divide anche il soggetto stesso da una parte significativa di sé, così insieme all’altro si può perdere anche il senso del mondo per come lo si era conosciuto, e il ripiegamento per quella mancanza può darsi come un’ombra che ricade sull’esistenza in un buio irreparabile. E più il trauma della perdita è difficile da simbolizzare, più la negazione maniacale alimenta progettualità grandiose che mirano a misconoscere la ferita.
Gabriele prova ad addomesticare il buio facendoselo amico, ritrovandoci il profumo di mamma e la protezione del suo abbraccio, trasforma la sua assenza per darsi forza nella solitudine, un indugio con cui si dà il tempo per elaborare quel che non tornerà ma potrà ritrovare in un altro modo dentro di sé.
Il lavoro del lutto comporta la risignificazione del mondo intero del soggetto, non tanto per scongiurare la morte ma per trasfigurarla in una nuova forma. Il rappresentarsi, come accade anche nel sogno, è quel funzionamento in doppio con cui la psiche ragiona su di sé per conoscersi e fare i conti con la sofferenza del procedere. Questo ci permette di fare la nostra psiche: la simbolizzazione carrella fra una percezione insostenibile e la costruzione di un significato soggettivo che la renda poco alla volta tollerabile e accessibile al nostro mondo interno.
Ne “Il tempo ritrovato” c’è un passaggio esemplare sulla “materia di cui si compongono le cose quando ce le raffiguriamo”. Scrive Proust: “le verità che l’intelligenza coglie direttamente, scopertamente, nel mondo della piena luce, hanno qualcosa di meno profondo, di meno necessario di quelle che la vita ci ha comunicate, nostro malgrado, in un’impressione, materiale in quanto entrata in noi attraverso i sensi, ma di cui possiamo enucleare l’intimo spirito. … Si trattasse di reminiscenze sul tipo del rumore del cucchiaio, o del sapore della madeleine, o di quelle verità scritte con l’ausilio di figure delle quali cercavo di cogliere il significato nel mio pensiero, esse componevano un complicato e fiorito libro di magia, la loro prima caratteristica era ch’io non ero libero di sceglierle, che mi venivan date tali e quali. E intuivo che proprio questo doveva essere il segno della loro autenticità… il modo fortuito, ineluttabile con cui ero incappato nella sensazione, garantiva di per sé la verità del passato che essa resuscitava, delle immagini cui dava l’avvio, poiché noi sentiamo il suo sforzo per risalire verso la luce, sentiamo in noi la gioia per la realtà ritrovata. Essa costituisce parimenti la garanzia dell’autenticità di tutto il quadro, composto d’impressioni contemporanee che essa trae al suo seguito, con quell’infallibile proporzione di luce e di ombra, di risalto e di omissione, di ricordo e di oblio, che resteranno sempre ignoti alla memoria o all’osservazione coscienti” (Il tempo ritrovato, Einaudi, p. 931-32).
Pisano, regista e autore di cinema e teatro, con questo romanzo plasma mirabilmente l’atmosfera di fluidità dei confini fra realtà e immaginario, dove si intravedono i meccanismi seduttivi della rinuncia al reale e del ripiegamento su un pensiero magico.
“Le idee sono dei surrogati dei dolori: nel momento in cui questi si trasformano in idee perdono un poco della loro azione nociva sul nostro cuore. (…) Quanto alla felicità, essa non ha quasi che una sola utilità: render possibile la sventura. Bisogna che, nella felicità, foggiamo legami bel dolci e ben forti di fiducia e di tenerezza, perché la loro rottura ci causi quello strazio così prezioso che si chiama «sventura». Se non fossimo stati felici, per lo meno grazie alla speranza, le sventure sarebbero prive di crudeltà e, di conseguenza, infruttuose” (Proust, Il tempo ritrovato, Einaudi, p. 961-62).
Pisano, con il suo delizioso scenario onirico, tesse soprattutto un apologo sulla necessità di elaborare il lutto, l’inevitabile passaggio di un buio essenziale da attraversare, e lo affida a un protagonista che è nell’età più delicata alle offese e al contempo più capace di trasformare l’invisibile.
Anche in questo senso vale quel che diceva Pavese, che la letteratura è una difesa contro le offese della vita.
In un contemporaneo che moltiplica le guerre fino alla minaccia di dissoluzione per l’ottusa incapacità di riconoscere i limiti, questa storia ha molto da trasmettere sul pensiero necessario per rimarginare la notte.
