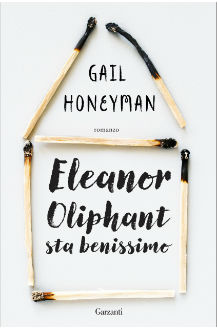
Eleanor Oliphant sta benissimo
Di Gail Honeyman (Garzanti, 2017)
Recensione di Daniela Federici
“Vedi, in questi silenzi in cui le cose
s’abbandonano e sembrano vicine
a tradire il loro ultimo segreto,
talora ci si aspetta
di scoprire uno sbaglio di Natura,
il punto morto del mondo, l’anello
che non tiene,
il filo da disbrogliare che finalmente
ci metta nel mezzo di una verità.
Lo sguardo fruga d’intorno,
la mente indaga accorda disunisce
nel profumo che dilaga
quando il giorno più languisce.
Sono i silenzi in cui si vede
in ogni ombra umana che si allontana
qualche disturbata Divinità.”
Montale I limoni
“Sono un’entità autosufficiente. O almeno è quello che mi sono sempre detta.”
Eleanor è una trentenne chiusa in una corteccia di solitudine che la isola dagli altri: contabile efficiente, senz’altre ambizioni da ciò che conosce, vive in un mondo rigido di abitudini, aliena per non adesione alle cose del mondo, verso le quali non si sente partecipe e che non comprende secondo il comune sentire. Così appare bizzarra e patetica, una mite nerd disadattata, ritirata nel lindore ordinato del non-coinvolgimento per cinque giorni lavorativi e poi nella sua stanza con l’alcool come unica compagnia. Bisogna pur tamponare l’angoscia.
“Il dolore è facile, il dolore mi è familiare. Mi rifugerei nella stanzetta bianca che c’è nella mia testa, quella del colore delle nuvole. Sa di cotone pulito e di coniglietto.”
Eleanor è una creatura segnata dai traumi.
“Questa era la mia anima che si raggomitolava nel biancore, un vuoto esistenziale dove un tempo c’era stata una persona.”
Chi parla di vincere? – diceva Rilke – Resistere è tutto!
“Il buio è dove accadono le cose brutte.”
C’è una catastrofe psicotizzante quando l’inermità affidata di un piccolo incontra il tradimento di una fiducia di base: l’abuso dell’altrui dipendenza spezza la prevedibilità necessaria verso un altro empatico. Quel che resta è l’affettività dissociata, la mancanza di una visione di sé unitaria a organizzare l’esperienza, l’avaria dell’interiorizzazione e l’incistamento di figure spregevoli e colpevoli. “Io non potevo essere riparata..”
La realtà si distorce, cadendo vittima delle proiezioni di paure e bisogni.
“A volte ho la sensazione di non trovarmi qui e di essere un frammento della mia immaginazione.”
Dal momento che ciò che non ha la possibilità di rappresentarsi tende a ri-presentarsi, queste persone cadono facilmente in bocca ai medesimi lupi – traumatofilia che annusa ciò che è familiare – e sono continuamente a rischio di una riattivazione traumatica per la facile esposizione a stati disorganizzati in assenza di potenzialità elaborative. Soggettività oltraggiate che possono riparare nell’inaccessibilità, “passare accanto alla vita.. vagare per il mondo come uno spettro.”
Quell’esilio può custodire la brace del desiderio di restare mentalmente vivi sotto quelle rovine.
“Non sono bruciata mamma. Ho attraversato il fuoco e sono sopravvissuta. Sul mio cuore ci sono cicatrici altrettanto spesse e deturpanti di quelle che ho in viso. So che ci sono. Spero che resti un po’ di tessuto integro, una chiazza attraverso la quale l’amore possa penetrare e defluire. Lo spero.”
Il pertugio di un’infatuazione, la fantasia romantica di esseri unici e speciali che si rinnova sotto la scure dell’ambivalenza, manufatto illusionale sgorbiato dall’analfabetismo affettivo e apparecchiato a nuove delusioni.
Mentre Eleanor prova aperture misurate alla sua autarchia, cercando di assimilare il nuovo entro un registro di controllo, qualcosa fa breccia: “sentii un piccolo bagliore dentro di me – non un incendio, ma più una specie di piccola fiammella costante.”
Dosi omeopatiche di una presenza non incandescente e affidabile, un’alterità che non ti pretende a modo suo, ma offre la scintilla solidale di un rispecchiamento. In quello spazio temperato fecondo alle metamorfosi del mondo interiore, sbocciano frasi rivelatrici, lacrime improvvise, sensazioni che si spandono nel corpo silenziato per anni, come acqua che torni a scorrere nel deserto, sfrigolante sull’arsura come scariche elettriche.
“A volte basta soltanto una persona gentile seduta al tuo fianco mentre affronti le cose.”
L’anello che non tiene, scriveva Montale, come uno strappo nella tela attraverso cui è possibile intravedere ciò che non è mai venuto alla luce, ciò che ha accecato della sua gorgonica effrazione, del suo eterno presente inelaborabile, indimenticabile.
“Gli occhi sono sempre accesi… vorrei strapparmi gli occhi per smettere di guardare, per smettere di vedere tutto il tempo. Le cose che ho visto non possono essere non-viste. Le cose che ho fatto non possono essere disfatte.”
Come un nudo proteo che si affacci fuori dal buio della sua grotta. I silenzi in cui si vede.
Eleanor affronta i suoi fantasmi, per provare a risorgere più integra e viva dalle ceneri del suo passato. Perché il trauma è sempre trauma psichico.
Questo romanzo è un’opera prima divenuta un caso letterario. Ben scritto senza essere un capolavoro (ma di quanti si può dirlo?), raccoglie entusiasti e detrattori. Ci si può chiedere perché.
Personalmente trovo che l’autrice abbia foggiato con notevole sensibilità una figura sofferente veritiera e impiegato un buon espediente narrativo per rappresentare la persistenza rapace dell’oggetto cattivo nell’atemporalità dell’inconscio a vampirizzare ogni slancio vitale. Che si tratti poi di fine intuizione o fine calcolo, la velatura ironica che tratteggia le storpiature del dolore come bizzarrie argute, consente al lettore di accostarsi a una figura tragica con il suo male profondo senza restare imprigionati nella drammaticità.
“Non esisteva uno spazio sociale a forma di Eleanor in cui potermi infilare.”
Tenera e forte a un tempo, Eleanor è una delicata mescola umana di disabilità e resilienza nella quale è possibile rispecchiarsi, condividendone la comune fatica di ricavarsi un posto nel mondo.
“Ai giorni nostri la solitudine è il nuovo cancro.” Questa la chiave proposta dalla Honeyman, che con i suoi personaggi fa ripensare alla solitudine dei numeri primi (romanzo di P. Giordano, Mondadori 2008, da cui S. Costanzo ha tratto un film nel 2010).
Che personaggi nerd, con il loro disadattamento relazionale, siano sempre più frequenti nei plot letterari o filmici, che film come La forma dell’acqua (di G. del Toro del 2017, Leone d’oro a Venezia) ottengano così ampi consensi, che romanzi di formazione con storie di riscatto da inferni violenti diventino bestseller (Mio assoluto amore, di G. Tallent, Rizzoli 2018), fa pensare che colgano degli emergenti forti di questo nostro tempo. I sentimenti di alienazione verso gli assilli sociali performanti e massificanti, la disabilità delle emozioni in un’epoca iperconnessa eppure così in affanno nei legami, lo sfondo di una pervasiva violenza in assenza di pensiero.
Arendt diceva che il pensare è un’attività senza fine, una ricerca di senso che accompagna la vita come una tela di Penelope che disfa ogni mattina quel che ha fatto la sera. È inesausta nell’umano la ricerca di traiettorie possibili dell’incontro e dell’addomesticamento dell’alterità – compresa quella interna – con le proprie cicatrici, per dare forma a ciò che ci abita e condividerlo.
