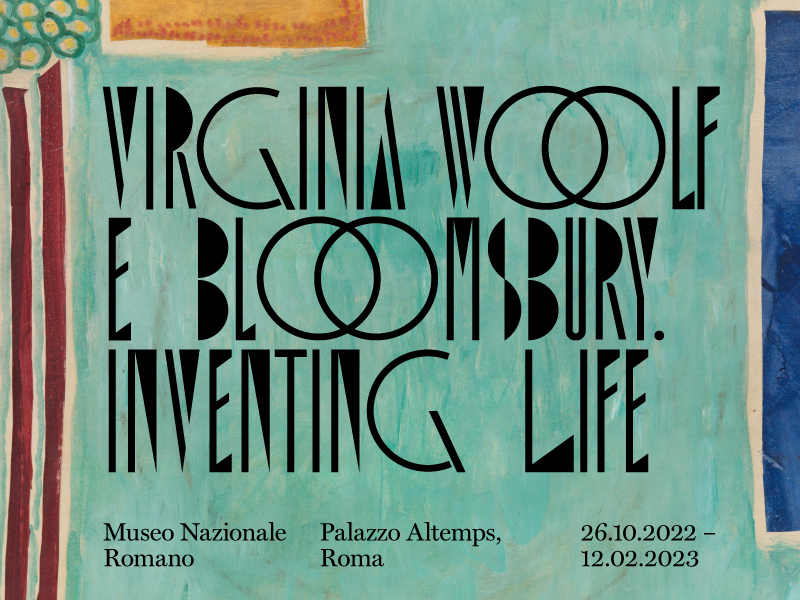
Parole chiave: Psicoanalisi; Gender; Bloomsbury; V.Woolf
INVENTING LIFE.
Bloomsbury, Virginia Woolf e la Psicoanalisi.
Luca Scarlini intervistato da Anna Migliozzi
Virginia Woolf e Bloomsbury. Inventing life, è la prima mostra Italiana che celebra lo spirito e le idee che animarono il Gruppo Inglese di Bloomsbury. Costituito inizialmente dai fratelli Virginia Woolf, Vanessa Bell e Thoby Stephan a cui presto si aggiungeranno Leonard Woolf, Lytton Strachey, Clive Bell, J. Maynard Keynes. David Garnett. Duncan Grant, John Nash, Henry Lamb, Edward Wadsworth, Roger Fry, Frederick Ashton, Lydia Lopokova, Dora Carrington, Helen Anrep, Julian Bell, Quentin Bell Frederick and Jesse Etchells, Angelica Garnett David Garnett, Wyndham Lewis, e alcune altre figure minori, ha segnato fortemente la sua epoca, sia culturalmente che politicamente in quanto sfidò l’atmosfera repressiva, soprattutto sessuale, che caratterizzava l’Inghilterra, proponendosi di cambiare i principi vittoriani e il forte spirito patriarcale di cui era ancora intrisa la società Britannica. Un Gruppo che ha fatto della collaborazione tra pari la sua cifra distintiva e che ha rappresentato il territorio d’elezione per l’invenzione e la sperimentazione di nuovi stili di vita e di pensiero. Tra le tante azioni che meritano di essere ricordate, fu la costituzione della casa editrice Hogarth Press che pubblicò l’intera opera di Freud in lingua inglese.
La mostra, attualmente a Palazzo Altemps di Roma fino al 12 Febbraio 2023, nasce dalla collaborazione tra Nadia Fusini, massima studiosa di Virginia Woolf, nonché presidentessa della fondazione Virginia Woolf, recentemente insignita del Premio Musatti (Società Psicoanalitica Italiana) e Luca Scarlini, scrittore, critico, performer, insegnante (Ca Foscari, Venezia), studioso e profondo conoscitore del mondo Anglosassone.
Abbiamo chiesto a Luca Scarlini di raccontarci il mondo Bloomsbury.
Come nasce la Mostra
La mostra nasce da una collaborazione tra il sottoscritto e Nadia Fusini, massima esperta di Virginia Woolf, con l’obiettivo di mostrare quanto il Gruppo Bloomsbury sia stato una vera e propria avanguardia e dove la maggior parte delle produzioni sono state ‘inventate’ nella conversazione e nel ritrovarsi durante le serate e nei weekend. L’obiettivo era rinnovare un paese molto arretrato, la Gran Bretagna imperiale, che, quando il Gruppo inizia nel 1911, era il paese più potente del mondo ma culturalmente conservatore e repressivo. Ad esempio, l’omosessualità dentro Bloomsbury era un tema rilevante e non dobbiamo dimenticare che solo 15 anni prima c’era stato lo scandaloso processo contro Oscar Wilde che aveva avuto come conseguenza la sua condanna al carcere e l’esilio a Parigi e In Italia di molti omosessuali.
I Bloomsburiani fanno scelte mai viste prima. I coniugi Woolf, Virginia e Leonard, vanno a vivere a Bloomsbury, allora un quartieraccio dove le case costavano poco, per potersi permettere una casa grande dove ospitare tanti amici a discutere ogni giovedì sera al memoir club. Il memoir club è un luogo dove le persone si incontrano, ognuna racconta quello che sta facendo, le storie più curiose che gli sono capitate, e poi molte di quelle storie diventeranno celebri romanzi. Oltre a Virginia Woolf, c’erano E.M. Forster, Roger Fry, il biografo Lytton Strachey e l’economista John Maynard Keynes. Il Gruppo inaugurò un modo di vivere caratterizzato dallo stare insieme, sostenendosi a vicenda per tutta la vita, nella buona e nella cattiva sorte. Per mano di Roger Fry, diedero vita agli Omega workshop, un tentativo del gruppo di entrare nel mondo dell’arte attraverso mostre e workshop che ebbero, però, vita breve, dal 1913 al 1919.
Quindi la mostra cerca di evocare per tramite di immagini, libri, documenti e oggetti, un’avanguardia che proprio nell’intimità del vivere ha dato il suo meglio. La sfida quindi, come curatore, è stata quella di rendere, le invenzioni dei romanzi di Virginia Woolf con i correlati oggettivi dei quadri e dei dipinti, ad es. di Duncan Grant o della sorella Vanessa Bell, artista straordinaria quando crea copertine bellissime e innovative per la Hogarth Press. Il gruppo di Bloomsbury non ha prodotto manifesti rivoluzionari ma ha rivoluzionato la vita, lavorando sulla conversazione e lo scambio delle idee.
Mi sembra di capire che proponi l’idea di Bloomsbury come laboratorio culturale attivo
Certamente. Fu un periodo di esperimenti, dove si incrociarono persone provenienti da ceti e ambienti differenti, con visioni differenti ma che hanno tentato di ‘provocare’ un paese arretrato. Nella mostra, ci sono molte fotografie di artisti a cui ‘Bloomsbury’ ha permesso di ‘debuttare.’ Basti pensare all’autore indiano di lingua inglese, Mulk Raj Anand, il primo che descrisse le condizioni miserrime in cui versavano gli abitanti delle colonie; oppure al caso eccezionale di Nancy Cunard, inglese di famiglia facoltosa, autrice di poesia nera, che sposa un pugile nero con grande scandalo di Londra. Bellissima, inventa Cecil Beaton, si fa fotografare con gioielli africani e lancia Samuel Beckett che scopre in un concorso poetico a Parigi. Nella sua autobiografia scriverà che deve molto all’essere andata da Leonard e Virginia Woolf, dove imparò anche a stampare.
Al Gruppo è stato spesso rimproverato di possedere belle case, anche in campagna dove ‘scappare’ per il weekend perché, Londra era necessaria ma fetida, e di frequentare l’High Society, come Lady Ottoline Morrell, ricca nobildonna Britannica, che spesso finanziava le loro imprese. Certo non erano poveri come le altre avanguardie ma è bello sapere che Lady Ottoline, da molti criticata per smanie di protagonismo, in realtà, quando ci fu la I Guerra Mondiale, nascose molti di questi intellettuali, pacifisti e obiettori di coscienza attaccati da stampa e pubblica opinione, nella sua fattoria, trasformandoli in finti contadini per permettere loro di non andare in galera. Non c’era una gerarchia nè un referente. Non lo era Virginia, nè Leonard e neppure Foster e nemmeno Lytton Strachey, nessuna figura di mentore o guru. Volevano influenzare il mondo con le idee e cercarono di farlo ascoltando tutte le posizioni più aggiornate, comunicandole in modo che potessero facilmente circolare.
Parliamo della sessualità che tanto ha interessato il Gruppo. Pensi che la sessualità, nelle sue varie declinazioni, sia al centro delle loro battaglie contro la repressiva Inghilterra.
Totalmente. La sessualità, con la sua carica eversiva, fu al centro dei loro interessi.
Pensiamo a Vanessa Bell, sorella di Virginia Woolf, che ha due figli con due uomini diversi ma che attribuisce ad uno soltanto. Vivono tutti insieme in una comune sessuale a Charleston. Tutto questo verrà raccontato molto bene dalla figlia Angelica Garnett, nel libro, Ingannata, con dolcezza, dove Vanessa è descritta come una grande madre cretese del XX secolo, una vera e propria ‘regina dell’alveare’ in cui gestisce tutti gli uomini, maschi che sovente sono omosessuali, e la situazione è molto libero. Oppure Lydia Lopokova, grande danzatrice Russa, che sposò John Maynard Keynes, omosessuale, con il quale mantenne però sempre una relazione d’amore che durò per tutta la vita anche quando Keynes andava ricoprendo incarichi sempre più importanti presso il governo Britannico.
Furono esperimenti culturali e politici che attrassero molta stampa negativa, producendo scandali e attacchi che durarono per circa 20 anni. Ma gli artisti e le figure che ruotarono intorno al Gruppo di Virginia e Leonard Woolf, sono state quelle hanno influenzato la scena culturale Britannica per molto tempo.
Veniamo ora a Leonard Woolf e alla Hogarth Press. Leonard fu commentatore politico, giornalista, scrittore. Fu sua l’idea di aiutare Virginia Woolf a curare la sua depressione, e riscoprire così interesse per la vita, attraverso l’editoria. La Hogarth Press rappresenta l’editoria come cura.
Leonard Woolf è una figura eccezionale, è sempre stato una voce Liberal estremamente importante in Gran Bretagna, anche durante la Seconda Guerra Mondiale. Pubblica peraltro Christopher Isherwood, probabilmente la cosa più lontana da Virginia Wolff, fatto che testimonia apertura e una notevole capacità di favorire la pluralità di idee. La Hogarth Press prima di diventare una casa editrice professionale, stampava a mano nella tradizione delle case editrici d’avanguardia Britanniche, ovvero l’artista stesso stampava i suoi libri in polemica contro il mondo industriale. E’un ‘gioco’ che inventa Leonard Woolf per Virginia dopo uno dei suoi vari tentativi di suicidio in cui le era stato suggerito di trovare un’attività particolarmente coinvolgente. Leonard pensò che l’attività editoriale avrebbe distratto Virginia e le acquistò torchio tipografico. Sembra che le avesse detto, “Ora imparerai a fare i libri.” Questa attività salva Virginia Woolf per due decenni. Comporre il libro, non solo scriverlo, comporre i caratteri mobili sulla pagina di stampa, è la base del successo della Hogarth Press che nasce veramente come attività domestica. Dopo il libro di Virginia sui Giardini di Kew Garden (1919), gioiello di evocazione poetica, la Hogarth diventa talmente famosa che devono subito correre ad una tipografia a stampare copie perché non sono in grado di dare risposta alla richiesta di 200 copie che arrivarono improvvisamente.
Hogarth Press che rifiutò Joyce e pubblicò, invece, l’intera l’opera di Sigmund Freud in inglese. Quale rapporto c’era tra il Gruppo di Bloomsbury e la Psicoanalisi?
Il legame con la psicoanalisi fu creato dal fratello minore di Lytton Strachey, James Strachey. Allievo di Sigmund Freud, aveva passato ben due periodi, di 6 mesi ciascuno, a Vienna da Freud. Oltre ad avere contribuito e realizzato la pubblicazione di tutta l’opera di Freud, James Strachey aveva contribuito a divulgare la psicoanalisi negli incontri del Gruppo e tramite i giornali, dove pubblicava intere pagine dedicate alla psicoanalisi; una di queste fu sul caso Dora. Stiamo parlando di un testo giornalistico di dieci pagine in cui il pubblico inglese veniva introdotto ad un mondo che non era ancora del tutto noto. James Strachey, peraltro, era anche lui una persona che attraversava ‘fluidamente’ svariate identità. All’inizio era omosessuale, poi si lega ad un donna, Alix, che diventerà sua moglie e con la quale resterà per tutto il resto della vita, permettendosi entrambi tutte le avventure che desiderano.
Virginia Woolf è interessata culturalmente alla psicoanalisi ma non si farà mai analizzare, anche se molti glielo suggerirono. Ben sappiamo che, in quell’epoca, un’alternanza up-and-down veniva dato come un fatto abbastanza comune tale da non richiedere necessariamente un intervento terapeutico per risolversi.
Altri componenti del mondo Bloomsburiano, come Auden e Isherwood, che emigreranno negli Stati Uniti per sfuggire al clima ostile dell’Inghilterra contro gli omosessuali (l’omosessualità è stata depenalizzata nel 1967), avranno con gli psicoanalisti incontri e accese discussioni culturali.
Bloomsbury dunque come avamposto dei temi quali, sessualità, gender e cultura.
Il merito del Gruppo di Bloomsbury fu di far esplodere le contraddizioni di un sistema che conteneva in sè da una parte la repressione, soprattutto sessuale, e dall’altra fenomeni quali l’exploitation sessuale, ad es. il bullismo omosessuale dei superiori sugli inferiori da parte dell’high society quasi come sistema didattico. Erano fatti molto gravi su cui per primi i Bloomsburiani avevano fatto luce.
Per finire, si può affermare che Orlando rimane l’opera più importante, il confine più avanzato, ovvero il primo libro transgender mai scritto. Virginia Woolf non aveva mai scritto niente di così forte. Nasce dall’amore per Vita Sackville-West ma per la prima volta in un romanzo Britannico si parla di amore, sesso, cambiamento-metamorfosi in termini espliciti e invece di bruciarlo, fu trasformato in un best-sellers. L’aspetto interessante della cultura Britannica, che tutti peraltro sentivano come una gabbia, è il fatto di aver saputo produrre risposte assai diverse e contradditorie alla repressione sessuale.
La mostra è una finestra che cerca di mostrare come dovrebbe funzionare il mondo culturale, ovvero capace di intercettare la contemporaneità e di individuare i nuovi soggetti. Un laboratorio in cui si entra ma da cui si deve necessariamente uscire.
Tutti aspetti rivoluzionari anche oggi dove si ha un individualismo selvaggio e si tende a rimanere al proprio posto fino alla fine. Leonard e Virginia nominarono, invece, alla guida della Hogarth Press, John Lehmann, giovane poeta omosessuale, dato che avevano 40 anni e si consideravano già vecchi. Pensavano che ci fosse la necessità di una persona di 25 anni, più capace di interpretare gli umori nuovi e intercettare anche gli scrittori più contemporanei.
Infine, la mostra ricorda che una vita rivoluzionaria è essa stessa importante quanto un’opera.
Completano la mostra una serie di incontri volti a far conoscere al pubblico Italiano anche figure minore che hanno dato vivacità e fermento al mondo Bloomsburiano, mondo che ha lasciato una traccia fortissima nel ‘900.
Domenica 13 novembre / Luca Scarlini, Lo spettacolo del mondo: un palcoscenico per Bloomsbury. Musiche inglesi del Novecento per chitarra eseguite da Alberto Mesirca.
Domenica 18 dicembre / Nadia Fusini. Carrington, l’indimenticabile.
Domenica 15 gennaio / Nadia Fusini e Giorgio La Malfa. John Maynard Keynes e le arti.
Domenica 12 febbraio / Nadia Fusini, Luca Scarlini, Stéphane Verger. Woolf, Forster, Bloomsbury e il rapporto con la Grecia e il mondo antico.
