
Parole chiave: #procreazione assistita, #aborto, #maternità
Cose che non si raccontano
di Antonella Lattanzi (Einaudi, 2023)
Recensione di Barbara Giorgi
Sulle rive dell’oceano dell’universo
I bambini fanno festa.
In cielo arriva la tempesta,
in mare la barca affonda:
l’angelo dellla morte passa in volo,
i bambini continuano a giocare.
R. Tagore
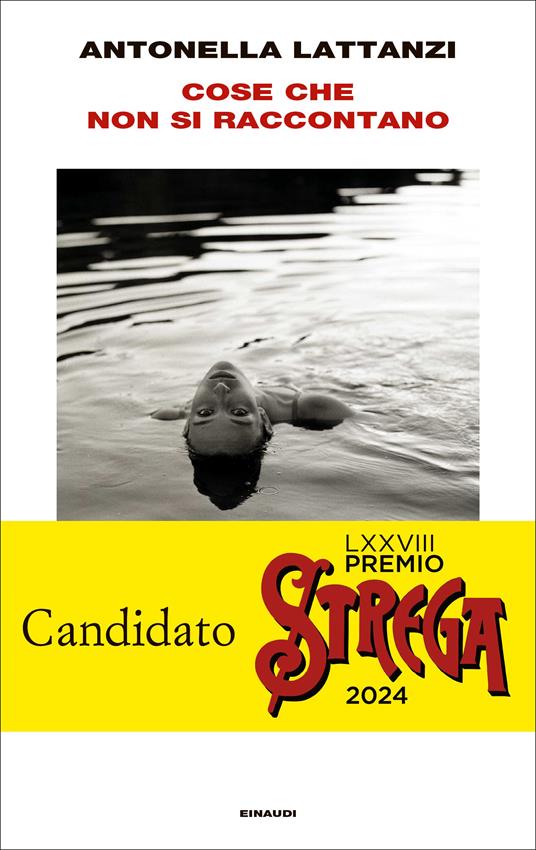
Leggere questo romanzo è come fare un’immersione in mare. Ci si immerge nella più autentica sincerità, si nuota in acque limpide e schiette, si riemerge provando un certo stordimento, un senso di vertigine.
E’ la storia, nuda e cruda, della faticosa ricerca di una maternità.
E’ la storia di una diagnosi di infertilità sine causa, di un percorso di procreazione medicalmente assistita, di una gravidanza monocoriale triamniotica e di una riduzione embrionaria.
E’ la storia, la vera storia, di Antonella Lattanzi, che si affida alla scrittura per raccontare cose che non si raccontano.
La prosa è semplice e asciutta, non serve complessità per un contenuto così coraggioso. Non è un diario: “un libro è una cosa seria. Non puoi scriverlo per sfogarti. Non puoi scriverlo perché serve a te.”
Lattanzi apre porte che non vorrebbe aprire, svela segreti mai raccontati, insegue ricordi dimenticati. Il risultato è un romanzo che si legge tutto in un fiato, fino alla fine, senza un lieto fine.
“Odio andare dagli psicologi – non ci andrò mai, in tutta questa storia, anche se me lo consiglieranno in tanti, amici, medici e perfino l’ospedale.”
Allora la scrittura diventa una necessità, diventa un modo per pensare, per mettere ordine, per rendere vero l’indicibile e l’irracontabile.
“Quelle cose, io non voglio dirle a nessuno. Io non voglio pensarle, quelle cose. Io voglio che non siano mai esistite. E se non le dico non esistono.”
Lei, che di mestiere fa la scrittrice, mentre percorre i tortuosi corridoi della procrezione assistita è alle prese con la presentazione di un suo romanzo, libro che, chissà perché, racconta proprio di maternità. E sarà proprio quel libro a tenerla a galla, a non farla annegare nel dolore della sua esperienza.
“I libri non sono figli, l’ho detto. Ma tutto quello che mi convince a non spalancare la finestra del mio quinto piano è lì: in quelle quasi quattrocento pagine.”
Mentre leggevo, ho ripensato alle toccanti pagine di Primo Levi. Al suo incontro con Jean, il “Pikolo”. Al suo affidarsi a Dante, al canto di Ulisse, nel tentativo di sopravvivere nell’inferno del lager.
“… Il canto di Ulisse. Chissà come e perche mi è venuto in mente.”
Come dire, la scrittura può anche salvare.
Nella vita della giovane autrice si concretizza la possibilità della maternità, ma è un’occasione imprevista, non pensata e non attesa. Accade in un tempo remoto della sua vita, un tempo nel quale manca, dentro e fuori di lei, lo spazio per un figlio.
La genitorialità è una faccenda complessa, non è scontata. E’ qualche cosa che parte da molto lontano, molto prima del concepimento. Ha a che fare con la costruzione di uno spazio interno che fa parte dello sviluppo della persona e si arricchisce con la nascita di un figlio, uno spazio interno che ha radici profonde dentro di noi, radici che, attraverso le nostre madri, affondano nelle nostre nonne, e ancora più giù.
Se questo spazio non c’è nella mente, non c’è neppure nella vita, e viceversa.
Così Lattanzi sceglie di non portare a termine due gravidanze in giovane età, chiarendo subito al lettore che “Non è il libro in cui raccontare il perché.”
Ma questo perché, secondo la mia opinione, non è poi così necessario. E’ invece necessario, assolutamente necessario, che ogni donna, di oggi e di domani, possa contare sempre sulla possibilità di interrompere una gravidanza, perché “un’interruzione di gravidanza è un diritto, me l’ha insegnato mia madre.”
Ci sono cose che non si raccontano, e questa è proprio una di quelle cose.
Pagina dopo pagina, nel rivelare questo segreto, mai raccontato prima a nessuno, Lattanzi si mette a nudo e affronta la sua vergogna.
Perché si prova così tanta vergogna ad abortire?
In un momento diverso della sua vita, lei più matura e con una relazione affettiva che la sostiene, il figlio cercato non arriva. Sceglie la procreazione medicalmente assistita ed entra nel tunnel delle “analisi, medicine, monitoraggi”, un tunnel che diventerà presto buio e doloroso. Così, alla vergogna si unisce la rabbia.
Urla tutta la sua invidia nei confronti delle altre donne, quelle che, ai suoi occhi, riescono facilmente ad avere figli. Dentro a questo urlo, si muove sincera la penna di Lattanzi, l’invidia si dilata e diventa odio.
“Quello che diventi, certamente, lo scegli tu. Quello che ti accade, spesso, no. Per sapere chi diventerai davvero, devi aspettare che il futuro accada. Solo quando il futuro accade sai se sei una delusione per te. Se sei proprio chi speravi di non essere. Io lo sono stata.
Una donna che non esce più dall’unico pensiero di fare un figlio. Una donna che guarda le donne incinte con invidia. (Sii sincera quando scrivi). Va bene, sono sincera.
Io le guardo con odio.”
Vergogna, rabbia, invidia, odio. Si nuota con questi sentimenti, dentro a questa storia, con la sensazione di annegare in un mare di impotenza e fallimento.
Gli stessi sentimenti regnano sovrani, nella stanza di analisi, quando si lavora con pazienti alle prese con la procreazione medicalmente assistita. Paziente ed analista sono obbligati a sedersi sui sedili scomodi di un’altalena di emozioni: spinti verso l’alto, quando prevalgono aspettative e attese, spinti verso il basso, quando si precipita nelle attese disilluse e nei fallimenti.
In questo scomodo ondeggiare, la relazione analitica, rassicurante e prevedibile, aiuta a trovare un equilibrio, diventa un appiglio per non scivolare.
Antonella Lattanzi non poteva non scrivere questo romanzo.
Perché, fuori dalla stanza di analisi, il gesto della scrittura diventa, per lei, una strada introspettiva. E’ la sua occasione di trasformazione. Nel dare forma e senso ai suoi pensieri, la sua esperienza diventa uno specchio attraverso il quale molte lettrici possono vedersi, possono ritrovarsi nel suo racconto.
Fortunatamente, oltre alla scrittura “Questa storia è piena di persone che mi salvano senza saperlo.”
Una di queste è il dott. S., con la sua presenza, rassicurante e prevedibilie.
“Il dott. S. non dimentica mai che, oltre ad una donna incinta in grande difficoltà, sono una scrittrice. Non mi dirà mai: adesso lascia stare il libro e concentrati solo su questo. E’ così raro incontrare una persona che ti considera in tutto il tuo essere, non solo come paziente.”
E poi c’è Andrea, il suo compagno di vita.
Non un personaggio d’invenzione, che segue un grafico ordinato. Il vero Andrea, che “va giù e su, cambia e torna indietro, si attorciglia su sé stesso, si ripete, si ribalta.”
Ci sono i litigi con Andrea, c’è tutta la fatica di questa coppia spaventata e confusa, di questo rapporto che si stringe e si allarga a seconda dei momenti, degli stati d’animo.
Resiste quasi a tutto questo rapporto, non si spezza.
“Questa immagine. Andrea che salta dalla sedia e si strappa il piumino, e non dice niente. Sono quasi sette anni che stiamo insieme. Non l’ho mai visto così disperato. Nemmeno nei dolori più insopportabili.
Questa immagine. Mi dà la misura della tragedia. Mi dice che è vero. Mi grida che è vero. Ma io che è vero non ci credo.”
In senso letterario, questo romanzo non ha un un lieto fine.
“Mentre scrivevo, mi sono resa conto che dovevo riconsiderare l’espressione lieto fine, e soprattutto cos’è un lieto fine per questa storia.”
Mentre scrive la sua storia, nella mente di Lattanzi accade qualche cosa, qualche cosa che si può raccontare.
“Il 7 ottobre inizio a scrivere questo libro. L’8 ottobre le mestruazioni tornano dopo sette mesi.
Lo giuro. Non sto inventando nulla. Devo essere sincera. Questo libro agisce, bene, male, su di me.”
Antonella Lattanzi troverà il suo lieto fine. Forse, anche perché, la scrittura, è stata per lei una forma di riparazione.
A volte, può essere necessario scrivere cose che non si raccontano.
“Ogni giorno, quando mi faccio la doccia, vedo una cicatrice sull’inguine.
Me l’ha lasciata una delle due operazioni che ho fatto dopo il raschiamento, l’embolizzazione.
E’ un buco.
Ogni volta, mi dimentico che c’è. Ogni volta quando la vedo mi sento sbriciolare.
Un giorno, spero, farà parte di me come tutte le altre cicatrici che ho. Un giorno non mi sbriciolerà più.”
