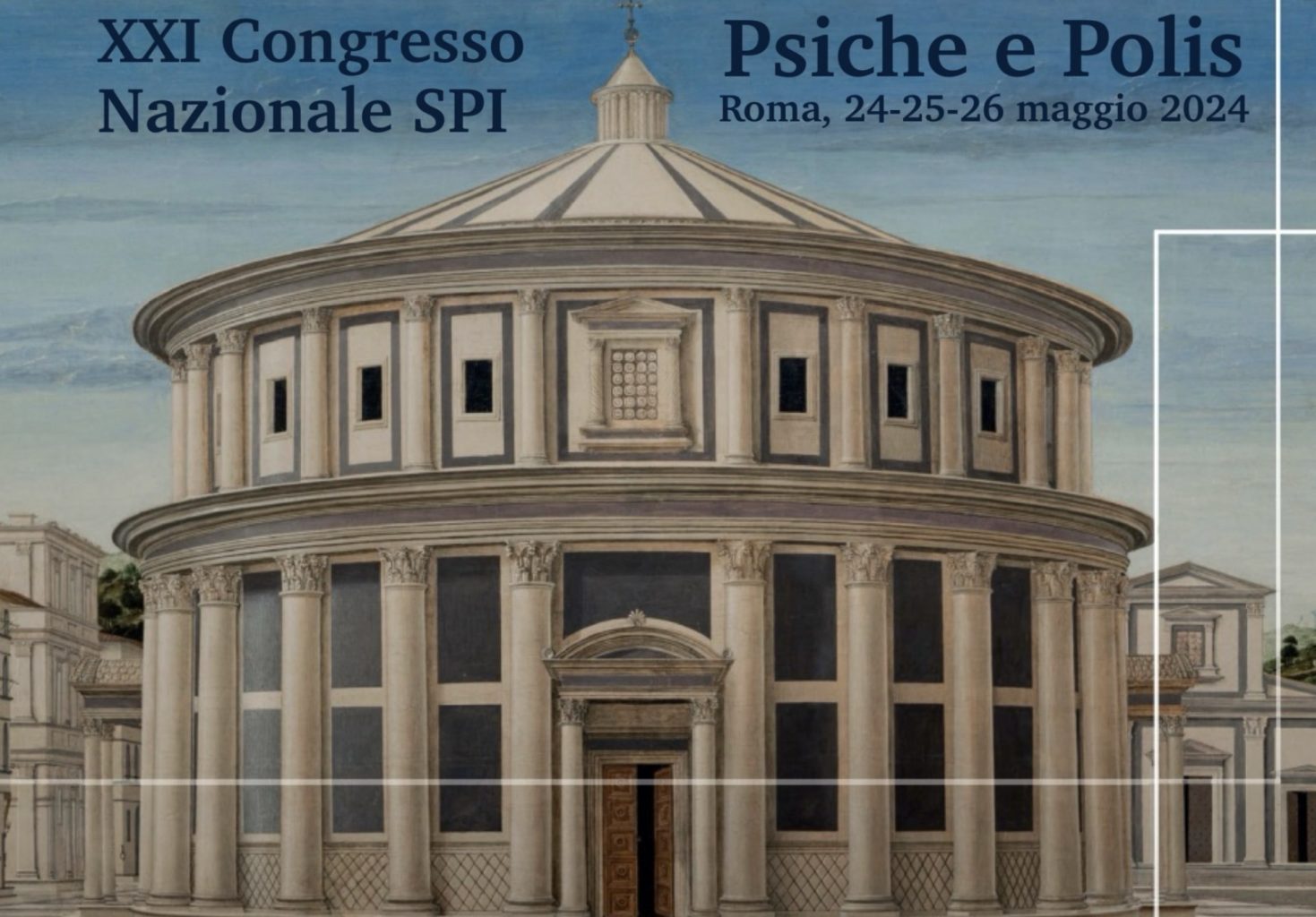
Cerimonia di conferimento del Premio Cesare Musatti 2024 durante il Congresso “Psiche e Polis”, tenutosi a Roma dal 24 al 26 maggio 2024.
La motivazione del Premio Cesare Musatti di Roberto Musella, Segretario della SPI
L’opera di Mario Martone mette in campo il continuo sforzo della rappresentazione a dispetto della violenza, della follia, della malattia e della morte. Nel suo cinema, il conflitto è inseparabile dalla vita, ma è l’esercizio continuo della rappresentazione di Eros e Thanatos e le continue trasformazioni richieste per mantenere viva la vita ad essere al centro della sua produzione artistica.
Il regista premiato oggi, mette in scena, in una prospettiva di rara bellezza, la tensione costante tra la sublimazione e la distruttività in un equilibrio, allo stesso tempo precario e vitale, sospeso tra lo slancio creativo e lo scontro intestino contro un esercito di nemici interni ed esterni.
La tensione creativa alla rappresentazione, nonostante il conflitto, rende l’arte uno strumento politico di relazione; la Polis di Martone si realizza in un capolavoro di equilibrismo poetico che sopravvive al conflitto attraverso la rappresentazione. E nello scontro tra la vita e la morte “ti salverà solo una relazione vitale”, come ha avuto modo di affermare Martone facendo sue le parole di Pasolini.
Il discorso di ringraziamento di Mario Martone
Questo montaggio è già un premio. Ero molto curioso di vedere cosa sarebbe venuto fuori da un montaggio fatto dagli analisti. In effetti mi sorprende, mi emoziona e mi fa capire quante cose … perché, sapete, quando uno fa cinema sa tutta una serie di cose dei propri film, ma è infinitamente superiore la quantità di cose che non sa dei propri film, proprio in maniera esorbitante E dunque dire che sono onorato è dir poco, chiaramente sono felicissimo! Sono stato molto sorpreso quando ho avuto questa notizia, non me lo sarei mai aspettato. So che tra i premiati delle scorse edizioni c’è stato il grande Bernardo Bertolucci, che era un amico carissimo, e so benissimo quanto per Bernardo la psicoanalisi contasse nella sua vita. Sarà stato decenni e decenni in analisi e adesso starà facendo analisi in paradiso…ma naturalmente nel suo cinema è proprio molto evidente e era anche molto intenzionale. Parlando con Bernardo si capiva come proprio la costruzione dei suoi film la seguiva. Naturalmente non è niente del genere è per me, nel senso che il mio rapporto con la psicoanalisi comincia dal fatto che da bambino ero convinto —- perchè leggevo Freud e sentivo parlare di “Froid” — che fossero due persone. Questo è il mio inizio da bambino — avrò avuto sette o otto anni — e solo ad un certo punto questi due nomi si sono sovrapposti. Allora vorrei dire che questa scissione più o meno va avanti, perchè per me le cose sono sempre doppie, triple, quadruple ed è difficile capire. Non riesco a fare un film se non quando capisco che il soggetto, il tema del film, mi porterà ad affrontare qualcosa che comunque è “due”, che comunque è un conflitto, una relazione, che non è una cosa sola. Quindi, a volte, mi sono sono stati proposti film molto belli, come mettere in scena dei romanzi stupendi e, se vogliamo, anche molto adatti a me. Questo lo capisco da parte dei produttori, però a me scatta la molla per fare un film soltanto quando capisco che si comincerà un viaggio e che questo viaggio sarà tra poli dialettici, quando c’è il conflitto, ma anche l’armonia — come visualizza molto bene questo montaggio — perchè le parti di conflitto corrispondono anche a delle parti di liberazione. Quindi, esiste un rapporto tra conflitto e liberazione. Poi c’è un rapporto con gli psicoanalisti: per tanta parte della mia vita la psicoanalisi è stato un fatto culturale, ho letto Freud — e a quel punto sapevo che era uno, non due — così come mi interessava molto anche Jung. Ricordo un episodio che mi è successo che mi ha fatto pensare che forse anche lui avesse le sue ragioni, ma è sempre stato Freud la stella polare, anche quando mi capitava da ragazzo di leggerlo. Poi sicuramente bisogna dire anche un’altra cosa, che cinema e psicoanalisi sono due sorelle, nel senso che sono nate insieme dallo stesso ventre della storia. Ad un certo punto la storia partorisce il cinema e la psicoanalisi. Questo può piacere o meno sia ai cineasti che ha gli psicoanalisti, ma di fatto è difficile non tener presente questo stare insieme, l’equilibrio tra questi due linguaggi, tra queste due arti. E dunque ci sono state occasioni ad un certo punto belle, importanti, che hanno avuto a che fare spesso con la tragedia greca. Perché oltre al mio lavoro di regista al cinema sono un regista di teatro, sono un regista di opera — sempre a proposito di due, tre, quattro — certamente di cinema e teatro. Perché poi il teatro, che sia di prosa o che sia teatro musicale, è sempre teatro, ci sono persone su un palcoscenico e persone in una platea, che stanno insieme nello stesso spazio, che condividono un’esperienza presente. Mentre invece quando si ha che fare col cinema…come diceva Cocteau, il cinema è “la morte al lavoro”, c’è qualche cosa che non c’è più, è una cosa che c’è stata — anche da poco o da molto — ma è stata e non sarà più, e chi sta in sala la vede. Il tempo è completamente diverso tra cinema e teatro, quindi la tragedia greca è stato un campo di indagine per me molto importante. Io ho messo in scena tante tragedie greche e “Teatro di guerra” è un film in cui la tragedia greca è al centro, “I sette contro Tebe” di Eschilo. Allora ricordo che ad un certo punto a Napoli si tenne un convegno e Sarantis Thanopulos mi invitò. Si fece questo convegno al Grenoble e io rimasi veramente sorpreso dalla qualità incredibile, abituato ai mondi del cinema e del teatro, che sono mondi molto carini, molto divertenti e molto altro … ma lo spessore era completamente diverso. Fui molto colpito, fu una giornata magnifica e mi sembrò di capire tante cose del mio film, il che ha a che fare con la critica. C’è un rapporto tra psicoanalisi e critica, io mi sono portato questi pezzi, quello che hanno scritto gli psicoanalisti sui miei film, e che sono anche delle critiche di un livello importante. In qualche modo lo psicoanalista è un critico? Chissà! Comunque le pieghe si cercano laddove non è evidente, si guarda nell’ombra, si possono scoprire cose …quella volta al Grenoble ebbi la sensazione che gli analisti fossero anche dei critici molto interessanti. Qui c’è Andrea Baldassarro, si fece “Edipo a Colono” di Sofocle, qui al teatro India di Roma, si fece una giornata e anche in quel caso si parlò in maniera molto interessante. Poi, ad un certo punto, da questo aspetto culturale, dalla prima fase di conoscere gli psicoanalisti e dal leggere la psicoanalisi, è arrivato un momento in cui ho avuto bisogno di uno psicoanalista. Questo è qualcosa di molto diverso…e allora non sapendo a che santo votarmi, tra le altre cose ero un po’ vergognoso, mi dissi “quasi quasi quasi scrivo a Sarantis Thanopulos”. Questo perchè mi era piaciuta tanto quella giornata al Grenoble. Gli scrissi due righe e due righe mi rispose, mi fece una rosa di nomi e io non conoscevo nessuno naturalmente, non avevo nessun elemento per scegliere, tranne che uno di questi nomi era greco: Andreas Giannakoulas. Io scelsi questo, sarà perché mi piaceva la tragedia greca, sarà per la mia fascinazione, non lo so, sarà perché naturalmente Thanopulos è greco e mi aveva dato fiducia…quindi adesso potrei stare tutta la sera a raccontare i due anni con Andreas Giannakoulas, sono stati due anni straordinari e indimenticabili, che mi hanno aiutato. Questo per dire che la psicoanalisi non è solo uno strumento culturale, ma di salute, di salute mentale e di salvezza per certi versi. Così non dirò molto, ma forse qualcosa la posso dire perché ha a che fare con lo spazio, con lo spazio del teatro e quindi con il cinema .Giannakoulas non c’è più e quindi si può parlare: il suo studio era stretto e lungo, aveva una profondità e io entravo dalla porta, c’era una poltrona, venivo fatto accomodare e lui si sedeva di fronte senza dire una parola e si apriva la partita…e siamo andati avanti per parecchio tempo, un anno buono in questo modo, e io vedevo una porta sulla destra in questo lungo studio. Non so perché nella mia testa nell’altra stanza c’era il lettino, ero convinto che il lettino fosse oltre quella porta. È successo che dopo un anno lui mi disse “se non le dispiace dalla prossima volta vorrei che lei fosse sul lettino” e allora io dissi “quindi andiamo nell’altra stanza” e lui mi ha risposto “il lettino e là”. Ed era proprio là! Lo vedevo benissimo, era davanti a me e l’ho visto, e io per un anno non l’avevo mai visto. Io non posso interpretare nulla di questo, siete voi che dovete farlo…chissà che cosa starete pensando…e giustamente! Però questo dice qualcosa anche di me regista. C’è Ippolita qui, è il mio amore, è mia moglie, è il frutto di quel cambiamento, di quella salvezza che c’è stata in quel momento difficile. Poi lei è figlia di Adele Nunziante Cesàro, che è una vostra collega che conoscevo prima di conoscere Ippolita. Quindi diciamo che c’è qualcosa nel modo di fare cinema, di fare teatro, ma forse soprattutto di fare cinema, che è affidato al mistero, è affidato per me al fatto che il lettino non lo vedevo e pensavo che fosse nell’altra stanza e poi si è rivelato. Questo non è estraneo al mio modo di fare il cinema perché —- come Ippolita sa — io sono molto preciso nel fare un film, sono quasi ossessionato, sono preciso e tutto però poi in realtà, come dicevo all’inizio, è molto di più…è molto più quello che accade che mi è sconosciuto, e questo perché si lavora con gli altri nella collettività. La collettività non è solo un campo di indagine politico-storico—sociale. Comunque per me che i film siano immersi nella polis è decisivo, la tragedia greca mi ha formato la testa in questo senso. Quindi nelle tragedie greche ci sono personaggi stagliati con molta nettezza in rapporto alla polis, sempre, in ogni tragedia greca. In fondo per me i film sono così perchè in centro ci sono dei personaggi che cerco di mettere a fuoco nel modo più chiaro possibile, che però non sarebbero nulla senza senza il coro, senza la polis che c’è intorno, vengono tirati fuori da una dimensione sociale-storica. Poi c’è anche la collettività del set, parola che la psicoanalisi condivide, è un luogo affollato di attrici, di attori, di persone che passano, di persone molto importanti perché hanno grandi responsabilità nelle scene, ma anche persone che ne hanno pochissima, si occupano di cose infinitesimali, ma possono diventare molto significative su set. Hai voglia stabilire con precisione tutto, in realtà ogni volta tutto verrà in qualche modo messo in crisi, messo in discussione, cioè tu arrivi sul set con le idee chiarissime, molto chiare, tu sai cosa vuoi fare, ma devi sapere che uscirai da quella giornata che non tutto necessariamente sarà stato come tu pensavi. Il che può essere bene, può essere male, può funzionare i vari modi. Non so se magari ci sono colleghi molto più precisi nell’indicazione, nel disegno, non lo so, ma ho la sensazione che comunque sia proprio un elemento del cinema quello di affidarsi…A proposito di porte c’era già Jean Renoir che diceva “sul set devi tenere una porta aperta”, un’espressione magnifica cara a Bernardo Bertolucci, che voleva dire che devi sapere che c’è quella porta; come nello studio di Giannakoulas: quella porta era chiusa, ma per me si apriva. Non ho mai saputo che cosa ci fosse dall’altro lato della porta, però appunto sentivo quando stavamo là qualche cosa di vicino a quando stavo sul set. Quando andavo da Giannakoulas c’era la precisione della liturgia, arrivare in orario, era una cosa difficile da capire che tipo di impresa fosse per me…eppure non sono mai arrivato in ritardo, mai. Questo lo considero uno dei più grandi risultati! E poi appunto tutto doveva essere così in qualche modo preciso…adesso mi devo proprio divertire con gli analisti, devo raccontarvi quello è successo ad un certo punto, era una sfida continua chiaramente…poi l’intelligenza…ho passato dei momenti di divertimento straordinario, mi manca in una maniera terribile. Quando entravo e quando me ne andavo vedevo che c’era un grande quadro in bianco e nero come un fumetto, tipo Lichtenstein, con delle scritte in greco. Poi quando sono andato sul famoso lettino, che era sul fondo dello studio, la mia testa era voltata verso il quadro. Un giorno dopo un po’ di tempo gli chiesi: “Che cos’è quel quadro?”. Lui mi disse: “Un giorno ne parleremo”. Da quel giorno io cosa cominciai a fare? Ogni volta che passavo — avevo penna e carta con me — visualizzavo e memorizzavo una parola della frase. Come uscivo la scrivevo, quindi, nel giro di una dozzina, una quindicina di sedute avevo composto la trama. Immediatamente me la feci tradurre…adesso nemmeno me la ricordo, non era la frase in sè…era la partita.
Io andavo diciamo sul set di Giannakoulas con un entusiasmo, una serietà, un’allegria e anche un dolore molto simile a quello che porto sul set al cinema, e sono stato bene nello stesso modo. C’è poi davvero momento in cui io sto bene sul set o quando sono in prova a teatro, e lì stavo bene e questo, chissà, forse vuol dire che cinema e psicoanalisi hanno davvero qualche cosa in comune. Ce l’hanno profondamente. Grazie, grazie ancora veramente a chi ha scritto questi bellissimi testi e a chi ha realizzato il montaggio che vorrei tantissimo avere.
